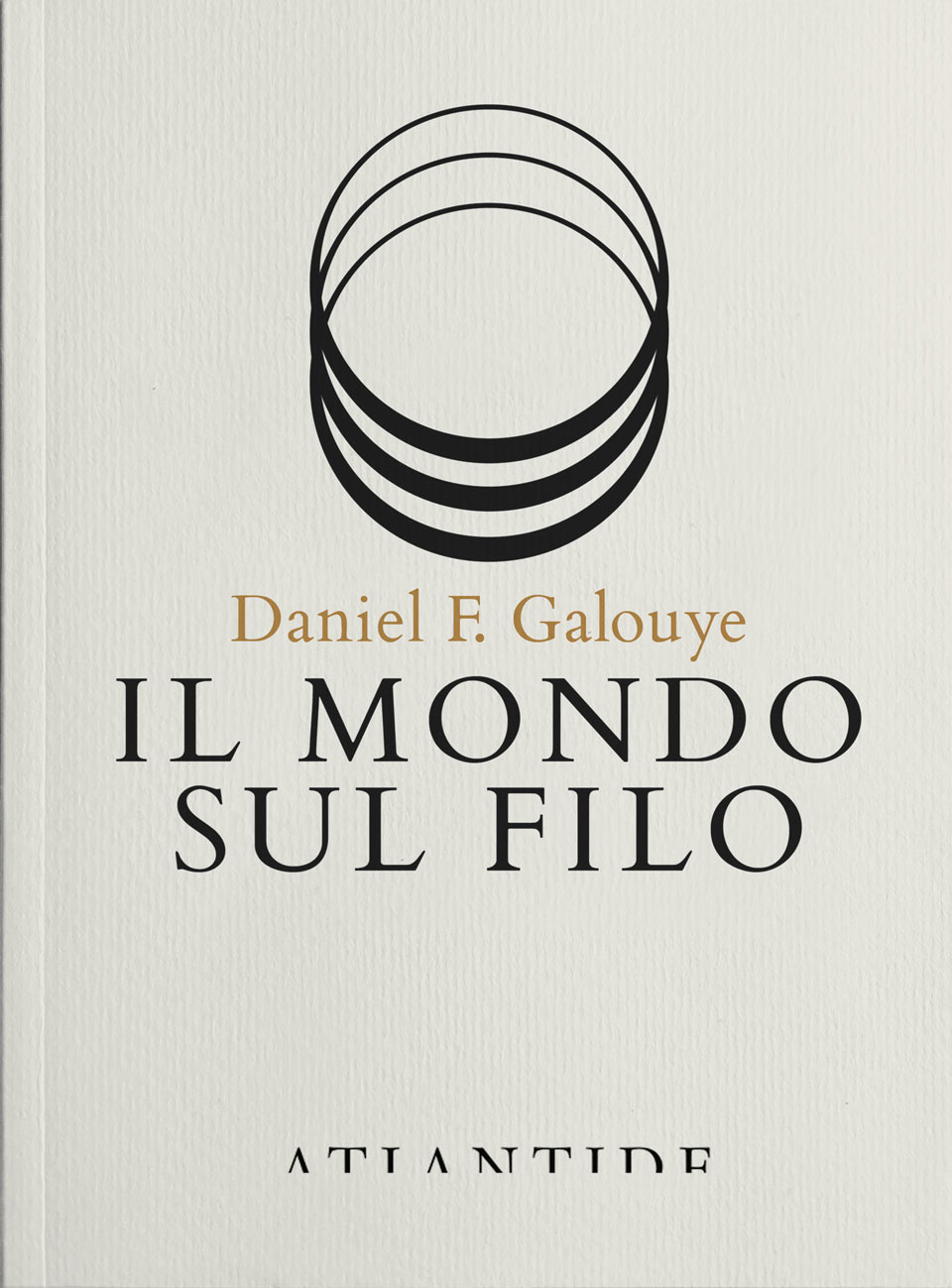Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. (da "Il tempo ritrovato" - Marcel Proust)Poesia della settimanaQuesta poesia è proposta dal 27/06/2022 12:00:00
Pagina aperta 634 volte, esclusa la tua visita
Ultima visita il Tue Apr 1 02:33:00 UTC+0200 2025 Il mondo sul filodi Daniel F. Galouye« indietro | versione per la stampa |
invia ad un amico »
Gli diedi ancora un cazzotto. Non perché fosse fuori controllo. Solo per l’abietta menzogna che mi aveva appena raccontato. Quindi, mentre miei occhi guardavano nel vuoto oltre la forma immobile di Chuck Whitney sul tappeto, qualcosa, un pacato senso della ragione forse, gridò dentro di me che era tutto vero.
Tutto era esattamente come Ashton lo aveva rappresentato.
Io, tutto quello che mi riguardava, ogni respiro d’aria, ogni molecola nel mio universo: nient’altro che realtà fittizia. Un ambiente simulato disegnato in un qualche mondo più vasto dove esistere era un fatto assoluto.
Quell’idea orribile mi scosse in profondità, minando la mia ragione dalle fondamenta.
Ogni persona e oggetto, le mura attorno a me, il pavimento sotto ai miei piedi, ogni stella fino al più remoto angolo di infinito: nient’altro che ingegnose costruzioni. Un ambiente analogo. Una creazione simulatronica. Un mondo di intangibile illusione. Un’interazione bilanciata di cariche elettroniche che percorrevano nastri e cilindri, saltando da catodi ad anodi, raccogliendo stimoli da griglie selezionatrici.
Impotente davanti a un universo improvvisamente orribile e ostile, osservavo senza sentimento gli assistenti di Whitney che trascinavano via il suo corpo privo di conoscenza, posseduto da Ashton.
[ La poesia qui proposta è un libero adattamento in versi della scrittura in prosa tratta da Il mondo sul filo, Daniel F. Galouye, Atlantide (pagine 126-127), traduione di Federico Lai ]
# 1 commenti a questo testo: Leggi | Commenta questo testo » |
Mappa dei servizi | Regolamento | Privacy Policy | Cookie Policy | Donazioni