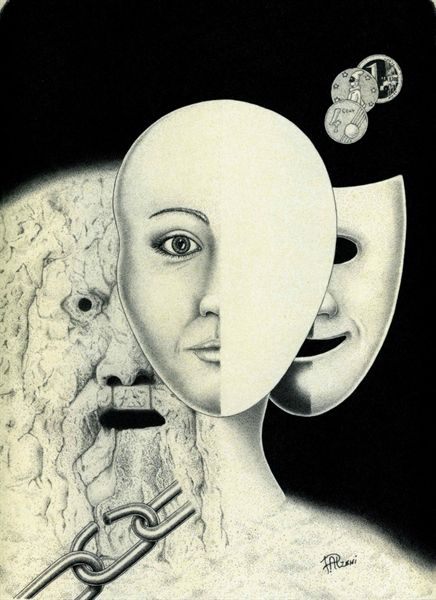Dio mi sta cercando. Io lo sto aspettando.
Ormai i piatti si accumulavano sul lavello della cucina da giorni, forse settimane. Il frigo vuoto tranne per qualche lattina di birra scadente. Formiche correvano come pazze per l’ultimo pezzo di pizza abbandonato forse la sera prima. Il rubinetto della cucina perdeva, ogni goccia era come un colpo di martello sulla testa, una goccia cinese e questo mi faceva impazzire. E io? Io avevo bisogno di dormire, ma il sonno era un lusso che non potevo permettermi.
Da quanto non dormivo? Vagavo per la casa come un cadavere, appena risorto dalla tomba. Non mi sembrava nemmeno più casa mia quella. Ero sempre stato solo? O vivevo con qualcuno? Non ricordavo nulla del giorno prima, né degli altri ancora, sentivo solo questo bisogno disperato di dormire.
Così decisi di mettermi a letto. Nudo fissai le pareti spoglie della stanza, solo qualche sedia sgangherata, un lenzuolo sporco per terra, un armadio senza ante e senza vestiti. Il soffitto mi fissava, quasi a giudicarmi. In un lato del letto un comodino bianco macchiato di chissà cosa, una foto di una donna che non riuscivo a riconoscere, e quell’odore acre che non sapevo da dove arrivasse, forse dalle viscere stesse del mio stomaco o della mia anima. Guardavo il soffitto come se fosse uno schermo maledetto, sembrava proiettare un film in bianco e nero: immagini sfocate che lentamente diventavano sempre più nitide. Visi di donne si susseguivano, un corteo di donne dimenticate? “Quante ne sono passate nella mia vita?” pensai. Alcune le ricordavo bene, erano frammenti nitidi, altre no. Sono state poche cose o deliri a colori, nella mia testa frullavano come arance con tutta la buccia, alcune confessavano i loro peccati altre ne accendevano, di peccati o forse non le avevo mai viste, fantasmi della mia mente.
L'angoscia mi stringeva la gola. Chi ero? Cosa facevo? Non ricordavo nemmeno il mio nome, non mi riconoscevo più nemmeno nello specchio incrinato alla sinistra del mio tormento. Quelle figure di donne, alcune familiari, altre estranee, mi facevano sentire ancora più perso, ancora più solo. Come potevo essere così straniero a me stesso? Non trovavo risposte, solo quel bisogno disperato di scivolare nel sonno e sfuggire da ogni cosa.
“Laura, quella è Laura!” Me la ricordo bene Laura. Era una di quelle bellezze che ti colpiscono subito, occhi grandi da cerbiatta e un sorriso solare. Ricordo il suo altruismo, sempre pronta a dare tutto agli altri, sempre lì, per chiunque ne avesse bisogno, o forse lo faceva solo per liberarsi l’anima da libertina con il velo. Non ricordo come ci siano conosciuti, ma rammento che dentro di lei c’era anche una tempesta. Era come un vulcano pronto ad esplodere da un momento all’altro. Diceva di essere felice con me, e a volte ci credevo anche. Ma poi, senza preavviso, scoppiava il temporale. Urlava, piangeva, e poi spariva, così, senza motivo. Spariva per giorni, settimane. E quando tornava, era come se nulla fosse accaduto, “Ho preso un treno qualsiasi”, mi diceva. Così, come la cosa più naturale al mondo. E poi il ciclo ricominciava. Era una contraddizione costante, altruista, generosa ma piena di demoni che non riusciva a domare. E io? Io ricordo che ero solo uno spettatore impotente, succube del suo uragano, incapace di lasciarla andare, perché ero affascinato dalla sua bellezza ma soprattutto dalla sua follia.
Poi, un giorno, Laura sparì, come sempre, così all'improvviso, ma stavolta non prese un treno. Non ricordo nemmeno cosa fosse successo. Forse una delle sue solite tempeste, forse una delle sue fughe improvvise. Ma c’era più. Il suo posto sul letto era vuoto, il suo profumo nell’aria e i suoi vestiti svaniti. Ogni traccia di lei, evaporata. Cercai di ricordare l’ultima cosa che ci dicemmo, l’ultimo sguardo, l’ultimo tocco. Niente. Solo un vuoto insopportabile. Era come se fosse stata solo un sogno, un’allucinazione. E io? Io restavo lì, con i miei demoni e quella stanza da fissare, cercando di capire cosa fosse andato storto.
Quell’odore acre alle narici diventava insopportabile e avevo sonno, una terribile voglia di dormire o di morire. Sarà la stessa cosa?
Le immagini sul tetto scorrevano a volte lente, altre veloci. Intravedevo momenti di vita che mi tornavano alla mente: un uomo alla finestra che piange, una donna che partorisce, un bambino che gioca con il lego, tante mosche, un prete, una chiesa, una sirena, sangue, mentre altre immagini non mi dicevano nulla, non mi appartenevano. Poi la sequenza rallenta, fino a a fermarsi sul viso di una donna. “Tecla, questa è Tecla! Santo Dio, da quanto tempo… quanto tempo è passato dall’ultima volta che siamo stati insieme!” Di lei rammento tutto.
Conobbi Tecla una sera mentre camminavo solo lungo il viale della città, durante le mie solite passeggiate serali a rubare i pensieri degli altri. Era inverno e piovigginava, una di quelle sere in cui il freddo ti entra nelle ossa e la pioggia ti martella il cranio. Già, il cranio. Lei mi si piantò davanti all’improvviso, con i vestiti fradici e un’aria impaurita. Mi chiese di accompagnarla a casa, diceva di sentire qualcuno alle sue spalle che la seguisse. La guardai per un attimo: occhi azzurri, capelli castani lunghi e ondulati, sembrava appena uscita dal parrucchiere. Una donna minuta, ma con un corpo carnoso che non si dimentica facilmente.
Le dissi di sì. Camminammo in silenzio, le nostre ombre danzavano sotto i lampioni. La pioggia cadeva incessante, rimbalzava sui marciapiedi e formava pozzanghere che riflettevano la nostra immagine distorta. La mia ombra lunga, la sua corta. Sentivo il suo respiro affannoso, a metà tra il sollievo e la paura. Finalmente arrivammo al portone di casa sua. Mi ringraziò con un filo di voce, mi prese la mano e ci salutammo. Quel tocco era caldo, un contrasto assurdo con la notte gelida.
Tecla era una donna diversa dalle altre. Mentre tornavo a casa, il suo viso mi restava impresso nella mente. Pensai che poteva stare chiusa in una valigia e portarla a spasso. Una donna da tenere stretta, da proteggere. Non riuscivo a togliermela dalla testa.
C’incontrammo altre volte, per caso, dato che abitavamo a poche centinaia di metri l’uno dall’altra. Alla fine, ci davamo appuntamento ogni mattina per fare colazione insieme. Le nostre soste duravano un’ora, forse meno, forse più, non lo so, il tempo con lei si fermava. Parlava, parlava, e io ascoltavo. Mi piaceva ascoltarla. Aveva una voce rauca, rovinata dalle troppe sigarette, ma allo stesso tempo dolce e bassa, quasi musicale. Parlava con pause studiate, sapeva come tenere alta l’attenzione, sembrava che recitasse. Era un piacere ascoltarla, qualsiasi cosa dicesse, anche una banalità era come una melodia e in maniera sottile stava nascendo qualcosa tra noi.
Decidemmo di andare a vivere insieme. Lei lasciò la sua casa solitaria, un rifugio pieno di ricordi. Io, invece, la accolsi nella mia, una prigione di solitudine dove ero stanco di vivere come un eremita. In quell’atto c’era una speranza, forse un’illusione, di riempire probabilmente il vuoto che entrambi ci portavamo dentro nonostante la sua loquacità, nonostante i miei silenzi.
Non furono giorni felici quelli con Tecla. Inizialmente si, ma dopo venne fuori quell’ordine mentale che sfidava continuamente il caos. Ogni cosa doveva essere al suo posto, ogni pensiero incastrato come un tassello di un puzzle. Barattoli, pane, uova, persino la polvere sotto al letto, tutto aveva una sua precisa collocazione. Era una maniaca del controllo, calcolava ogni dettaglio, ogni eventualità. Controllava anche me che, certo non ero un santo. Io avevo voglia spasmodica di libertà. Non mi sono mai piaciuti gli schemi imposti, ogni tanto avevo bisogno di stare per i fatti miei, magari a non fare nulla, magari solo a pensare.
A volte Tecla combatteva con se stessa, lottando contro quel lato di lei che odiava: un desiderio ribelle di fuggire dalla sua prigione fatta di logica e metodo. Quando quella macchina di meticolosità la soffocava, spegneva il cervello e si perdeva in viaggi mentali, disprezzandosi per quella debolezza. Tecla doveva avere il controllo su tutto, sempre. Eppure, in quei momenti di vulnerabilità, sentivo di amarla ancora di più.
Non amava essere sorpresa dal nulla, sempre un passo avanti al destino. Quando ci innamorammo, fu come un pugno nello stomaco, un ubriaco che inciampa su un marciapiede sconnesso. Diede tutta se stessa, e in quel caos di emozioni trovò finalmente un po' di quella disordinata libertà che aveva sempre evitato.
Tecla aveva mani belle e abili, capaci di creare ordine anche nel più grande disordine. Eppure, nel profondo, sentivo che c'era sempre un piccolo demone. Chi non ha demoni dentro? Tecla ogni tanto ascoltava questo folletto e si lasciava andare.
Ricordo anche il periodo quando la mia fiducia nei suoi confronti iniziò a vacillare. Tecla ogni tanto aveva dei comportamenti strani, usciva all’improvviso, chiudeva il telefono di colpo, rientrava tardi senza una vera spiegazione plausibile, così un giorno, decisi di seguirla. La pedinai con molta descrizione, cercando di non farmi notare.
Tecla camminava con passo svelto, l’aria di chi ha qualcosa da nascondere. Continuava a guardarsi intorno, nervosa. La seguii lungo una strada vecchia della città, le cui pietre erano consunte dal tempo. Si fermò davanti a una porta fatiscente, le mani tremanti. Gettò un'ultima occhiata intorno, assicurandosi di non essere osservata, poi entrò rapidamente.
Aspettai qualche minuto, il cuore martellava nel petto, poi mi avvicinai con cautela. La finestra accanto alla porta, ad altezza d’uomo, offriva una vista parziale dell'interno. Mi chinai leggermente e sbirciai dentro, trattenendo il respiro.
Quello che vidi mi lasciò di stucco. Tecla era inginocchiata a un bambino che giocava sul pavimento. Un bambino con i capelli ricci e gli occhi grandi, simili a quelli di Tecla. Intuì immediatamente che quello era suo figlio; quel segreto tenuto nascosto. Il cuore mi si riempì di emozioni contrastanti: sorpresa, rabbia, tristezza. Come aveva potuto nascondermi una cosa del genere e così importante?
Decisi di aspettarla fuori. Quando finalmente la vidi uscire di casa, con lo sguardo dolce e sereno, le andai incontro. Tecla, vedendomi, abbassò lo sguardo e iniziò a piangere.
“Perché non me l’hai detto?” dissi, cercando di trattenere la rabbia.
Tecla non fu capace di rispondermi subito. Poi, con voce tremante, spiegò che aveva avuto paura. Paura del giudizio, paura delle conseguenze, paura di perdere lui.
La mia rabbia montava come una bestia furiosa. "Paura? E io dovrei crederci? Tecla, non puoi tenermi nascosto un figlio e poi aspettarti che ti capisca."
Lei continuava a piangere, senza riuscire a guardarmi negli occhi. "Mi dispiace... Non sapevo cosa fare."
Mi sentii come se stessi per esplodere. "Sai cosa? Non mi interessa più. Te la sei cercata. Non tornare più a casa. Hai capito? Sei fuori dalla mia vita."
La lasciai lì, sul marciapiede, le spalle pesanti di un tradimento che non potevo perdonare. Mentre mi allontanavo, le sue lacrime erano l'unica cosa che risuonava nel silenzio di quella strada. Ero incazzato, e quella rabbia mi bruciava dentro come un fuoco eterno. Non c’era redenzione, solo un vuoto che non riuscivo a colmare e un bisogno di vendetta che montava dentro inarrestabile.
Il disordine nella mia mente cresceva di pari passo con l’intensità dell’odore che riempiva la stanza. Non capivo cos’era né da dove provenisse, ma impregnava ogni angolo, soffocandomi. Scesi dal letto lentamente, il piede sinistro toccò per primo il pavimento, freddo e scivoloso. La casa era un porcile; non ricordavo l'ultima volta che avevo pulito, forse non l'avevo mai fatto. Mi alzai, la schiena dritta, il letto dietro di me. L'odore mi riempiva le narici, impregnando il mio corpo nudo.
Mi chinai e guardai sotto al letto. C’erano i resti di Laura. Non ci avevo pensato da giorni, forse settimane. Avevo perso il conto del tempo da quando l'avevo fatta a pezzi. Il sangue, ormai secco, si era fuso con il pavimento, e i brandelli di carne erano diventati parte dell’oscurità sotto il letto. La sua testa, con i capelli ancora attaccati, era nascosta dietro un vecchio paio di scarpe lise.
C'era Tecla. Anche lei sotto il letto, più lontana, quasi nascosta. I suoi occhi vuoti mi fissavano ancora, come se volessero ricordarmi qualcosa che non volevo ricordare. Mi ero divertito con lei, più che con Laura. Le avevo fatto cose che non avrei mai immaginato.
E poi c’erano pezzi di altre donne, sconosciute, forse Giulia o Asia. Ossa spezzate come un vecchio giocattolo. Gambe in un angolo, il tronco in un altro. Ogni tanto mi chiedevo se qualcuna di loro avesse lasciato un segno. Ma chi se ne frega? Il mondo è pieno di cadaveri, alcuni solo più evidenti degli altri.
Mi sedetti di nuovo sul letto, l'odore acre sempre lì, a ricordarmi chi ero. Ero vivo, in un certo senso. Ma la mia vita era quella, un buco nero di morte e decadenza. Non c'era redenzione, solo una discesa lenta negli inferi. E sotto il letto, il mio passato mi guardava, fatto a pezzi e abbandonato.
Forse Dio mi stava cercando. Io lo stavo aspettando.
2024 -
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Giuseppe lonatro, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.