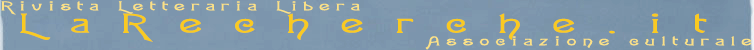Pubblicato il 08/01/2008
(L'articolo, qui riportato soltanto in parte, è un'intervista di Antonietta D’Introno al professor Giuseppe Mastromatteo - professore di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -, pubblicata sulla rivista "Il peperoncino rosso" pagina 10, ed è interamente leggibile scaricandosi il giornale dal sito www.globeglotter.it)
Domanda:
Qualche decennio fa i meridionali che si trasferivano al Nord (del Mondo) per motivi di lavoro erano tutti “emigranti”. Oggi viene usata molto di più la parola “migranti”, riferita soprattutto ai cittadini del terzo mondo. I ragazzi, diplomati e laureati, lasciano il proprio paese senza grandi sofferenze. È una scelta di vita. Essi tagliano più facilmente il cordone ombelicale perché si vive ugualmente bene in un altrove spesso simile al paese di origine. Un profumo, un sapore, una canzone, una festa, una chiacchierata con il vicino di casa significavano un tempo “patria”.
Cosa pensa un economista di una simile trasformazione, apparentemente “semantica”?
Risposta:
Tento di tratteggiare in poche righe alcune tematiche relative alla complessa questione della migrazione. A livello nazionale, i migranti continuano ad esserci e riguardano, oggi come allora, i meridionali che si trasferiscono nelle regioni settentrionali. Ma c’è una differenza importante nella qualità di tali flussi. In passato era la manodopera che, spinta dalla fame, dal Sud andava ad ingrossare le fila dei lavoratori nelle grandi fabbriche del Nord. Oggi, invece, sono soprattutto i lavoratori altamente qualificati che, non riuscendo a trovare sbocchi lavorativi nel Meridione (in effetti, pur migliorato a livello di reddito pro-capite, esso resta arretrato quanto a dinamismo e modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali), si trasferiscono al Nord dove più facilmente il capitale umano è valorizzato dal mondo produttivo. In particolare essi si rivolgono sia ai settori presenti al Sud come al Nord, ma che solo in quest’ultima area offrono reali opportunità di lavoro, sia ai settori che si sviluppano solo al Nord - come ad esempio il settore finanziario - caratterizzati da una forte internazionalizzazione. A livello internazionale esistono due tipi di migrazioni, la cui suddivisione per qualifiche professionali tende a coincidere con quella per aree geografiche. I migranti dei paesi occidentali, ma anche dei paesi emergenti (Cina, India, Brasile…), emigrano specialmente verso gli Stati Uniti d’America - che è il primo paese al mondo per immigrazione high skilled - per cercare occupazione nei settori ad alto contenuto di conoscenza e di valore aggiunto. Dai paesi poveri, invece, un numero crescente di persone, anche con livelli d’istruzione medio-alta, cerca fortuna nei paesi occidentali, dedicandosi a impieghi di bassa qualifica. Quest’ultimo tipo di migrazione, il più diffuso, comporta benefici e costi sia nei paesi di origine che in quelli di approdo. I paesi di provenienza beneficiano delle rimesse degli emigrati, le quali spesso rappresentano quote significative del Pil e possono essere considerate veri e propri aiuti allo sviluppo; ma nel lungo periodo tali paesi sostengono il costo della mancanza di persone mediamente istruite in termini di scarsa presenza di un ceto medio-alto dinamico.
Quanto ai paesi di destinazione, gli immigrati compensano la debole crescita demografica e la mancanza di lavoratori con occupazioni di basso profilo professionale; mentre una loro presenza non adeguatamente gestita può ingenerare nel mondo produttivo una concorrenza sleale rispetto alle condizioni retributive e una spinta al lavoro in nero. E qui emergono ulteriori importanti spunti di riflessione circa il tema della priorità del lavoro sul capitale e, più in generale, intorno ai rapporti tra economia ed etica. Le questioni di carattere etico non hanno mai trovato una facile ospitalità presso l’economia nelle sue diverse espressioni: sia l’economia di tutti i giorni praticata dai diversi operatori economici, sia lo studio scientifico dei fenomeni economici da parte dei competenti. La frase “gli affari sono affari” – cui ci s’ispira nei microcosmi come a Wall Street - ben riassume un radicato pregiudizio di incompatibilità fra la sfera dell’economia e quella dell’etica o, almeno, di certa etica. Al contrario, personalmente ritengo che la crescita economica non sia affatto incompatibile con la giustizia distributiva, tesi che la teoria postkeynesiana della Scuola di Cambridge mi ha definitivamente insegnato: creare ricchezza per distribuire ricchezza.
Il fenomeno descritto si fonde con gli effetti della globalizzazione (in questo processo non sono ancora chiari il ruolo della Unione Europea e i conseguenti aspetti inerenti alla solidarietà e alla sussidiarietà fra le regioni, come negli USA, nel rispetto del patto di stabilità) sui movimenti di popolazione e sulla conseguente mescolanza di culture e di significati (penso sia questa, nella domanda postami, l’accezione del termine “semantica”). Quando “partire” significava lasciare un intero mondo di significati condivisi solo dalla popolazione residente, tutto ciò che ricordava quei significati (usi, costumi, tradizioni, linguaggio, ecc.) era un ritorno al riconoscimento di forme di appartenenza (chi non ricorda quando all’estero, incontrando anche solo una macchina targata Italia, ci si salutava festosamente?). Oggi le appartenenze sono più fluide, più distribuite, alcuni tratti appartengono non più a segmenti di popolazione ben definiti da un territorio (la nazione), ma a una popolazione più vasta, a volte comprendente la gran parte del mondo (penso ai consumi, all’abbigliamento, al cibo, alla musica, alla lingua inglese…). Partire non significa più lasciare definitivamente tutto quello in cui ci si riconosceva, ma essere certi di trovare nel paese di destinazione qualcosa – per così dire – di noto e familiare.
Il che, secondo me, lascia aperta la possibilità di aprirsi senza paura al nuovo che, volenti o nolenti, si incontra. L’economia, poi, che tanta parte ha avuto nella globalizzazione, catalizza i processi e velocizza l’acquisizione di elementi culturali provenienti da regioni del mondo prima irraggiungibili. Questa situazione, con uno status di “migrante” alle spalle, è stata da me vissuta nel credere di poter trascendere la mia individualità considerata a sé stante (compreso il mio villaggio) e tendere a diventare persona. In tal modo scopro e realizzo la meta che è in me, le mie risorse nelle quali credere e su cui puntare.
La globalizzazione, purché non persegua unicamente gli obiettivi del Mercato, ci affranca dalla necessità impellente e indilazionabile di una relazione quale che sia con l’altro e dalla fragilità dei rapporti interpersonali, perché non ci fa dipendere più dalla benevolenza dei nostri concittadini. Ovviamente, tale processo può erodere la fiducia che ci tiene insieme e che di fatto permette ai mercati stessi di esistere. In questo la Dottrina sociale della Chiesa è maestra, sostenendo sia la priorità del capitale umano su quello fisico e finanziario, sia la condivisione con i poveri e con coloro che vivono un’esperienza culturale “altra” quale vera ricchezza della convivenza umana.
Il villaggio (benché faccia parte di noi) può rinchiuderci, nel senso di indurci a considerare genuini dei falsi rapporti interpersonali, creando così di fatto “carestie di felicità”.
Domanda:
Io sono nata nel Nord, sul fiume Po, ed ho scelto di trasferirmi in Puglia, una regione amata che considero la mia terra. Talvolta, però, riscopro le mie origini in alcuni momenti e situazioni particolari. Preferisco, ad esempio, l’inverno con le sue nebbie serali ed i suoi strascichi di intimità, oppure mi incantano i salti di ranocchi e rospi, animali che hanno popolato i miei giochi di bambina sul fiume. Che cosa ti fa ricordare inconsapevolmente d’improvviso, durante la frenetica e “successful” attività, il tuo Paese di origine?
Risposta:
E' possibile leggerla scaricando il giornale da:
http://www.globeglotter.it/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=75
(Copia e incolla la riga sopra nella barra degli indirizzi del tuo browser)
« indietro |
stampa |
invia ad un amico »
# 0 commenti: Leggi |
Commenta » |
commenta con il testo a fronte »
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Redazione LaRecherche.it, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.
|