«Attraverso la grande massa discontinua e frusciante dei lecci i raggi del sole penetrano sempre più obliqui, popolando il bosco di bersaglieri Iannopulo modellati in un’instabile polvere d’oro che sembra moltiplicarne, in uno sfavillio insieme accecante e oscuro di sguardi, la morbosa inquietudine. Sulla tenera pelle dell’angelico Guido scorrono brividi di paura, d’impazienza e di freddo.»
da L’amore al fiume, Ezio Sinigaglia, Wojtek Edizioni
Sarebbe stato facile e allettante parlare di questo libro, scegliendo bene il momento, calcolando le parole, in modo da contrapporlo a certe, recenti, bieche uscite libresche. Ma sarebbe stato ben triste contrapporre la raffinata scrittura di Sinigaglia allo sguaiato stridere del becero di turno, sarebbe stato come porre tutto sullo stesso piano. Ma il piano in cui si muove il nostro Sinigaglia è ben altro rispetto al chiacchiericcio, all’irrisione, è il piano della letteratura con la maiuscola, che esula dall’immantinente, dall’ora e qui, e si estende universale, oltre le ristrettezze dei temi, nostri, ma anche passati o da venire. Si colloca in tempi e luoghi svincolati dalla loro apparente appartenenza. E così, in un luogo sganciato dalla geografia, e in un tempo che non ha nulla a che vedere coi calendari e le cronache, Sinigaglia ci consente di cedere alle tentazioni della carne insieme ai suoi simpatici bersaglieri. Il luogo prescelto è un campo estivo sulle rive di un fiume che – nessuno me ne voglia – nella mia immaginazione scorre nelle campagne circostanti Lopezia. Il tempo invece è quello ormai mitico del servizio di leva, ferma ormai abolita e di cui sempre si favoleggia: “dopo il servizio di leva i ragazzi tornavano uomini”, oppure “la leva insegna la disciplina e la capacità”, e così via. Naturalmente qualcuno mormora che la leva serviva ai ragazzi per “incontrare” coetanei provenienti da altre città e creare così una sorta di rimescolamento geografico. Quindi, in un tempo e in un luogo tangibili, ma mitici e idealizzati, questi ragazzi possono cedere alle tentazioni della carne, con mille tentennamenti, mille timori ma liberi, soprattutto dal peso delle parole. Perché, se una parola non esiste, o non la si conosce, per designare certe pratiche o una certa inclinazione, allora queste non esistono, non si sa se sono bene o male, quindi tutte da esplorare, in una sorta di limbo della conoscenza. Ed è proprio nei dialoghi che Sinigaglia crea per i soldati protagonisti dei racconti che si avverte l’estraneità dal contingente e la spinta verso un luogo che è patrimonio dell’immaginario; il desiderio è espulso dall’ordinario, non parla la lingua di tutti ma per ciascuno ne parla una tutta personale, che attiene all’origine, all’infanzia. Così i nostri bei soldatini (e che nessuno tocchi il formidabile Giancrì, dal coltello facile, che avrà fatto sognare tanti) approfittano di un non luogo per esternare, attraverso la loro lingua segreta, parlata e pulsionale, i desideri innominabili, ma innominabili perché non se ne conosce il nome, sicuri di trovarsi in una sorta di “sacca” protetta della loro vita: la leva era un evento di un anno che una volta concluso non si sarebbe mai più ripetuto, in un luogo lontano da occhi indiscreti. E soprattutto lontano da lingue (il diavoletto del doppio senso sogghigna) indiscrete, rese mute dalla mancanza del lessico e ingannate da un linguaggio per ciascuno differente. Per cedere alla tentazione non la si deve contrapporre alla realtà o usare come arma di confronto, ma la si deve vivere nel proprio profondo, con la lingua del nostro io, in un luogo dove le imposizioni cessano in una sospensione temporale. Ma questo luogo non esiste mi direte, Lopezia è frutto della fantasia, certo, ma in ciascuno di noi c’è una Lopezia, c’è un campo estivo, c’è la polveriera di Fifty-fifty, basta sospendere il contatto con lo spazio-tempo contingente e affrontare la vita seguendo la propria grammatica interiore, ascoltando quella lingua che è propria, quasi inservibile per comunicare verbalmente con gli altri.
Dunque, ecco L’amore al fiume e altri amori corti, suppongo perché l’amore al fiume designa la situazione di estraneità all’ordinario, in cui mettere in scena la passione, e, gli altri amori, del sottotitolo sono quelli, sei, che compongono la raccolta, corti proprio perché hanno la breve durata della sospensione dalla vita comune, molto efficacemente richiamata dallo scandire del tempo: nella narrazione c’è spesso un richiamo all’ora esatta di quel momento, come se l’orario, il tempo misurabile, fosse una gabbia attraversando la quale, sfuggendo alle sue maglie, il desiderio si libra. Questo giocando col titolo della raccolta, che è anche il titolo del primo racconto che fa da traino agli altri. Ma è proprio in questa iniziale proprietà polimorfica che si inizia a intravedere la bellezza della scrittura di Sinigaglia. «Il bersagliere Patanè, mantenendo in uno stato di perfetta quiete scultorea la sua faccia di pietra basaltica, batte due volte il tacco dell’anfibio sinistro contro la corrispondente gamba anteriore della propria seggiolina di ferro, producendo due sordi rintocchi». Le frasi, le singole parole, sono come prismi che rilucendo cambiano continuamente forma e colore «I due grandi laghi celesti dell’angelico Guido si sono come impietriti sotto i cristalli lucenti delle lacrime trattenute all’ultimo istante», sfuggono allo sguardo superficiale vanno dritti alla mente del lettore. E sfaccettando questi diamanti Sinigaglia li trasforma in tanti oggetti diversi, tutti simili alla realtà ma esistenti solo in realtà altre.
L’autore evoca i mille dialetti d’Italia, vuoi per sottolineare la provenienza dei protagonisti dei racconti o vuoi per sottolineare la singolarità di ciascuno, per farlo ritornare al suo linguaggio originario come sopra accennato. E così il maramaldo Giancrì esordisce con un romanissimo «Ahò, ma che cazzo me pija?». Usato anche per porre il momentaneo e fortissimo desiderio per il commilitone in un luogo estraneo alla sua vita, non è lui a essere così, è un desiderio passeggero che, vista la situazione altrettanto passeggera, si può pensare di soddisfare. E che proprio perché svincolato da preconcetti, darà una ancor più completa soddisfazione al romanaccio. Invece, l’eleganza teutonica di Ulderico – che immaginiamo biondissimo ma dalle gote rubizze per essere stato colto in fallo – gli fa esclamare. «Non folefo tchogare, sercente!». E invece, essendo un bel bambinone un po’ tontolone,i giochi non li capisce e cede alle lusinghe del più scaltro Massei. L’autore mescola le carte dei linguaggi per dare credibilità e consistenza alle persone ma anche a quell’epoca in cui il dialetto era ancora la prima lingua e l’italiano sentito più come una lingua quasi straniera. Ma non sono solo i dialetti a incantare, è bensì tutto il fraseggio, veloce e scattante, con un’ironia sottesa e luccicante, atto a ricreare un’atmosfera da romanzo d’appendice anni Cinquanta: «A queste parole l’esemplare bersagliere Berger si sente pervadere da un tale senso di panico che il suo lucido Garand, già di nuovo imbracciato a spall’arm, prende a battere ritmicamente il suo calcio sfolgorante d’olio di lino contro la natica sinistra tremante». Ma ovviamente ci sono delle pubblicazioni che fanno capolino qua e là tra le pagine, e nei sogni dei soldatini, che vengono continuamente evocate da situazioni, linguaggi, silenzi e sguardi: i celeberrimi fumetti soft (ma anche hard) porn che sono circolati fino agli anni Settanta, circa. Quei piccoli albi disegnati in cui varie categorie appartenenti al fetish (ma che allora non si chiamava ancora così) popolare (camionisti, infermiere, insegnanti e, naturalmente, sprovveduti soldatini di leva) si venivano a trovare in situazioni erotiche più o meno volute. E giustamente anche tra i bersaglieri dei racconti trovano il giusto successo: «Frattanto il romanzetto da nulla, affidato alle affusolatissime dita e al sofisticato occhio critico del sergente Massei, si è rivelato in un attimo per quello che è: un voluminoso fumetto erotico-grottesco della serie Poppea, e precisamente l’episodio dal titolo Il cavallo di Troia». E anche: «Un fascicolo dalla copertina sempre più lercia e dalle pagine sempre più gualcite e qua e là lacunose, della serie ‘La dottoressa’, e precisamente l’episodio dal titolo ‘La dottoressa dei pompieri’ rientri, dopo tortuosi e imprevedibili passaggi». Ed è forse nella sfrontata innocenza di quelle pubblicazioni che va ricercata una sorta di paternità a questa raccolta di racconti; paternità nelle situazioni, ma soprattutto in quella simpatica sfacciataggine, poi soppiantata dalla pornografia, che ha sottratto tutto il sotteso e soprattutto l’umanità, soppiantandolo con corpi patinati e situazioni estreme. E qui mi tocca fare un passo indietro, all’inizio di queste riflessioni, e cedere alla tentazione di porre il libro in parallelo all’attualità per sottolineare che di fronte a una sfrenata voglia di “passato”, ai cosiddetti “valori antichi”, forse la vera soluzione è fare ritorno all’innocenza del desiderio disinibito, al lasciarsi andare alla passione, senza attribuire un nome, dichiarare la propria appartenenza, ma sentendosi parte di un simbolico “battaglione”, quello dei gaudenti.
Un altro grande pregio del libro è quello di prendersi il tempo giusto per raccontare e per godere delle parole, dei luoghi, senza voler fare la morale, senza affidarsi alla scrittura “fast”, al breve consumo; un vero narratore, narra e incanta con situazioni anche minime, gigioneggia coi sogni di un infermiere sovrappeso, o i guizzi della virilità di Baldini. Insomma, è una lettura veramente piacevole e solidamente leggera in cui è bello abbandonarsi al ritmo e all’imprevedibilità delle frasi, in cui gesti minimi, e a volte ripetuti, danno il carattere del personaggio, ma sono altrettanti spiragli da cui prendono il via situazioni impreviste, immagini a volte spiazzanti e cariche di una levità poetica affascinante: «Con una serie di piccoli gesti insieme disarticolati, asciutti e graziosi il sergente allievo ufficiale Massei estrae dal taschino della camicia un pacchetto di Players, sceglie una sigaretta, la batte tre volte sul bianco cartone lucente, la stringe fra le labbra, sfrega un cerino ed accende. Poi, dal centro di un pesciolino di fumo azzurrastro, fa brillare nel campo visivo del capoposto paralizzato nel suo faticosissimo e agitato riposo un sorriso tagliente che non promette niente di buono».
Per finire, il solito rimando proustiano che per un autore come Sinigaglia è sempre in agguato, l’ambientazione fluviale e il casuale scorrere dello sguardo dell’autore che resta celato, rimanda ai famosi “sipari” che di tanto in tanto si aprono su certe situazioni della Recherche e nei quali Proust presenta al lettore delle vere e proprie piccole pièces, terminate le quali il sipario si chiude. E in senso lato il periodo limitato del campo estivo del battaglione Crimea può essere inteso come tale. Ma anche l’assistere casualmente all’amplesso iniziale, còlto sulla sponda del fiume, sembrerebbe rimandare alla scena della profanazione di Montjouvain, in cui uno dei protagonisti più che profanare la memoria del padre profana l’idea che ha di sé stesso, sebbene nessuno creda mai all’amante che dice «A esse onesti, Zanè, nun te posso dà ttorto: pur io, pe’ uno segsi com’er sottoscritto, la farebbe pur io, ’n’eccezzione». Ma di questo aspetto parlerò con Ezio, vorrei chiudere queste riflessioni come si chiude la raccolta di racconti, con un bacio. Perché l’amore al fiume, ma anche altrove, il rincorrere il proprio desiderio o lasciarsene sopraffare, per ciascuno ha sfumature e significati diversi da un rapporto profondo e completo, fino al semplice bacio.

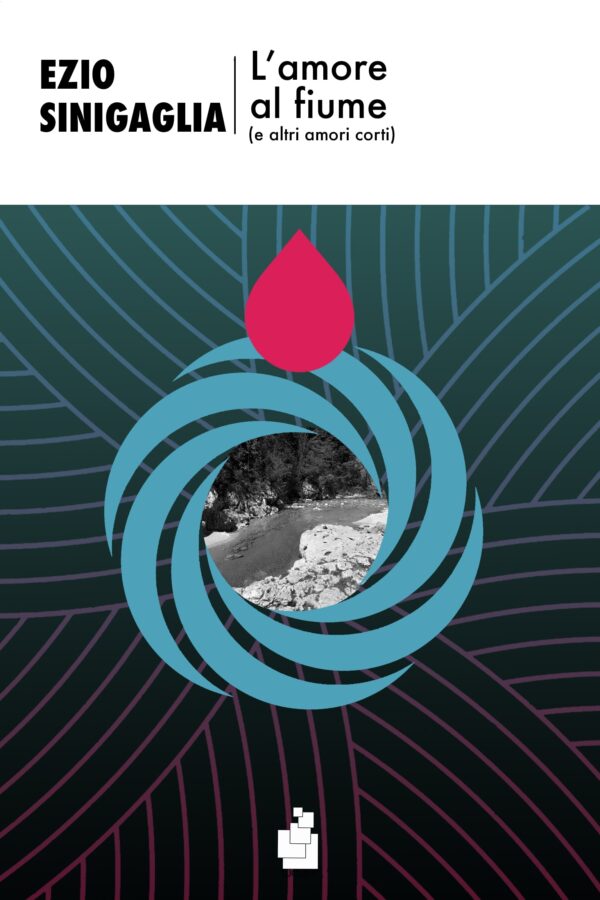

 ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::