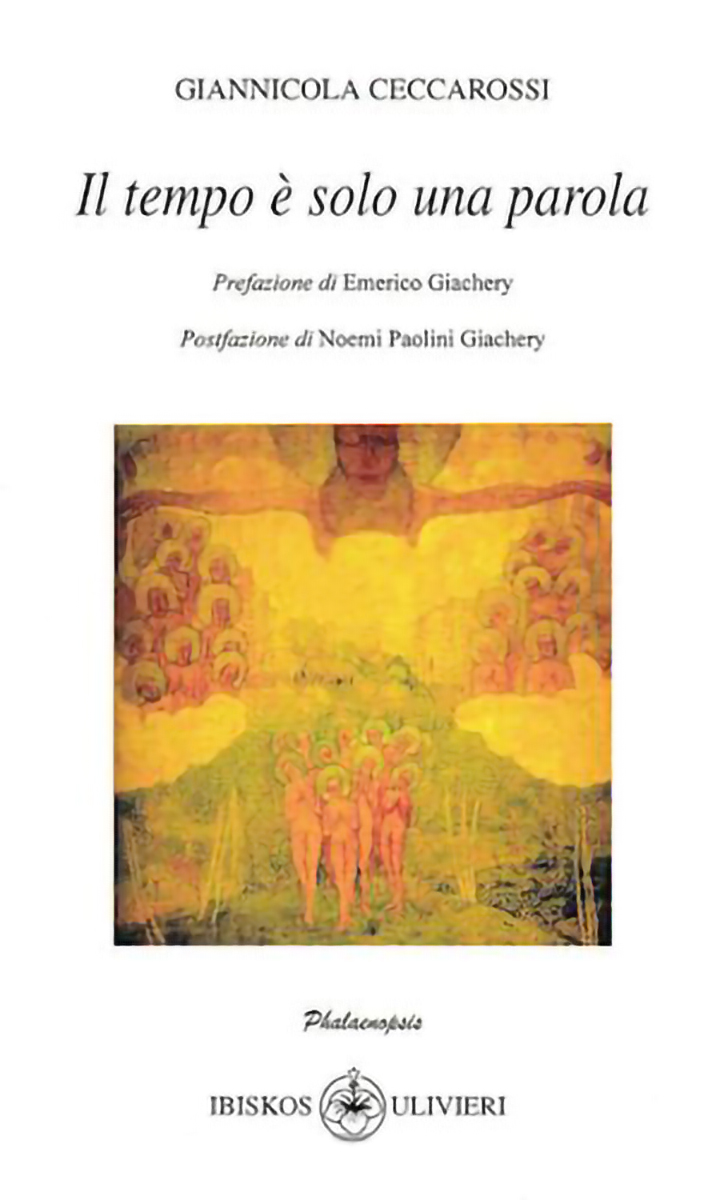Una nuova ennesima grazia ci regala il tempo nella poesia sapiente, perché discreta ed umile nella remissione delle sue interrogazioni, del caro Giannicola Ceccarossi, autore per certi versi appartato ma ogni volta penetrante per una bellezza d’armonia e d’amore rimessa all’interno di un circuito quello umano sovente bloccato, chiuso nella passività del suo buio. E all’insegna del tempo, del suo mistero, del suo appartenerci e superarci e distenderci entro una eternità sconosciuta quest’ultima breve raccolta di una trentina di testi. Riflessione non a caso allora annodato al tema della morte, cui non manca non solo per un’età non più giovanissima (Ceccarossi è del 1937) ma perché saldamente inserito nell’espressione di una esistenza, di una condizione carnalmente, e liricamente, intesa nella dimensione, e nella suggestione di quel limite- da cui appunto la sua meraviglia- trasceso poi nella sacralità di uno spazio più alto che la va a racchiudere. Non a caso, ancora, il testo vien dopo A mancare è il tuo canto, densissimo ricordo in invocazione alla madre, come figura non solo della mancanza ma anche della sponda tra la virtualità effimera dei vivi, di chi resta e di chi, di là da un’angolata nota d’echi infiniti, non cessa, non cesserà di tendersi, e di tenderci nella dischiusa casa di una memoria non più solo privata. Volto caro, mano caro che di qua, nei versi de Il tempo è solo una parola, va a intrecciarsi con quello altrettanto caro della donna amata, della donna di sempre, se per sempre- come qui sembra risalire- non s’intende che un rinnovato e ritrovato distendersi, l’attimo ancora, una parola sola ancora dopo l’ultima forse- come il tempo appunto- ma ontologicamente incisiva a dirci di nuovo seppure nell’illusione, nel dissolvimento poi entro una nebbia cui la natura stessa nei suoi avvolgimenti, e stordimenti ora ci finge ora ci smemora. Così questa poesia che si chiede del dopo sa risolversi nella sola possibilità data (aldilà delle riflessioni stesse, dei tentativi di rimando a chi uomini, donne d’arte e qualunque come lui si son provati all’indagine) quella della sospensione, teneramente perché fragilmente umana (tra “la dimora della quiete/e la fragranza/del basilico”) a cui la fede, di là cristianamente, personale e degli avi, tenta nella consegna, nella sua immagine l’accesso. E sono proprio gli ultimi brani a dircelo, tra gli scomparsi nell’invito a non interrogarci troppo sui loro silenzi, (sono in pace, anche là sorgendo l’alba, spesso mormorandosi “dell’amore/che lega le nostre esistenze/Eterne”) e a credere, a pacificarci, loro stesso soffrendo per le nostre “vite disturbate”. Bisogna rimuovere le pene infatti ci dicono, e si dice, comprende Ceccarossi (“nel passaggio/ da un cielo all’altro” saremo accolti dai volti a noi cari “con molte presenze a cantare”) consegnandosi infine al pensiero del proprio, tra il dolore di chi resta e l’accolto amore di azzurrità di anime appunto a intonare il suo nome. Nella chiave dell’eternità dell’amore, in nitidezza di “pupille dell’arcobaleno”, questa non la risposta ma la consegna nella struggimento, e nella dolenza anche certo, ma nell’aderenza finale a quella vita stessa nelle cui passioni siam stati detti ed abbiam detto in quel mistero che di noi che già sa, ci chiede, non smette- non potendo- di accoglierci: “Ho fede./ È la luce/ che attendo./Una luce/che mi abbagli”.