In un’epoca come quella che stiamo vivendo, la realtà e il sogno sembrano sempre più alternarsi reciprocamente, facendo emergere i fantasmi, disegnando in giorni approssimati la nostra presenza quotidiana. E proprio in questo periodo dove non riusciamo più a distinguere il vissuto giornaliero dall’elaborazione degli incubi, i ricordi del passato dalla scansione di un tempo irrimediabilmente condensato, Mario Fresa ci consegna una raccolta come Bestia divina (La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2020), che sembra stata scritta sull’esperienza di questi mesi.
Invece, i testi raccolti sono stati scritti tra gennaio 2018 e agosto 2019 e la scrittura di Fresa è il frutto di una ricerca lunga e meticolosa. Pertanto, questo straniamento così attuale è nient’altro che la sua evoluzione di scrittore: dagli aforismi degli esordi alla scrittura in versi, fino alle brevi prose presenti anche in questa raccolta. Questo perché la “Bestia divina” di Mario Fresa è il linguaggio. La parola cercata, scavata, distillata, amplificata; una scrittura con cui fare i conti, fino a scontrarsi, prima di riemergere da un momentaneo “svenimento” (non a caso il precedente libro aveva come titolo “Svenimenti a distanza”).
Una scrittura, in queste 34 composizioni, ricca di quelle reminiscenze artistiche, in particolare la pittura e la musica, che non fanno da sfondo, ma diventano elementi delle storie che si susseguono attraverso le immagini stranianti di questi nuovi versi del poeta salernitano.
Il lettore viene veicolato in un teatro dell’assurdo, dove veglia e sogno si susseguono e, proprio come un improvviso risveglio, viene colto, di volta in volta, da uno “stordimento intellettivo”, più che emotivo, con interruzioni dei discorsi avviati dai personaggi, inattesi silenzi, cambi di scena e ritrovati dialoghi.
Risveglio da un’angoscia che si fa dolore «quasi dal niente», scuse che «fanno acqua di parole» di fronte ad una traccia che è già memoria, nello stesso tempo in cui ci troviamo riversati «nell’orrendo viso di terrore» che è la scomparsa.
Da questo vuoto prende forza l’esigenza di nominare, dare corpo alla “materia umana” che popola le sequenze e si manifesta scena dopo scena: Antonio e Veronica, Agnese, il padre o il babbo, Ester, Goffredo, Landi e Francesi, Franz, Luisa, Paola, Anna, Sara, Francisca, Angiola, Nicola, fino a Francisco, che riporta alla mente il pittore Goya, il quale è protagonista di alcune scene che si accavallano, prendendo spunto dai suoi dipinti o da episodi della sua vita. Immagini che si muovono, tuttavia, in “una narrazione poetica che gioca con uno scollamento” – come rileva nella sapiente e puntuale prefazione Andrea Corona – dove il “soggetto del discorso resta il più delle volte ignoto”.
In questi quadri esistenziali «a parlare sono dei personaggi che più che esseri umani sono ipotesi semantiche» – come ci suggerisce in una pertinente recensione Stelvio Di Spigno – i quali «se non riescono a trovare il modo di parlare […] semplicemente muoiono, escono dalla spirale del linguaggio», così il passaggio da un personaggio e l’altro si crea il silenzio, cui segue una scomparsa, uno straniamento con successivo riavvolgimento della narrazione, spiazzando il lettore prima di coinvolgerlo in una nuova dimensione.
Quindi, la scrittura è la protagonista indiscussa. Troviamo soluzioni che vedono affiancare soggetti, o stati d’animo, a oggetti («madre orologio», «forno dolore», «desideri-soldati», ecc.), evocando immagini che emergono da un mondo reinventato dalla vivacità del linguaggio, e che ricorda quella dimensione onirica dell’Alice di Lewis Carroll, o quella favolistica dello Schiaccianoci di Hoffmann.
Una osservazione del mondo che coglie aspetti misteriosi, dove fa da sfondo il nostro bisogno di “divorare”, quali «carnivori e infelici» che popoliamo il pianeta, i momenti della vita (le parole?) e metabolizzarne i significati o crearne di nuovi, ogni volta, perché «ognuno risponde alla fame come può».

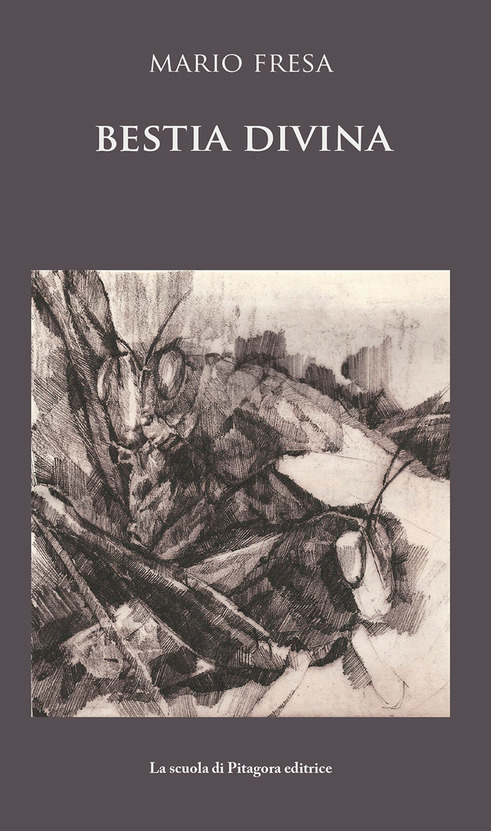

 ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::