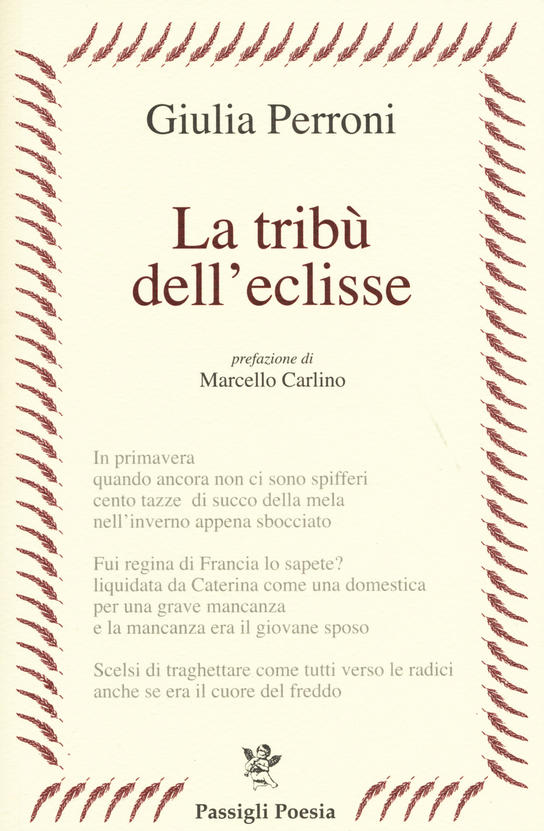Dal suo vasto campo poetico, che non conosce periodi di maggese, perché perennemente seminato e coltivato, Giulia Perroni ha raccolto per il suo ultimo libro una copiosissima messe di versi, di periodi musicali, di strofe anomale ma originali, componendo un ampio disegno, che si offre al lettore come un nuovo e romanzesco genere letterario. Meglio sarebbe dire che ci ha regalato un romanzo poematico in cui un inarrestabile e immane discorso lirico si dispiega come un fiume, che a salti, per rapide e gorgoglianti cascate di parole, scorre secondo un circuito preciso, dando forma alla vita, ai sogni, ai desideri, ma anche alla morte e alle tragedie quotidiane, unitamente ad una serie infinita di perdite e di illusori ritrovamenti. C’è tutto il mondo privato dell’autrice e c’è il mondo circostante, con i suoi bagliori, con le sue paure, con i suoi ineluttabili condizionamenti. Il sostrato è un back ground culturale assai ricco, in cui si riconoscono ascendenze letterarie inconfondibili, da Emily Dickinson (alla quale si deve il titolo), a Ezra Pound e ad altri autori, la cui frequentazione ha formato e influenzato la Perroni. L’autrice nelle note finali al testo avverte che è ben consapevole che il suo io si mescoli a qualche personaggio, entrando e uscendo da esso, ma aggiunge che tutto questo avviene “non senza un’intrinseca ragionevolezza”. E infatti quel diluvio di versi che attraversa il libro, sarebbe farneticante e irrazionale, se non scaturisse da un’osservazione sempre attenta e circospetta della realtà e della propria interiorità, un’osservazione fatta non solo di sguardi penetranti e indagatori, come sa avere colei che nello Scoiattolo e l’ermellino, fissa ed individua una perpetua icona (la Dama con l’ermellino appunto) che ci guarda dall’al di là dell’arte. Tale osservazione è però integrata da una straordinaria capacità di ascolto delle persone e delle cose che sono intorno a noi. Già un’altra volta affermai che ciò che Giulia vede e sente si trasforma in versi, tanto che con Ovidio potrebbe dire quod tentabam scribere versus erat; ora direi che ciò che pensa viene pensato in versi. Lo dimostra la particolarissima disposizione dei suoi versi in questo libro, in alcune pagine in particolare, dove, quasi disarticolati l’uno dall’altro, con intervalli anche di spazio, si rincorrono, come inseguendo un’immagine, come volendo afferrare un’idea, per poco trattenuta e rivelata e subito poi nascosta e superata da altre. Assonanze, rime e ritmi si succedono vertiginosamente creando l’effetto silvae che ben ha segnalato Marcello Carlino nell’ottima sua prefazione all’opera, con riferimento sì alle Silvae di Stazio, ma essenzialmente all’intrico inestricabile e sapiente di pensieri, sensazioni, azioni, storia pubblica e privata, geografia di luoghi e di sentimenti, in un flusso di coscienza vorticoso che si guida da solo tra gli anfratti della poesia.
Dicevamo prima che il titolo nasce da un verso della Dickinson che ritroviamo in una poesia inviata per lettera a Susan Gilbert, sua cognata, moglie del fratello Austin, ma anche sua migliore amica, alla quale spesso inviava liriche chiedendo un parere e un giudizio. La lettera risale al 1859 ed Emily esordisce chiedendo se i versi che le sta inviando siano gelidi: (da The letters lettera n. 238 D)
Springs-shake the Sills- Primavere scuotono le soglie
But the Echoes-stiffen ma - gli echi resistono –
Hoos - is the window - Canuta - è la finestra – e
Numb – the door - torpida – la porta
Tribes of Eclipses – in tents Tribù d’eclissi – in tende
Of marble di marmo
Staples of Ages – have Ganci di secoli – sono
Pucked – there - fissati là.
È ovvio che il significato che la Dickinson dà a Tribù d’eclissi è assai diverso da quello che la Perroni intende esprimere, perché la poetessa americana allude a una certa memoria mitica di quegli antichi che assistevano all’eclisse con spavento, quasi fosse un evento divino, mentre nella nostra poetessa la memoria mitica è rimossa e assente, laddove invece è presente la storia. Si guarda alla Sicilia, e al Meridione in particolare, si allude alle questioni sociali attuali, alle piaghe del nostro tempo, sempre con un’incredibile percezione del dolore e della sofferenza altrui, da parte dell’autrice.
Procedendo spesso per ossimori, tra ombre e luci, chiaroscuri e luminescenze, traspare la realtà contemporanea, con tutte le sue inquietudini e le sue contraddizioni, eppure rifulgono improvvise accensioni stagionali, di primavere e di estati, tra colori e profumi che la poetessa custodisce e serba nel segreto delle sue memorie. Si affacciano talora personaggi, alcuni dei quali non ci sono più, ma hanno esorcizzato la morte e ricompaiono sulla soglia del tempo, in un tentativo di eternità.
In questa ininterrotta confessione di vita vissuta e di poesia pensata, non è facile, né agevole, muoversi per il lettore, che si trova a dover percorrere un terreno accidentato, senza grucce, né aiuti, a meno di non voler immergersi totalmente nel flusso delle parole, lasciandosi trasportare come da folgorazioni di immagini. Infatti è così che si presentano i versi, specie quelli singoli, spaziati dagli altri, come momenti inafferabili, attimi da godere nel suono e nella visività, senza tentare di ricomporli in un tempo unitario. Ci scorrono dinnanzi, nomi, eventi, fatti, temi che a volte appaiono opprimenti nella contemporaneità che li genera; vi sono macerie che la poesia raccoglie e tenta di assemblare, vi sono infiniti rimandi agli orrendi naufragi nel mediterraneo, ma vi sono anche case, di cui è dolce il ricordo, notti di stelle, o giardini fioriti, persone care e volti amati. Si tratta di un lunghissimo monologo interiore che il prefatore definisce oratio soluta nel corso della quale ciò che spicca è la parola, usata come permanente veicolo del pensiero poetante e sempre in ossequio alla bellezza (termine che, com’è stato osservato da Carlino, ricorre assai frequentemente nel libro, come fosse una garanzia di salvezza e di riscatto nel buio dei tempi.
Accade inoltre qualche volta che i versi si raggruppino in strofe più normali e si compongano in un piccolo poemetto nel poema. Vediamone un esempio:
E tanto bella non ci fu altra mamma
non c’era mamma con due occhi verdi
un corpo piccolino sodo e stretto
d’ogni cosa portatrice in tenera abbondanza
di danaro padrona in sicurezza saggia nei giorni…
ma ogni cosa aveva l’ovale generoso del suo viso
che ha lasciato su me come un suo marchio
dio dalle sette balze di corona nel fiume degli inchiostri
Ma quale mostro nello specchio viene
per dire che io sola la frantumo?
Come il vento nel cuore dell’inverno
solo l’acero ha gridi di smeraldo
dentro al monte che suona
o al vento astrale del territorio fermo
Andavi con papà bella e leggera
brillava il tuo bracciale d’oro fino
ingentilito dal muschio delle pietre
Poi mi specchiavo ed io ero più bella,
perché nessuno mai mi rivelava
quel mio ovale perfetto
e i quattro sguardi incrociati nell’iride?
La vetrata lo specchio del giardino
era tutta in un magico perfetto
muta come un traliccio in soffio basso
di misura di tegole
Mamma così gentile come il cielo
che i gioielli officiavano in sereno
nel margine di un volto
“Io mi sentivo niente”.
La poesia continua ma fino a questo punto ci è sembrata una elegia alla madre, nel confronto con la quale, la figlia perde, si sente “niente”. Questo è solo uno dei tanti casi in cui dalla fiumana che scorre nel libro si stacca un poemetto a sé, si raduna un agglomerato di immagini che focalizzano un solo argomento, o meglio un solo vivo ricordo.
Non saprei se definire questo romanzo poematico un diario della memoria o più esattamente un libro della vita, perché l’autrice come tale lo scrive, quasi fosse un suo bisogno fisico di cercare “aria”, di raccontarsi e raccontare, per continuare ad esistere, di abbandonarsi alla poesia come all’unica luce che possa salvarla. E non c’è dubbio che Giulia Perroni cerchi la luce, lo ha fatto anche nelle precedenti sillogi, lo dichiara in questo libro quando dice:
Io ero intesa all’altezza
e le montagne mi chiamavano sempre
mi mancava la luce ed io soffrivo
e non sapevo mai perché soffrivo.
Io credo che un po’ la chiave della sua poesia stia in questa dichiarazione, chi è poeta soffre per mancanza di luce e finchè può cerca la luce.
Questo lavoro, così complesso, così stupefacente per la lingua diluviante e i versi-fiume, ci consegna una poesia della luce, una poesia non velleitaria, che non consola, né conforta, ma che illumina e accende speranze, incoraggia i cuori.