Tra le immagini di “Nessuno in mostra”, esposizione nata dalla collaborazione di LEVANIA e Saaci/Gallery inaugurata ad aprile scorso a Napoli, c’è il volto bellissimo, forse troppo, di una giovane donna, ritratta da Federico Lombardo. È forse l’opera più neutra tra quelle riproposte su questo numero 6 di LEVANIA, dedicato all’autoritrazione/ritrattazione: Picture Yourself. Eppure, forse, è questa l’immagine più conturbante, perduta tra rappresentazioni più scomposte, asimmetrie identitarie. Il bel volto di una giovane donna si afferma qui come l’essenza stessa dell’automarketing, della strategia di mercato che in un modo o in un altro tutti vorremmo poter utilizzare per rappresentare noi stessi; è il totem, la testimonial della nostra campagna esistenziale, che in questo numero si appiana poi in versi e figure ‘poetiche’. Si tratta di aggredire l’insignificanza, o anche dire l’impertinenza di lastre di specchi, per usare le parole di Paola Nasti in uno dei testi introduttivi al numero; l’ambivalenza dell’importanza e della godibile illogicità della profondità della superficie, “insensata” e “insignificabile” come il nostro autorappresentarci, illusorio sempre moderno vizio di forma.
I testi di LEVANIA 6 che seguono sono specchi con cornici asimmetriche più o meno deformanti di un io poetico a volte esplicito, a volte dispiegato in una voce rifratta ambiguamente nelle immagini che li accompagnano, o velata in testi di altri, tradotti o riproposti. Apre Mariano Bàino con inexacta o sulla propria cosa, componimento bistrofico in cui riappare l’“io è un altro”, tra Rimbaud e Foscolo; si assiste al disaccordo cosmico del “punto nerastro” interiore che lotta col mondo esteriore e i suoi eventi ostili, le ingrifate “ombre più grandi del mondo”, l’arrabbiata lotta con un’alterità sociale che ritroviamo molto spesso nell’opera di Bàino. L’io accartocciato sotto il peso del conflitto interno/esterno si acquieta in alcuni componimenti successivi in cui non si scompone ma piuttosto si ricompone nel dialogo col suo ricordo e le proiezioni future. È quanto accade nell’Autoritratto dell’autore da cucciolo mezzo cane e mezzo uomo, quasi una scimmia di René Corona, intento nell’atto di storpiare Dylan Thomas che storpia Joyce. È un autoritratto d’autore con firma soddisfatta, somigliante “per via della sensibilità e della polvere di sole” all’autore. E ancora troviamo il confronto col passato, prose e poesie allineate asimmetriche, infanzia di scuola e quaderni, o di muri e fotografie, i numerosi io degli (Auto)ritratti in un interno di Enzo Rega. Il tempo che si rivive ogni giorno, nel presente, nella quotidianità dell’andare al lavoro, destinazione sopravvivenza, accumulo di futuro e la ricchezza del passato. Nelle Poesie di Antonio Pietropaoli l’autoritratto si fa assonante resistenza alla vita, al suo invecchiamento, tragicomico moricchiare come in Senilità 1; mentre nelle Quattro poesie di Vera D’Atri leggiamo un’identità spezzettata, mossa da “indefinite autonomie” e fatta in un post-maremoto, vegetale. L’autrice è quasi impaurita dalla possibilità delle parole, o dalla loro impossibilità, dalle loro pause punteggiate, entità di risulta di cauta stampa: “sono un viola messo a guardia di rossi e di blu”; eppure questa paura è meno forte di quella primigenia, che è l’anonimato nel caos del mondo, e che obbliga a quest’ordine malvoluto ma necessario della pagina digitale.
A metà volume, separate solo dalle foto di Marco De Gemmis e dai testi di Eugenio Lucrezi, troviamo due traduzioni, quella della colombiana Camila Charry Noriega, in cui ancora la nostalgia e la perdita di una desiderata unità è nella polvere e nella luce che la attraversa, ancora e ancora, un dio leggero (“come se da lei / la fragilità del tutto si potesse scoprire / e il suo attaccamento alle cose più elementari / accentuasse l’abbattimento dei giorni”), eterna sfida della memoria rappresa nel quotidiano del passato, la vertigine “di quello che ti precede”, che permane, che deve permanere; e poi la traduzione dei Two Poems di Deborah Woodard, che ancora una volta ci prospettano oggetti rinchiusi in bauli, e persone perdute (“How could you do anything? You were dead”;“My mother was imagining red plaid, the side we saw it from, the remains / of a different quiet, this sadness as she tied my laces”).
La dialettica con un io perduto si manifesta come morte giocata, invece, nelle poesie di Paolo Valentino, dove la sua Controfigura rende vago il confine tra la vita e la morte, con menzioni pop di cui fa uso anche, a seguire, Emanuele Canzaniello. Le sue Due Imago Christi ci rendono falsate prospettive di pseudo ritratti autobiografici, film e opere d’arte immaginarie di uomini realmente esistiti che distorcono il rapporto di fede tra poeta e lettore, polaroid nient’affatto sbiadite ma anzi colorate di specchi sempreveri e rifrazioni menzognere.
Intendimenti compositi pertengono infine a quella che è forse la parte vitale di questo numero di LEVANIA che affianca, sovrappone, riscrive immagini e parole, a partire dai Due autoritratti di Marco De Gemmis accompagnati da poesie di Eugenio Lucrezi, anch’essi in dialogo con oggetti di nostalgia esperienziale: una camicia a quadri antropomorfizzata e logorata dall’esperienza, l’Autoritratto annientato dall’autointerrogatorio, e l’altro doppio autoritratto, in absentia, con San Domenico Savio, incorniciato dai bianchi pieni della fotografia di De Gemmis e completato da una poesia, forse nostalgica, a un morto giovane, poeta di preghiere. O anche gli sguardi con parole di Daniela Capalbo e Emmanuel Di Tommaso, che misurano parole spolpate da sovrapporre a immagini, entrambe a rischio della perdita di carico semantico, come accade nella “foresta di sguardi” della vita d’oggi, tentando di “sentire” il mondo come Baudelaire, ma allo stesso tempo disciogliendone il significato, quasi ad essere mimetici, invece che fuggiaschi, della società contemporanea.
Gli Undici distici per undici ritratti di Bruno Di Pietro e Luigi Filadoro – ancora numerazione, ancora “ritrazione” – fanno invece implodere la rappresentazione di personaggi storici, tratti e ritratti di uomini e donne “convocati come sacerdoti o coreuti di una danza fuori tempo”; ancora una volta alla ricerca di una unità, forse data proprio dall’accostamento furioso di individualità a sé stanti unite da un trarre di nuovo, da un ritrattare ciò che già è stato. E le anafore con “immagine” di Francesco Aprile, contenitore ancora una volta di quotidianità, materialità, primi piani in cornici di mondo; e Mimmo Grasso, e la sua dedica poetica che ritrae mimeticamente Franco Cavallo, nonsensista, in un gioco, ancora una volta, di io e rifrazioni.
Del resto, l’“autoritratto inciurmato” in copertina di Luigi Sinisgalli ci era stato monito di poliedriticità e ironia semiseria, che troviamo smistate in questo volume: come se per autoritrarsi la poesia necessiti di smantellamenti, e le immagini di serietà. O almeno ciò fanno pensare spesso i componimenti e gli elementi visuali scelti qui dai curatori. Eppure, Levania 6 raccoglie la riflessione sul nostro amore, a volte ipocritamente rinnegato, per l’autoritratto, che è, quasi sempre, tradotto nella nostalgia di ciò che non possiamo esser più. Essere altro da sé, in tempo e parole. Je est un autre, i giovani poeti.

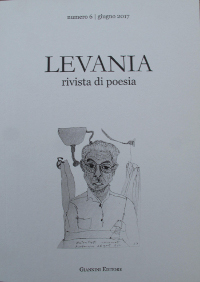

 ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::  ::
::