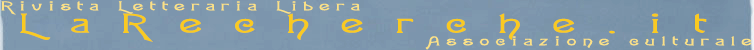Non sugnu pueta;
odiu lu risignolu e li cicali,
lu vinticeddu c'accarizza l'erba
e li fogghi chi càdinu cu l'ali;
amu li furturati,
li venti chi straminanu li negghi
e annettanu l'aria e lu celu.
(Non sono poeta/odio l'usignolo e le cicale/il venticello che carezza l'erba/ e le foglie che cadono con l'ali/ amo le bufere/i venti che disperdono le nuvole/ e puliscono l'aria e il cielo.)
Queste poche strofe da Non sugnu pueta riassumono sostanzialmente la complessa e tormentata poetica di Ignazio Buttitta: poesia è affondare le mani nel cuore degli uomini che soffrono per tirarne fuori tutto il dolore, e nel contempo aprire gli occhi, sciogliere cappi e catene. In una sola
parola la missione del poeta è quella di denunciare gli abusi del potere sulla povera gente, far propri il dolore e la miseria di questa stessa gente – la sua, il popolo siciliano – e lottare al suo fianco, strappandole preventivamente ogni sorta di velo dagli occhi per liberarla innanzitutto dalla servitù dell’ignoranza.
Nato a Bagheria nel 1899, Buttitta fu vicino sin dal 1945 agli ambienti lombardi gravitanti intornoalla redazione de L’Unità ; nello stesso periodo strinse relazioni amichevoli e culturali con Vittorini, Cagli, Bontempelli e Quasimodo. Il dopoguerra lo vede essenzialmente poeta "di piazza", impegnato ed anticonformista, voce di ferro contro la guerra, il fascismo, lo sfruttamento dei lavoratori delle miniere di zolfo; contro i baroni che opprimono i contadini, contro la mafia, contro chi costringe i siciliani disperati ad emigrare, contro chi mantiene il popolo nell’ignoranza per strumentalizzarlo a proprio piacimento. Abusi ed ingiustizie ai danni dei più deboli sono condannati dal Buttitta col duplice intento di fustigare i colpevoli e dare alle vittime il coraggio di alzare la testa: "U privilegiu piaci/ “ sottolinea nella poesia U rancuri, rivolto ai feudatari “ a tradizioni di l’abusu/ a disumanità/u sfruttamentu piaci/ l’aviti nto sangu;/e vurrissivu ristari a cavaddu/cu elmu e
scutu/e li spati puntati;/crociati di l’ingiustizia,/ a massacrari i poviri." Poi, con ironia tagliente: "Io vi considiru… sunnu i braccianti chi v’odianu" arrivando al paradosso di un plebe stracciona ed invidiosa, rea di insidiare la tranquillità di antichi privilegi che nessuno da secoli ha mai dovuto mettere in discussione. La poesia di Buttitta diventa così lotta, riscatto, liberazione, voce del popolo che soffre perché oppresso e sfruttato. Naturalmente questa peculiarità nell’opera del Nostro non è
nata con le opere giovanili, ma è piuttosto l’approdo di un lungo processo di maturazione culturale e politica, una presa di coscienza, insomma, che ha preso forma negli anni. Un sentimentalismo manieristico, con richiami dannunziani alla vita pastorale contraddistingue, ad esempio, il poemetto Marrabbedda, pubblicato nel 1928: in esso la partecipazione intima alla vita dell’umanità oppressa non si delinea ancora con efficacia, e resta ancora sui generis, come uno sfondo piuttosto sfuocato.
La forza ideale delle opere più mature si avverte a partire dal 1954, con Lu pani si chiama pani, cui faranno seguito Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali ( 1956), La peddi nova ( 1963 ), Lu trenu
di lu suli e La vera storia di Giulianu (1963), Io faccio il poeta (1972), Il poeta in piazza (1974), Prime e nuovissime (1982), Pietre nere (1983) Colapesce (1986).
Un pessimismo esistenziale permea fortemente tutta la produzione di Buttitta, il quale intende sempre porre in primo piano la tragicità del destino dei protagonisti, quasi sempre braccianti, contadini e minatori: la lotta per il pane e la libertà è estenuante, sofferta e spesso infruttuosa, ma sempre animata da una speranza vibrante e comune a tutti.
Qualcuno ha accostato la poesia di Buttitta a quella di Majakowskij e di Neruda, nonchè alla mistica francescana: Buttitta stesso ha smentito queste voci richiamandosi al verismo ma soprattutto ad un percorso formativo tutto personale, che attinge alla tradizione dei canti popolari siciliani e alla verità del sentire – e del parlare, come testimonia il vivido dialetto da lui impiegato – del popolo siciliano. E quanto egli senta seriamente questo ruolo di vox populi lo testimonia uno dei suoi più tipici detti: "Chi mi cuntati?/Io u pueta fazzu!" come a sottolineare ironicamente che il poeta non parla, dà semplicemente voce a chi non può parlare.
Donatella Pezzino
(Versi d'apertura tratti da Ignazio Buttitta, Io faccio il poeta. Con prefazione di Leonardo Sciascia, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 37.)
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Donatella Pezzino, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.