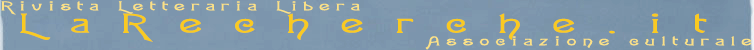In un'epoca come la nostra dove tutto è merce e il discorso del capitalista (J. Lacan) domina le nostre vite senza che ce ne rendiamo conto; in un'epoca come la nostra dove la tecnologia non è più servizio ma padrone e investe la nostra inconsapevolezza assimilandoci allo strumento di turno, l'arte – che dovrebbe costituire baluardo certo (d'incertezza) – è asservita a sua volta alla logica spersonalizzata e spersonalizzante della merce e si trasforma in oggetto di esibizione, di potere, di violenza contro il senso nascosto all'interno di uno stupore che non suscita più.
Dove, all'interno dell'arte, un segnale di resistenza, un rimando a un altrove scomparso, a un senso sommerso che ci protegga dalla banalità del letterale; dove la meraviglia e il vuoto, da riempire di vissuto straordinario (al di là dell'ordinario)? Dovremo forse comportarci come quel personaggio di Bernhard che ogni mattina si recava al museo, sedendosi sempre di fronte allo stesso quadro (T. Bernhard, Antichi Maestri)? Sarebbe inutile: quel personaggio non ne traeva altro che la ripetizione vuota della vita.
Dove, allora, un moto di resistenza, se l'arte stessa si trasforma in espressione del banale, ripetitività e apologia della catena di montaggio (Warhol) in cui noi stessi siamo inseriti?
Eppure l'arte non è quello che la abbiamo fatta diventare; siamo noi che, con la nostra visione asservita, la riduciamo a quei termini minimi. L'arte allora reagisce. Come? Se osserviamo la sua espressione, ci accorgeremo che è vuota.
Si guardi, ad esempio, Hopper che, nelle sue tele, riproduce la paralisi del tempo e il nostro esservi invischiati senza averne coscienza. L'arte reagisce allora con la violenza di un'espressione diventata muta che comunque parla per chi la sa ascoltare. Il suo “altrove” si impone, proprio di fronte a noi che siamo “qui”, in un luogo strettissimo, del tutto insufficiente. Tuttavia, per rintracciare un “altrove” che rimandi a un senso occorre interrogare. Dove l'assente? Forse in una presenza che è soltanto apparente mentre, in realtà, restituisce altro.
Si prenda Van Gogh, “fino al terribile quadro finale, l'autoritratto, l'ultimo, quello in cui Van Gogh è assente, ma in cui parlano in modo terribile le sue tracce che si scavano in esso” (F. Rella, Forme del sapere). La sua è una presenza “assente”, rivolta altrove, ma non verso l'infinito: ci ricorda la morte.
O si consideri l'opera di Kafka. Come scrive Adorno “Da nessuna parte in Kafka traluce l'aura dell'infinito, da nessuna parte si dischiude l'orizzonte. Ogni proposizione è letterale, ogni proposizione è significante. Le due cose non sono fuse, come vorrebbe il simbolo bensì separate da un abisso. E da questo abisso barbaglia il crudo raggio della fascinazione” (Adorno, Appunti su Kafka).
Dunque, arte rimanda a abisso. L'abisso non è riducibile a concetto; occorre una visione diversa.
“Si considera un oggetto da molti lati diversi senza comprenderlo tutto – perché un oggetto preso in tutto il suo insieme perde di colpo il suo volume e si riduce a concetto” (Musil L'uomo senza qualità). Sembra allora che anche la presa di coscienza di un oggetto (artistico) sia insufficiente e ne stravolga il messaggio riducendolo ad un unico aspetto. Come procedere?
“... il saggio procede in questa resistenza al concetto frantumando l'oggetto stesso, frantumando ogni pretesa di totalità e compiutezza... L'oggetto verso cui il saggio si china viene scheggiato. La sua superficie è incrinata. Di lì esso si sporge verso chi lo interroga e di lì entrano in lui le domande che di fronte ad esso si sono generate. Le domande si incorporano così all'oggetto, ed è questo che ora ci interroga: interroga noi che lo interroghiamo” (F. Rella, op, cit.).
Cosa ci chiede Pollock con i suoi “paesaggi neuronali”? Cosa ci chiede Rothko con le sue “finestre” aperte sull’interno? E Kline, con le sue linee nere in campo asciutto, dove ci vuol condurre? Forse verso domande.
Cosa ci chiede l'oggetto (dell'arte)? Di non ridurlo a cosa, a oggetto di mercato. Di ascoltarlo e, facendolo, ascoltare noi stessi, lasciandoci penetrare dalla sua incompiutezza per compierlo, generando in noi un vissuto significante che la coscienza tradurrà in significato. Da informale a forma e da immagine a parola.
Il potere costituito, oggi la finanza e il denaro, ha sempre tentato di assimilare l'arte ai propri canoni. I potenti della terra si sono sempre circondati di artisti da ridurre al proprio capriccio. Spesso ci sono riusciti, spesso no. Caravaggio ha dipinto il “sacro”, ma rivestendolo di un umano
dissacrante che non si lascia ridurre a semplice contemplazione metafisica. Michelangelo è stato costretto a piegarsi al potere del papato, ma ha dimostrato, in un contatto ineludibile, che Dio ha bisogno dell'uomo per esistere.
Il potere, il Leviatano, pretende che l'arte vesta i suoi stessi panni e si lasci comprare. Spesso ci riesce. “Eppure, anche appese alle pareti di un museo, le opere di Francis Bacon o di Mark Rothko continuano a proporre un'altra storia rispetto alle narrazioni omologanti. La scarnificazione di Alberto Giacometti ci riporta comunque a un livello dell'umano abissale” (F. Rella, op. cit.) e dall'abisso, come abbiamo visto, sale una domanda che chiede di essere interrogata. Non ci si siede a contemplare un'opera o a leggere un libro; si lascia che essi ci contemplino e ci leggano, per quanto quell'operazione possa risultare “perturbante” (S. Freud), come sempre dovrebbe essere un dialogo.
In questa nostra modernità senza senso, che uomo siamo diventati? Deleuze risponde che siamo “macchine anonime, macchine desideranti, macchine molecolari e macchine del potere (F. Rella, op. cit.). Macchina allora l'arte, ripetuta meccanicamente, metodicamente, messianicamente sul dio senza nome della rete, in attesa di un consenso che non si rifiuta mai.
“E alla fine”, scrive ancora Rella citando Deleuze, “un processo di disumanizzazione: il gioioso divenire altro, il divenire inumano dell'uomo”.
Il moderno, con tutta la sua sterilità, non nasce oggi; si tratta di un processo lungo che viene da lontano e che qui non posso riassumere. Basti dire che “Benjamin, attraverso Baudelaire e la Parigi del XIX secolo è penetrato nella cultura e nei linguaggi del secolo XX, è ha proposto una visione della storia e del tempo e della redenzione di ciò che ci è stato sottratto, che ci si propone ancora oggi, nella nostra modernità estrema, come un compito” (F. Rella, op. cit.).
Scrivere è camminare, il cammino della riflessione.
Riflettere è un sobborgo. Ci vivono i delusi. Raccontano frammenti; non li ascolta nessuno.
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Giovanni Baldaccini, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.