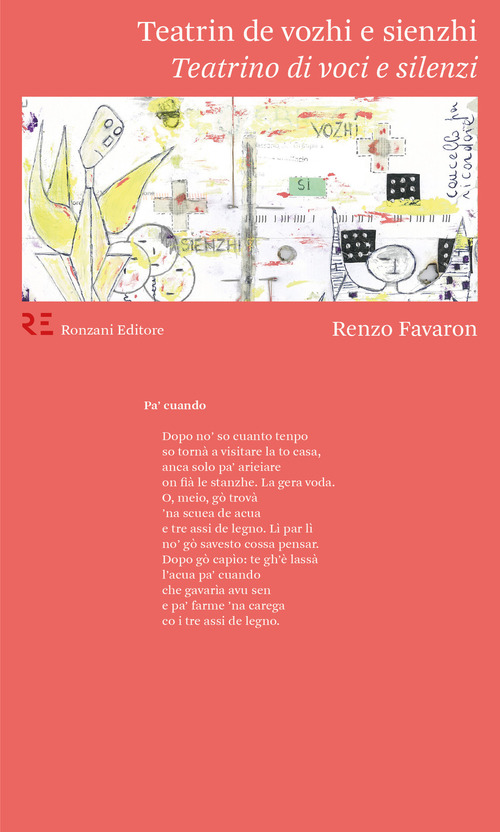Classe 1958, poeta e narratore veneto bilingue, Renzo Favaron è da annoverarsi tra gli autori neodialettali più rilevanti e incisivi del nostro paese in una produzione oramai trentennale nell’uso di un veneziano sapientemente dosato nella coscienza di sé e del mondo secondo la cronistoria della sua scelta come espressione di una storia personale vissuta sofferta e pensata in dialetto , e nella consapevolezza allora dell’insufficienza dell’italiano stesso in quanto lingua già pronta, e dunque meno malleabile, a dire compiutamente ciò che si deve, ciò che è. Una lingua la sua “distillata e duttile perfettamente radicata nel territorio” come ebbe a rilevare la critica, ma appunto costruita nel tempo e per questo perfettamente salvaguardata nei riferimenti a morire delle antiche parlate in quel restare là dove quello scomparire significa anche lo scomparire stesso, antropologico, degli uomini. Questo appunto a riferire un continuo far di conti coi limiti di una condizione allargata e più universale di limite, di prova nel concreto dettato di un quotidiano svanire e un quotidiano incarnare, e dunque anche di un quotidiano perdersi, in questo intenso volume riportato alla dimensione luttuosa della definitiva assenza, e dunque allora, anche (nonostante i tentativi e forse gli infingimenti) al prossimo scacco della parola a dirlo, e a dirsi. La scomparsa, la mancanza al centro della narrazione è quella dell’amata madre ma non nella freschezza della perdita piuttosto in quella per certi versi più risonante perché ormai saldamente incorpata nell’anima del tempo lungo, dieci anni, e di un pensiero come già da primo testo che non sa rispondersi se non nell’immagine di una ferita ancora aperta. Il racconto allora è quello di un orientamento con la quale si cerca di venire a patti nella consapevolezza di un passato e di ciò che poi è seguito che non si può sciogliere. Così a seguire, nel partecipato e sofferto riconoscersi entro cui il lettore è come strattonato, è tutto un lottare con se stessi e con l’immagine dell’altro e di una figura che si vorrebbe per sempre, pur nell’assenza, nella struttura, nell’idea relazionale del tempo antico ed invece riportato a una dimensione di cui nulla sappiamo e dunque nella vanità adesso di una memoria i cui dialoghi nell’intento di trattenere finiscono col cedere piuttosto all’illusione di un soliloquio che rimanda sempre le stesse immagini, sempre gli stessi toni e una voce che non è altro quella dei nostri echi interni, delle nostre irredimibili paure (d’altronde il ricordo come gli ricorda la stessa madre è anche un’erba amara). Come è straziante allora questo avanzare e retrocedere nello stordimento sotto i colpi delle rassicurazioni e dei reclami circa le proprie abitudini di sempre dove a imporsi sovente è la forma reciproca della lettera in cui a dominare è la realtà di non sapere più chi si sta pensando, se è giusto come è giusto fermarsi al ricordo o lasciarlo andare, rinascere con esso col rinnovamento stesso dell’altro in quella dimensione di cui però non sapendo nulla non resta che il pungolo e lo sforzo della parola, nella sua accezione pienamente umana dell’imprimere e del dilatare cui forse solo il dire della poesia per sua natura potrebbe anche nell’abbandono dare meno condizionante accesso. Ed è allora in primis una parola che nell’attraversamento della carne, e non potrebbe essere altrimenti, affonda e ritorna nei luoghi e negli spazi di sempre, nei frammenti delle cose dove la vita quella vita che ancora ci parla appare ferma e ancora sospesa tra il dire e il rimettere, tra la pronuncia e il trasfigurato silenzio entro una insonnia che non è poi solo del corpo ma quello di un abbandono entro una quinta senza più copioni, attori soli adesso in una parte di cui non si sanno perché non si hanno più le battute e le controparti a cui riferire. Dunque è questo il teatrino di cui Favaron ci parla (“teatro de on scherzho infinìo/’ndove no’ resta che le parole/e ’na vozhe distante” “teatro/di uno scherzo infinito in cui non restano/che le parole e una voce distante”), in un cambio di scena di palchi separati, i cui protagonisti sembrano inseguirsi oltre il buio del velo nella non comprensione di lui dei suoi fantasmi. Allora è tutto un dire con noi a voce alta come a chiamarsi a liberarsi già nella condivisione molto classica e quasi terapeutica della propria passione, della mortalità non solo di una condizione ma soprattutto di legami. Voce voce voce, quella del figlio a spiegarsi a cercarsi e a cercarla, quella della madre ad acquietarlo e a rimandarlo nella direzione più sana dell’avanzare (“vivare male/ el to tenpo, xe vivare/male el tenpo passà/(...)/el sole cresse in avanti” - “vivere male il tempo/ presente, è vivere male/ il passato. (...)/il sole cresce sempre in avanti”), e quella del nostro essere uomini e donne alla ricerca di un senso in quella solitudine che più ci appartiene nel profondo e che non sappiamo portare, in quel silenzio a cui non sappiamo affidarci ma che potrebbe salvare nel nostro gioco di proiezioni. Così se la madre non può tornare, il figlio può ridurre le distanze buttando la parola dall’altra parte traendo a sé di nuovo come da rete ogni riflessa immagine in questa distesa di un’Ade sotto una luce che non cambia mai, di figure evanescenti ma non nella stessa consistenza e stabilità di relazione, la cui unica occupazione nel racconto della madre è il camminare continuamente in una direzione sola non conoscendo la meta nella visione di una fine (a partire da quella del marito Giovanni) che avviene per decomposizione (tra il gassoso e l’acquoso in cui è possibile scorgere fattezze e parte di una natura vegetale). Una seconda morte dunque (in una evocazione fortissima acutamente affidata nel legame di condivisione e potere proprio della scrittura alle parole di Thierry Metz, poeta che toltosi la vita alla morte prematura del figlio di là vaga alla sua ricerca) in una meditazione che in qualche modo non lo vince né può un’impossibile pacificazione in una quinta che resta ma pure lo rinsalda nella consapevolezza adesso di una memoria che sfronda, va a toglier via come nell’opera di uno scultore ciò che non serve, ciò che è inutile. Nel ritorno ancora, anche, di un eco paterno sul senso di una universalità di buio da cui tutto nasce, nel contrario della visione (noi di qua, noi di là, nelle nostre reciproche condizioni) dell’impossibilità di vedere nei nostri cuori, sempre che qualcosa da vedere ci sia: “cue’o che ghe xe de acessibie/xe inpensabie. E inaferabie” (“Quello che c’è di accessibile è impensabile. E inafferrabile”). L’eredità allora resta, deve restare, nella parola stessa nel suo fiorire, nel suo smentire del silenzio l’azzeramento passivo, nella misura allora sì di spazi di nuovo colmi laddove è possibile sempre ogni comprensione di ciò che è, di ciò che è stato. Questa è la nostra consacrazione, e questo anche è stato in questi versi nella carne e nella densità di una scrittura la cui forza, in questo veneziano (come da qualcuno sottolineato) di “coloritura occidentale”, è nel corpo di una materia incandescente nell’umile remissione di figlio - e di uomo - a fronte di un mistero più grande che quella stessa parola dalla terra trasfigura e, nella terra, raccogliendo, seminando supera.