Autore autorevole, giornalista, con alle spalle un'esperienza pluridecennale in poesia (con alle spalle una dozzina circa di titoli dal lontano 1983) Nicola Romano in quest'ultimo lavoro cerca appunto un appiglio, perdonateci il gioco di parole ma è dovuto, tra le voragini e i vuoti di una contemporaneità cui la stessa poesia sconta una separatezza ormai definitiva entro una realtà senza appelli, senza voci e suoni che ancora potrebbero dirla, inciderla in un dialogo a ricucirne in qualche modo possibilità ed incontri. Eppure derive e infingimenti, istanze e logiche di cabotaggio e sentimenti vengono qui nella prova dello scioglimento interrogate alla luce aurorale, sempre, e autorevole di autori più o meno illustri della tradizione poetica italiana (dal novecento ad oggi) dalle cui citazioni in esergo in ogni brano Romano prende spunto (servendosene nell'impianto del discorso) nel gioco dei rimandi. Nella densità del dettato la scelta stilistica, riuscita, è nell'uso di un settenario agile, secco, funzionale nel saper "radunare al meglio le parole", nel loro ascolto nella consapevolezza dello spiazzamento di fronte al male del mondo. Il tono, "a metà tra il calligrafismo e la didascalia stilizzata" (come ricorda Giorgio Linguaglossa nella prefazione) va a rivelare verso dopo verso una dolenza di memorie nella deriva, di nostalgie e malinconie cui si tenta un qualche impossibile distacco- e rinascita forse- se non come ramo annodato e rimpattato al fusto "ed i suoi bracci in fiore" entro una via non prevedibile (e per questo destinata all'esclusione). Nella consapevolezza di una cronaca "ruffiana e ammiccante" che più che dire confonde la verità del tempo, di gioventù offesa, di aghi e polvere che restano sul volto e di una poesia ridotta a mero idolo di se stessa ("E i poeti non hanno più canti/ non un messaggio di gioia", nel riporto da Padre Turoldo) seguire i guadi, gli appunti e le tracce sembra la sola strada per non sviare e rimettere in chiaro ( nel mistero che "dal cielo bucato/(..)/ sgronda") "quella sequenza d'occhi/ smarrita fra le scale". L'arma, però nel rovesciamento è anche quella di una ironia come "strategia di sopravvivenza" verso il "reale" (ancora Linguaglossa soccorrendoci), come per venirne a patti nella distinzione delle distanze. E allo stesso tempo, aggiungiamo noi, per meglio illuminare nelle certezze ( la famiglia , l'eros, la casa stessa nelle sue memorie - seppure nel pericolo di una suggestione che può chiudere al mondo) le figure, i soloni "carichi di dottrina" di una realtà che appunto non più incarnando nega allo sguardo storie e dolori sottaciuti ("sicuri che sia il nostro/ cervello in esilio"). Il coraggio più grande è, resta la fedeltà a se stessi nelle lusinghe del quotidiano giacché ad altra libertà ci chiama l'anima "per godere in pace/il dono dei risvegli" nel solo tempo di una natura e di una Parola che unica "patisce e cede come/Elica quando cede il gelsomino" ("La ginestra alle scarpate"). Intanto però quel tempo e quella parola va custodita e per quanto dato raccontata nella cronaca di giorni che devastano e così ecco nel dire fulminante dell'Haikù i quaranta movimenti della seconda sezione ("Dimmi se hai Kuore- cronachette ferali") gli eventi grandi e piccoli, personali e della storia, riportati nel segno di una violenza, di una solitudine e di una indifferenza che non risparmia e dove l'andamento surreale e quasi canzonato assume il sapore indistinto dell'azzeramento. Nella raffinata ricchezza di una lingua e di una radice forte nel suo stare nel transito come "morto a galla" il lascito è dunque nella rimemorazione di un'offerta non più così ovvia:" "Diventa ricco/ di gesti e di parole/le tue monete", Romano forse rispondendo dapprima a se stesso nell'imperativo a quella interrogazione inseguita nel testo: "Ma quando torneremo/ al centro delle cose/ dentro quel solco antico/che luce diede al mondo?".

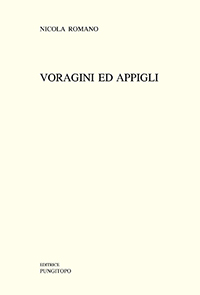

 ::
::  ::
::