A pagina 47 del suo “Il bosco, il mondo, il caos. Come un romanzo”, Stefano Lanuzza scrive: “La poesia, quella vera, dovrebbe spaventare il lettore”. Questa citazione parrebbe inadatta a Sensibìlia, se non fosse che l’autrice attinge a piene mani, per fare avanzare il plot del suo romanzo, alla metafora (ossia alla figura poetica per eccellenza), che raggiunge il suo vertice inventivo nel capitolo VII, il cui stesso titolo: “Metafisica delle narici” favorisce di per sé un approccio tra il surreale e l’onirico.
Ciò premesso, “la poesia narrativa” della Davinio fa davvero spavento, e per il linguaggio crudo, violento, ossessivo, e per l’estremizzazione delle situazioni, e per l’intricato, spinosissimo roveto dei sentimenti, che contribuiscono, man mano che si procede nella lettura, a suscitare un inquietante e sconvolgente sentimento di identificazione con Luna/Carmela.
E non tanto perché le sue vicende possano più o meno coincidere con dei fatti strettamente personali, ma perché esse costringono il lettore a porsi di fronte a quel periclitante e oscuro confine tra bene e male, da cui difficilmente ci si ricorda di essere abitati, una volta messa a tacere la bestia sotto un cumulo di perbenismo morale, di comportamenti piccolo-borghesi, di consunti e abitudinari meccanismi del pensiero.
Luna/Carmela, binomio di “volgare” terrestrità e di metafisica angelicità, rompe gli argini fra il bene e il male: l’amore, dal quale è spinta ad agire, vittima e carnefice allo stesso tempo, origina un sorta di orgasmo mentale che, causando la perdita di ogni controllo psichico-emozionale, determina, a sua volta, una spirale inarrestabile di eventi sempre più malvagi, che ha come punto intermedio l’auto-annullamento nella relazione con il partner e come conseguenza ultima la nientificazione dell’esistenza personale e della vita, in genere.
La Davinio rivela una precisione chirurgica nell’affondare il suo bisturi all’interno di una psiche ormai surriscaldata da un pathos autodistruttivo, all’interno del quale l’emozione più sconvolgente è il piacere del male, che, in genere, costituisce un tabù narrativo: pochi scrittori vi si sono cimentati con tanta lucidità, specialmente quando si è trattato di raccontare il piacere legato ad un rapporto sessuale deviato, al limite dell’aggressività e della pornografia.
Maestro di quest’analisi in ambito letterario è certamente Sade con Le 120 giornate di Sodoma. Teorico Freud: “La natura umana è molto più estesa, nel bene e nel male, di quanto si creda” (in Io ed Es).
Già Caterina scriveva in una sua nota a Il Libro dell’oppio: “Di certe malattie del corpo e dell’anima forse è meglio non parlare, dissimulare, non turbare la suscettibilità di chi al mondo riesce a dipartire con tanta sicurezza il bene e il male, la salute e l’afflizione, il paradiso e l’inferno”.
Ed è questo la cosa che spaventa il lettore: che questa duplicità, questa relazione capovolta tra bene e male diventi per chi la metta in atto, come la protagonista del romanzo, una sorta di norma, fino addirittura a rivendicare per sé una bellezza del tutto autonoma dall’etica, in una sorta di ideale tragico che qualche studioso di psicoanalisi ha voluto vedere come una copertura del ritorno al vecchio ed ormai espulso “senso di colpa”.
La protagonista di Sensibilia non riesce, però, ad eludere del tutto questo senso di colpa, che la Davinio indaga con una correttezza e profondità analitica, le quali presuppongono un’ampia cognizione dei meccanismi della psiche umana e, prima di tutto, di se stessa.
Per dimostrare la “normalità” della deviazione, la Davinio sceglie una protagonista nient’affatto eclatante: Carmela non è più giovanissima, né particolarmente bella, ha perduto la madre, una sorellina, il gatto amatissimo, vive la sua condizione di moglie senza gioia, senza una soddisfacente sessualità, è mediamente colta, ama la musica classica e soprattutto Mozart. Eppure, dopo l’incontro con il signor X, si trasforma in un una sorta di “macchina sessuale”, inseguendo la “bestia” del suo io, tragicamente, teneramente, ossessivamente, impudicamente, distruttivamente, ma senza raggiungerlo o raggiungersi mai. Forse perché da questo sbilanciamento dei “sensi” sembra fuoriuscire, insieme alla sorveglianza dello spirito, ogni possibile interezza dell’io.
È interessante che il romanzo divida le sue sequenze narrative in sette capitoli: sette – si è portati a pensare- come i vizi capitali, sette come l’insieme di virtù cardinali e teologali, a ribadire la violata relazione fra vizi e virtù. Forse. Ma, ancora più veritieramente, sette in quanto somma dei cinque sensi: dell’udito, del gusto, della vista, dell’olfatto, del tatto (ossia le vie percorse in incessanti tragitti dal bene al male, dal piacere alla sofferenza, dall’eccitazione alla depressione, essendo il corpo la sola mappa del viaggio d’ogni vita), e di due sovrasensi, indagatori dell’invisibile e dell’immateriale. Se, poi, si ricorre ad una lettura metaforica, il sesto senso è quello che percepisce il nulla, anzi, è il nulla stesso; il settimo è quello della parola insensata, e, dunque, in modo particolare della poesia.
È, infatti, sorprendente, come all’interno di una vicenda patologica e affannata, la teorizzazione poetica trovi tuttavia il suo spazio attraverso un uso abbondante della metafora: il senso del male è percepito dalla protagonista come “un roditore che mi squassasse all’interno, che mi sguazzasse nelle mie viscere e nel petto”; il doppio nome della protagonista, come si è detto, allude alla doppiezza della natura umana; la bocca è “quella Grande Porta della Città di Kiev”, da cui sgorga, secondo la definizione di Hölderlin, il linguaggio, dei beni il più pericoloso”. Anche la ciliegia che rappresenta il gusto, è figura dell’Eros, “parola enigmatica di un dio al cui suono insolito si può uscire di senno”.
Potremmo continuare così, ricordando l’allusività del nome (Guazzo) del paese in cui Carmela si ritira con il padre per trovare un suo equilibrio, e che “il brillio di smeraldo” delle mosche carnivore è il colore della morte. E andare avanti e trovare altre metafore fino all’ultima pagina, ma senza la potenza visionaria che possiede quel Naso che ,come un personaggio del tutto stravagante ed enigmatico, all’interno di uno stato delirante della protagonista, dialoga con lei proponendosi come emblema della transitorietà della forma e della vita, dell’eterna presenza della morte, del nero abisso a cui convergono i fori oscuri delle nari attraverso le quali trascorre l’inconsistenza del respiro.
E ci sarà un motivo per cui proprio le narici parlano di poesia, esclamando: “Che sarà mai la differenza, che recita l’impossibile! Via via! Il dente è tolto, il dado è tratto, l’anima è resa e il poeta…È fregato!” e ancora: “Così la poesia sarebbe un’estrema padronanza, ma pure un’inattesa, sorprendente sottomissione alle intemperie dei linguaggi; si rimane totalmente schiavi della libertà, solo bendisposti a tutti gli incontri, alle occasioni. L’occasione è un orecchio predisposto al ritmo; si accetti di compiere il misfatto e di rimanere impuniti.” E, poco più avanti: “È questa l’arte? Una confusione sensoriale …strutturata?”.
A me sembra che proprio questa confusione sensoriale strutturata, che è la poesia, come ogni altra forma d’arte, costituisca l’appiglio grazie al quale Caterina si salva dalla morte fisica: durante il suo sonno comatoso, è Mozart, infatti, con la sua musica a sottrarla al nulla fino a riportarla alla superficie della vita in una stanza d’ospedale in cui persone e cose del suo passato “borghese” si fanno guardiani della sua “salute”. Incapaci , però, di colmare quella solitudine che rimane la sola compagna dopo un così feroce attraversamento dei territori del male.

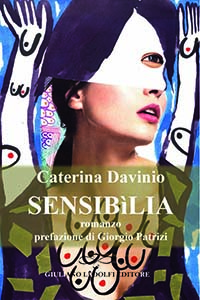

 ::
::  ::
::  ::
::  ::
::