Da più parti è stato detto come la poesia di Alberto Toni sia di difficile collocazione nel novero delle pur sbagliate approssimazioni, che tendono a incasellare i poeti in qualche corrente poetica o di pensiero, come pure in qualche scuola. In effetti, pur facendo parte della scuola romana a datare dalla seconda metà del Novecento, con intonazioni molto vicine alla sobrietà linguistica dei neo-classici, e pur avendo riferimenti forti, a detta del poeta stesso, con Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Vincenzo Cardarelli, Andrea Zanzotto, Vittorio Sereni, Amelia Rosselli, Elio Pagliarani, Sandro Penna, Yves Bonnefoy, Elio Pecora, Mario Benedetti, la poesia di Toni sfugge a codificazioni di siffatta specie, soprattutto per il fatto che, come gli viene unanimemente riconosciuto, ha una sua propria originalità di timbro e di intonazione, che tra l’altro, come dice Santagostini nella Prefazione a Vivo così, il libro di cui ci occupiamo qui, si esplica in una modalità di genere che è a cavallo tra lirica e epica. E nella dimensione lirica, qui lo dico e qui lo nego, perché sarebbe necessario un dovuto approfondimento, mi sembra di poter cogliere alcuni tratti della poesia di Toni affini alla poesia di Milo De Angelis. Poesia di difficile collocazione questa, pertanto, così come di difficile approccio, dal momento che le recensioni e le letture fatte fin qui mettono in evidenza come sia davvero difficile cogliere nell’andamento narrativo di quest’opera, che è un dato di fatto, il filo rosso che tiene legate insieme le diverse poesie della silloge. Anche per quanto attiene alla liricità dei versi c’è concordia, dal momento che quasi tutti si soffermano sulla forma, sulle figure retoriche e sulla metrica dei versi, sui quali non c’è davvero nulla da dire per il fatto che denotano una sempre maggiore ineccepibilità e maturità stilistica del poeta, che, secondo il mio modesto parere, con questo libro raggiunge un livello sempre più alto rispetto alla sua produzione precedente, vasta e comunque sempre piuttosto impeccabile, tanto da renderla una delle maggiori voci della poesia contemporanea. Va però detto, che in pochissimi si sono cimentati nell’entrare dentro le righe della sostanza dei versi, sostanza che pure c’è e che emerge in modo prepotente ad ogni ulteriore lettura. Perché questa silloge, come tutta la poesia che si rispetti, ha bisogno di essere letta e riletta e non una ma più e più volte, per avere modo di soppesarla, di guardarla, di rimirarla e di entrare ogni volta di più a contatto con le sue possibilità ermeneutiche, ovvero con l’offerta di significato e di senso che essa pone.
E allora proverò a tracciare, seppure in breve, sia il filo rosso di Vivo così, sia il possibile significato, sia il possibile senso. Perché è stato anche detto che la poesia di Toni per i passaggi criptici dei suoi versi è vicina all’ermetismo del Novecento, ma è stato anche detto che questa poesia si staglia all’inverso sui canoni dell’anti-novecento. A tale proposito dico subito la mia impressione. La poesia di Toni pur essendo di difficile lettura, se non altro di primo acchito, per una qualche cripticità ermetica, non può essere analogata alla poesia ermetica del Novecento, nella quale vi era una vera e propria fuga dalla realtà, come ha ben sottolineato Giuliano Ladolfi. L’ermetismo era alla ricerca di una poesia assoluta sganciata dalla vita, qui piuttosto c’è un tentativo forte di approdare a una poesia che si faccia carico di una parola, che a prescindere dalla banalità linguistica, che qui non c’è assolutamente, possa traghettare verso lidi dove senso e significato della parola poetica siano la ricerca forte di un ritorno alla realtà. La letteratura e in particolare la poesia declinata come verità, intesa come adeguamento del pensiero alla realtà, - piuttosto che come menzogna, intesa come parola inautentica, perché autoreferenziale al solipsismo dell’autore, come spesso altrove avviene, - è, allora, la cifra della poesia di Alberto Toni, che con la silloge Vivo così ne suggella in qualche modo un percorso iniziato, ormai, come abbiamo detto, diversi anni fa e che ora si attesta a dimensione di struggente forza poetica raggiunta attraverso la maturità nella consapevolezza della biunivocità di vita e poesia, che tendono al ricongiungimento pro-nomiale, e non solo, dell’io e del tu nel noi, che rende universale la poesia, in una dimensione cognitivista e etica della parola poetica.
Verità, a proposito di che ci chiediamo? Verità intesa soprattutto come ricerca di senso nella dimensione della complessità esistenziale, che si sostanzia in una visione della vita e della poesia nella loro massima interazione, che vuole l’esperienza di vita alla ricerca non solo del senso dell’hinc et nunc, ma anche dell’oltre e viceversa. Non per niente più volte compare nella trama poetica quel Dio, di cui spesso ci chiediamo quanto sia presente oppure assente, soprattutto quando c’è di mezzo il male, ma che seppure nella fattispecie di Deus absconditus, quel Dio prossimo e ribelle, denota comunque quell’Essere, di cui siamo in qualche modo vivendo in attesa. Quel Dio che conosce tutto, come il tratto dei misteri: Dio lo sa nel silenzio che attraversiamo e che attendiamo perché talora ci vuole la mano di Dio. E quindi il Dio risolto.
Vivo così. Pare che già il titolo sia emblematico e nello stesso tempo rivelativo. Vivo, dice il poeta, vivo la vita attraverso gli accadimenti e gli eventi, ne colgo gli aspetti salienti e cerco di rimanere nell’esemplarità del gesto, che si tramuta in parola e che ne svela il mistero, nel bene e nel male. Come? Così: fondamentalmente, semplicemente, vivo d’attesa. E sono vivo nell’attesa. L’attesa di qualcosa o qualcuno, meglio Qualcuno, che prima o poi si sveli. E che noi vivendo attendiamo in un’aura di sacralità attesa al mistero di una vita, di cui possiamo e dobbiamo continuare a stupirci, sperando. E comunque in presenza e in comunione con gli altri, con la loro calda mano, che illumina, riscalda e conforta:
Vivo così: d’attesa,
spergiurando su cosa mai può essere:
cuculo, tortora d’attesa. Oscilla il lume,
la calda mano degli altri.
Mi viene subito da dire, dopo avere letto e riletto questa bella e originale silloge, che la poesia di Alberto Toni è una delle massime espressioni della poesia contemporanea che vuole dare voce a un realismo onnicomprensivo, intendendo con questo un realismo che non si fermi soltanto agli aspetti naturali, empirici e razionali, e sociali, dell’uomo, ai suoi bisogni fisici e fisiologici, ma che vada oltre alla ricerca della genuinità del suo essere che implica il soffermarsi, camminando e cercando, su quanto fa parte della vera natura dell’uomo, che pur essendo un corpo, fatto di materia, va oltre il dato empirico, perché sia colto nella sua originarietà e originalità di unitotalità somato-psichica-spirituale.
La vita può essere vista, certamente, di primo acchito, sotto la lente della biologia, ma anche sotto quella della psicologia, che poi non si discosta molto dalla prima, ma soprattutto la vita può essere avvicinata e vista nei termini di una visione fenomenologica, nella quale il dato di coscienza ne rende chiari gli aspetti di fondo nel momento in cui la coscienza ci rappresenta la vita come esistenza, e, in quanto esistenza, da giocare nel migliore dei modi. La vita come esistenza pone i problemi della verità e della menzogna, del buono e del cattivo, del bello e del brutto, e del senso e del non senso, dell’essere o del nulla, quindi implica una dimensione strettamente legata alla più alta caratteristica dell’uomo, che è la sua libertà e che ne connota la sua spiritualità. Insomma, la poesia di Toni mi pare che possa stare benissimo nell’alveo di questa dimensione, che non esiterei a definire ontologica, nelle more di una concezione dell’uomo, oltre che come Dasein, esserci, come vero e proprio essere, che germoglia dall’Essere, e comunque, in quanto esistente, se ne pone tutte le problematicità per cercare di venire fuori dalle aporeticità del nulla, che fa slittare sull’orlo di un baratro senza fondo, se non se ne esce con una qualche ricerca di senso da dare all’esistenza stessa.
Poesia quella di Toni, dunque, tout-court, personalista. Poesia nella quale c’è un gioco dell’io del tu del noi, che richiamano in modo evidente le notazioni del pensiero personalista di Maritain, Mounier, Marcel, Ricoeur e soprattutto Levinas. Non per niente, mentre i luoghi naturali e urbani e la natura spesso sono evanescenti, approssimativi, indefinibili, non lo può essere il volto dell’uomo, di quest’uomo, qui e ora, che vive in questi luoghi, il volto dell’uomo prossimo a noi, che sta davanti a noi e che ci ricorda che siamo proprio perché c’è quel volto, quell’uomo, che ci guarda e ci interroga e ci invoca a una risposta con responsabilità e libertà.
Poesia e vita, dunque, che si radicano nell’esperienza di una onticità forte, senza infingimenti e ipocrisie, senza menzogne e falsa retorica, ma che si stagliano in modo altrettanto forte nell’orizzonte metafisico. E la parola poetica, nel frangente, ha il compito, oltre che teorico, pratico, di aiutare a reggere l’alto lascito di un impegno morale, che l’uomo, e ancor più il poeta, assume nella sua libertà, che è nello stesso tempo responsabilità.
La vita è certamente bella e va vissuta, ne vale la pena, ma non sono tutte rose e fiori, anzi, una delle costanti dell’esistenza è il dolore, fisico e morale. La vita può essere certamente rappresentata come una commedia, in alcuni passaggi sembra drammatica, ma se vista dall’alto e nella sua univocità legata al momento della persona, la vita ha del tragico. Nella misura in cui è, in ultima analisi, sotto lo scacco della morte. Ora che cosa è che fa pensare alla morte? Certamente vi sono i tanti casi di morte violenta, delle tante troppe morti causate dalle guerre, ad esempio, ma poi vi è la costanza delle morti naturali. E la morte, intesa a chiusura del percorso esistenziale, spesso è preceduta dalla medicalizzazione, oggi sempre più accentuata, della vita e così anche della sua fine. E uno dei momenti per i tanti che hanno la sventura di trovarcisi, è, nella malattia, il momento dell’ospedalizzazione.
Ora è proprio l’esperienza della malattia, del dolore provocato dal male fisico, dolore che in partenza è fisiologicamente corporeo, ma che presto diventa anche dolore psicologico e quindi morale, e spirituale per meglio dire, che infligge all’esistenza la tara di quell’angoscia, che mette davanti alla coscienza la morte.
In questa silloge il filo rosso di cui si diceva all’inizio è proprio quello dell’esperienza e dei vissuti di questo dolore, che emergono in una location, che è quella dell’ospedale, luogo-non-luogo per antonomasia, che suscita le più svariate cognizioni ed emozioni e che, se visto non nei termini di un pensiero positivista e solo empirico e razionale, apre la porta ad una ermeneutica di senso e di significato, che in questo caso Toni sviscera con il bisturi affondato non nella carne ma nell’anima.
Il male fisico conduce davanti a molte porte e spesso tali porte non si aprono. E i vissuti si fanno i più svariati, anche se prevalgono la sofferenza e il dolore che non sono soltanto fisici e che anzi facilmente si trasformano in angoscia esistenziale.
Ma non è detto che si possa andare in deroga alla prevalenza dell’aporeticità del male:
Dopo, molto dopo. La porta è spalancata,
il raggio mi riconquista, finis terrae
in preghiera mattutina il tuo messaggio.
E c’è spazio per una nuova festa, amata,
disancorata.
In ospedale ci sono non solo pazienti, non solo individui biologici da studiare, che si danno alla scienza medica, ma uomini, persone come Raffaele, che porta nel suo letto di degenza la sua storia, i suoi affetti e i fantasmi di una vita:
Raffaele, operaio Fiat, la notte al muletto,
è solo un tempo fantasma
che racconta di sé e del dolore non smette
mentre dall’altra parte il nipote non sa,
poi chiude gli occhi per pensare al domani.
Forse, si chiederà più tardi, il tormento
non passa così in fretta e ci sarà bisogno
di ricordare.
A Raffaele non resta altro che la sua incoscienza giocata in un letto d’ospedale e lui è assorto dentro il quadro degli affetti, nell’elegia di un sogno che vale perché è presente nell’assenza nel cuore dei suoi cari, e forse anche lui sta sognando:
Raffaele non ha ancora reazioni alla vita.
Giugno potrebbe essere un mese come
un altro, ogni notte il gemito strazia l’aria,
corrompe il silenzio mai puro, tira in ballo
sogni di un’età spaventosa e raggiante.
E’ assorto
dentro il quadro degli affetti. Mancano.
Nulla toglie valore al sonno.
In ospedale si vive. Si entra in ospedale e si esce, come nella vita. Sul come si esce è meglio sorvolare. A volte si esce meglio, altre volte peggio. Talora si entra, ma non si esce più. E comunque i letti si liberano. E allora avanti a chi tocca, e si hanno nuovi compagni di avventura:
G. ora allo stesso posto dell’altro.
Caricava un sorriso al mio rientro,
la moglie preoccupata di lasciarlo solo.
È l’umanità mite al suo bivio, mentre
per noi, carichi di presente, il cielo
è un improvviso transito di tutto ciò
che è stato. Il dubbio era proprio
negli occhi che bruciavano, sibilava già maturo in me.
Come dirlo? Come spiegarlo senza perdere il filo,
la vita, dormire un po’ tra le tue braccia in abbandono.
La vita scorre, va avanti anche in ospedale; si deve sottostare comunque ai percorsi stabiliti; si è come in un carcere, la metafora c’è tutta, come il corpo è carcere della nostra libertà, e per conoscenza, solo per la conoscenza si sottostà, perché si sappia, la diagnosi impera, fino a recinti di consapevolezza, ma poi non sappiamo se l’illusione è verità o viceversa e non resta, allora, che la trasparenza di un vetro a separarci dai colori che chissà se vedremo in una sola volta nell’istante:
Tutto deve andare avanti.
Ma poi noi non sappiamo
se l’illusione è verità. Allora scendo
e salgo fino alla prova e non per paura
e dolore, ma soltanto per conoscenza.
Vedrò tutti i colori insieme, soltanto
per un istante? Un vetro solo che separa,
esclude tutte le immagini più volte ripetute.
Nel vortice degli eventi, ci si dibatte dal male, si esce dal corpo, tra flussi di tempo e flussi di liquidi tra vene e flebo; il male mette tutto in bilico, in procinto della caduta; nonostante questo, non ci può essere abiura, rinuncia e abbandono, ci si può solo nascondere:
Uscire dal corpo si può,
per tenere il fuori campo, dibattersi,
controllare il flusso con tutto che rallenta.
Simili richieste dovresti tenerle per riprendere
fiato, una volta era più facile: bastava la vita
battente che si alzava a vortice. Non ora che
tutto è in bilico. Ma non c’è abiura, solo
nascondersi.
La vita in ospedale non può che consumarsi in alterità e di questa alterità consta il diario di bordo dei vissuti più diversi, che vanno agli antipodi dal dolore alla gioia, dall’amara consapevolezza del corpo come carcere alla dolce fioritura inebriante del gelsomino là accanto:
Un diario di alterità.
Corpo e prigione ma anche a un passo il gelsomino
tutto per te è fiorito.
Senti il vestito che ti va stretto
e non rinunci al sorriso.
Qualcuno penserà: quelle
aeree parole in cima alla collina
serviranno al risveglio.
Più sopra parlavamo del volto, che richiama alla prossimità e all’alterità. Le facce sono le maschere, sono le persone, che siamo e che ci invocano alla reciproca responsabilità e solo allora ci dicono che siamo davvero liberi. Nella misericordia, nel conforto. E in ospedale questo vale a maggiore ragione:
La bella faccia di R. Gli ho dato tutto
quello che avevo, non il superfluo, ma la parte vera,
l’essenziale parola nel conforto,
la considerazione mentre sdraiato
si lasciava andare e andare.
Ci sono l’assenza, l’ineffabilità, che rischia di portare all’afasia, la comparsa di una madre, accanto, i bambini lontani, che godono del mare, e la cogenza dell’ansia che conduce all’angoscia dell’essere assente, di non esserci, e che fanno toccare con mano, come avviene spesso in questa raccolta, lo zenit della lirica:
Una madre accanto, in sovrapposizione,
mentre i bambini si godono il mare
lontano, più lontano da ciò che verrà.
Crescono tra il mare e la città,
linea d’ombra, vita e sorgente
e l’ineffabile che ha il nome
dell’ansia congenita della sfida in avanti.
Nominati all’ascolto, mentre il corpo
già tormenta l’asfalto con fatica dei tanti
che verranno forse dopo a nominarlo, l’assente.
Ecco che l’attesa si fa nuovamente viva, e nell’attesa di un giudizio che potrebbe essere a prognosi sfavorevole, si prende il coraggio a due mani e si cerca, pur eludendo il nome del possibile evento, anche un improbabile entusiasmo per dire quale dovrà essere l’ultimo abito:
Decidemmo la strada.
Il grosso sarebbe giunto di lì a poco,
l’atteso, il non nominato giudizio.
Avevo scelto con te tra le pieghe
dell’abito, il più portabile, l’unico
forse che non casca male,
un blu solito, tra i tanti.
E l’entusiasmo per dirlo.
In ospedale ci sono immagini di vita e anche immagini di morte e sono tanti i momenti in cui il poeta indulge con discrezione su quei volti fissi e raggelati in enigmatici sorrisi a margine di scorribande di monitor che musicano quel rumore sordo del cuore in ritmi più o meno frequenti, che sfociano talora in aritmie e non solo del corpo, ma anche dell’anima:
Il rumore sordo del cuore,
animarlo delle solite cose e un salto
verso il cielo, quando è caverna e la perla
che qui consumava l’errabondo. Vedeva
e non vedeva, scavalcava. Lo sentivo appena.
Poteva non conoscere, non sapere dove
svetta la chioma dell’ultimo albero rimasto?
E gli altri, i nostri vicini così lontani.
Tutti lo sanno: distinguere l’ultima scintilla,
l’opaco del fuoco in brace che sconfina
nelle periferie, ciò che appena si vede, non si vede.
L’ospedale è il luogo-non-luogo, metafora dell’esistenza, dove ognuno è tutti, dove l’io e il tu si confondono e si coagulano nel noi, per entrare e uscire e nuovamente distendersi in una identità, che è sempre e comunque alterità. Così è; o, almeno, così dovrebbe essere, stando alla realtà.
La sofferenza, il dolore, l’ansia, l’angoscia, le sortite alla speranza, le riprese dal silenzio e dal precipizio, che spiazzano l’oblio e riportano a immagini presenti e passate, agli affetti, a presenze e assenze, confluendo nei sogni di notti insonni e di giorni passati nella penombra del dormiveglia e che appaiono senza futuro sono la condizione di ciascuno e di tutti. Al punto che le storie si incrociano, si confondono e spiazzano l’identità spaesata per farla ritrovare nell’alterità. E l’alterità la si legge nel volto e nello sguardo dell’altro. In questa sede ho riportato solo alcune poesie della silloge, e probabilmente neppure le più significative. L’invito non può essere altrimenti che leggere tutto Vivo così. È necessario, infatti, leggerlo tutto e tutto di fila, il poema di Toni, per rendersi conto di quello che ho appena cercato di mettere in evidenza, perché ogni passaggio poetico ha da dirci qualcosa, ha da aggiungere parole e sfumature, che portano alla quadratura del cerchio del senso profondo di una vita e di una poesia, che vanno accettati per quello che sono e che non possono essere vissute altrimenti che al modo che ci suggerisce il poeta.
Ma la poesia può darsi se c’è dolore sofferenza malattia morte? Il filosofo Theodor W. Adorno in pieno Novecento disse che dopo il male della Storia, nella quale gli uomini avevano esplicitato tutto il male possibile, oltre l’immaginazione, nei confronti dei propri simili, attraverso i campi di concentramento e l’olocausto, non era più possibile fare poesia.
Anche per Celan non è possibile che si dia parola, ancor più poetica, davanti alle tragedie, in quanto la tragedia stessa non può condurre che al silenzio. Ma il silenzio non può, secondo Celan, fermare il poeta.
Come dice Antonio Spadaro, Celan nella poesia Atemwende (Svolta del respiro) dice che il poeta “assume, ‘inspira’, la realtà che gli sta intorno, la elabora per mezzo dell’arte e la restituisce, la ‘espira’ come poesia”. Ma se l’aria intorno diventa irrespirabile? Allora al respiro del poeta non resta “che diventare rantolo e sarà sufficiente appena per un grido, incapace di dire il reale e appena utile a denunciarne l’indicibilità”.
Come Celan tenta di superare l’indicibilità davanti alla tragedia della Storia, mi sia concesso il paragone, Toni cerca di uscire dall’aporia dell’ “afasia incombente” a proposito della tragedia della storia personale del singolo uomo sopraffatto dalla malattia e dal dolore, che ne consegue, attraverso la speranza, comune a entrambi i due poeti, riposta nell’unica possibilità di salvezza, che spetta alla parola.
Parola della poesia, che si proietta dunque in una dimensione escatologica e metafisica per acquisire quella patente d’infinito, che porti a vivere nella realtà più autentica della vita vissuta a trecentosessanta gradi con lo sguardo al qui e all’ora, ma anche all’altrove in altro tempo.
Fatte queste considerazioni, si capisce, allora, il significato della parola come è e come appare nella poesia di Toni. Da questa parola non ci si può aspettare una linearità di logica, cristallina, di matematiche certezze, giocate con linguaggi tecnici, strumentali o solo della quotidianità. La lingua di Toni è una lingua complessa proprio perché non si ferma alla scontatezza del dato immediato, ma procede in un oltre dove abita il mistero, che il poeta cerca di cogliere con la parola, che stenta e che si chiude, che rasenta il rantolo, ma che pure incede e si apre e pur continua a respirare e a far prendere aria perché si viva. E, purtuttavia, si vive, e si vive così.
Si deve vivere così. Perché questa è la vita. Pena la catastrofe di un irresolubile e ineludibile nichilismo, che la poesia autentica come quella di Toni vuole combattere e abbattere per eludere quell’abisso presso il quale spesso ci portiamo, ma nel quale dobbiamo evitare di cadere.
Si comprende ora quali siano il filo rosso, il significato e il senso della poesia di Toni.
Nella poesia di Vivo così c’è un dipanare continuo quel filo rosso, che sono i vissuti di un’esistenza che si trova davanti al male fisico, che riguarda non solo l’io, ma il noi, e ci conduce a meditare sulla nostra vulnerabilità, sulla nostra precarietà, sulla finitezza di noi esseri umani, sulla nostra particolarità, che si trasmuta in universalità del dolore e della morte, che sono il metro della nostra umanità.
Se ne deduce che il poeta cerca di riflettere su questi vissuti e tenta di darne una parola come esito della sua elaborazione ermeneutica, facendo emergere, è vero, una amarezza di fondo, ma anche una estrema dolcezza nella misura in cui fa intravedere la possibilità dell’empatia del dolore, giocata in termini sia razionali sia irrazionali, ma comunque in uno sfondo di affetti.
Gli uomini nella loro esistenza devono confrontarsi, e nel corso dei secoli lo hanno fatto, e ancor più nel Novecento, con la Storia e con i suoi fatti e misfatti, così come da sempre si sono dovuti confrontare con quella natura matrigna, che da sempre coinvolge nella Storia naturale con terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, e quant’altro le vite e le esistenze di milioni e milioni di esseri umani. Ne sono emersi da queste tragedie problemi che l’uomo si è da sempre posto circa il significato e il senso della vita umana. Ne è scaturita perfino una teodicea. E alla fine qualcuno ha detto e dice che meglio sarebbe stato non essere mai nati, altri affermano che alla fine è meglio l’essere piuttosto che il nulla. Nella fattispecie, Toni si pone il problema della finitezza, della morte, attraverso i vissuti del dolore fisico e spirituale e morale, che si esperimentano in ospedale e davanti a quella che è una tragedia, comunque una tragedia personale, in quanto mette difronte al dolore e all’angoscia della morte, si risolve nella presa d’atto che anche questo tipo di esperienza fa parte della vita e in quanto tale va vissuta e vissuta nel modo più umano possibile.
Se la natura è comunque matrigna, e se esiste la malattia, il dolore, che prima o poi ineluttabilmente conducono alla morte, può l’uomo continuare a fare poesia? Certamente sì, pare rispondere, seppure indirettamente, il poeta; attraverso una vita vissuta autenticamente, con la consapevolezza di una finitezza della vita stessa, che comunque va vissuta in certo modo, e che fa da contraltare alla possibile eternità della sola parola poetica, che per quanto ancora e sempre inadeguata a esprimere tutta quanta la realtà così come è, ci prova e ci riprova in una comunione data per assunto di tutti gli esseri umani.
Giacomo Leopardi, nel periodo della Ginestra, aveva cercato di dare una svolta al suo pessimismo, proponendo una sorta di progresso, certamente non come quello prospettato dal positivismo, idea innestata proprio a partire dal pessimismo stesso. Leopardi era da sempre consapevole della condizione umana e aveva sempre guardato la natura come matrigna, come nemica, ma in questa fase comprese quanto fosse importante, per uscire dall’impasse di una visione nichilista, che gli uomini si unissero per combattere la minaccia della natura attraverso i valori della solidarietà.
Qui sembrerebbe che Toni voglia riprendere il senso dell’idea leopardiana, per quanto il riferimento è qui ristretto al microcosmo della natura del corpo umano, dove il male si può indovare, spesso non venendo da fuori, ma originandosi dalle nostre stesse cellule, dai tessuti, che siamo, facendo scattare tutti quei meccanismi che dovrebbero chiamare a raccolta le umane forze per fronteggiare la malattia, a cominciare dai medici, che purtuttavia non bastano, perché, come abbiamo detto, il male fisico ha come sequela il male psicologico e poi ancora quello spirituale, nella misura in cui la malattia ci pone davanti al senso di tutta un’esistenza. E allora una parola e un gesto che non siano solo della scienza e nella scienza possono certamente aiutare a tentare un oltre che la poesia, come in questo caso, riesce a compiere poematizzando e pneumatizzando la vita, quella vita che sentiamo così nostra nel bene e nel male, che non ci resta che vivere così, per dare compiutezza alla sua autenticità, che rimane radicata in quel mistero, che la parola poetica, salvezza essa stessa ma anche ancora di salvezza in mezzo a cotanto pericolo, cerca purtuttavia di svelare, emozionando.
In conclusione, dico che Vivo così di Alberto Toni è uno dei libri più belli di poesia, che mi sia capitato di leggere negli ultimi anni e che è riuscito a emozionarmi non poco. Una poesia che sta dentro la nostra migliore tradizione e, per parlare dei poeti a noi più prossimi, trovo che ci sia nella forma e nella sostanza del dettato poetico del nostro una netta vicinanza a uno dei nostri migliori poeti del Novecento, Vittorio Sereni, che è stato uno dei migliori tessitori del nostro esistenzialismo in poesia, che Alberto Toni riesce a riprendere e a implementare col suo realismo onnicomprensivo, una posizione che in questo preciso momento storico politico e culturale mi sento ancora un volta di definire come poesia personalista, in barba a ogni nichilismo, post-humanismo, sperimentalismo, che non contempli l’ontologia e l’assiologia dell’essere umano in quanto persona, che pur essendo ben piantata nell’immanenza fisica, si apre alla trascendenza metafisica. Realtà che si dà in tutto e per tutto, ma che non è assolutamente scontata.
La realtà, e soprattutto la nostra realtà, la realtà di esseri umani, consta di fango come di aria e perfonde dovunque, nel qui e nell’oltre, la propria aura di prodigio e mistero.
Sta a noi e in particolare ai poeti e alla parola poetica vivere, e vivere così.
Vivo così, dice, appunto, Alberto Toni. Vivere in una dimensione mai conclusa e pertanto infinita, in cui la realtà ha la necessità di un continuo confronto, giocato con un autentico atteggiamento, genuinamente ermeneutico, dove si cerca di comporre il fuori e il dentro, il sacro e il profano, il bello e il brutto, il bene e il male, in attesa alla verità, ri-congiungendo fango e aria. Per tornare a stupirci e a meravigliarci ancora una volta del suo mistero. Forse un ritorno alle origini.
Per la realtà ci vuole un confronto.
Toccava a lui ripetersi nel gioco, ricrearsi
nell'illusione. Poi sale l'infinito, si prefigura
il Dio prossimo, la roccia che è termine di paragone.
Avviene tutto dentro,
un moto rapido,
un'accelerazione che non dà tregua.
Forse un ritorno alle origini.
Roma, agosto 2015



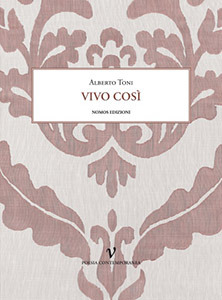 ::
::  ::
::