“Conservare i germogli dall’inverno”: così la Musa di Deidier salva se stessa.
C’è come uno spazio d’occultamento sotto i versi di questo libro: vi cadono le emozioni più profonde, i ricordi, e perfino i nomi dei molti che spariscono nella folla, e degli amori vissuti in case non più abitate, o comunque vuote d’oggetti, di colori, talvolta allucinate ooniriche.
E le città, le vie, i porti, le stanze, sia quelli visitati nel passato, sia quelli che accolgono il tempo presente, non importa se solitari e bui o luminosi, deserti o affollati e vitali - come nella città di Palermo dove da qualche tempo Deidier risiede - sono luoghi d’estraneità in cui l’autore sta e vive solo fra gli altri.
Questa percezione di inappartenenza è, del resto, la cifra esistenziale di Deidier, tant’è che perfino le relazioni amorose se ne oscurano; e a tal punto, che, pur nella prossimità fisica con l’amato ( molto più spesso fantasma baluginante della mente, tra nostalgie, rimorsi, rassegnazione all’incompletezza ed alla clandestinità ), il sonno di lui a labbra appena aperte gli suggerisce l'immagine enigmatica ed inquieta della notte che là si è tutta riversata. Che è come ammettere che la parola recisa dal sonno è la stessa della veglia, rabbuiata, ammalata, ormai, di inadeguatezza, incapace di tessere rapporti di più intima confidenza ed appartenenza, lasciando posto alla più sterile ed amara “discrezione” “dei non visti, usciti di nascosto”.
Tutto, allora, diventa in questa silloge un segnale della perdita, della rovina che sembra attraversare la storia dell’uomo e poeta Deidier, come quella dell’Umanità, a partire dagli stessi personaggi biblici a cui è dedicata un’intera sezione. Essi, sempre alle prese con un difficile e soffocante rapporto con una Volontà inafferrabile, non visibile, che tuttavia entra nel loro privato e ne confonde gesti e sentimenti, vanno spesso incontro alla rovina di se stessi, alla rinuncia ed alla rassegnazione. E così, benché tratti dall’antico libro sacro, essi si fanno figure contemporanee che hanno smarrito l’interezza ed il dialogo.
Lo stesso Adamo diventa colui che rifiuta il ruolo di nominare il mondo, per cercare il silenzio, la ferita, l’abisso. Adamo, allora, è il poeta contemporaneo che non sa più usare i nomi per raccontare il mondo agli altri.
Egli, che preferisce il vuoto, s’apparenta anche alla significativa figura del trapezista, protagonista della terza sezione della silloge, che ormai da anni vive nella sua dimensione sospesa, avendo scelto la separatezza dal mondo e dagli altri, dominato soltanto dall’assillo di perfezionare la sua arte: “Manteneva esercizio e perfezione / Soltanto comportandosi a quel modo”. Questa “figura” della condizione di solitudine esistenziale dell’artista è tratta dal racconto breve di Kafka : Primo dolore, in cui un trapezista, come scrive Ermanno Cavazzoni, dimora “nella sua altezza siderale, lontano dalla curiosità degli spettatori, divorato dall’ansia di non riuscire a superare se stesso”: è questo, infatti, il senso della richiesta - accoratamente accompagnata dal suo primo pianto - al suo impresario di procurargli un secondo trapezio grazie al quale rendere più complesso e spettacolare il suo esercizio. E quelle funi, che per il trapezista di Kafka rappresentano simbolicamente i pochi legami che lo annodano alla vita, diventano per il poeta le parole, sebbene sempre più inappartenenti, sempre meno “religiose”. Solo che inevitabilmente la rinuncia ai rapporti interumani finisce con il lasciare sulla “fronte fanciullesca” del trapezista kafkiano la prima ruga, il cui significato ( per ammissione dello stesso Deidier ) sta anche “in un surplus di bisogno, anche amoroso, che segna la fine della gioventù, la sua schietta indipendenza”, un certo scricchiolio del cuore e della mente, “l’inizio di un tormento mai cessato” di fronte alla difficile vocazione dell’arte: “(…)Come faccio a vivere / Solo con questa sbarra fra le mani?”.
Questa separatezza – se non, spesso, sepoltura tra macerie, fiumi sotterrati, residui, ombre e notti senza sogni, nel presente e, di conseguenza, nel futuro – anche dalla vitalità e dalla speranza, che investe soprattutto la comunicazione e la forza degli archetipi (“Non posso più accendere immagini”), ricorda fortemente “L’AngelusNovus” di Klee, così come lo descrive Walter Benjamin, che in esso vede l’angelo della storia che “ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula rovine su rovine”, intanto che una tempesta “lo spinge nel futuro, a cui volge le spalle”. La sua descrizione ricorda quella del personaggio che introduce le poesie di “Solstizio” diDeidier, visto nel momento in cui “Si era fermato, lo sguardo all’indietro/ Il passo avanti verso l’orizzonte “, mentre tutto intorno non c’è che distruzione. Questa “istantanea senza redenzione” sembra fotografare lo stesso autore, che, nella prima delle sezioni, più volte, anche se mai la nomina, paragona il suo destino a quellodella moglie di Lot, che, voltandosi indietro, divenne una statua di sale.
L’immobilità, il deserto, la bianchezza del sale, il non sapere la meta, la presenza delle rovine sono, infatti, le immagini più ricorrenti nei versi di questa silloge. È, dunque, chiaro come tutto converga verso il problema del linguaggio, in specie quello della Poesia, a cui spetta,più che alle altri arti, il ruolo di salvare la parola come unico strumento di comunione con le cose del reale, e dare fondamento e fattibilità al sogno dell’Uomo e alla storia dello Spirito, quale linguaggio altro, se non “magico”, rifondante.
Non a caso la silloge si conclude con la sezione intitolata “Musa”, alquanto diversa dalle altre e nelle sue soluzioni stilistiche e nel suo contenuto, né descrittivo, né riflessivo, ma piuttosto volto a rappresentare il rapporto fra la poesia e l’autore che sembra mettersi sotto accusa il ricorso alle immagini contro la pochezza del dire e si accorge, intanto, dei tentativi da lei messi in atto per autodifendersi, ben più viva e dotata di volontà com’è dell’uomo, quali: “guardare altrove”, “potare le begonie” e “conservare i germogli dall’inverno”.
L’autore, d’altra parte, riconosce che sono ormai rari i momenti in cui si abbandona davvero a lei, mentre più frequenti sono gli altri in cui ne ha quasi paura per quella sua lingua che sente come “un mostro da evitare”; per il suo salto fuori del tempo ordinario, per la sua “troppa luce” che lo fa fuggire.
Tuttavia egli sa che soltanto la poesia è la sua amata, quella che, se perduta di vista, lo spinge a cercarla affannosamente, a pregarla di rimanere : “Ti chiedo a bassa voce di tornare”.
E non credo che questo appello sia soltanto rivolto a suo beneficio, quanto piuttosto a quello di ogni uomo-poeta, affinché ritrovi se stesso e il proprio mistero attraverso il linguaggio alternativo e salvifico della poesia. Le radici mitiche, religiose, affettive, che qui appaiono turbate e corrose da un eccesso di razionalità, devono essere recuperate nel loro significato vergine ed autentico, affinché tutti possano conoscere “il nome vero del gioco che facciamo” e recuperare “la felicità sommersa”. È così che si apre tra i versi uno spiraglio di luce e dal solstizio d’inverno il tempo sembra anelare alla “pura luce estiva, che è luce della lingua, quando è il centro di se stessa”, come mi scrive in un messaggio privato l’autore stesso.

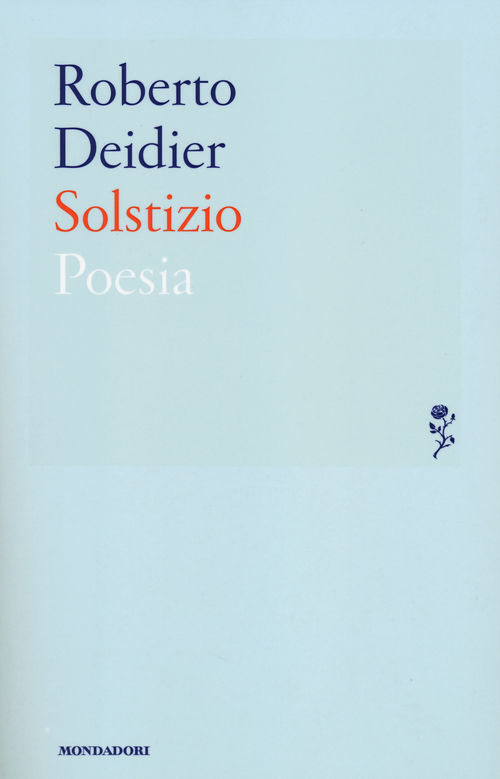

 ::
::