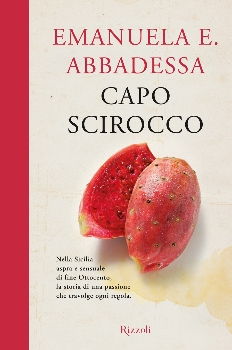Capo Scirocco (edito Rizzoli) è un libro che si ciba delicatamente del pentagramma della scrittura e che si esplicita attraverso una musica positivamente neoplastica che invade tutto e tutti. Forse non a caso, in questo bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel libro trovano spazio la Traviata e il Rigoletto che, attraverso un’abilissima mise en abîme, si intrecciano con la storia fino a diventare essi stessi espressione e mimesi della fabula.
Il titolo squisitamente rematico e la copertina locativa sono indicativi del contenuto. Lo scirocco infatti è metafora di turbamenti sessuali (“É lo scirocco. Fa impazzire le femmine, pare che cambia tutte cose”; ed ancora: “E la musica, spandendosi sulla platea, risalendo lungo gli ordini di palchi, investiva il pubblico simile ad un ciclone bonario, a un vento caldo di scirocco che mette un fremito languido addosso”). Il fico d’india, invece, è quel frutto di origine messicana che ‘ntuppa, diciamo noi in Sicilia, che riempie lo stomaco perché astringente come quell’amore che toglie spazio e sonno e che, tra l’altro, nel caso specifico, rimanda ad Ercole Patti e al suo romanzo Un bellissimo Novembre, e più precisamente alla scena erotica in cui il nipote Nino offre alla zia Cettina il succulento frutto. E questo è solo il primo dei tanti pastiche che si possono individuare nel romanzo della Abbadessa, quasi che l’autrice abbia voluto richiamare alla memoria la storia della letteratura italiana da Manzoni fin quasi ai nostri giorni.
Il romanzo, a ‘mò di melodramma, è preceduto da un prologo e seguito da 29 quadri (capitoli) e da un epilogo. Il libro si apre con un arrivo, uno sbarco in quella Sicilia da sempre terra centrifuga e qui scelta quasi casualmente dal protagonista, Luigi, per realizzare il proprio slancio vitale della personalità. Luigi è in fuga, è come un novello ‘Ntoni: ha lasciato la sua Subiaco perché si era ritrovato cresciuto in un mondo immobile che procedeva lento come le greggi verso il pascolo (in contrapposizione a quella che Verga proprio nella prefazione del suo primo grande romanzo definisce la fiumana del progresso, vero motivo della sciagura dei Malavoglia).
Luigi non è in preda ad astratti furori come il protagonista di Conversazione in Sicilia ma ha uno scopo ben preciso: desidera cantare, una passione trasmessagli da don Pietro, attività contrastata dal padre tanto da ricevere - come Zeno- uno schiaffo che brucia. È arrivato a Capo Scirocco sotto l’egida di un pianoforte a coda che ritroverà accarezzato dalle mani della giovane Anna, la quale gli concede –sebbene dietro compenso- il suo prezioso aiuto per esercitarsi nel canto e masturbare lentamente il Don Giovanni in erba che si nasconde in lui, finendo per innamorarsene.
Il giovane diciottenne viene notato una mattina da Donna Rita Agnello, una nobildonna ubriaca di musica e di desiderio, vedova al momento dei fatti, che lo prende con sé a casa per adempiere un vecchio voto (“Proprio sotto il vecchio arco con l’immagine della Sacra famiglia chiusa in una graziosa mandorla di pietra bianca, si arrestò davanti ad un ragazzetto che dormiva per terra, appoggiato a una grossa valigia marrone, rannicchiato come un capretto. Restò a guardare il giovane per un istante e poi riprese il cammino verso la matrice”). Essendo figlia di una traviata -giusto per citare l’omonima opera lirica che segna il primo contatto fisico fra i due -(anche se all’epoca in Sicilia si sarebbe detto figlia di una “caduta”), aveva fatto un voto solenne: “giurai a Dio che avrei espiato io la colpa di mia madre. Avrei dato una famiglia a un orfano così come era stata data a me e avrei rimesso a Dio i peccati della mamma”. E così lo fa studiare e lo introduce nell’alta società.
Ma com’è la Sicilia che ci presenta questa romanziera esordiente, fino a ieri solo musicologa? È una terra che parla attraverso l’olfatto, in cui "la frutta si matura al sole, il pane con la crosta coperta di semi di sesamo, la ricotta calda”. Altresì è una terra dalla lingua antica e misteriosa, mitologica, una isola che si muove, in fieri, “perché galleggia sull’acqua”.
L’originalità di Emanuela E. Abbadessa è quella di trasformare la Sicilia in luogo d’approdo, terra centripeta, sul modello della letteratura inglese. È qui, infatti, che il giovane Luigi arriva per dare compimento alla sua formazione di uomo e di cantante operistico. Luigi è presentato come uno scapigliato, è uno che è fuggito per il dolore dell’assenza materna, perché non regge più il rapporto col padre. Il canto diviene strumento di ricordo perché “solo mentre cantava, i tratti di mamma si ricomponevano dietro le palpebre chiuse … allora rivedeva gli occhi verdi come l’acqua dell’Aniene sulle cui pietre Assunta sbatteva le lenzuola mentre gridava gli stornelli della sua terra”.
Luigi ama il canto perché ciò che suona non può avere effetti nocivi e, dopo otto mesi in casa Platania, confessa il suo desiderio di abbracciare questo percorso. Ottenuto un diniego, trova però la donna desiderabile ed anche lei sente per la prima volta dopo la morte del marito la presenza di uomo, ”un odore fragrante di pelle appena sbarbata”, e comincia ad avere paura.
Un giorno, durante la celebrazione della messa, il giovane vince la sua timidezza e, con una vena di orgoglio, si abbandona al canto, con la stessa energia e lo stesso travolgimento con cui si cede alla passione, tanto che per raccontare la scena la scrittrice gioca con l’equivocatio, rimandando ancora una volta alla simbologia sessuale. La paura di aver fatto qualcosa di sbagliato è tradotta infatti come il fallimento non riuscito di un coito interrotto: “per la prima volta dopo tanto tempo si sentiva sicuro di sé e così, quando il Sanctus si levò verso il cielo, il giovane inalò il sentore d’incenso e di fiori quasi appassiti, riempì i polmoni e l’addome d’aria come aveva imparato da don Pietro e decise di aggiungere la sua voce al canto dell’assemblea. L’aria mise in moto le corde vocali, arrivò sulla lingua e divenne tonda nell’alveo delle guance e poi, miracolosamente, vibrò. Alta, possente, precisa. Nel momento in cui venne fuori, Luigi ebbe timore e avrebbe voluto risucchiarla in gola ma quella incurante del suo volere rimase per un attimo immobile nello spazio proprio davanti al suo naso, poi scappò via. Fu come una ventata che scosse i merletti sul capo delle donne, annodò i riccioli ai bambini, giocò a sfiorare i lobi delle orecchie degli astanti e, alla fine, si riverso magnanima sulle sottane del parroco. Fu tutto in un batter di ciglia. Donna Rita si stupì, arrossì e poi subito sorrise. Nascose il volto dietro le mani giunte e si accostò a Luigi sussurrando: <<Vero era, sei un tenore>>”.
Ad un certo punto, però, la nobildonna avverte che per Luigi nutre un amore diverso da quello che aveva realizzato con lo sposo (“il marito, per quanto più grande di lei, era stato un compagno amorevole. L’aveva coperta di ogni tenerezza, aveva fatto ristrutturare alcune stanza a Villabate perché lei potesse possedere tutto ciò che desiderava. Voleva che l’arredamento stesso degli appartamenti si adattasse alla fierezza della padrona di casa. Era stato un buon matrimonio, con la misurata passione che non rende infelici. Ora era diverso, ora sentiva che la stoffa degli abiti le bruciava addosso. Era una sete di mani e di bocca”). Come per la capinera di Verga –in Capo Scirocco espressamente citata per descrivere il turbamento di donna Rita-, è proprio tra le pendici dell’Etna che l’amore si rivela in tutto il suo parossismo, perché “è la donna che fa sapere a tutti di esistere”.
A complicare questo idillio è la trasformazione dello stesso in un triangolo. Luigi ha bisogno di un’accompagnatrice e si rivolge ad Anna, la figlia di don Cucè, un mercante caduto in disgrazia.
Luigi è abile a farsi amare da donna Rita ma capisce che questo non è sufficiente: è bello e libero e può avere il mondo ai suoi piedi. Tuttavia, come mastro don Gesualdo, soffre la contraddizione della posizione mediana: non si sente né contadino, né tantomeno signore.
La serva Cettina- fedele come Stefana dell’Illusione di De Roberto- cerca di avvisare la signora perché ha paura delle conseguenze: “gli uomini dovete tenerli cosi: né troppo stretti per evitare di soffocarli e non troppo lenti sennò scappano. Come gli uccellini”.
Per sfuggire all’amore, Donna Rita si rifugia in quello stesso convento dove era nata e scoprirà tramite la lettura di Sant’Agostino che il vero grande peccato è quello di reputarsi privi di colpe. Ciononostante la fede diventa una mania, una patologia come l’amore (ecco la lezione del naturalismo), tanto da voler beneficiare della sua carità un’opera pia, una sorta di lazzaretto per i poveri, fondata da un uomo il cui unico figlio era stato ucciso da una infezione provocata da un ubriaco, il quale non aveva voluto cedergli il passo come l’inventio manzoniana di fra’ Cristoforo.
Durante l’assenza, Luigi diviene un amministratore oculato e stringe amicizia con un tombeur de femme, Domenico Russo, presentato con le parole della famosissima aria della Boheme (Mi chiamano Mimì). Il giovane è uno che si divertiva a sorprendere le donne e che si era chiesto spesso se in amore l’appagamento non stesse tutto racchiuso nell’attimo in cui il rossore le vinceva. Sarà proprio lui a far avvicinare i due con la scusa di una gita in barca.
Donna Rita e Luigi finiscono per condividere il talamo “perché Dio non condanna coloro che amano”. Luigi si giustifica di questa decisione con Anna parlando della gratitudine come quel sentimento complesso e molto vicino ad un altro ancora più potente.
Dopo il matrimonio inizia l’attività operistica di Luigi in termini professionistici: l’impresario Jacopo Cavallaro lo scrittura infatti per il Rigoletto ed è costretto ad andare a studiare a Palermo insieme ad Anna. La moglie, che vinta dalla gelosia nel frattempo si è ammalata, non può andare e diventa una sua appendice: “dopo la morte del barone, la donna era vissuta nella noia, aspettando una novità, qualcosa che scuotesse la calma delle sue giornate tutte uguali. Adesso però che Luigi aveva portato nella sua vita tanti cambiamenti, qualcosa dentro di lei rifiutava l’idea di un domani diverso da quello che si aspettava, ovvero un tranquillo matrimonio, una vita in due nella quale il massimo dello sconvolgimento poteva consistere nel cambiare la tappezzeria al salotto o rifare il guardaroba. O forse, semplicemente, trovava fastidioso che quanto stava avvenendo, in fondo, non la riguardasse in prima persona”.
Rita si accorge di non essere più lei la regina di quel palcoscenico chiamato vita e di questo soffre amaramente (“la vita dopo un breve ritorno sulla ribalta, la stava ricacciando tra le quinte nere in cui si era ritrovata con la morte del barone. Ora Rita non avrebbe saputo dire se la gelosia fosse pura preoccupazione per gli eventuali tradimenti del marito o, piuttosto, disappunto per aver perduto il ruolo di protagonista appena conquistato”).
Decide pertanto di farsi agnello sacrificale, Norma per l’appunto, ossia l’omonimo melodramma di Bellini. Ed è qui che avviene il colpo di scena che uno non si aspetterebbe quasi: Luigi si trasforma suo malgrado in un personaggio prima sveviano e poi moraviano. La odia e, anziché esserle grato, capisce che quella ottenuta non è vera libertà, proprio come non lo fu per i protagonisti dell’omonima novella verghiana.
Insomma, Capo Scirocco, trasfigurazione di una Catania barocca che non vuole scomparire, romanzo ricco di intertestualità e interartisticità, che fa uso della musica non come un semplice orpello riempitivo e accomodante ma come intreccio, è un libro d’ispirazione romantica che va letto con tutt’e cinque i sensi e che, attraverso una scrittura dolce, sensuale e rassicurante, chiarisce quanto la vita possa (e debba) essere investita da questo vento voluttuoso che soffia anche a porte chiuse.