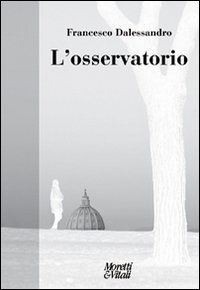[ Recensione di Domenico Vuoto ]
Lo sguardo vedente è per elezione uno sguardo dotato di una sua intrinseca moralità – di occhi che guardano, siano essi umani o tecnologici, di un iperilluminismo dello sguardo, invadente e vacuo, essendo affollata l’antropologia del millennio in corso.
Ma in cosa consiste la moralità di uno sguardo vedente? Certo nella capacità di penetrare e insieme distinguere gli oggetti del reale, nel coglierne, fuori dalle convenzioni e convenienze del guardare corrivo, il senso vero e profondo, di comprenderli e dunque farli propri e conservarne memoria; in questo, naturalmente, sostenuta da un necessario corredo sentimentale e di pensiero. Lo sguardo vedente è, insomma, già di per sé uno sguardo interiore, è un osservatorio, luogo fisico e mentale di azzardi e avventure dell’occhio, e infine di scoperte - da custodire, queste ultime: del resto observare non significa forse puntare lo sguardo su qualcosa serbandone la pienezza della visione?
Quanto ho cercato di dire sopra è il compendio imperfetto de L’osservatorio di Francesco Dalessandro, senz’altro una delle sue più importanti raccolte poetiche. Si tratta di un’opera che, per compattezza e densità di costruzione, per insistenza dei temi e peculiarità dei toni presenta le caratteristiche di un poema. Che, uscita nel 1993 per Caramanica, viene riproposta, dopo molte e laboriose revisioni, di cui per altro l’autore dà conto nella Notizia a fine libro, da Moretti e Vitali con una testimonianza di Attilio Bertolucci e una esaustiva nota critica di Gianfranco Palmery.
Francesco Dalessandro è, come si vedrà bene in seguito, cantore dei sentimenti e della fisicità (e riconoscibilità) degli spazi e degli oggetti che vi abitano. L’osservatorio, che dà il titolo all’opera, e che trova una sua specificazione nella poesia che chiude la quarta e ultima sezione del libro, domina materialmente l’altura di Monte Mario, luogo spesso nominato dal poeta. (Valgano come esempio i versi tesi e molto belli a pag. 23: «… da Ponte Milvio ai piedi / del Gianicolo fosco l’oltrefiume si perde / nella luce agghiacciata latitante / sui rami ulcerati dal freddo sulla rampa / di Monte Mario e dove all’occhio miope / è concesso lo sguardo il viola che preannuncia / neve ai Castelli…»). E, col Monte, altri luoghi di Roma, centrali o meno - del nord ovest della città, in particolare - convergenti tutti verso il sito prediletto, e cioè il Pineto o la Pineta Sacchetti, lo spazio fisico e ideale più assiduamente frequentato dal poeta. Dalla “rampa” di Monte Mario l’occhio telescopico e l’occhio umano si rendono complici di incursioni celesti e terrene. Il celeste, l’aereo, il terreno degli spazi romani compongono il paesaggio che Francesco Dalessandro esplora (ancora un verbo intimamente connesso all’esercizio e all’arte del vedere) con un movimento di volta in volta centrifugo e centripeto dello sguardo. E che si fa protagonista, uno dei protagonisti, della raccolta poetica in questione. È, il suo, va detto, un paesaggio che svaria secondo l’ora, il giorno, il mese, le stagioni, reso con grande minuzia e potenza descrittiva. E con toni ora impressionistici come nei versi dell’undicesima poesia (pag. 30): «… ci accompagnano estri / leggeri e dolcissime ginestre sui bordi / della strada, casolari lontani tra filari / di lecci si mostrano al nostro divagare / silenzioso, prati di un verde smarrito / e incandescente, altro più assorto / verde di canne lungo gli argini del fiume / biondo…», ora, più frequentemente, con le tinte forti e insistite di un espressionismo che registra stati d’animo volti alla pena e a un angustiato sentimento del vivere (pag. 21): «… il risparso / suono ancora della pioggia contro i vetri / e le persiane, il trepestio delle ruote sull’asfalto / viscido […] /… mentre cuore torpido / e uggia la città che non ha pace / paludata ora spartiscono stigia dove si muore…». O ancora (pag. 33): «… muri di sempreverdi efflorescenze / fioriti dove l’edera conserva / il suo malaticcio colore, gli anemici tralci / sporchi avvinghiati alle maglie delle reti / di recinzione ai pali alle pareti a tutto / togliendo luce e calore tutto soffocando…».
Quale controcanto al paesaggio o specchio della sua multiformità si dispiegano i sentimenti. Si è detto della riconoscibilità dei luoghi segnalati ne L’osservatorio, bisognerebbe aggiungere che essa nasce da una loro esatta puntigliosa nominazione. Riguardo ai sentimenti, l’esattezza e il puntiglio si convertono nell’opera di Francesco Dalessandro in chiarezza e onestà della confessione. Ecco allora la smania, l’illusione e il rapido disincanto, la noia di leopardiana ascendenza, lo sconforto. Ecco affacciarsi la cognizione dell’immedicabilità (a tratti fatalistica) della vita, del trascorrere del tempo, il senso di un declino delle energie vitali, il rammarico per le occasioni perdute e per gli inganni del cuore. Sentimenti consustanziali al percorso poetico di Dalessandro e alle sue opere. Così come l’amore, che ha larga parte in questa e nella precedente (in ordine di pubblicazione) raccolta Aprile degli anni. E che non manca di apparire nella sua espressione fisica. Ed è allora desiderio (febbre, “smania”, “vizio”) che già in sé contiene i germi, il presentimento della fine, dell’estenuazione e delusione mortali. Come si vede, è il proprio io ulcerato altro luogo di continua osservazione del poeta. Un’ulcerazione che la dignità, al tempo stesso orgogliosa, ma niente affatto ostentativa, della sua parola dilata ed espande oltre i confini dell’io, fino a comprendere il vasto consorzio umano e a fare della materia della propria confessione l’emblema di una generale e sofferta condizione: «… un morbo maligno mi ha corroso in tutti questi / anni mi ha reso arido e del sogno ricordo solo / insensate speranze e bisogni non la luce / né il malvagio dèmone della notte che mi ha spinto / in quest’abisso vuoto del cuore!» (pag. 89).
Mi è capitato altre volte di accennare ai toni della poesia di Francesco Dalessandro, al suo stile di classica compostezza che vela, non sopisce, il fuoco dei sentimenti. Ma è proprio il velo - i veli - che tentano massimamente l’occhio interiore o quello che mi ostino a chiamare “lo sguardo vedente”. Il merito della poesia di Francesco Dalessandro è qui: in uno stile sorvegliato e rigoroso che agglutina e scioglie alternativamente la tensione della parola e del verso secondo ritmi di marca spesso narrativa; vela e disvela, in mimetico accordo con l’universo sentimentale.
Si è detto (qualche volta con eccessiva insistenza) dell’influsso che la poesia di Attilio Bertolucci ha avuto su quella di Francesco Dalessandro. Vale anche qui ribadire che la poesia, la poesia degna di questo nome, non nasce dal nulla: paternità e maternità (poetiche) ne segnano la nascita e i percorsi, ibridazioni e contaminazioni l’arricchiscono. La poesia latina (Orazio e Catullo), del Tasso e del Leopardi, di lingua inglese (Keats, Elisabeth Barret Browning, Hopkins, W. Stevens, poeti tradotti dall’autore) fino ai contemporanei (Bertolucci, ma non solo) ha certamente influito sulla poesia di Francesco Dalessandro, ma non al punto da condizionarne lo sviluppo, che rimane autonomo, frutto di sapienti rielaborazioni, e con esiti altamente positivi.
E allora va raccomandata all’attenzione e delibazione del lettore quest’ultima fatica del poeta, come del resto le altre sue opere. Ha il pregio dell’intensità e della passione. Non si abbandona agli assordanti proclami di altra, molto meno valida, poesia. Non intende riscuotere facili e rumorosi consensi. È, nella sua bellezza, discreta.