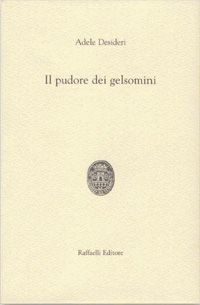[ Recensione di Silvio Aman ]
Per dire qualcosa attorno a questo libro, partirei dal suo grazioso titolo, che, se prelude al pudore floreale della poesia di Adele Desideri, ci lascia la sorpresa di vederlo, poi, contraddetto dall’irrompere della passione e del delirio. Si tratta, tuttavia, di una contraddizione apparente, perché i fiori sono pudichi proprio in quanto non possono nascondere, con la civetteria, ciò che essi sono: organi sessuali. Basti ricordare “Il gelsomino notturno” del Pascoli (che era invece una Mirabilis Jalapa a fiori rossi) con le sue implicazioni erotiche, sia pure attenuate. Qui si tratta, dunque, di un gelsomino gentilmente spudorato, come possono esserlo solo i fiori (senza dover ricorrere ai moti inconsci o alle scelte orrido-oscene di Huysmans) e le nature istintive, le quali, quando amano, non hanno bisogno di celarsi dietro le foglie di fico e i ventagli del falso pudore: “La rugiada dei sensi/ bagnava/ gli steli d’erba tremanti. E non si poteva negare/ il bacio rubato,/ i petali intrecciati/ a labbra turgide,/ il cielo tra le gambe,/ il concime nella pelle./”, (in “Delirio”). Del resto, dal punto di vista simbolico, il gelsomino è il fiore di Venere, anche per il numero dei suoi petali: cinque, come cinque volte, secondo le antiche ricerche degli astronomi arabi, la stella Venere appare in cielo nel giro di otto anni, formando il pentagramma, benché in questo caso, si tratti dell’Afrodite uranica.
Per Tomaso Kemeny – nella prefazione – Adele Desideri “evoca l’intenzione di trasfigurare la natura nei giardini di una grazia antropomorfica, e/o di mutare l’umano in una leggenda vegetale”. Può essere vero. Tuttavia la Desideri non è una gioielliera delle metamorfosi, ma una poetessa passionale che infuoca la “leggenda” anche in chiave di amore guerresco e doloroso, come possiamo leggere in “Guerra”, in “Del dolore e dell’amore” e in “Casta meretrix”, dove scrive: “Vivi tra il mito e l’orrido,/”, (ma il mito è quasi sempre orrido). In questi componimenti l’estesa fioritura delle metafore sessuali può effettivamente richiamare la grazia antropomorfica, ma solo con una connotazione di felicità, o di maggiore tranquillità: “Tra le mele mature, nel mio fiore di zucca,/ sei germogliato come il gelsomino/ quando profuma, pizzica l’aria/ e si nasconde tra il pudore delle foglie./”, (in “Soverato”); “I petali umettati si chiudono a conchiglia/ nello spazio oltre il bosco e la fontanella./”(in “Cartaceo”).
Se pensiamo a questo libro come a un’opera sinfonica, le sue edeniche fioriture, pur non mostrandone il tratto più caratteristico, hanno comunque la funzione di rappresentare un punto in cui l’onda lirica si abbassa dolcemente nell’attesa della prossima cresta: quella drammatica della santa o di una faustiana Pandora.
Il pudore dei gelsomini ci appare, insomma, tutto composto da questi passaggi e sussulti (“ma Giove e Marte/ si contendono lo scudo./”), tanto da far pensare ad una appassionata e sofferta tensione fra l’Olimpico e il Guerriero. Nella poesia “L’innominata” leggiamo: “Non fermarti non voltarti/ scuoti il sale dalle spalle/ guarda avanti/ gioca un soldo sulla tua sorte./ Spengi il lume, danza al buio,/ non temere./ Spendi tutte le tue grazie,/ vivi l’attimo più esteso,/ pensa a quando capirai,/ nella cenere del vento,/ che era solo un lampo,/ un tradimento./”.
Eppure i faustiani imperativi a vivere l’attimo trovano ora un sostegno nella certezza del “sono”, ora una caduta nel melanconico “vorrei”, fra i quali, come nella plathiana “Pronto soccorso”, parrebbe balenare l’ombra di Lady Lazarus, oscillante fra il “calice atteso” e l’“aceto” nello stomaco.
“Testamento”, poesia di chiusura, ricapitola come meglio non si potrebbe i temi ricordati sopra, sintetizzando il dissidio nelle immagini della “pioggerella di marzo”, della “la cicala delle torride estati” e nel simbolo riuscitissimo della “mantide religiosa” (“Sarò concubina leggiadra e disperata,/ sarò farfalla di una notte,/ cicala delle torride estati,/ luna calante,/ giovinetta del ballo assassino/ […]// Sarò pioggerella di marzo,/ girasole distratto, mantide religiosa./ Di Edipo seguirò la sorte, mi caverò/ gli occhi che non hanno veduto/ quei secondi tra l’utero e la fossa,/ che marchiano come pecora al macello./”).
Mi pare basti “Testamento” per chiarire come la poesia di Adele Desideri si muova all’interno del Cristianesimo (vale a dire di un monismo con finale dualistico, oscillante fra i poli del bene e del male tanto invisi a Nietzsche), ma con una passio ad ampia escursione. Ai versi appena letti dobbiamo peraltro aggiungere quelli contenenti i delicati pensieri rivolti ai figli, al padre (specialmente nell’accorata “Elegia”), alle vittime del genocidio armeno (in “Tsitsernakaberd”), al Cristo e allo Spirito che inebria (in “Monastero di Sanahin”).
Silvio Aman