“Di sole voci”, questo perentorio esordio della giovane poetessa torinese Silvia Rosa, il suo “battesimo di carta”, come lo definisce la stessa autrice, uscito nella collana Erato, ormai sempre più costellata di preziose proposte, per le Edizioni LietoColle - corredato da immagini di Giusy Calia, di assoluta confluenza cromatica, nel loro algido viraggio onirico - rivela, fin dai primi testi che raccoglie, una salda, asciutta misura stilistica, pur in un ambito di espressività lirica pulsante, franta, a tratti persino lacerante. Nella sua densissima raccolta, l’Autrice sembra operare un procedimento alquanto sofisticato di filtro tonale, attraverso uno slittamento mimetico dell’io poetante, che assume l’ottica, costantemente spiazzante, ora di obiettivo, ora di controcampo al suo stesso sguardo, con una minuziosa testimonianza drammatica, dapprima teatrale, quasi a tratti didascalica, e poi pulsionale, in profonda trance mesmerica, apparentemente consanguinea di un macro-minimalismo iperrealistico, da reperto autoptico straziato e straziante, ma più in fondo, tra le pieghe della tessitura composita e polisemantica dei testi, ad uno straniato rito di espiazione, magistralmente stilizzata nella sua sofferta reviviscenza, delle miserie più atroci e insondabili della condizione umana: “Astratta carne / ti vivo di parole / e non di sangue / prigione di respiri / e braccia e occhi e gambe / condanna, che ti sconto / giorno dopo giorno dopo notte /[...] / raschiandoti / dall’ombra del mio corpo.” Come osserva con nitidissima “messa a fuoco” esegetica, Alessandra Pigliaru, nella sua prefazione al volume: “Ecco che la nudità diventa la possibilità di decifrare con la pelle la scrittura e il segno del mondo: resta come un coagulo che si distingue dall'anima e accede al Senso.”
E come afferma, con sottilissima, penetrante indagine ermeneutica, Enzo Campi, nella sua corposa nota critica, che conclude il curatissimo “Libriccino da collezione”: “Questa poetica è essenzialmente impegnata nella ricerca non tanto di un destinatario quanto di una destinazione, di una dimora ove il senso possa trovare il suo aver-luogo. Se ‘Poesia significa per lo meno toccare la cosa delle parole’ (J.L. Nancy), la poeticità e la poematicità di Silvia Rosa toccano, simultaneamente, la trascendenza del corpo verso le parole e il sacrificio delle parole verso il corpo.”
In questo suo, tanto congruo, iniziale tratto di percorso di scrittura, l’Autrice dà prova, insomma, di una padronanza quasi strabiliante, per la giovane età, di un linguaggio sempre esatto, severo, a tratti preziosamente spoglio; un dettato concreto, intimamente vigoroso, rigorosamente sorvegliato, che sottolinea e acuisce l’efficacia e la profondità evocativa dell’assunto, in una sommessa, coerente monodia “in minore” che si consolida, alla fine, in un impietoso “requiem” per tutta l’umanità offesa, oltraggiata, nel mondo, nella storia, mesta filigrana di un caleidoscopio, riflesso su uno schermo scuro, ma vividamente delineato, del suo “lucido martirio”, verso cui, questo arrochito e trasognato gemito, porge un quanto mai macerato germe, larvato, quasi soffocato nel fitto miasma del dilagante fango, ma strenuamente fecondo di fermenti nitidi di rivalsa.

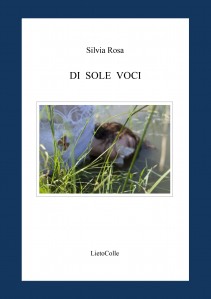

 ::
::