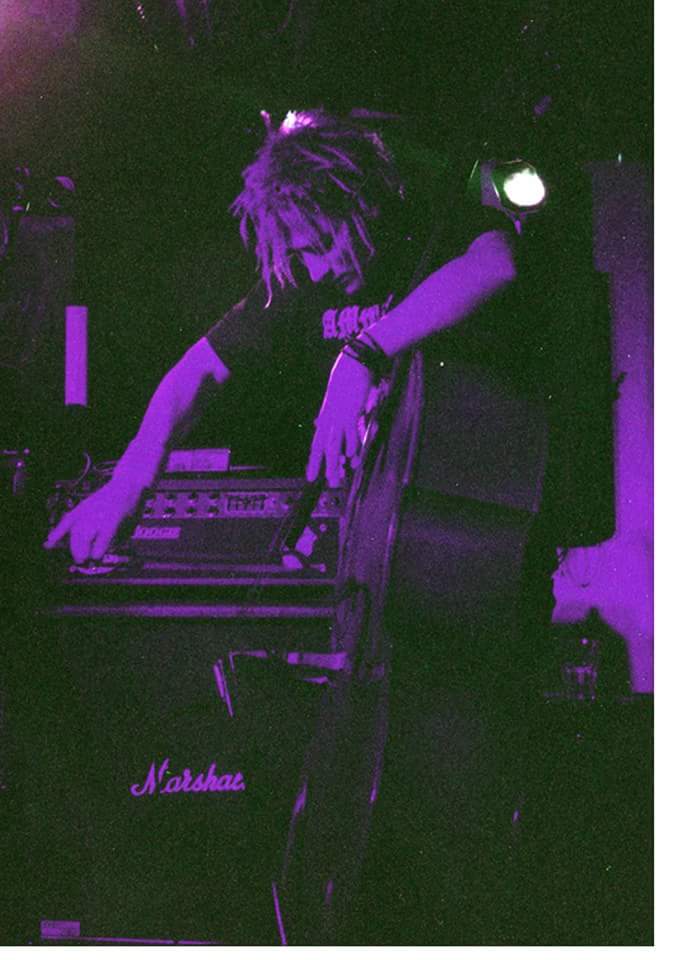L’EREDITA’
Nella stanza cadeva una bava di luce e allungata come un’ombra nel letto giaceva la contessa Lodovica Rabbia Trincavelli, che, a dispetto di ogni buonsenso, aveva continuato a fare scialo della ricchezza, come della vita.
Ritto in mezzo alla stanza stava il medico. Si schiarì la voce e poi parlò; ad ascoltarlo le nipoti della contessa, il suo alano Hugo, e la nuova cuoca insieme al figlio, un bambino di nome Osvaldo.
Non appena il medico ebbe finito di raccomandare aria fresca e medicine, s’aprì la porta; e l’ultimo cameriere in servizio introdusse il notaio, un uomo atticciato e ansante, che a passo spedito si avvicinò al letto della contessa; e provando a fissare quegli occhi di cemento, con il cappello in mano gettò una supplica come carne a un lupo:
– Contessa, ormai non le è rimasta che questa villa, qualche gioiello e il suo violino. Per l’amor del cielo la smetta di giocare o perderà tutto.
– E le pare poco? Solo il mio violino vale quanto un castello, e poi ciò che perdo mi appartiene. Giusto, care?
Le due nipoti annuirono con vigore, guardando quel viso di pergamena con la bocca aperta.
E se in gioventù era stata giudicata un miracolo di bellezza, grazia, e un eccellente violinista, era nell’età anziana ch’era emersa una personalità viziata, armata di una sottile crudeltà; aspetto che si era andato affilando negli anni, tanto da meritarsi l’epiteto di Trinca Rabbia.
Da quando il medico si era espresso la prima volta, dandole ancora pochi giorni di vita, erano passati mesi; durante i quali le nipoti avevano bandito una gara ad assecondare ogni suo capriccio. Ed era con celata soddisfazione che contemplava gli sforzi in cui le due donne si lanciavano nell’adularla e covarla di attenzioni; e avendone ormai il polso, dosava con malizia le richieste, per prolungare quel suo ultimo divertimento. Quando le dolevano i piedi, alzava una mano sibilando un “ah” perpetuo e immobile nel tono; se era un braccio a darle noia, alzava un piede creando una piccola montagna di lenzuola in fondo al letto, dando il via a una litania di singulti, cui rispondevano cori di celestiali Oh Signore, povera donna, che tradotti erano Povere noi, quanto durerà questo strazio? Ma la paura di essere diseredate era una frusta che schioccava obbedienza.
Il notaio era stato chiaro a riguardo: “Quando sarà il momento, la contessa scriverà il nome di quella che tra di voi l’avrà meglio soddisfatta.” E con questo capestro, la Trinca Rabbia si faceva accompagnare al casinò, quasi ogni sera, senza che l’una sapesse niente dell’altra; poiché a entrambe, a sere alterne, allungava la minestra con del sonnifero. Così, mentre una nipote strizzava l’occhio all’eredità, l’altra dormiva con lo stesso sentimento nascosto sotto il cuscino.
La Trinca Rabbia aveva ben compreso da quale interesse fossero mosse le nipoti. Appena arrivate alla villa, le due giovani si erano precipitate dal sarto: “Ancora più gonfio quel guardinfante, avanti, dobbiamo distinguerci noi, non badi a spese, paga la contessa.” Avevano ottenuto gonne talmente larghe da non passare più dalle porte.
Ma con il correre del tempo, mentre la Trinca Rabbia pareva risorgere a nuova giovinezza, i visi delle due donne sembravano armi spuntate dalla guerra; e persino il medico non riuscì a comprendere il segreto di quella donna, che sembrava aver detto alla morte: “Se esce testa vinco io, se esce croce perdi tu.”
Svegliatosi a mezzanotte, per i morsi della fame, Osvaldo si era diretto in cucina, luogo a lui proibito, se non di giorno, e al seguito della madre. Quando sentì le ruote della carrozzina calcare la ghiaia sul vialetto, e prima che la porta strepitasse sui cardini, si fiondò dietro la tenda e sbirciando vide una delle nipoti spingere la carrozzina, cercando di ricondurre alla ragione la contessa.
Poi le voci si allungarono nel corridoio.
– Mi era parso di essere stata chiara, decido io cosa farne del mio patrimonio. E poi voi non siete qui per quello, vero?
– Certo che no…è solo che…sarebbe un peccato perdere tutto. Lo dico nel vostro interesse, zia.
– Il mio interesse è affar mio. Maledetto zero, se solo fosse uscito. Che sfortuna!
Osvaldo stava per sgusciare fuori, quando Clotilde rientrò. Gettò gli occhi di là dalla tenda e la vide nascondere delle posate d’oro dietro una credenza. La nipote si guardò alle spalle come una ladra. Incrociò lo sguardo del bambino, e in due passi lo raggiunse.
– Che ci fai lì nascosto? Guarda che… - disse tra i denti mimando il gesto di uno schiaffo.
Ma Osvaldo, per niente intimorito e forte di quello che aveva visto, le fece capire, con gli occhi pieni di furbizia, che la carrozzina l’avrebbe raggiunta in pochi passi, e che la bocca l’avrebbe aperta non per far entrare le mosche, ma per far uscire il suo segreto. Quando Clotilde comprese di essere nelle mani di quel moccioso, gli chiese cosa volesse.
– Una forchetta d’oro, - bisbigliò Osvaldo.
– E che te ne fai?
– Affari miei.
– D’accordo, domani però.
– No, no, io la voglio adesso, - rispose mostrando il palmo della mano.
– E va bene.
A Osvaldo piacevano i pirati; e soprattutto amava costruire navi improvvisate con la fantasia dei bambini. Di tutte le imbarcazioni che aveva costruito, quella con la bandiera rossa era la migliore. Sosteneva che potesse anche volare. Gli mancava, però, oltre a un nome, qualcosa che le desse una certa personalità, soprattutto a prua.
L’indomani s’aprì con un concerto di mugugni soprani e lamenti baritonali, che la Trinca Rabbia inscenava ogni mattina per sfinire le nipoti. Poi, con una voce rauca e forte a dimenarsi in quel collo lungo e avaro, ordinò che le fosse portato il suo Maréchal Berthier e una coppa di champagne.
Osvaldo, che si trovava a passare di lì, attaccato alla gonna della madre, capì di aver scovato il nome per il suo veliero, e ripeté scandendo bene: “Ma-ré-chal Berthier.” Mollata la presa, corse per il corridoio, corse giù dalle scale, corse attraverso il giardino, e con Hugo che lo seguiva festante, entrò nel capanno degli attrezzi ormai abbandonato. Da sotto il banco prese la scatola di legno, e con il solo alano a far da testimone, la nominò: Maréchal Berthier.
Sebbene non lo potesse più suonare, a causa dell’artrite, la contessa riusciva ancora a impugnarne l’archetto; e ogni mattina lo voleva toccare e udire: due colpi d’arco sulle corde vuote, come la sua vita. Poi lo puliva dalla pece e lo chiudeva a chiave nella teca. Chiave che lei stessa custodiva intorno al collo e da cui non si separava mai.
La Trinca Rabbia passava le ore ad ammirarne la fiammatura, a perdersi nel profumo del legno che riapriva le porte dei teatri, dei balli di primavera, degli amanti e dei mariti cui era sopravvissuta fino a quel giorno. Era in quei momenti, e in quelli soltanto, che un sorriso le attraversava il grigio degli occhi, come un lampo.
Per le due nipoti, invece, quello era solo un oggetto di venale interesse, che da lì a breve la Trinca Rabbia avrebbe perso al gioco.
Dedicata la mattina al rituale del violino, celebrato con champagne o chianti, secondo il tempo, la Trinca Rabbia trascorreva i pomeriggi di novembre a fumare Vésuviennes sulla terrazza, contemplando l’immenso giardino: al centro c’era una fontana di marmo bianco, cinta da siepi e platani di un verde drammatico.
In uno di quei pomeriggi, in cui le nipoti l’avevano appena ricondotta al letto, chiese che i piedi le fossero puliti; calciò le coperte e mise in luce un’unghia nera come il nulla; poi domandò un altro cuscino.
Fu allora che scoppiò in una risata che partì bassa, dallo stomaco, e, attraversando il torace come a frantumarlo, sgorgò dalla gola sproporzionata, risuonando nei corridoi.
Clotilde, la più giovane delle due nipoti, si guardò le dita, tremule come foglie, e senza parlare afferrò un cuscino in fondo al letto, affondandovi le unghie, come a volerne strappare la trama; e con il volto accartocciato, si diresse con passi vicini verso la Trinca Rabbia. Ma Angelica, compreso il gesto estremo, anticipò la sorella, alzò con una mano la testa della vecchia contessa; sistemò un altro cuscino; e l’adagiò come un’urna.
Preso commiato, le due uscirono dalla stanza.
– Ma sei impazzita? Cos’è, non hai sentito il notaio? Se muore prima d’aver firmato, la villa e i beni rimasti, compreso quel maledetto violino, andranno…
– Lo so, lo so…ma sentila come ride di noi. E’ il demonio.
Le due sorelle si strinsero in un abbraccio e poi confessarono di essersi ingannate a vicenda. Poco dopo, davanti a un servizio di maiolica e due tazze di tè fumanti, decisero di rubare il violino, nasconderlo dove nessuno lo avrebbe cercato, e passare al ricatto.
Dopo cena, la Trinca Rabbia beveva sempre un bicchiere d’acqua calda allungata con l’Anesone triduo; le conciliava il sonno, diceva. Lì, finirono le due dosi di sonnifero.
Appoggiato il bicchiere sul comodino, la Trinca Rabbia cadde in un sonno pesante. Angelica le rubò la chiave, aprì la teca e consegnò il violino a Clotilde che l’andò a nascondere nel capanno degli attrezzi, mentre la sorella riponeva la chiave intorno al collo della contessa.
La mattina era arrivata tiepida di sole e Osvaldo, avvezzo a menar vita da pirata e a tendere arrembaggi alla schiena di Hugo, per poi trovar rifugio nelle aree più dimenticate della tenuta, aveva deciso che il galeone doveva essere finito entro la giornata, non solo perché era un bambino assai volitivo quando si trattava di giocare, ma soprattutto perché la madre lo aveva avvisato: quella sarebbe stata la loro ultima giornata alla villa.
A mezzogiorno il sole cadeva a picco sulla fontana, bianca da ferire gli occhi. Intorno al letto a baldacchino le nipoti osservavano la Trinca Rabbia: era buttata nel letto come uno straccio e un rivolo di saliva le scendeva all’angolo della bocca. Sembrava priva di vita. Le due giovani donne si tesero tutte in avanti. Angelica portò l’indice sotto il naso della contessa, per sentire se respirasse ancora. In quel momento aprì la bocca e parlò.
– Ho deciso. Andate a chiamare il notaio, ma prima vestitemi e portatemi sul terrazzo, e dite alla cuoca di preparare le mie omelette.
Le nipoti si scambiarono un’occhiata d’intesa e, allontanatesi dalla camera, cominciarono a parlare a fil di labbra.
– E ora il violino? – chiese Clotilde.
– Dopo, dopo, ora non c’è tempo. Corri dal notaio, presto, - rispose Angelica.
Clotilde si precipitò a chiamare il notaio; Angelica si occupò del resto.
Le omelette non arrivarono, ma dopo un’ora Clotilde tornò accompagnata dall’uomo che già impugnava il testamento e una penna. Le due ereditiere mordevano l’attesa della firma, quando la Trinca Rabbia chiese di vedere il suo violino e per la prima volta, con un gesto tra il sacro e il profano, si tolse la chiave dal collo e l’allungò verso le nipoti.
– Ma-ma certo, zia, - disse Angelica, battendo col tacco il piede della sorella – su, vai Clotilde, non hai sentito?
– Ah no, vacci tu, anche tu sai dov’è.
E nel dirlo restituì un calcetto alla sorella, che rispose con una spinta e dalla spinta a un pizzicotto e dal pizzicotto finirono ad attaccarsi per i capelli lanciando gridolini belligeranti come coltelli nell’aria.
– Silenzio! lasciatemi sola, basta! - intimò la Trinca Rabbia, - Fuori tutti! Guarderò il panorama con il mio binocolo, nell’attesa.
Dopo aver scrutato l’orizzonte, seguì il volo di un passero fare capolino sul bordo della fontana, dove Osvaldo, arrivato di corsa con Hugo a traino, giocava offrendole la schiena. Quando il bambino si voltò, alla Trinca Rabbia si drizzarono le gambe, il binocolo le cadde di mano, e lei si fece rigida d’un tratto.
Dalle acque caraibiche si alzò nel cielo e fu inondato dal sole: i raggi baluginavano sull’albero d’oro da cui spiovevano quattro stralli di seta e acciaio; un refolo gonfiò le vele fruscianti come carta, e il suo profilo iniziò a delinearsi: prima sbucò la ricciola prua, con quattro pirati d’ebano, e poi i fianchi con le f scroscianti d’acqua; finché la forma si rivelò nella voce fanciullina del capitano:
– Vola Maréchal Berthier, vola.
Quando la porta fu aperta, la stanza era avvolta dal silenzio come da un sudario. Le due nipoti, disperate per non aver trovato il violino, entrarono insieme al notaio come in un corteo funebre, trovando la contessa in un precoce rigor mortis.
Gli sguardi agghiacciati dei tre si spostarono dalla morta al giardino e da lì, veloci come lepri, all’erede dell’intera tenuta, che alzò una zampa per segnare la fontana come suo territorio; per poi scappar via con la lingua penzoloni, inseguito da un capitano e dal suo galeone, in una giornata piena di sole.
I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Andrea Olivo, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.