Quest'ultimo libro di Rosa Salvia, autrice lucana da tempo di stanza a Roma dove insegna storia e filosofia nei licei, ha il merito e il coraggio, dunque, di riportare al centro della riflessione poetica il suo luogo centrale, e cioè l'abitare la terra. Dico riportare perché nell'andamento ora della preghiera, ora della veglia, sa raccontare nel riferimento, non solo metaforico e simbolico, del giardino la tensione vitale di una creazione cui l'uomo stesso nell'inscindibilità degli elementi è chiamato a rimemorarsi, a concorrerne al corpo, mistico certo perché nell'unità di un legame che non gli viene da sé e di cui è responsabile nel carattere profondamente- e teneramente- umano e dunque fallibile della sua costruzione. Così il giardino da subito, dal primo testo, senza divaganti astrazioni, senza equivoci, si mostra, ci chiama a ciò che è, luogo del seme e dello "spazio che accoglie/quel seme". Occuparsi del seme allora è il primo movimento, che viene da un setacciare consapevole e partecipante della terra, di un'erba falciata con la lingua nella splendida definizione di un insieme che non esclude ma ricuce nel dire stesso le diverse aspirazioni del suo procedere. Un procedere che ha nell'altro l'osso, il cardine di un'impalcatura di cui ognuno è scheletro e albero, ancora, ed in cui la misericordia, l'attenzione e la partecipazione al dolore dice nella semplicità della complessità la speranza e quindi la comunità nella ricucitura della ferita. Giacché è evidente quello della Salvia è un discorso sulla comunità umana riportata nel microcosmo della comunità lucana d'origine e che ha nella seconda parte del libro il suo sviluppo più stringente. Non a caso il termine di radice in cui la fioritura si raccoglie ha la risonanza esatta in uno dei testi iniziali del rintocco vigile del campanile nella rispondenza che dall'ombra la afferma sigillandone il cerchio. Ma il senso, ci avverte, è tutto, nella seconda parola, essenziale e complementare al giardino, l'attesa, ecco, nella fatica ascendente e discendente dell' esserci "là dove agisce la gravità" e la nascita ha la provenienza oscura e umida del freddo. L'attesa infatti è un agire sì procedente ma anche rimettente ci viene costantemente ricordato, educazione alla fedeltà e alla pazienza che viene appunto dal concorrere entro una pratica d'orizzonte che tutto investe ma che anche ognuno, ogni cosa supera, trasfigura e rimonta. La parola deve, non può che accompagnare quest'agire, farne memoria a partire dagli uomini e dalle donne (soprattutto, in rappresentazioni in queste pagine esemplari), dagli animali, dagli elementi di una natura sovente fatta di fatica, di dolore (ed anche di morte là dove per nostra incuria "aspetta e riposa") in uno scorrere che ha il suo sviluppo, denso e piano, proprio accanto ed entro la rosa di spina, eletta qui a figura del senso. La parte finale del volume allora va a connotare l'esistente come esercizio e fisiologia del respiro nella sua tensione con la forma, di un'assenza diremmo che nell'accoglienza possa dire del mondo- e di noi- più che un' oscura bellezza il suo certo tornare ("innocente come una pala d'altare") e restare "ove con il vino spartiremo il pane,/il pane, la memoria e la casa" (si legga al proposito "Medusa", uno dei testi più esemplari). Questa lezione sacra e al contempo etica e civile altissima (essere "lingua ove le lingue/ cessano") in un tempo che non ammette tempo (nella sua tendenza a fare della coscienza un incidente) va al merito di un'autrice che ha saputo coltivarsi- e richiamare- alla luce di una verità possibile.

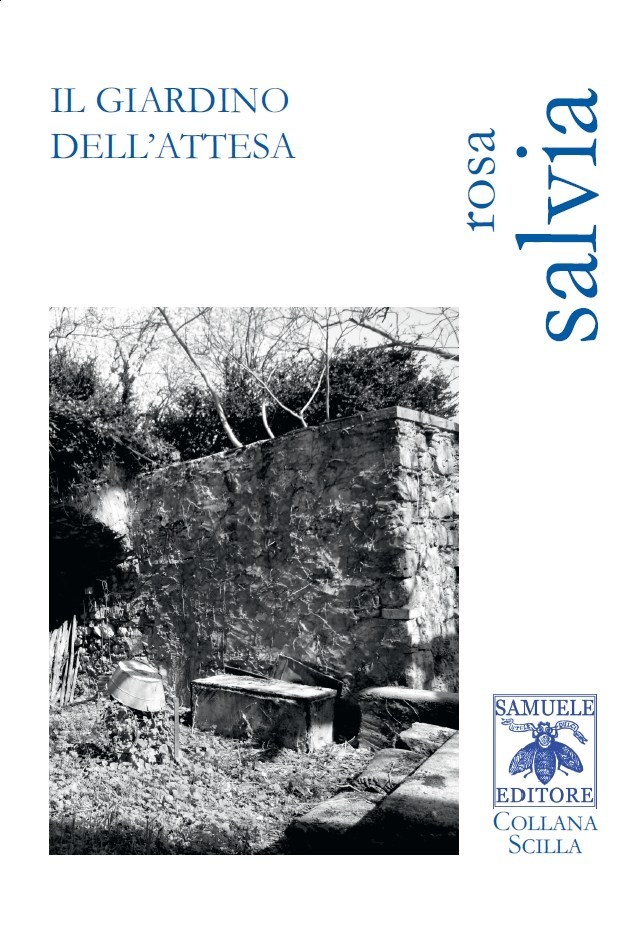

 ::
::