È un lucido disincanto a permeare questa nuova raccolta di versi di Filippo Ravizza, la coscienza storica del rivolgimento e dell’implosione delle grandi ideologie, e quindi dei valori guida che hanno animato il secolo breve a dominare questi versi accalorati ed espliciti, spesso dalla cadenza oratoria o affabulatoria, che non temono mai di farsi anche verso-pensiero, meditazione filosofica sul senso del trascorrere e dell’esistere, la fiducia “in uno spazio finalmente creato / dal pensiero”. L’autore non esita dunque a impiegare una terminologia, che potrebbe parere a molti datata, superata dai fatti, ribadendo con energia e decisione valori come comunità, socialismo, uguaglianza, giustizia, che sembrano essersi ormai ridotti nella società del nuovo millennio solo all’ombra del loro nome. Bene si intuisce la personalità dell’autore dai versi di questa silloge, la sua solida cultura umanistica che ha sempre creduto nel valore del cosmopolitismo, dello scambio culturale fra i popoli, nell’idea di un’Europa condivisa che sia un’opportunità per le genti che ne avrebbero dovuto realizzare l’idea fattiva. Urge tuttavia ricorrere, come nella proposizione precedente, al condizionale, alla constatazione di un’ipotesi storica incompiuta: il disfacimento delle ideologie ha portato all’affermazione di un falso edonismo neo-capitalistico, “nuova età di mezzo” dove l’unica stella polare è l’accumulazione della ricchezza, il soddisfacimento del superfluo, quel mondo a rovescio contro cui Ravizza non teme di contrapporsi, con la fierezza di versi senza compromessi, impossibilitati a una bonaria accondiscendenza. Ci ricorda infatti Ravizza, citando il titolo della sua precedente silloge, “è nelle radici di questo nostro / secolo fragile e incerto il vento / l’alba del mondo che nascerà / domani.”, sempre consapevole che il cammino è faticosamente incerto, ma occorre ancora crederlo possibile “un / uomo nuovo persona felice di / essere comunità” e solo questo merita di essere tramandato ai figli, alle future generazioni, perché le basi su cui poggia la nostra contemporanea ingiusta società sono d’argilla, l’unico finale che ci si può attendere è il loro sgretolarsi:
[…] ti lascio, figlia, nelle
mani di chi ha vinto la battaglia
del futuro… per qualche decennio
almeno, per qualche decennio
ancora padrone del nostro destino;
ma non per sempre, non per sempre
io credo.
E ancora
Qui forse rinasce la Storia…
tu vedi ora come scava
sotterraneo la condizione
della propria morte
il potere del denaro.
Rovina dunque e palingenesi (“un ponte intravisto nella notte”) che si mescolano inestricabilmente in un dire poetico asciutto, che rinuncia a sorprendere con metafore o ardite analogie, ma si serve della capacità comunicativa e argomentativa del linguaggio per articolare la denuncia, prospettare possibili vie d’uscita da un pensiero unico sempre più dominante. E questo sempre con “occhi asciutti” dice Ravizza, ricordandoci lo Sbarbaro di Pianissimo, e non lui soltanto, perché in certe iterazioni insistenti con valore rafforzativo e ritmico ci sembra di leggere un evidente influsso di Sereni (e questo confrontarsi con la Storia unisce Ravizza anche all’ultimo coriaceo Raboni), oltre al Luzi di “Nel magma” che è presente in alcuni esiti di tipo dialogico, quasi monologanti, come in questi versi
“L’uguaglianza di cui parlavi…”
- “parlo”, vi ho interrotto –
“di cui parli, non è mai stata
data, non sarà mai data…”
Vi ho voltato la schiena, un
dolore mi ha costretto dentro
camminando pensavo “o poesia,
poesia, strenua forza, unica
unica forza” come un pazzo
Sono questi espedienti retorici a dare dinamismo alla raccolta, a permettere il coinvolgimento attivo del lettore, che diventa parte in causa, interlocutore silenzioso, ma non muto, a cui queste domande vengono poste, perché agiscano in profondità fino a scuoterlo da una pericolosa letargia ed assuefazione allo status quo: e la poesia, in questa ripetizione “o poesia, / poesia” che ricorda a rovescio il leopardiano “o natura, o natura…”, viene ribadita come unica verità praticabile, forza di rottura. Gli anni possono disperdersi, evaporare, ma non muore l’idea profonda che gli uomini vi hanno saputo imprimere, come ci ricorda Ravizza in questi versi, dolorosi ed al contempo aperti alla speranza:
[…] “Tutto è impossibile,
ma tu ricordati, ricorda il desiderio
offeso del tuo pur mutilato amare”.
Questa non è però poesia che si arresta all’enunciazione, per quanto incisiva, di un pensiero, ma che crede fermamente nella capacità del pensiero di rendersi e doversi eticamente rendere azione, per non scadere colpevolmente a “rassegnata scienza”, quella che ci trattiene a capofitto nel baratro, perché è più semplice accettare la deriva in un oceano che sembra indomabile, anziché cercare di resistere alla devastante azione delle sue onde (quelle contro cui lottano le “nuove migrazioni”). Ecco allora anche i riferimenti continui a Hegel, alla sua visione che crede la Storia il concretarsi dell’Idea, il cammino incessante della Ragione che vuole oltrepassare se stessa, perché “si potesse toccare, sì toccare, / spingere un poco almeno più / in là l’idea, l’esperienza terribile, / vera, della totalità.”, perseguire così la ricerca di “una diversa verità” in cui sia il rispetto dell’uomo la priorità autentica, il ritorno alla dimensione dello Spirito.
Un libro vero, scritto da chi ha vissuto in prima persona certi sviluppi storici recenti, “La coscienza del tempo”, eventi di cui traccia un provvisorio bilancio, senza la pretesa di offrirne una chiave di lettura universale, ma come vuole la poesia aprire prospettive interpretative e sproni cognitivi al lettore. In questi giorni in cui si discute sulla scelta del Ministero di sopprimere la traccia storica nella prima prova scritta dell’Esame di Stato (la nostra vecchia e cara Maturità… altri tempi, quelli), credo che approcciare la lettura di un libro in cui la storia e poesia si intessono quasi come in una matrice organicamente pulsante, ci possa essere utile a capire che la Storia se non magistra vitae – come si assumeva in certo assolutismo pedagogico – per lo meno ci può essere proficua per evitare la ripetizione degli stessi, estenuanti errori (primo fra tutti ridurre la cultura a utilitarismo asettico, anziché formazione delle coscienze). Al poeta spetta solo scriverne, in silenzio, raccolto nella misura breve del verso, lasciarlo animare le coscienze. Spegnere la luce, sparire.
e levigare pietre e ostacoli superare
i mulinelli della Storia sapere ancora
una volta che qualcuno ricorderà
chi fummo noi… e poi spegnere la luce
deporre la matita, affidare al silenzio
alla carta le parole intere.



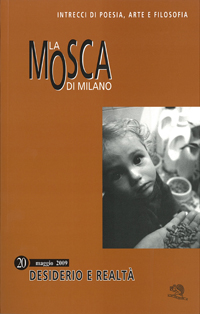 ::
::