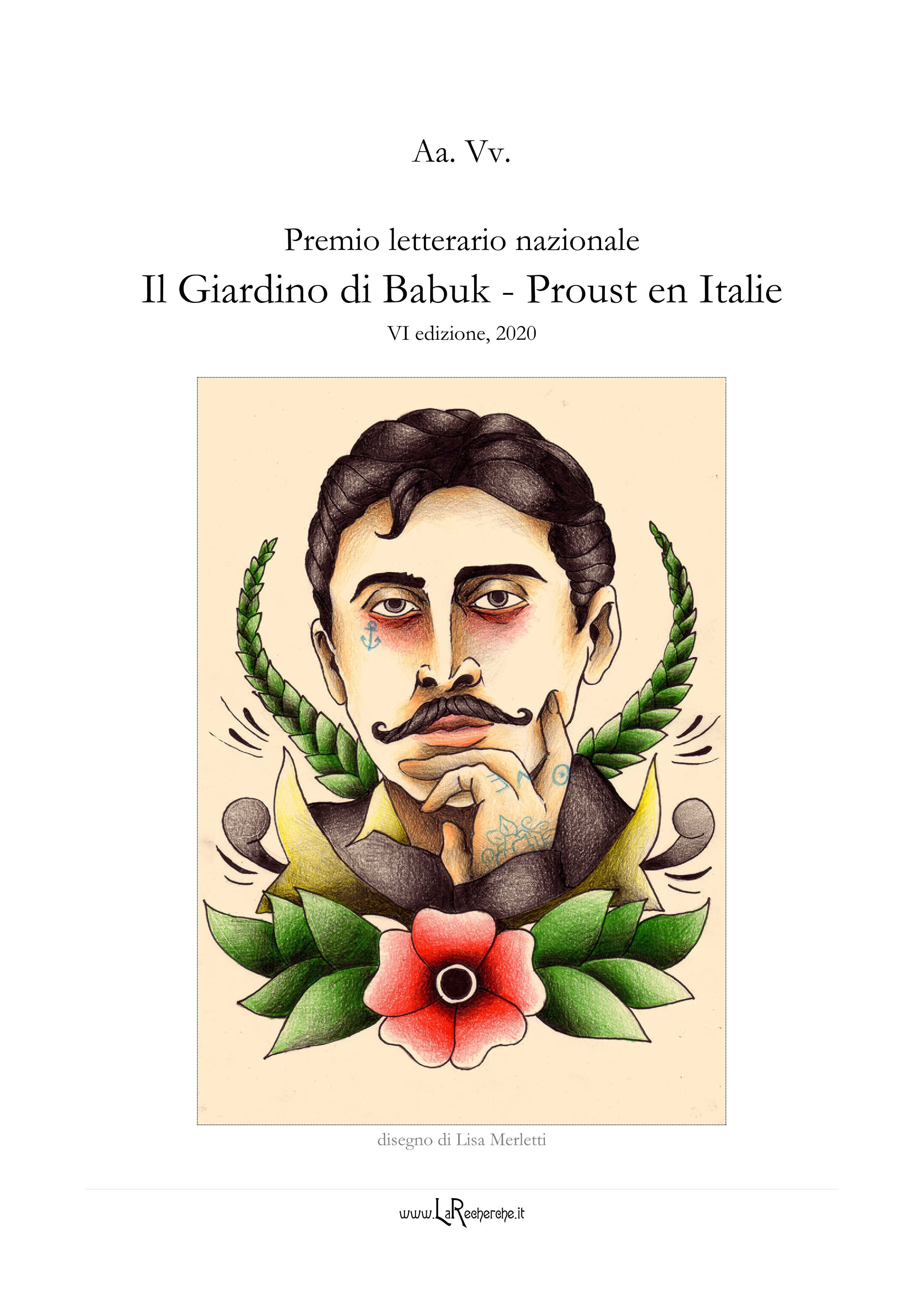chiudi | stampa
Raccolta di testi in prosa di Giaime Maccioni
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.
*
Pi-ri-pě!
[ Opera terza classificata al Premio letterario nazionale “Il Giardino di Babuk – Proust en Italie”, VI edizione 2020, nella Sezione B (Racconto breve) ]
Quel grido che giace dentro di te da chissà più quanti anni, attaccato ai tuoi organi, sepolto mille volte e che ancora si agita come un povero verme, liberalo amico mio, liberati!
«E va bene! Sì, stavolta ci sono!» rispose Carl «Ecco, ce la faccio, ecco: Pi-ri-pì!»
Rimasi attonito. Lui mi guardava, liberato.
«Come pi-ri-pi?» dissi.
«Pi-ri-pì!» rispose Carl.
«Ma sono dieci anni che ne parliamo e.…»
«Come mi sento leggero, finalmente! Erano appunto dieci anni! Che senso di sollievo!» disse Carl, massaggiandosi le gengive, in un gesto piuttosto repellente.
«Cosa significa, Carl?»
«Ma nulla!» ribatté lui «era questo, sì, proprio questo. È grazie a te sai, se…»
«Cosa significa questo…? Dieci anni, Carl, ne abbiamo parlato quasi ogni giorno. Era questo: pi-ri-pi?»
«Sì, proprio così. A dire il vero sbagli la pronuncia. È Pi-ri-pì! Oh, guarda, l’ho ridetto, lo posso dire quante volte voglio, ma è magnifico: Pi-ri-pì! Pi-ri-pì! Pi-ri-pì!»
Passò un autobus, due autobus, tre autobus. Scomparvero, blu, in fondo alla strada. Tre autobus come i suoi tre pi-ri-pì. Il viso di Carl non l’avevo mai visto così. Più giovane, la serenità negli occhi, un altro. Mi guardava con senso di gratitudine.
«Scusami Carl, ma io non riesco a capire…»
«E cosa vuoi capire?»
«Non riesco a capire se mi stai prendendo in giro oppure…»
«Come prendendo in giro, che ti viene in mente? Non mi metto a saltare di gioia solo perché sono ancora frastornato. Sono sbalordito, sono annichilito! Io…l’ho detto! Lo posso dire ancora, ascoltami: Pi-ri-pì!»
Carl a questo punto lanciò un urlo verso il cielo, e mi abbracciò, mentre le lacrime gli scendevano libere sulle guance, formando due torrenti. Libero, nato una seconda volta. Lo sentivo dalla forza dell’abbraccio, che mi toglieva il fiato.
«Piano, hey, piano…»
Si staccò e rimase a guardarmi, il viso impiastricciato di pianto, chiazzato di rosso, perché era uno di quei pallidi che al primo sfregamento si infiammano e si riempiono di minuscoli puntini, soggetti a mille allergie e complicanze, e in lui la pelle non era che un’espressione simbolicamente molto azzeccata dell’animo.
Era sempre di umore fragilissimo. Bastava un nonnulla a distruggergli la giornata. Era meglio non prenderlo in giro, perché sebbene non fosse propriamente permaloso l’enorme disistima che aveva di sé lo convinceva sempre che in fondo in fondo colui che lo sfotteva avesse ragione, e ci restava molto male. Era incapace di fingere, poveretto, si ammutoliva e non ti guardava più negli occhi. Cosa c’è Carl, guarda che scherzavo. Sì, figurati, niente c’è, che vuoi che ci sia. Ma ci metteva un giorno intero a riprendersi, e a volte non bastava. E poi c’era questa cosa, che mi rivelò già poco dopo che ci incontrammo per la prima volta. Questo qualcosa che non riusciva a dire, che gli divorava il cuore e i polmoni, e tuttavia non si faceva espellere. Un mostro di lettere senza un ordine preciso, un concetto non bene elaborato, una sensazione che non si decideva a germogliare. Ne parliamo da dieci anni, quasi tutti i giorni, Carl! Prova, prova a dirmi, prova a buttare giù un discorso, come ti viene, fregatene! Silenzio. Gli occhi che finiscono dietro un filtro. Se faceva freddo si copriva di sfoghi color carota. No, non ci riesco, non ci riesco davvero! Ma grazie lo stesso, grazie, sei il mio solo amico.
È vero, ero il suo solo amico. Che terribile responsabilità. Conosceva qualcun altro ma vedeva solo me, per bere una birra, per fare una passeggiata. Gli altri erano colleghi di lavoro o parenti, zii e cugini che incontrava qualche volta all’anno per un pranzo comandato. Le donne lo evitavano come la peste. Era grassottello e morbido come una montagnola di albume montato, aveva pochi capelli biondi e il suo alito ricordava una cantina, pulita ma rimasta chiusa per anni. Ci eravamo conosciuti in fila alla posta e ci eravamo scambiati il numero di telefono solo perché lui doveva fare un’altra commissione e mi aveva chiesto la cortesia di avvertirlo quando fossero arrivati vicino al suo numero. Aveva voluto poi a tutti i costi offrirmi un caffè per ringraziarmi, e così avevamo chiacchierato. Avevo capito subito che doveva essere molto solo dall’avidità con cui si attaccava alla coda di ogni frase, come se non volesse far finire mai quella conversazione. Due settimane dopo, quando organizzai una piccola festa per il mio compleanno, gli mandai un breve messaggio: se ti va di passare. Rispose che avrebbe provato, ma ero convinto che non l’avrei visto a casa mia, né forse mai più. Invece venne, eccome se venne. Vestito di tutto punto, in giacca e cravatta (unico tra gli invitati), mi portò un portafrutta di ceramica, accompagnato da un biglietto in cui annunciava quello che mi attendeva. Grazie, scriveva, questo tuo invito mi fa pensare che il mondo forse non è tutto da buttare!
Mi faceva tenerezza. Acconsentii a ogni caffè che ci teneva a offrirmi, e a poco a poco diventammo amici. Volevo aiutarlo. Qualcosa lo affliggeva nel profondo, e non riuscivo a capire cosa. Sì, il suo aspetto, i suoi odori, quel modo di camminare da acrobata di quart’ordine, come alla ricerca di un equilibrio irraggiungibile, con i piedi che alla prima distrazione inciampavano l’uno sull’altro, mi faceva capire che la sua vita sociale non dovesse essere una cosa semplice, ma era un ragazzo in gamba, piacevole e anche buffo, nel suo malessere a oltranza, nella manifestazione fisica e verbale di piccoli dolori che, a suo dire, lo sconquassavano simili a macchine di tortura. Uno sbuffo di vento gli trapassava il cranio come una lama. Un movimento sbagliato equivaleva a una tenaglia stretta intorno al bacino. Una volta perfino un colpo di tosse lo gettò in un baratro di angoscia, perché sosteneva, subito dopo aver espettorato, che la gabbia toracica gli stesse andando in fiamme, e mi chiese di sentire con una mano sotto alla maglia se non ci fosse stato in effetti un repentino aumento di temperatura. Mi rifiutai.
Nel calderone di quella sfilza di guai fisici ed emotivi, c’era poi questa cosa che voleva tanto dire ma non riusciva a dire. Né in alcun modo poteva descrivere, collocare in un terreno semantico, farne una metafora, semplicemente accennare in quale dei più comuni campi d’appartenenza dei tormenti umani essa risiedesse. No, nulla di preciso, è solo una cosa, una cosa che mi sta dentro da sempre, la sento come un animale vivo, che mi cresce nella pancia, che abita in me, e so che è possibile tradurla in parole, delinearla, comprenderla a fondo e finalmente buttarla fuori. Oh, come mi piacerebbe liberarmi, mormorava passeggiando, col pingue sedere che ondeggiava afflitto dalle preoccupazioni, nel crepuscolo primaverile di una via del quartiere dove abitavamo entrambi.
Lavorava come informatico per una società che sviluppava videogiochi. Da ragazzino era stato uno di quei fissati che passano i pomeriggi a ingrassare davanti a uno schermo, mentre i compagni di scuola giocano a calcio. Non fu del tutto una scelta. I suoi genitori lavoravano entrambi fino a molto tardi. Una nonna lo passava a prendere a scuola e lo portava a casa. La sua maniera di tenergli compagnia era accendergli una consolle, e chiudersi in cucina a preparare pietanze di ogni tipo che avevano tutte, così mi raccontava Carl con una smorfia, il medesimo odore di cipolla.
Nei suoi occhi di adulto, sempre inclini ai rossori e alle lacrimazioni, si vedeva la fissità di quei pomeriggi, che probabilmente contribuirono a rendere quel ragazzino il silenzioso, solitario e introverso uomo di oggi. E non gli diedero nemmeno in cambio un po’ della passione che se non altro anima quei piccoli maniaci di elettronica e giochi di ruolo che fino a un certo punto vengono relegati ai margini della vita sociale di licei e università, e poi, poco a poco, si prendono la più sonora delle rivincite, diventando inventori o registi di successo, accumulando milioni e belle donne, mentre quelli che al tempo della scuola erano popolari finiscono a lavorare in un’autostazione, e la loro antica bellezza sfiorisce al sole di giornate tutte uguali.
No, nemmeno questo al povero Carl. Era diventato un bravo programmatore, ma nulla di speciale. E nessun fuoco di conoscenza ardeva nel suo cuore a forma di prosciutto. Si annoiava, dei videogiochi non gli interessava più nulla, e non vedeva l’ora, ogni giorno, che arrivassero le cinque del pomeriggio, il momento di scappare via dall’ufficio.
Di queste cose mi parlava volentieri, e con una certa enfasi. Capivo che non aveva mai avuto nessuno cui descrivere il grumo delle sue sensazioni, ed ora che l’aveva trovato era preso come da una foga di raccontare tutto, di non dimenticare uno dei particolari che aveva incolonnato chissà per quanto tempo in lista d’attesa dentro la gola. All’improvviso spintonavano per venire fuori. I suoi discorsi erano spesso confusi, tornava sulle stesse frasi, le correggeva, le riformulava con altre parole, poi si accorgeva di aver tralasciato un dettaglio (spesso insignificante) e allora riavvolgeva il nastro e ricominciava, agitato, restando a fissarmi dopo aver finito, come per individuare nel mio volto i segnali del fatto che avessi capito esattamente di cosa mi aveva parlato.
E le cose erano all’incirca queste: erano tutti spietati, chi più e chi meno, sempre pronti a farsi le scarpe, mai disponibili a un piccolo sacrificio per dare una mano. Condiva le sue considerazioni generali con il resoconto di episodi di piccoli soprusi aziendali, molto noiosi e tutti all’incirca simili. Per me avevano poca rilevanza. Mi sembrava di ascoltare un bambino che per la prima volta, col faccione sconvolto, si rende conto della natura degli uomini, e vede intorno a sé i castelli e i ponti della favola in cui pensava di abitare crollare nell’abisso della vita. Per fortuna, per qualche motivo che non so nemmeno io bene decifrare, Carl mi divertiva. Il suo pessimismo era qualcosa di cosmico, e conduceva i suoi pensieri in un assurdo logico per il quale il mondo risultava essere una trappola per topi, e lui, sorprendentemente, il solo topo in circolazione.
Una volta me lo portai dietro all’opera. Era la Turandot. Io andavo con la mia fidanzata. Dai vieni, Carl, vedrai che ti piacerà! Non so come vestirmi, e poi di certo sono di troppo, figurati, il terzo incomodo, meglio di no! Carl, siamo insieme da due anni, conviviamo! E che vuol dire? E poi è prevista pioggia, e io con la pioggia ho sempre un mal di testa nauseante, come se mi mettessero sul naso un bavaglio imbevuto di vomito, hai presente la sensazione? Alla fine lo convinsi. Altro che opera. Era lui il vero spettacolo. Quando Calaf decide di accettare la sfida della principessa, Carl si portò le mani alla testa, e per tutto l’intervallo tra il primo e il secondo atto non fece altro che spiegarmi perché lui, al suo posto, non si sarebbe mai fatto abbindolare. Più tardi, non appena Turandot finisce di porre il terzo enigma, iniziò a mormorare tra sé, a fior di labbra, non lo sa, non lo sa, e mi chiedeva: lo ammazzano vero, lo ammazzano? Guarda, Carl, guarda! E ridevo con la mia ragazza. Ah, questa la conosco, disse a voce alta quando sentì le prime note di Nessun Dorma, facendomi vergognare. E verso la fine, quando Liu si lascia trafiggere dalla lancia di uno degli sgherri, per poco non cadde dalla sedia. Da quel momento in avanti pianse come un vitello, a grandi singhiozzi, e fuori, prima di salutarci, mi disse: è la cosa più bella che abbia mai visto!
«Pi-ri-pì!» cinguettava ancora Carl, «Pi-ri-pì!». Essendo abituato a un ben preciso Carl, quest’altro Carl nemmeno lo riconoscevo. Per la primissima volta appariva quieto, come un malato che ha appena ricevuto l’iniezione di un formicolante sedativo e finalmente, invece di occuparsi del dolore fisico, può pensare ai fatti propri. Guardava un punto generico, con un semisorriso, e la faccia a forma di pera colorata uniformemente di un rosa acceso.
«Ma che accidenti significa?» lo incalzai ancora.
«Nulla! Pi-ri-pì! Che bello, che bello! Nulla significa: Pi-ri-pì! Pi-ri-pì! Ecco cos’avevo dentro, un grande, gigantesco Pi-ri-pì!»
Ci salutammo e lo vidi allontanarsi, rinfrancato anche nel passo.
Poi per qualche giorno non si fece vivo. Gli mandai qualche messaggio ma non rispose. Dopo una settimana, la sera, passai a casa sua. Citofonai senza successo. Un tale, che ronzava intorno al portone del palazzo con un cane, si avvicinò con un’aria leggermente famelica, e mi chiese se cercassi qualcuno. Lui abitava là, spiegò. Un amico, dissi. Carl. La faccia dell’uomo mutò di colpo. Si chiuse in un’espressione di disagio. Cosa c’è, domandai. Non sa nulla, vero, rispose lui. Lasciò passare qualche secondo, in cui non smise di guardarmi, e poi: Carl si è… disse, lei è un amico eh… Carl si è buttato dalla finestra. Una settimana fa, oramai. Ma possibile non abbia saputo nulla? Rimasi impietrito. Attesi la conferma alla domanda che avevo immediatamente posto con lo sguardo, e che lo sconosciuto comprese all’istante. Morto sul colpo, disse, pover’uomo! Una cosa sconvolgente, mi dispiace che solo ora… stai fermo tu, strillò al cane, io non sapevo…abbiamo messo un’inserzione sul giornale, noi come condominio…immagino non abbia letto il…mi dispiace molto di averle dovuto dare questa orribile, orribile…
Me ne andai verso casa, stravolto. Mi veniva da vomitare. Non riuscii a dormire per giorni. Nei pochi momenti di sonno mi compariva il viso di Carl come lo avevo visto l’ultima volta, sorridente, liberato, e mi risuonava nelle orecchie quell’assurdo pi-ri-pì.
È passato molto tempo ma ripenso spesso al mio amico Carl, e a quella fine. Pensare al rumore orripilante del suo corpo sull’asfalto mi fa venire i brividi. Vorrei prendere il tempo e rivoltarlo, seguire Carl a casa in quell’ultima camminata, leggere meglio dentro i suoi occhi, e salvarlo. Ma da cosa, poi, mi chiedo. Allora il suo volo lo immagino come un volo di felicità, verso un mondo che meglio avrebbe saputo capirlo e amarlo per quel che era. Mi tornano in mente le sue mille idiosincrasie e il pianto che si era fatto alla Turandot, e con uno strano calore nello stomaco torno alla mia giornata, alla mia vita che tanto mi piace.
Id: 4836 Data: 26/04/2020 20:18:50