[Recensione di Roberto Maggiani]
La nuova raccolta poetica di Paolo Ruffilli è divisa in due sezioni: “Le stanze del cielo” e “La sete, il desiderio”. E’ una raccolta importante e ne consigliamo la lettura, poiché l’autore tocca, in versi di rara leggerezza, chiarezza e musicalità, temi di rilevanza sociale e umana. E’ una poesia attenta alle tematiche più intimamente legate alla vita dell’uomo. Probabilmente pochi, tra i lettori di questo sito, avranno sentito parlare di questo poeta, poiché una delle sue caratteristiche è proprio la capacità di comunicazione non urlata e non imposta, ma basta leggerlo una sola volta per rimanerne affascinati e toccati intimamente. Il libro si sviluppa su una novantina di pagine che scorrono snellamente, al ritmo di versi precisi, come una bella e melodiosa canzone. Si legge, nella azzeccata prefazione di Alfredo Giuliani: “[…] In questo nuovo libro Paolo Ruffilli conduce il lettore in due territori a dir poco inconsueti per la poesia: lo spazio concentrazionario ‘esterno’ della prigione e quello ‘interno’ della tossicodipendenza, in entrambi i casi dietro all’ossessione della perdita della libertà”. Ruffilli si – e ci – avvicina in punta di piedi, con grande intelligenza e umanità, al complesso mondo interiore ed esteriore di un detenuto e racconta il dramma intimo e pratico della convivenza atroce con una condanna che spesso oltrepassa il limite della dignità della persona, fino a non limitarsi alla condanna del solo fatto compiuto ma che rischia di spingersi fino all’essere dell’individuo stesso che ha compiuto il fatto, ragionamento perverso che, portato all’estremo, può arrivare a legittimare persino la condanna a morte, punizione ultima, definitiva e irrevocabile della persona umana. Egli mette in evidenza un bigottismo sociale troppe volte capace di condannare chi è stato, per così dire, “beccato in reato”, rispetto a chi non lo è stato; ma la domanda è: chi può mai dirsi innocente di fatti condannabili? Sintomatica di una visione particolare del poeta sulla pena detentiva è la poesia intitolata “Il patto”: “[…] / ma che significa punire? / E’ un patto: si arriva / a giudicare il fatto, / non la persona. / E una sola azione / non corrisponde all’uomo, / non può rappresentarlo / né tanto meno cancellarlo.” L’autore rimette le cose, con un accento fortemente umano e comprensivo, nell’ordine che devono avere, l’errore di un’azione non corrisponde all’uomo, e non può permettere a nessuno di decidere la bontà o la cattiveria di una persona. La persona è una cosa, il fatto compiuto un’altra. Nella poesia intitolata “Lettera morta”, Ruffilli descrive – in brevissimi versi che hanno la stessa e immediata bellezza dello scatto fotografico su azioni che riconducono a pensieri intimi dell’uomo detenuto in prigionia – la solitudine e lo scoraggiamento, il dissolvimento e l’oscurità, la perdita di ogni conquista dello spirito laddove il male semplicemenmte è, per quanto non voluto: “[…] / batti le dita / sopra il tavolo / o sul muro / e fai fatica / […] / Le grandi conquiste / dello spirito / quaggiù sono solo / lettera morta. / In basso regna l’abiezione: / il male non si vuole, / semplicemente è. / Dissolvimento, / oscurità infinita… / la fine / di tutti i valori / della vita”. La perdita della libertà è cosa orribile per un uomo, per quanto possa essersi macchiato della colpa più atroce, tanto più se il detenuto, come sembra trasparire dall’insieme dei testi, riconosce la propria colpa fino ad esserne pentito, ed è proprio questo intimo e personale pentimento che fa apparire il soggetto detenuto e narrante come un individuo con un’intima certezza di innocenza, come se Ruffilli volesse darci il messaggio, propriamente e gradevolmente evangelico, che il pentimento può riportare l’anima di chi lo vive allo stato iniziale, per quanto questo lasci la persona umana in una profonda solitudine: “[…] / Ci volle per riavermi / o, forse, è un’illusione /riprendersi da un colpo / come questo…spogliato, / sia pure nella colpa, / di ogni dignità / lasciato nudo e indifeso / di fronte al puro / mio fatto compiuto”. Ed è una solitudine che è un supplizio, come si evince dalla omonima e bellissima poesia intitolata “Supplizio”: “La donna che un tempo / avevo amato, la ragazza / dagli occhi neri / che per sempre / mi ha lasciato. / L’idea che non / la vedrò più… / E’ il supplizio mio di qui: / morire senza morte, / un tempo che / intanto passa lento / e non esiste / e sembra non finire, / un non avere / ormai più porte / da cui uscire”. E ancora in “Ombre”: […] / le parole, a un tratto, / cominciano a strisciare / più viscide dei vermi / lungo il muro. / Solo il silenzio / può sembrare allora / il modo per restare / vivi ancora e più al sicuro”. Nella seconda sezione, “La sete, il desiderio”, le poesie seguono il ritmo dell’angosciante mondo della tossicodipendenza, che Ruffili inizia con questo epigramma: “Ma non c’è strada / che mi riporti indietro?”. E subito, versificando in prima persona, indaga le cause che portano il soggetto narrante all’uso degli stupefacenti: “Non fu curiosità / e non fu noia / che mi spinse / e mi ha smarrito… / fu anzi la coscienza / minuziosa /di me e del mondo / a muovere e guidare / i passi ignoti / del mio precipitare. / […] “. E la droga diventa quel “lei” che assume le fattezze di una ossessione da cui è quasi impossibile liberarsi, poiché trascina nel vortice della necessità dirompente del nulla mascherato da pienezza: “[…] / ti basta lei per stare al mondo / e dare voce aggiunta / al tuo silenzio / e finta luce al buio / che ti gonfia il cuore”. Come un monito e un S.O.S., una richiesta che vuole spaccare l’indifferenza, sale il lamento: “”[…] / Vorrei lasciare / adesso, sì, l’inferno / del tempo mio perduto, / cercare di levarmi / giù dal volo, / ma non riesco / a smettere da solo”.

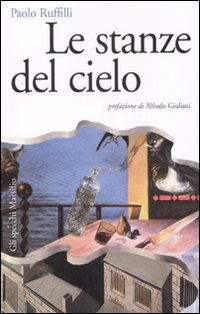

 ::
::  ::
::