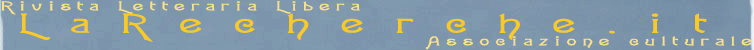
« torna indietro |
leggi il testo | scrivi un commento al testo »
Commenti al testo di Antonio Terracciano
|
|
Antonio Terracciano - 22/01/2018 19:39:00 [ leggi altri commenti di Antonio Terracciano » ]
Ringrazio tanto Leonora Lusin per il suo interessante intervento. Ma a me (sarò un don Chisciotte... ) piace battermi (anche) per un ritorno (dopo cento anni, ormai, pure la poesia "moderna" e quella "ermetica" sono diventate vecchie... ) , se non proprio alle rime, alle solide forme metriche della tradizione (per non correre il rischio di fare, come a volte accade, delle "prose verticali" ... ) Insomma, mi piacerebbe una maggiore democrazia in campo poetico: se una poesia è scritta bene, lo è sia in modo classico sia in versi liberi (che, se scritti davvero bene, sono secondo me ancor più difficili da realizzare... ) Sono d’accordo, infine, che occorre molto lavoro di scavo interiore per ottenere qualcosa di interessante, anche se non credo che tutti siano capaci di usare appropriatamente la metrica... |
|
Commento non visualizzabile perché l'utenza del commentatore è stata disabilitata o cancellata. |
|
Antonio Terracciano - 14/01/2018 15:48:00 [ leggi altri commenti di Antonio Terracciano » ]
Ringrazio moltissimo l’architetto Colozzo per il suo sincero contributo al mio (probabilmente troppo manicheo) intervento. Pur capendone poco o nulla, ho sempre ammirato la professione dell’architetto, perché costituisce un ponte tra l’arte e la tecnica (ho, fin da bambino, un amico che da giovane voleva fare il pittore - ed era anche bravo! - , ma che poi, consigliato oculatamente dal padre, si laureò, con eccellenti risultati, in Architettura) . Ebbene, secondo me la costruzione di una poesia assomiglia parecchio a quella di una casa: se si vogliono ottenere risultati magari modesti, ma sicuri, la si farà secondo le regole della tradizione, usando buoni materiali (buone parole) e stando attenti alla solida struttura (al rispetto dei metri) . Solo architetti eccelsi (poeti eccelsi) potranno permettersi di infrangere (fino a un certo punto) le regole tradizionali, creando, ad esempio, il Beaubourg di Parigi (Renzo Piano) o il Centro Direzionale di Napoli (Kenzo Tange) , che si distinguono per le loro linee originali e innovative (pur evidenziando poi, mi pare di sapere, qualche problemino... ) In altre parole, una poesia in versi liberi, per essere considerata davvero poesia, può essere composta (ogni tanto! ) solo da grandissimi poeti, e può presentare anche degli inconvenienti... Parigi sarebbe ancora Parigi se avesse non una, ma dieci, cento, mille Tour Eiffel? |
|
Avendo buttato giù da profana qual ritengo di essere, nel mio saggio: "E’ morta la Poesia?", alcune mie riflessioni sulla morte della metrica sia per scelta personale sia per carenza di approfondimenti seri sulle opere degli autori del passato e contemporanei, mi permetto di dare il mio umile contributo in questa sede. |
|
Commento non visualizzabile perché l'utenza del commentatore è stata disabilitata o cancellata. |
|
@ Raffaele |
|
@ Ferdinando |
|
Commento non visualizzabile perché l'utenza del commentatore è stata disabilitata o cancellata. |
|
Ferdinando Battaglia - 10/01/2018 20:58:00 [ leggi altri commenti di Ferdinando Battaglia » ]
Angelo, potrei dilettarmi di fisica e non considerarmi, a ragione, in fisico; sarebbe una contraddizione? Oppure una necessaria condizione per smettere? Credo che la consapevolezza di un confine non infici una prassi ancorché per riferimento al modello ancora approssimativa. |
|
Caro Ferdinando, mi vien da dire di queste tue affermazioni "il senso lor m’è duro". Capisco cosa intendi con il tuo criterio differenziale tra scrivere versi e scrivere poesie ma francamente lo trovo artificioso. Se uno scrive versi lo fa per scrivere poesie. Riguardo al rapporto tra consapevolezza e capacità anche qui siamo su un terreno molto scivoloso. Non so per altri ma io non perderei tempo a scrivere ciò che autodefinisco poesie se non fossi convinto che valgono qualcosa. Impiegherei il mio tempo in modo più fruttuoso. |
|
Ferdinando Battaglia - 10/01/2018 20:25:00 [ leggi altri commenti di Ferdinando Battaglia » ]
Angelo, non vi è contraddizione tra scrivere versi e non considerarsi poeti: una questione di consapevolezza della propria vocazione di fronte alle possibilità d’espressione raggiunte. |
|
Per quanto mi riguarda sono del tutto sereno. Ma in una discussione bisognerà pur dire qualcosa di significativo. |
|
Antonio Terracciano - 10/01/2018 18:50:00 [ leggi altri commenti di Antonio Terracciano » ]
Vorrei riportare un po’ di serenità nella discussione, aggiungendo soltanto che, in base alla mia esperienza (a vent’anni scrivevo versi liberi parecchio sentimentali, ed alcune mie "poesie" furono anche gratuitamente pubblicate, in un’antologia di giovani "poeti" , dall’allora abbastanza noto intellettuale e poeta romano Pietro Cimatti) , col tempo si è forse portati a dare maggiore importanza alla forma che al contenuto (perché probabilmente tanti contenuti, prima o poi, si sciolgono come neve al sole, mentre le forme restano solide come pietre) . A proposito di Einstein, citato da Ricotta, poi, non so se avessero ragione i suoi discenti a disertare le sue lezioni, troppo difficili. (Dico questo perché, negli ultimi due anni di scuola superiore, fui alunno di Savino Coronato, sacerdote solo per l’abito che indossava, ma in realtà con due grandi passioni, la Matematica, che insegnava - era stato il primo assistente del mitico Renato Caccioppoli alla "Federico II " di Napoli: dopo la tragica morte del nipote di Bakunin, non avendo più appoggi all’Università, si era ridotto a insegnare in un Istituto superiore - , e la poesia di Baudelaire, che spesso e volentieri declamava in classe. Riempivo il mio quaderno dei suoi appunti matematici di livello universitario - e talvolta forse anche postuniversitario - , appunti che mi risultavano sempre praticamente incomprensibili, ma che, accostati a quelle grandi poesie, mi aprirono gli occhi alla sostanziale - leonardesca e, tutto sommato, anche proustiana - unità di tutto lo scibile umano. ) |
|
Caro Raffaele evidentemente mi hai frainteso. |
|
Commento non visualizzabile perché l'utenza del commentatore è stata disabilitata o cancellata. |
|
Ferdinando Battaglia - 10/01/2018 14:29:00 [ leggi altri commenti di Ferdinando Battaglia » ]
Chiedo scusa, ripropongo la versione riveduta e corretta. |
|
@ Raffaele De Masi |
|
Ferdinando Battaglia - 10/01/2018 14:06:00 [ leggi altri commenti di Ferdinando Battaglia » ]
La Recherche ha molti pregi e pochissimi difetti, che peraltro io non vedo. Condivido sia il richiamo ai classici sia le argomentazioni di Angelo ricotta, meno che la definizione di poeta torvi fondamento su di un giudizio meramente soggettivo, ancorché è indubitabile, secondo me, che la poesia è esperienza di lettore e non canone di un dogma, pur tuttavia i due aspetti coabitano forzatamente in una indefinibilità dell’oggetto, ma neppure, fautore di una libera espressività, si può negare l’importanza della lingua e dell’uso che ne fa un autore, per una sua collocazione tra i grandi o tra i minori, tra i poeti o semplici emuli o versificatori. Poi avremo sempre le voci critiche fuori dal coro, come ad esempio la Valduga che di Leopardi poeta non ne ha grande stima, mentre lo ritiene una grandissima intelligenza ed un filosofo. |
|
@ Antonio Terracciano |
|
Commento non visualizzabile perché l'utenza del commentatore è stata disabilitata o cancellata. |
|
Antonio Terracciano - 10/01/2018 10:33:00 [ leggi altri commenti di Antonio Terracciano » ]
Ringrazio moltissimo Angelo Ricotta per essersi interessato a questo mio scritto, effettivamente troppo veemente e ingeneroso. Il mio intento era però essenzialmente quello di invogliare, soprattutto chi non ci avesse ancora mai provato, a scrivere in qualche modo più "classico" , per gustare le profonde soddisfazioni interiori che l’uso della metrica (e della rima) riesce a dare all’autore (del resto, è famosa la frase di Picasso, che esortava i suoi allievi a dipingere prima in modo classico e poi, semmai, come lui; e Umberto Eco, una volta, in una "Bustina di Minerva" , scrisse che ci sono cose - materiali e immateriali - che hanno raggiunto una perfezione oltre la quale non si può andare, e portava l’esempio del bicchiere... ) |
|
Complimenti per aver letto tutta La Recherche in originale! Ti fa senz’altro onore. Però il resto delle tue considerazioni mi paiono ingenerose e anche infondate. Sappiamo che Giuliano Brenna, che gestisce insieme a Roberto Maggiani e Maria Musik il sito, è un raffinato cultore di Proust e quindi da qui il nome, immagino. Comunque Proust non mi pare proprio un "tradizionalista" in letteratura, e l’eccezione che fa per Mallarmé è significativa in poesia. Poi i gusti sono molto personali. Un sito può benissimo configurarsi come tu auspichi ma, evidentemente, i creatori hanno deciso diversamente e, secondo me, giustamente. Che senso ha dopo millenni di evoluzione culturale costringere la produzione artistica in ristretti ambiti? Mi sembra anche ingiusto apostrofare gli autori del sito come imitatori dei poeti del novecento. Che si dovrebbe dire allora di chi scrive sonetti? Questo è il solito facile sprezzo riservato a chi non è famoso, non certificato dalla critica ufficiale. Sarebbe ora di leggerli senza prevenzioni, per quello che sono, i testi degli autori sconosciuti e su di essi dibattere onestamente. Ma questo sembra impossibile. La maggior parte delle persone sono plagiate da coloro che hanno successo, che appaiono spesso in tv, che vengono osannate dai critici di regime. Gli artisti, che sono per definizione persone creative, non possono passare la vita a ripetere i moduli del passato. Sarebbe una noia mortale. E poi a che pro? E quali moduli del passato? Ci dovremmo fermare ad Omero o alla Divina Commedia, o in qualche altro punto della storia? |