chiudi | stampa
Raccolta di saggi di Giorgio Mancinelli
[ LaRecherche.it ]
I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*
 - Fede
- Fede
’Pacem in Terris’ - Papa Giovanni XXIII
“Ogni essere umano ha diritto alla libertà di movimento e di dimora all’interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consigliano, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi con esse. Per il fatto di essere cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l’appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale”.
*
 - Poesia
- Poesia
Enrico De Lea … o il tempo del ritorno.
Enrico De Lea … o il tempo del ritorno.
“Cacciavento”, silloge poetica – Nuova Limina / Anterem Edizioni 2023
È così che funziona, allorché l’eco del gemito che abbiamo emesso all’origine del (nostro) tempo, viaggia col vento di ritorno che spacca la roccia e fa rotolare il sasso giù dalla montagna; quello stesso che scompiglia la solitudine degli anfratti in cui ci rifugiamo alla ricerca di un’identità che uguagli ciò che siamo, polvere che s’invola al guardo dell’irraggiungibile orizzonte, oltre i tetti delle case, le strade dell’ignota città in cui viviamo, i marciapiedi, i lampioni, il suolo che i piedi hanno calpestato, in cui la gente (come noi) s’ammassa nelle piazze, nelle chiese, dimentica del cipresso silente cui il ‘cacciavento’ smuove la cima che ispira il dialogo delle nuvole che fluttuano sopra e sotto il cielo di quel Dio che si vuole assente…
“…di cui non si rammenta / volto figura voce, solamente / l’aria smossa il soffio i luoghi il passo, / cui ricordare […] per quanto è lungo ed infinito a guardarlo […] nell’utopia delle armacìe paterne.”
Ma se niente passa, allora tutto ritorna nella trascendenza che ci illude del nostro vivere nel presente, che solleva il diaframma al necessario respiro del tempo, onde per cui sentiamo “il segname della terra-scorza” come d’una malìa che tutto accresce della materia che ci compone, molecole di entità nascoste in cui tutto si ravvisa dei naturali elementi; dacché la sensibile umanità che ci portiamo dentro, la pressione sanguigna che nondimeno ci rende vivi, il cospicuo patrimonio strutturale che ci vuole unici nella elegiaca espressione dei sentimenti e che ci vede proiettati nello spazio avvolti della poetica intuizione dell’istante…
“Ergo, ima spina abbrusca il cacciavento, / lo impedisce e spinge, scialle e solerzia, / l’aria di uguale furia, valletta del momento, / luccichio che domina la pietra, / pertanto esso trascende l’aria in forza, / che lo rialza, lo preme e lo sostiene, / (ma) ignorano le frequenze dell’ascensione e del rischio, / allo sguardo sul volo, che sanno del cacciavento?”.
Niente e tutto è la risposta, nel tentativo di cancellare un sapere postulato, onde restituirlo all’imprevedibilità della parola, a quell’immaginifico metafisico di cui fa qui uso l’autore Enrico De Lea, proiettato com’è nel format ontologico-filosofico della poesia contemporanea, situandosi, come avrebbe detto Gaston Bachelard, “sempre un poco al di sopra del linguaggio significante” (*), nel voler sostenere la validità delle proprie suggestive immagini letterarie. Da cui l’ascesa, quel ‘sognare di volare’ come d’uccello che si leva nel vento, e la successiva ‘caduta libera’ verso la realtà, (in essere del presente), dalla quale pur restando dov’è, si distanzia dentro l’immagine olistica del suo inconscio e/o nascosto volere…
“A figurare il volo / del cacciavento, che non cunta e punta / e sospende, a spiritosanto, / l’aria che frolla sotto l’ala e scende, poi, / in picchiata, vuoi o non vuoi, / finché non si scorga non si veda / carne della necessità / nudo cuore del mondo, della preda.”
Con l’affrontare il tema in “cacciavento” l’autore, di fatto delinea il suo costante guardare verso un orizzonte non condiviso con la sua attuale esistenza, e che pure segna, a mio avviso, il tempo del suo (possibile) ritorno e/o la volontà di concludere la sua ricerca introspettiva nella “immaginazione materiale” in cui si conduce, come ossimoro attivo della coscienza a contatto con la materia, in questo caso il ‘cacciavento’, che l’ha plasmato-scolpito nella forma a sé irrefutabile…
“Serve un inferno assicurato, confortevole, / Sicché il cacciavento scaccia da sé demoni, da umano, / Si limita nel volo, scorge aspre nuvole, / Sale alle Rocche, ridiventa lontano. […] Ignorandoci, reciproci imputati, / Il volo è ignoto, l’albero e il morto ramo.”
Ma l’‘aria’ (il vento) non è il tutto, è solo uno degli elementi non ignaro della convergenza degli altri, per cui se restituiamo alla ‘luce dell’intelligenza’ il suo pur ambiguo progetto di indicarci la ‘soglia’ o forse la ‘meta’ leopardiana di un possibile raggiungimento dell’ ‘infinito’, noi materia finita che ci aspetta oltre l’albale dell’orizzonte, potremmo pensare alla volontà dell’autore di un sorprendente ‘volo’ che irrompe dalla sua contemplazione e che segna, di là dal suo divenire, l'essere giunto il tempo del suo ritorno…
“Eppure questo subitaneo volo / Consacra ignaro il secco e l’umore / Della terra, e una striscia senza colore / È il mare al cacciavento, aria attratta al suolo.”
È nella ‘trascendenza’ di quel che siamo, che l’aria contraffatta dalle parole, dalle frasi disgiunte dal contesto di una liricità rifratta che scolora fin dall’abbrivio, che viene a mancare il mittente nonché l’indirizzo della ricerca, che non va letto come un tratto negativo nella scrittura qui utilizzata, piuttosto in quanto frutto di un’azione decisamente affermativa di un legame fisico con la terra d’origine alla quale De Lea fa costantemente riferimento, quella Sicilia sospesa tra cielo e mare, fucina di validissime voci letterarie, battuta a tratti dal ‘cacciavento’ che s’impone riportando all’attualità l’antico sapere, nel riconoscimento dei tratti originali che la distinguono…
“Nel volo, tra bestiale e celestiale / Il cacciavento invero rassicura, inganna, / Per dire a memoria futura bene e male, / A cespo, a troffa, a ghiotta di vita che si gode e danna.”
Enrico De Lea infatti non contraddice l’influenza che la Sicilia inculca nell’afflato della sua personale poetica, vivida di innovazione culturale, altresì trova in ‘cacciavento’, l’aver plasmato la sua onomatopeica trascendenza linguistica …
“…una costante invenzione dell’eterno […] Alle anime-pietre, alle anime-piante, nel loro raggio, […] più di quanto ci dirà forse / Un infinito padre jonico, / Ci dirà una madre d’amore senza pietà, / Una carne un nulla un tempio laconico […] ‘ntinni, ntinni’ …
…il sempre nell’aria delle ali.”
Note:
(*) Gaston Bachelard, "Psicanalisi dell'aria" - Red Edizioni 1992
(") tutti i corsivi sono dell'autore dalla silloge "Cacciavento" Anterem Edizioni 2023
L’Autore. Enrico De Lea, avvocato messinese molto legato ai suoi luoghi d’origine per motivi di lavoro vie a Milano. Molto attivo nell’ambito della poesia ha pubblicato diverse sillogi poetiche, è stato finalista al Premio Montano 2016, con l’opera “La furia refurtiva”. Successivamente “Giardini in occidente” 2022 - Seri Editore. Suoi testi sono presenti inoltre in vari siti e riviste on-line.
*
 - Letteratura
- Letteratura
“La Distanza” …o dell’incomunicabilità - di Ermanno Guantini
Una raccolta di Ermanno Guantini - Anterem Edizioni 2023
Una parola o un’altra non avrebbe fatto la differenza, le parole non avrebbero potuto eludere “la distanza” cui neppure gli anni sarebbero riusciti a colmare e che in queste pagine non sembra conoscere rassegnazione, ma che potrebbe ben essere l’incipit di questo ennesimo excursus sull’ “incomunicabilità” del nostro vivere quotidiano culturale e formativo. Una realtà diminutiva e disgregante che abbonda sui social subdolamente acculturati, pur facendo uso di un vociare assordante che avvertiamo come ‘solitudine’ estrema, incolmabile dal punto di vista umano e sociale…
“…nella distanza della notte […] lei fissa la catasta […] lui osserva la catasta […] rincasa la notte”
“lui osserva schermo […] lei osserva ad ombra parete […] lui mano chiude […] lei osserva lo lascia […] lei osserva il silenzio”
Incolmabilità di distanze, al punto che neppure una certa psicologia analitica del profondo applicata al testo, riconosce come autentica quanto determinata di un cercato ‘distacco’ che nel voler farne poesia subisce l’allontanamento dalle reali intenzioni e la temuta cancellazione di tutte le emozioni che pure “la distanza” concerne. ] Voluta o involuta si è davanti a una storia personale fermata sulla carta, causa una ricercata scrittura creativa de-costruita, affine a una reiterata incapacità di esternazione che pure, se diluita, ad esempio, in forma di romanzo, vedrebbe raggiunta una più ampia quanto necessaria espressività cogente…
“fuori sincrono la casa […] sulle pareti segnali / scheletri di polvere / condividono stallo […] senso di claustrofobia […] la contaminazione non esiti”
“lui sfiora il pavimento / la bracciata in lentezza / carneficina di ombre […] lei scivola in casa / sviano le stanze […] franano ebbri / ripudiano la carne”
L’eccezionale, presumibile di un non-dire che l’autore Ermanno Guantini si riserva di colmare di senso, impone una domanda al lettore attento: a che pubblico rivolge la propria distante appartenenza; al poeta introverso mistificatore d’una realtà indicibile che lo attanaglia (?) e/o al mancato artista della parola in cerca di una qualche affermazione che ne riscatti in qualche modo l’esistenza (?)…
“pavida preghiera / da nuda ferita […] non afferrano parole / lei solleva gli occhi / a oltrepassare la notte […] cielo disfatto da luci […] non sa che muore / nel vuoto del cuore […] si confessano aspri / vigliacchi sontuosi / in asprezze ricade”
“sono giorni che è dentro / e non riesce a parlare / ai sogni origami / ricuce un viaggio […] o se tutto rimane / manca prospettiva / fuoco di mare / ancora cammino / in crosta di riva / lei osserva il vento […] …a paura /in fondo annegano / le nuvole in cielo”
Non ciò che le parole dicono confermano la veridicità dello stare sulla cresta dell’onda, se così fosse ma così non è, rispecchierebbero lo specchio d’acqua limpida; o anche fosse, della profondità torbida dell’anima in bolgia. O, forse, le parole che mancano, non mancanza d’idee, andrebbero cercate in quel che si è, in ciò che non si è capaci di dare, nella più cinica e spietata indifferenza della ‘distanza’ che separa…
“in lontananza il rumore / lui segue il pensiero […] lei osserva i respiri / la gioia fragile / non soccombe / poi osserva la luna […] denuda i pensieri […] squallori di luci”
“gli dice divenire / una parte del buio / rassicura tornerai […] possa il perdono / a volte ritornano / fluttua la notte […] almeno un’ora almeno / segno nel piacere […] i piedi in graniglia / al mattino fuoco / del loro stralcio / contumacia di cuori”
È allora che ‘la distanza’ assume il senso dell’incomunicabilità cui si è connaturati, o magari perché portati al silenzio, contro il vociare della moltitudine, da cui non si è capaci di prendere le distanze e/o ci si lascia sommergere. Un modo come un altro per sentirsi vivi nel ‘vuoto’ che tutto attornia, nel giusto e nell’errato; o forse solo per voler mantenere una certa ‘distanza’ a volte necessaria, dal bene come dal male, ma che pure permette di sopravvivere alle continue sfide della vita…
“lui segue l’orma / nel cielo crolli / contro campo luna […] nelle parole il fondo / nostalgia di colori / di nuvole crepitano / creste illune […] il silenzio il senso / di colpa la solitudine / aspra di mare”
“cielo su contrasti / grigi su distese / innamoramento […] carezza di silenzio / sassi di cielo / in scuri di bianco […] immagini nella coloritura […]la voglia di dirimere / le parole disseccano / poi lei siede sovrasta”
Sedimentazione di ‘vuoti’ le parole inusuali, i connubi azzardati nell’ipocrisia dei sentimenti, le assonanze sempre fuori sincrono, non permettono quella lettura fluida cui l’ostentata verbosità del linguaggio autorale si concede. Per quanto l’esperienza ‘poetica’, ovunque la si voglia cercare, non è nell’ineluttabilità della forma che gli è data, ma appartiene all’aere pregne di vita, alla testimonianza conoscitiva, al test sperimentale che di volta in volta si riveste della luce del giorno e/o anche volendo del buio della notte per avallare qualcosa che non c’è ma che pure, a sentore dell’autore, s’avverte da sempre come pre-esistente…
“concessione della notte / contaminazione di cielo / fuochi lungo la spiaggia / l’infanzia si riprende la notte […] in controluce la casa […] solo scalfitture […] disintegra una felicità / una distanza d’acque / la contaminazione / il trapasso dei sogni”
“lui rivede piano / si sente braccato / sa di non avere / speranze ricaccia […] si determina un fallimento […] la scelta della depressione [...] era solo allora / ascoltava le parole / sparigliava / la spirale della veglia”
“lei osserva il grattacielo / filigrana oppressione […] osserva la pioggia / la città la distanza […] la nebbia sopra gli alberi […] la colpa del senso […] ancora un’esplosione […] ci sono risultati / trasmissioni la solitudine / il cielo la collisione / niente trasalimenti”
Dov’è finita la poesia? È nell’intimo afflato di esistere che si conduce nei lidi edulcorati della ‘distanza’ dall’amore? Dalla musica esuberante e scontrosa dei nostri giorni? Nelle profondità degli abissali buchi neri di cui non si ha conoscenza? O nella “situazione di teatro” in cui l’autore fa muovere un “burattino che balbetta” e che “non assapora parola / in preda ad un rantolo”? Chi mai saprà dare risposte a questa nuova parola “incomunicabile” che chiamiamo poesia se si avalla una ‘distanza’ che sa di lirica performance senza costrutto, di compromesso generazionale? Di fatto la ‘poesia’ s’avvalora delle ali di farfalle libere di volare, non accalappiate nel retino e messe nella bacheca di collezionisti che, per quanto siano belle da vedere nei loro colori smaglianti, restano comunque cose morte…
“…uno assapora parola / attesa che sia / interpretata”, ed è già “nostalgia di parole” – scrive Giorgio Bonacini nella sua pur feconda post-fazione.
Rendiamo viva la poesia, che non finisca sulla bacheca dei soli ricordi.
L’autore:
Ermanno Guantini, scrittore, ha pubblicato raccolte di versi “Variazioni” Cierre Grafica 2003; “Aperto a inverni” 2004 e “Nocturama” 2012 per l’Edizioni d’if - Napoli
Nota:
Tutti i virgolettati “-” sono una sintesi dei testi di Ermanno Guantini.
*
.jpg) - Libri
- Libri
Alessandra Greco...o la ricerca interstiziale. - Anterem Ed.
Alessandra Greco…o della ricerca interstiziale. Collana Nuova Limina – Anterem Edizioni 2023
Andare alla ricerca di una qualche risultanza poetica alquanto marginale attraverso gli spazi ‘a vuoto’ dell’esperienza quotidiana, su cui raramente la scienza sociologica ha potuto mettere un punto fermo sul quale impostare un valore qualitativo presumibile e/o quantomeno prevedibile, e quindi spiccare quel volo pindarico che permette di proiettarsi nel mondo 'reale' di cui gli ‘interstizi’ sono parte integrante dell’arte scrittoria, potrebbe sembrare arduo.
Proviamoci, se non altro per il gusto (leggi piacere) di superare con un salto a piedi pari la ‘soglia’ che ci separa dall’essere quotidiani lettori di parole, a immaginari cultori dell’avanzata tecnologica che ci permette di re-interpretare la cultura letteraria e grafomane, e sperimentare contenuti coinvolgenti che catturino l'attenzione, magari alla luce di una piattaforma A.I. ultimo avamposto della comunicazione social e non solo.
Ed anche, per così dire di una presa coscienza del mondo virtuale verso cui siamo proiettati qui ben rappresentata nell’intenzionalità dell’autrice, Alessandra Greco, sia graficamente: con la scrittura e le immagini ad essa relative; sia con il linguaggio fluido (leggi liquido secondo l’elocuzione di Zygmunt Bauman), che prosegue ininterrotto dai segni ̶̶ ̶ ̶ specifici dell’interpunzione, in quanto simboli ‘interstiziali’ di un dialogare verbalizzato…
“--- nettando – acqua che sottrae all’informazione --- disfacendo”
Ma spingiamoci in una ricerca più avanzata in campo emotivo quanto creativo, il cui accesso, perduto o forse dimenticato non so, va situato al di là del concetto di un mondo solo in apparenza pauroso e pericoloso già superato dalle culture antiche, come quella vedica e taoista…
“- il suo essere immerso – emissioni – appena –e/sondazione --- del gioco -- -- acqua che si corrompe ---- ---- acque albule --- territoriali --- corrosivi inintelligibili acque -- -- in cui si nasconde – dove l’onda fa un rimbocco --- - au niveau du plateau”.
Si pensi ad esempio al potere apparentemente effimero della ‘resilienza’ che individua e permette di sviluppare la capacità di affrontare i cambiamenti della vita; e/o la saggezza di Jalal al-Din Rumi il poeta mistico persiano che «Al di là dei concetti di ‘azione’ ed ‘effetto’, nell’intervallo fra un un’ispirazione e un’espirazione, individua ‘campi’ di emozioni e riflessioni», dove sono ammessi anche i ricordi, i ripensamenti, le meditazioni che hanno accompagnato la crescita dell’umanità…
“principi di sovrapposizione chiamati strati | lamie constricti | fino quadriglie schegge blocchi a livello dell’oggetto chiaro sulla macula | brecce ossifere | scomparti superstiti del retablo del Giudizio Universale” .
Sono questi ‘campi’ in cui la fisica quantistica oggi sostiene ci fanno percepire in qual misura, nella corsa affannata della modernità, andiamo perdendo negli ‘interstizi’: «Analogamente al modo in cui molti fotogrammi in sequenza fanno apparire un film così reale, anche la vita si manifesta in base a brevi e minuscole esplosioni di luce, denominate ‘quanti’.» (*) La ‘poesia’ stessa, che da sempre rischiara il mondo, in fondo cos’è, se non una luce che il poeta individua attraverso i siderei ‘campi albali’ delle stelle epifaniche di eventi inspiegabili…
“oblique verso cielo, chinandosi in albore da luminosità distesa.”
Quella stessa luce che Massimo Recalcati in un’esplosione di fluorescenza equipara a “La luce delle stelle morte” (**) che arriva dal passato, in cui cita Freud «…più o meno quello che accade anche con la nostra memoria, […] tracce di un insieme aperte alla possibilità di produrre sempre di nuove.» Siamo all’apoteosi della ‘poesia degli interstizi’…
“coquille. carré. demi-raisin. raisin. jésus. soleil. colombier. petit aigle. grand aigle. grand monde. univers.”
Siamo all’elevazione della potenza del ‘close-up’; si va verso l’avvicinamento demiurgico della figura del poeta rapito dal…
“lisciare il flusso sopra un-non-so-che maternale nascosto --- (space/storage) contrasto umbratile di intensa durata - (air/exhaust) - non fatto da mano/intride le cose”; “al reciproco pensare per - fratture - allo stesso modo un singhiozzo ---”.
Siamo alla ‘parafrasi’ della parola, alla riformulazione lirica del canto per antonomasia, che decostruisce la frase, il registro del testo, pur mantenendone la riconoscibilità, l’assonanza con l’originalità del linguaggio, al controcanto e al discanto per quanto uniformi e paralleli al canto stesso, al di sopra del canto, fuori del pentagramma.
Per dirlo nel confronto con l’arte pittorica, di ciò che si spinge oltre il muro di fondo, alla sinopia, e/o dentro la trama della tela, oltre la cornice, come per la light-art o l’affissione pubblicitaria in movimento…
“il tutto - volendola così - intorno”, “non è mai ferma - un secondo inizio - ‘Untitled’ vs cominciamento”, “quando si riesce a sperimentare l’immaginazione delle immagini si avvicina l’invisibilità che riflessivamente fonda il passaggio”, “i sensi si ritirano progressivamente uno dentro l’altro - la possibilità di condividere/far svanire”.
Dacché la ‘ricerca interstiziale’ di Alessandra Greco si afferma in questo pamphlet di parole e immagini che non necessariamente danno forma a un unicum compiuto, quanto a una provocazione d’intenti, alla ricerca affannosa (leggi dolorosa) della memoria ancestrale che mai come adesso spinge verso una spazialità cosmica universale…
Ad maiora!
L’autrice. Alessandra Greco, studiosa antologizzata in “Continuo - Repertorio di Scritture Complesse”, indaga attraverso la scrittura i vari aspetti della processualità del pensiero come flusso e in relazione alle immagini, attraverso la tecnica del montaggio. È fra gli autori di BAU Contenitore di Cultura Contemporanea - Viareggio 2023. Ha realizzato performance e letture apparse su numerose riviste e lit-blog, suoi testi sono tradotti in “Babel, Stati di alterazione”, Antologia plurilingue a cura di Enzo Campi – Bertoni Editore 2022.
Note: (*) Max Planck “Sui quanti elementari della materia e…” - Convegno Internazionale, Roma - Accademia dei Lincei 2001. (**) Massimo Recalcati, “La luce delle stelle morte” - Feltrinelli 2022.
*
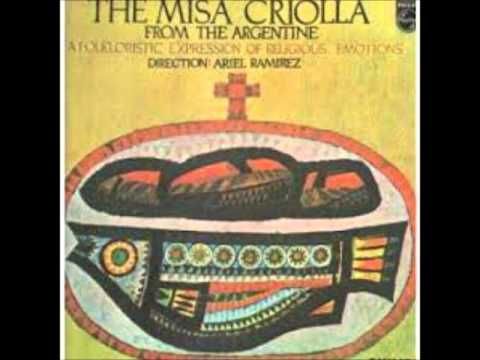 - Musica
- Musica
’La Musica di Dio’ 2 - ricerca etnomusicologica.
Sacro e profano nella Liturgia della Messa – Ricerca etnomusicologica.
Allorché la Liturgia Cristiana delle origini s’annunciava salvifica e sostanzialmente comunicativa di pace e di fratellanza, fin da allora era costume lo scambio e l’offerta dei doni della natura durante la “Messa” che, trasformati in cibo, venivano distribuiti ai più bisognosi in segno di solidarietà, affinché tutti potessero godere della ‘gloria’ per la ‘Resurrezione di Cristo’ con l’animo colmo di gioia, a voler significare che alla ‘nera fame del tempo’ andava corrisposta un’adeguata dose di sostentamento per il corpo e per lo spirito. Sostentamento che, dopo i necessari ‘pianti quaresimali’ e le ‘processioni di espiazione’, ben si prestava ai proponimenti di ringraziamento per il ritorno al quotidiano ‘vivere’ della comunità tutta, raccolta in preghiera per l’arrivo della Pasqua.
Questo il senso intrinseco alla spiritualità religiosa della “Messa Pasquale” delle origini, affermatasi nella concretezza definitiva agli albori del Medioevo per tutto il XV secolo, allorquando Santa Romana Chiesa giunse ad esercitare il suo pieno potere in Europa nella Spagna dei Re Cattolici. Successivamente, con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come Santa Inquisizione, l’aspetto quaresimale della ‘festa’ si tramutò ben presto in patimento popolare a causa delle truculenti “Processioni per la Settimana Santa” a scopo penitenziale, in cui si videro alzare i ‘roghi’ contro il paganesimo e la stregoneria, con la cacciata dei giudei-sefarditi, degli zingari e quant’altri fossero diversi, nel modo in cui abbiamo appreso a conoscere attraverso le insanguinate pagine della storia.
Ma una così ferrea disciplina di tipo aconfessionale, fortemente imposta dall’allora potere regnante, e forzatamente accettata dalle frange dei vecchi cristiani, trovò il disaccordo dei Mozarabi presenti sul territorio fin dall’Anno Mille, sorti in difesa
dell’uso della lingua ‘mozarabica’, che dava atto di un ‘continuum’ dialettale romanzo conservato nella penisola iberica da parte dei Cristiani nell'XI secolo e nel XII secolo, ancorché cancellato dalla loro secolare liturgia avallata in comunione con la Chiesa cattolica, dopo l’abolizione del rito liturgico ‘Mozarabe’ da parte di Papa Gregorio VII.
Molto si deve all’operato di quei padri missionari che, giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, inclusi i mozarabi e i nomadi zingaro-gitanos, a misurarsi con la liturgia della “Messa” cristiana, durante le funzioni imposte loro allo scopo di convertirli al cattolicesimo.
* La celebrazione della “Messa Mozarabe” (LP Philips), nell’interpretazione dei cristiani che verosimilmente ce l’hanno trasmessa nella forma orale, è caratterizzata dal connubio di elementi ispano-gotici con elementi di origine spagnola, quale retaggio di una sua probabile cristallizazione avvenuta nel periodo della calata dei Visigoti in Spagna. In ogni caso è ritenuta la liturgia toledana per eccellenza, essendo Toledo all’epoca il centro di magior forza e vitalità della sua diffusione. Ma mentre nella Cattedrale veniva imposto il ‘rito romano’ di Santa Madre Chiesa, un saggio compromesso permise di conservare il ‘rito mozarabico’ nelle altre chiese territoriali dove la popolazioni si erano insediate.
Gli esperti sono tutti d’accordo sul fatto che lo schema della liturgia morarabe è romano, quantunque essa presenti, come tutte le liturgie occidentali, elementi affini a liturgie orientali (bizantine). Alla liturgia Mozarabe è attribuita la più antica versione del “Pater Noster” nell’uso proprio della ‘cantillazione’, una sorta di recitazione quasi intonata (derivata dalla maniera ebraica di cantare in prosa i passi della Bibbia), eseguita con voce nasale, nel modo usato dai cristiani orientali nella lettura dei testi liturgici. Ancor prima quindi della riforma gregoriana, il ‘testo’ veniva eseguito nelle chiese spagnole durante l’occupazione dei Mori, facendo in modo che questi non ne comprendessero il senso. Una certa eleganza formale proviene da un altro esempio ripreso dall’antifona “In pace” come preludio corale al Salmo successivo:
«Lumen ad revelationem gentium: et gloriam plebis tuae Istrael.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
Quod parastiante faciem omnium populorum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut era in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.»
Quella contenuta in questa registrazione dal vivo della “Messa Mozarabe” (*), fu eseguita dal Coro del Seminario di Toledo e del Collegio de Infantes diretto da P. Alfonso Frechel con una orchestra di strumenti antichi, diretta da José Torregrosa. Degna di nota è l’affermazione di un cardinale presente nella Sala Conciliare del Vaticano II il 15 Ottobre 1963, il quale, dopo aver assistito all’esecuzione dellla “Messa Mozarabe”, disse che era il rito più bello che fosse mai stato celebrato nella Basilica di San Pietro.
* La “Misa Flamenca” (presente su LP Philips lato opposto alla “Messa Mozarabe”): costituisce una chiave di lettura di particolare interesse etnico e musicologico all’interno della tradizione liturgica Gitano-Andalusa ‘musicalmente compiuta’, così come è entrata nella religiosità cristiana, eseguita da gruppi ‘gitanos’ che hanno partecipato a questa registrazione ‘dal vivo’, entrata successivamente nella grande tradizione liturgica della cattolica Spagna. Si è spesso detto delle possibili influenze indiane, ebree, arabe e bizantine che avrebbero concorso alla formazione del topos ‘flamenco’, ma va qui considerata la profonda trasformazione che la “Misa” ha subito nel corso dei secoli, allorché i Gitanos anziché lasciare il paese, trovarono riparo nelle ‘cuevas’, le grotte nascoste fra le montagne più interne della penisola spagnola.
Ciò, che non avvenne con gli Ebrei-sefarditi, i quali, dopo aver tentato inutilmente di sottrarsi al terrore dell’Inquisizione di convertirli al cattolicesimo imperante, affiancando le migliaia di maestranze che giungevano in pellegrinaggio da tutta Europa per lavorare alla costruzione dei grandi santuari di Montserrat, Barcellona, Toledo e di Santiago de Compostela, furono in parte costretti a lasciare il territorio e a trovare rifugio nel resto d’Europa e oltreoceano, a seguito della colonizzazione del Nuovo Mondo.
In quell’epoca, la religiosità consolidata sul territorio, successiva ai primi canti sacri improntati sul gregoriano ed entrati in uso durante le grandi festività stabilite dalla Chiesa Cattolica Romana, fecero la loro apparizione nei primi ‘villancicos’ cantati per la Natività di Nostro Signore e ricreati sulle popolari ‘canciones de cuna’ (ninne nanne popolari), verosimilmente in contrapposizione lineare con le ‘lamentazioni funebri’ legate alla celebrazione della Settimana Santa che veniva officiata un po’ dovunque in Spagna con grande solennità, a cui partecipavano le masse popolari con tanto di devozione più o meno sentita.
A Siviglia, considerata epicentro della tradizione araba e moresca nonché gitana e quindi in parte miscredente, la “Misa Flamenca” si adeguò lentamente e straordinariamente nell’alta espressione liturgica, forse la più alta in assoluto, conosciuta come la ‘Saeta’, una sorta di canto religioso fortemente espressivo che in seguito fu accolto nel corpus del ‘Cante grande’, e che possiamo definire una ‘specificazione‘ dell’animo profondo del “Cante jondo”, a sua volta elaborata nelle scuole di Jerez e di Siviglia sulle salmodie corali dei fedeli cattolici nelle processioni liturgiche. Le più antiche e forse le più belle ‘saetas’ rimangono quelle lanciate, anzi scagliate appunto come una saetta, in onore della Vergine Maria o del ‘Cristo Morto’talvolta anche come vere e proprie frecce contro le istituzioni durante il sostare della processione, allorché, all’interrompersi della banda musicale che l’accompagna, si creava un spazio liturgico espressamente dedicato al ‘Cante’. L’ambiente è dunque quello trecentesco del Medioevo che troverà il suo completamento alla fine del Cinquecento, coè al ‘tempo’ in cui le celebrazioni per la Settimana Santa conobbero il loro apice nelle rappresentazioni della ‘Passione’.
Trascritto da una ‘cronaca’ che ben ricrea l’ambientazione recente dello svolgersi di una ‘Processione per la Settimana Santa’, leggiamo insieme questo racconto:
“Nella mattina degli ultimi giorni stazionano nella Cattedrale (di Siviglia), varie Confraternite e Congregazioni recanti in solenne processione i rispettivi e meravigliosi ‘pasos’. Le Confraternite presenti sono in tutto 49 con complessivi 91 ‘pasos’, distribuite nei 6 giorni che compongono la Settimana Santa. I confratelli indossano ampie cappe e alti cappucci a punta con rispettivo stemma (di appartenenza) sulle spalle e sul petto. Impugnano lunghi ceri o pertiche con lo stesso stemma in cime. I gruppi statuari, montati su enormi palchi sorretti a spalla dai fedeli e stupendamente addobbati, rappresentano le vicende dell’agonia e della morte di Cristo, come è narrata nei Vangeli. L’accompagna la Vergine Maria lussuosamente vestita come persona viva, stringente nelle mani il fazzoletto o la corona, il petto trafitto da una o più spade. Il Venerdì mattina è il turno della Cofradia de los Gitanos con due ‘pasos’ entrati nella tradizione popolare.»
Quello che segue è il ‘Pasos’ che Antonio Machado (**) ha incluso in una sua raccolta poetica:
“Oh la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar!
Cantar de la tierra mia,
que echa flores
al Jesùs de la agonia,
y es la fe de mis mayores!
Oh, no eres tù mi cantar!
No puedo cantar, nì quiero
a ese Jesùs del madero,
sino al que anduvo en el mar!”
“Oh la saeta, il cantare / al Cristo dei gitani, / sempre con il sangue nelle mani, / sempre per dischiodare! / Il cantare del popolo andaluso, / che tutte le primavere / va chiedendo scale / per salire alla croce! / Cantare della terra mia, che lancia fiori ( al Gesù dell’agonia, / ed è la fede dei miei padri! / Oh, non eri tu il mio cantare! / Non posso cantare, né lo voglio / a questo Gesù sulla croce / se non a quello che camminò sul mare.”
Lo studioso Manuel Martinez Torner tuttavia non include la ‘saeta’ nel genere ‘flamenco’ e la considera a parte come di un genere decisamente religioso per la sua caratteristica spirituale tipicamente occidentale. In pieno accordo con quanto riferisce padre Diego da Valencina che fa risalire la ‘saeta’ alla ‘lauda’ francescana, si tratta qui di un autentico ‘grido’ pari a una frecciata che si leva improvviso e quindi inaspettato sopra la processione ad invocare il mistero che la liturgia contiene:
“Vienes de los remotos paises de la pena”.
“Viene dal remoti paesi della pena.”
Recita con accorato pianto chi effettua il lancio della ‘saeta’, riportando alla mente il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, per quanto non manchino attribuzioni a più antichi riti pagani. Su questo stesso terreno fortemente impregnato di religiosità si è formata nei primi anni ’60 l’idea di una “Misa flamenca” moderna in stile ‘flamenco’ che rispondesse alle esigenze del popolo andaluso. La sua celebrazione, in quanto avvenimento rituale che esprime un ‘mistero’ ha riscaldato gli animi dei Gitanos che infine ne hanno cristianizzato il senso in una performance di intensa drammaticità.
La ‘Misa’ qui trasposta nell’uso interpretativo del ‘flamenco’ è : “..evocazione di un atto storico unico e manifestazione di un fatto che permane nell’eternità al di là dell’umana capacità di comprendere e rappresentare”, che trova la sua originalità nell’utilizzo di elementi d’ispirazione gregoriana e reminiscenze della più antica polifonia spagnola, connessi con temi gitano-andalusi, e trascritti per l’occasione da solisti impegnati alla chitarra e cori misti. Ma è infine il ricorso fatto alla ‘saeta’ che nel momento più alto dell’ ‘Eucarestia’ l’ha accesa di interiorità carnale, quasi da ricondurla alla trascendenza pagano-naturalista (e umana) delle origini.
“Non è stato facile adattare la Messa in spagnolo alla metrica fisica del canto flamenco – scrive Antonio Mairena co-autore di questa suggestiva ‘Misa Flamenca‘ – in quell’occasione: non v’è espressione drammatica più graffiante della seguiriya; non c’è alcun cantico che eguagli la serenità della malagueña; né alcuna spiritualità potrà mai essere comparata a quella della soleà. In questo lavoro di trasposizione della prosa in versi, noi abbiamo cercato di rispettare alla lettera le parole sacre. Il rimanente è venuto da solo e molto è dovuto all’esperienza e alla tradizione del Cante.”
Non è un caso che all’interno della “Misa flamenca” ritroviamo alcuni dei canti che hanno dato forma al corpus del ‘Cante gitano-andaluso’. Ed è ancora e soprattutto la struttura austera e ieratica del ‘Cante jondo’ a sovrastare l’intera partitura della “Misa” pur rispettando l’ordine della sequenza ufficiale: Introito, Gloria, Kirye, Credo, Sanctus, Agnus Dei. In quanto frutto di un’autentica espressione artistico-musicale la “Misa flamenca” trova la sua affermazione nell’ambito della moderna religiosità spagnola la cui salda continuità l’ha accolta nella tradizione, in quanto sintesi di una perfetta fusione del fatto religioso con la tensione drammatica espressiva del ‘Cante’.
Esattamente come l’hanno vissuta in prima persona i suoi esecutori e tutti coloro che assistettero al rito, e registrata dal vivo il 29 Giugno 1968 nella Chiesa del Barrio ‘A’ del poligono di San Paolo a Siviglia:
«La piazzetta di Santa Ana era il cuore del flamenco di Triana. Giungeva fin lì il suono metallico del martello sopra l’incudine, e si univa al rintocco della campana che chiamava al tempio. Un gitano, Manuel Cagancho, creò al ritmo di questo suono un canto per seguiryas che ora figura nella Misa Flamenca. Nella preghiera e supplica del Kirye, l’eco profondo della malaguena imprime la sua andatura con reminescenze del canto gregoriano. Il Gloria, cantico di esaltazione e allegria per la presenza di Dio sulla terra, si fa solenne e rispettoso sull’eco del romance gitano. L’andatura grave nel lamento della petenera serve a introdurre il Credo, mentre per il Sanctus è usata la soleà; l’accordo della chitarra introduce la tonà, la debla e il martinete che si fanno preghiera. L’unione sublime del Padre Nostro con il sangue e la carne del Figlio di Dio medesimo nell’atto solenne dell’Agnus Dei è invece affidato alla seguirya gitana nello stile più puro del Cante jondo: ..se ha puesto de rodillas y vibra y reza canta y llora.»
L’eco profondo della ‘malaguena’ tradizionale è qui trasposta nella forma del ‘Kyrie’ è intonata sulla reminiscenza del canto gregoriano:
«Dime donde ba allegar. / Este querce tuyo y mio. / Dime donde ba allegar. (..) / Yo cada dia te quiero mas. / Que Dios me mande la muerte.»
“Dimmi dove ci porterà. / Questo amore tuo e mio. / Dimmi dove ci porterà. (..) / Mentre io t’amo ogni giorno di più. / Spero che Dio mi mandi la morte.”
Un tema, questo della morte, che ritorna spesso nella letteratura e nel canto ispirato dei Gitanos, ma qui siamo di fronte a un fatto musicale che esula dalla semplice operazione colta sul folklore, che possiamo facilmente abbinare all’impatto della tradizione spagnola, l’espressione singolare dei Gitanos che hanno fatto del ‘flamenco’, e in particolare della “Misa Flamenca”, un momento trainante dello spirito che li accomuna alle altre eppur diverse culture presenti sul territorio: indiana, ebraica, araba e bizantina, ma, soprattutto cristiana, qui confluite come per un ‘encuentro’ fattivo fra il popolo gitano-andaluso e il resto del mondo.
* Composta da Ariel Ramirez negli anni che vanno dal ‘50 al ‘63 come un’opera per solisti, coro e orchestra, accompagnati da strumenti tipici delle popolazioni latino-americane, la “Misa Criolla” (CD Philips), denota con estrema originalità una simbiosi di intenti musicali diversi, realizzati grazie alla perfetta combinazione di temi religiosi ed elementi folkloristici ripresi da ritmi e forme musicali proprie della sua terra di appartenenza: l’Argentina. Forme che riprendono diverse forme musicali tuttavia tipiche proprie molte popolari, come ad esempio il ‘carnavalito’, qui utilizzato come forma di esaltazione del fatto liturgico.
Acciò la ‘Misa’ è a tutti gli effetti una Messa cristiana come la interpretiamo oggi, seppure con inserimenti popolari legati alla tradizione ispano-americana in cui Ariel Ramirez ha saputo conciliare il fervore religioso con l’elemento folklorico dando ad ogni sequenza della messa un elemento di originalità: Il ‘Kyrie’ apre la messa con i ritmi della vidala e della baguala, due forme espressive rappresentative della musica tradizionale creola argentina; il ‘Gloria’ è accompagnato dalla danza argentina del carnavalito, segnato dalle note del charango; il ‘Credo’ invece, è scandito dal ritmo andino della chacarera trunca; mentre il Carnaval de Cochahamba, tipico della tradizione boliviana, fa da cornice al ‘Sanctus’, e infine, l’ ‘Agnus Dei’ che conclude la Messa, è improntato sullo stile strumentale tipico della Pampa argentina.
Bella e gradevole all’ascolto la ‘Misa Criolla’ raccoglie in se il pacato ‘spirito del tempo’, stranamente dimesso, quasi sussurrato, che potremmo attribuire al vento, se non fosse che è proprio quest’ultimo a trasportarlo attraverso la Cordigliera che attraversa tutta l’America Latina fino agli estremi della Patagonia. Quello stesso ‘spirito’ che fa vibrare le corde degli strumenti e ottunde le pelli delle percussioni, così come risveglia i semi contenuti nelle zucche sonore utilizzate per i ritmi-a-ballo durante le numerose feste che si tengono un po’ ovunque, nei piccoli pueblo arrampicati sugli altipiani alle grandi ciudad delle vallate, fino ai villaggi dei pescatori che coronano le coste. Uno ‘spirito’ allegro, espressione di forme musicali puramente folkloristiche caratterizzate dalla presenza di strumenti e ritmi tipici della tradizione popolare latino-americana che s’intrecciano con i temi della tradizionale Messa religiosa.
Trovo davvero molto interessante conoscere come il compositore Ariel Ramirez, è giunto al concepimento della “Misa Criolla” in questo racconto del lontano 1964 qui di seguito proposto in essai:
«Nel 1950 presi una nave che, dal porto di Buenos Aires mi avrebbe portato nel continente europeo. Genova fu il luogo in cui, per la prima volta, posi i piedi su quelle terre. Il mio proposito era quello di lasciare un messaggio sulla nostra musica per mezzo del mio piano e aspiravo a porre al centro di quella illusione la città di Parigi. Però un invito da parte di un amico di infanzia, Fernando Birri, mi deviò a Roma nell’ottobre dello stesso anno. Da qui iniziò una serie interminabile di avventure con diversi pianoforti… diversi nuovi amici ed un’infinità di nuovo pubblico. Nei quattro anni in cui restai a quelle latitudini il mio domicilio fu Via della Lungara 229, nel cuore trasteverino di Roma. In quel periodo, con la mia musica, percorsi in lungo e in largo l'Italia, l'Austria, la Svizzera, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, in dignitosa povertà, alloggiando in alberghetti, collegi religiosi, conventi, ospedali, case di amici, Università, in un costante andare e venire, che mi riportava comunque e sempre a Roma dove cento mani cattoliche si tendevano per aiutarmi. […]
Ripetutamente tornai in molte di queste città come Londra, dove stipulai contratti con la BBC, interessata affinché un mio programma radiofonico si diffondesse nel Latino america. Alla stessa maniera stipulai contratti con Università come quella di Cambridge, di Utrecht, di Delf, di Santander oltra a società concertistiche e di teatro. A poco a poco stavo convertendomi a questo mondo che lentamente si andava ricostruendo dopo la guerra. Tutti i miei profitti furono resi possibili grazie all'aiuto ricevuto da esseri umani straordinari che contribuirono non solo alla mia formazione culturale, ma anche alla mia crescita spirituale. Sapevo di dover trovare una forma di ringraziamento per tutto questo. Fin quando, un giorno del 1954, non potendo resistere alla tentazione di prendere un’altra nave, quella del ritorno alla volta di Buenos Aires dove mi attendeva mia figlia di cinque anni ed i miei genitori che superavano ormai la settantina. Mi commuoveva pensare che quello che avevo ricevuto era esclusivamente dovuto all’amore di queste persone per la mia musica e la mia persona, finché compresi che l'unico modo che avevo per ricambiare quelle persone era quello di scrivere in omaggio a loro un opera religiosa benché non sapessi come realizzarla. […]
All'arrivo in Argentina tutto era mutato: mentre la mia carriera si andava affermando e le mie canzoni diventavano molto popolari; cominciai a cercare e raccogliere poemi di carattere religioso del Nord dell’Argentina che iniziai a pensare alla realizzazione di una ‘messa’ con ritmi e forme musicali della mia terra. In quegli anni Padre Catena, Presidente della Comisión Episcopal Para Sudamerica, fu incaricato di realizzare la traduzione in spagnolo del testo latino della ‘messa’, secondo le direttive del Concilio Vaticano II presieduto da SS Paolo VI. Il quale nel 1963 mi presento a chi, con straordinaria erudizione avrebbe realizzato gli arrangiamenti corali dell'opera: Padre Jesú Gabriel Segade. Dacché la sua composizione fu conclusa ci sentimmo di dedicarla a tutti quegli amici che mi avevano aiutato così generosamente durante quegli anni cruciali della mia gioventù.»
Con questo sentimento torniamo oggi ad ascoltarla valorizzando l’entusiasmo di un giovane ‘migrante’ che come i tanti che in ogni parte del mondo vengono accolti, portano con sé qualcosa del loro retaggio culturale che forse dobbiamo imparare a conoscere, contribuendo con un entusiasmo e umiltà, a riconoscere negli altri qualcosa della nostra missione fortemente intrisa di misticismo religioso e di sentimento umano, così come Ariel Ramirez a suo tempo, ha contribuito a diffondere la sua e ormai nostra “Misa Criolla"»
Ma un'opera musicale richiede - per essere conosciuta - una trasposizione concreta, cui dare la giusta dimensione che merita, nello spirito in ‘lengua’ con il quale mi piace concludere questa ricerca, col proporre una ‘sequenza’ del poeta spagnolo Pedro Salinas (***):
«Los cielos son iguales.
Azules, grises, negros,
Se repiten encima
del naranjo o la piedra:
nos acerca mirarlos.
Las estrellas suprimen,
de lejanas que son,
las distancia del mundo.
Si queremos juntarnos,
nunca mires delante:
todo lleno de abismos,
de fechas y de leguas.
Déjate bien flotar
sobre el mar o la hierba,
inmóvil, cara al cielo.
Te sentirás hundir
despacio, hacia lo alto,
en la vida del aire.
Y nos encontraremos
sobre las diferencias
invencibles, arenas,
rocas, años, ya solos,
nadadores celestes,
naufragos de los cielos.»
Note:
(*)“Messa Mozarabe” eseguita dal Coro del Seminario di Toledo - Collegio de Infantes diretto da P. Alfonso Frechel e l’Orchestra diretta da José Torregrosa.
(**) Antonio Machado, “Poesìas Compoletas”, Espasa-Calpe 1981.
(***)Pedro Salinas, ‘La voce a te dovuta’ – Einaudi 1979.
BUON NATALE E BUONA VITA A TUTTI VOI.
*
 - Musica
- Musica
‘La Musica di Dio’ La liturgia della Messa - Ricerca Etno
La liturgia della Messa – Ricerca etnomusicologica.
«..Sono di nuovo con me
Spiriti del vento
oltre il riparo delle mani degli dei
vanno al nord ed est e ovest
guidati dall’istinto.
Ma per volere degli dei
ancestrali
seduto su questa rupe
li osservo andare e venire
dall’alba al tramonto
con lo spirito che urge di dentro.»
Con questa ‘essai’ da una poesia di Gabriel Okara , eccoci proiettati nel cuore della Nigeria, nella cui spiritualità è rintracciabile una sorta di liturgia arcaica che il cantore esprime in presenza della divinità ancestrale, la sua appartenenza, rintracciabile nel contesto d’una realtà culturale antropologica di tipo religioso, non poi così diversa nella forma e nell’intensità, all’afflato espresso nella liturgia ufficiale della religiosità cattolico-cristiana. Se non per il suo rivolgersi a più entità distinte e tuttavia identificabili nella natura in cui esse si sono formate e hanno trovato una loro ragione di sviluppo culturale.
Proiettati nel periodo quaresimale che annualmente contrassegna il calendario liturgico della Pasqua, non possiamo non tener conto di certe ‘verità’ intrinseche alla religiosità nostrana, in cui l’entità ‘una e trina’ presuppone la salvaguardia ortodossa della nostra preghiera, di quel ‘Credo’ levato a salvaguardia di un equilibrio ‘ideale’ e ‘psicologico’ che vede il bene opposto al male, esattamente sovrapponibile alla religiosità antropologica delle popolazioni più arcaiche (non pagane), pur in mezzo a tanti contrasti e nello scontro in atto nelle diverse culture, e che ha finito per determinare nella preghiera comune una ‘verità’ conciliante di pace.
Nell’avvicinarsi della ricorrenza religiosa della Pasqua, propongo qui di seguito l’ascolto di alcune composizioni estemporanee alla liturgia ufficiale della Chiesa cattolica, ciò nondimeno raccolte nell’intento di testimoniare un ‘sentire religioso’ quanto mai vivo che accomuna i diversi popoli da un capo all’altro del mondo. Quegli stessi che trovano nella comunanza cristiana un’autentica fonte di religiosità unificatrice che li accompagna nella loro vocazione spirituale. Vocazione che, in occasione della Pasqua, assume una dimensione pressoché sentita negli altri popoli e che, a proprio modo e nella lingua d’origine, hanno voluto testimoniare con lodi e inni penitenziali nella ‘Messa’, desunti dalle loro più aderenti tradizioni popolari in fatto di musica.
Evoluta sulle direttrici conformi all’insegnamento dei ‘canoni’ costitutivi la tradizione liturgica cristiano-cattolica, la ‘Messa’ in-primis e l’orazione dei ‘Salmi’ poi, si impone all’interesse etnomusicologico per l’alto contenuto spirituale; quello stesso che ‘in illo tempore’ deve aver forgiato le singole culture gruppi di alcune popolazioni isolate che, pur conoscendo poco o niente una qualche forma di scrittura, hanno saputo mantenere un equilibrio, quasi perfetto, con la natura circostante, nelle difformi aree del bacino Mediterraneo e non solo. Nel modo qui di seguito contestualizzato, a incominciare proprio dalla tradizione etnica africana, per proseguire nella tradizione spagnola, trasferite oltreoceano nel folklore latinoamericano.
In ognuna delle quali si avverte il confluire di ‘forme’ culturali tardive, credibilmente diverse, che, in qualche modo, hanno sostenuto un processo di evangelizzazione persistente nei secoli e che, in campo musicale, ha dato vita a simbiosi di suoni e ritmi distinti, qua e là caratterizzato da influssi linguistici e dialetti gergali destinati all’uso quotidiano, quale riflesso di una struttura tribale articolata che ha permesso la conservazione e il riconoscimento di idoli arcaici, il cui ‘spirito’, ereditato dagli antenati, è ancora oggi comune a molte popolazioni sia africane che latinoamericane, benché svuotate del loro contenuto sapienziale.
Eredità che le popolazioni del continente africano delle origini, di seguito prese ad esempio, hanno articolato la propria struttura tribale-religiosa sull’uso di ‘maschere’ e ‘mascheramenti del corpo’, ancora attiva tra le etnie più interne del continente, tenuta in vita dal desiderio antropico, mai venuto meno, della ricerca di un ‘dio’ (divinità), sia esso cristiano e/o d’appartenenza ad altra confessione, in grado di garantire loro una qualche forma di sopravvivenza. La stessa che è possibile riscontrare nella forma prevalsa nella liturgia cristiana della ‘Messa’, dove il ‘fatto’ religioso non annulla, né sovrasta la ritualità della tradizione arcaica, sovraccaricandola di vigore , onde è l’Africa con i suoi strumenti, i suoi ritmi, le sue voci, i suoi battimani e le sue grida in primo piano, a regalarci un ‘evento’ rigoglioso di ancestrale brio.
* Lo testimonia questo “African Sanctus” elaborato da David Fanshawe (CD Philips 1089), in cui è riscontrabile una forte contaminazione di suoni arricchita dal timbro imitativo dei tamburi sulle percussioni rock, in aggiunta a registrazioni sul-campo di ‘cori’ africani e di ‘voci’ soliste, su brani liturgici cristiani; come appunto nel “Sanctus” elaborato su una danza Bwala tipica dell’Uganda; cui segue il “Kyrie”, ‘chiamata alla preghiera’, e il “Gloria” ripresi dalla musica per il matrimonio di tradizione islamico-egiziana. Così come per il “Credo” si è utilizzato un tema proprio del Sudan, mentre per i “Crucifixus” ripreso dal “Chant sul Qui tuum est regnum”, si è utilizzata una ‘ninna-nanna’ Masai di sicuro effetto onomatopeico. In fine l’ “Agnus Dei”, elaborato sulla musica d’accompagnamento di una ‘danza di guerra’ dei beduini del deserto del Sahara.
* Così avviene in “Missa Kongo” abbinata (sul disco Philips 1970) alla “Missa N’Kaandu”, comunemente cantate durante le funzioni religiose nella regione del Kisanto nell’attuale Zaire, in cui il sacro e il profano presenti nella liturgia africana è testimoniata dall’avvenuta interazione musicale zairota a contatto con l’espressione intimistica cristiana. le due ‘Messe’, relativamente diverse fra loro, utilizzano i toni ritmici di strumenti tipici e il necessario impeto delle danze tribali, così come nei canti si rileva una certa improvvisazione popolare disgiunta dal contesto prettamente religioso. In particolare nella “Missa Kongo” , l’uso prorompente delle percussioni tipiche delle popolazioni Bantu, fa da contrappunto alle grida spontanee delle donne Biyeki-yeki sostenute da colpi simili a spari d’arma da fuoco, che suscitano una sensazione di ‘paura’, verosimilmente derivata dal ‘fatto’ magico-trascendentale, e comunque trasgressivo, sostenuto dall’intervento di ‘seconde voci’ in alternanza alla ‘voce solista’ Diversamente nella “Missa N’Kaandu” troviamo un effetto melodico di maggiore spessore innestato su di una eccellente ritmica che esercita un richiamo alla drammaticità cerimoniale del “Prière Universelle”, in una sorta di "canto piano" davvero apprezzabile e molto gradevole all’ascolto.
Come recita una poesia di Leopold Sédar Senghor, noto poeta senegalese:
«L’uragano sradica tutto intorno a me,
e l’uragano sradica da me fogli e parole inutili.
Vortici di passione sibilano in silenzio.
Sia pace nel turbine secco, sulla fuga delle bufere!
Tu Vento ardente, Vento puro, Vento di bella stagione,
brucia ogni fiore, ogni pensiero vano.
quando ricade la sabbia sulle dune del cuore.
Donna, sospendi il tuo gesto di statua, e voi bimbi,
i vostri giuochi e le vostre risa d’avorio.
Tu, distrugga la tua voce col tuo corpo,
secchi il profumo della tua carne.
La fiamma che illumina la mia notte come una colonna,
come una palma.
Avvampa le mie labbra di sangue, Spirito,
Soffia sulle corde della mia ‘kora’.
S’alzi il mio canto, puro come l’oro di Galam.»
* Altresì la “Messa a Youndé” raccoglie documenti sonori del Camerun, detto anche ‘il riassunto dell’Africa’, per il semplice fatto che in questa regione coabitano numerosi gruppi etnici, circa 200, verosimilmente emigrati, provenienti da altre regioni del ‘continente nero’, che hanno conservato le proprie realtà tribali culturali e religiose, come l’islamismo, l’animismo e in bassa percentuale anche caratteristiche Cristiane, professate in diverse lingue, tutte ufficiali, quali l’arabo-musulmano, il francese e l’inglese, insieme a vari linguaggi autoctoni. Sul piano musicale le forme praticate sono molto vicine alla ‘monodia gregoriana’, almeno per quanto riguarda l’accostamento con la liturgia cristiana raccolta nel disco (Universo del Folklore - Arion 1975). Ciò, sebbene sul piano melodico la musica europea mal corrisponde alle rigorose esigenze toniche, per esempio, del dialetto Ewondo, o alla vitalità più ritmica tipica africana.
Diversamente accade per le influenze orientali portate senza dubbio dalle frange musulmane del Nord e di gran lunga superiori di quella cattolico-cristiana. fatto questo che già negli anni ’60, alcuni studiosi tra sociologi, folkloristi e musicologi del Camerun si sono posti il problema dell’africanizzazione della liturgia cattolica in seno al continente nero. In fine, ispirandosi ai testi biblici è stato l’operato l’Abate Pie-Claude Ngumu, già maestro di cappella della cattedrane di Notre Dame a Youndé a spuntarla sulle altre proposte, passando dalla teoria alla pratica, trascrivendo quelli che oggi sono detti i “Cantici di Ewondo”, utilizzando una delle principali lingue vernacolari del Sud del paese, dove era più influente il cattolicesimo.
In quanto fondatore della Scuola Cantori della Croce d’Ebano, Padre Ngumu ha utilizzato strumenti originari tipici della regione, come il ‘balafon’, una sorta di xilofono, per la composizione dei canti corrispettivi al canone liturgico dei così detti ‘canti d’ingresso’ e nella lettura cantata della ‘Epistola’ basandosi per entrambi sulla cadenza ritmica di una delle molte danze tradizionali. Impostando inoltre, nella conseguente lettura del ‘Vangelo’ inclusiva della relativa predica pastorale, sul suono dell’arpa ‘mvet’ tipica del Camerun, spesso mimata dal pubblico presente alla cerimonia, per facilitare la comprensione del messaggio evangelico. Lo stesso accade durante il “Credo”, in cui l’officiante apre al dialogo ‘a responsorio’ con il Coro, a cui partecipa l’intera comunità festante al suono dei tamburi e del ‘tam-tam’.
Interessante è anche la partecipazione più composta in occasione del “Kyrie” e dell’ “Offertorio” durante i quali il Coro si snoda in processione attorno allo spiazzo richiamando a raccolta i fedeli con il tipico clangore di ‘campane’ di metallo, recando offerte di prodotti della natura raccolti in ceste che portano sulla testa e che infine depongono ai piedi dell’altare per la benedizione rituale. Successivamente sono le donne che, piegate su se stesse, lanciano l’oyenga’, un urlo stridente che nell’esaltazione generale riveste significati esoterici, ma che per l’occorrenza riveste un esplicito segno della devozione popolare. Ovazione che trova il suo fulcro nei rispettivi “Alleluia” e “Canto finale” improntati sullo schema latino ma che qui acquisiscono maggiore forza evocativa, quella stessa che si ritrova nel ‘gospel’ che scaturisce in uno stato di ‘ebbrezza mistica’ che vede l’officiante unirsi cantando ai musicisti e al pubblico presente in una coreografia assai eloquente.
* Salutata come «...il più significativo inno che le generazioni africane abbiano mai elevato al Dio non soltanto e necessariamente cristiano: un prezioso documento storico da sottolineare e da prendere come esempio, che ravviva la forza mistica di cui è dotata la musica sacra.», la “Missa Luba” è indubbiamente la più rappresentativa di tutta la produzione ‘liturgica’ africana. Più volte riproposta da gruppi africani diversi, trova il suo originale nell’esecuzione dei Les Trobadours du roi Baudouin che ne furono i primi interpreti nel lontano 1958 (disco Philips BL 7592). Frutto dell’intuizione del missionario belga padre Guido Haazen, fondatore e arrangiatore del Coro formato da 45 bambini tra i 9 e i 14 anni insieme a 15 insegnati del Kamina School che accompagnò in una lunga tournée iniziata nella Sala Nervi nella Città del Vaticano e prosegita nel resto d’Europa. Trattasi di una ‘Messa latina’ basata su ‘native songs’ in puro stile congolese (ex Congo-Belga), costruita su ritmi percussivi e armonie (ninne-nanna, weddings, ecc.) rituali delle regioni Kasai e Kiluba, da cui il nome. “Missa Luba” va dunque considerata un piccolo capolavoro che ben riproduce l’alto livello di interazione raggiunta tra i diversi popoli e le diverse religioni: tradizione-etnica e cristiano-cattolica.
Musicalmente parlando si ritrova in essa il senso d’influenza reciproca, raggiunto nell’eliquilibrio perfetto che tutto sublima in ognuna ‘delle parti’ che la compongono: ‘Kyrie’, ‘Gloria’ e ‘Credo’ infatti, si svolgono secondo l’andatura inalterata dei canti ‘kasala’ della regione Ngandanjika (Kasai) da cui provengono. Mentre il ‘Sanctus’ e il ‘Gloria’ sono costruiti su ‘canti di addio e/o arrivederci’ tradizionali ‘Kiluba’. Mentre nell’ ‘Hosanna’ riprende il tempo di danza ritmica propria del Kasai, l’ ‘Agnus Dei’ si basa su un canto popolare di Luluabourg. Va inoltre sottolineato che nessuno di questi canti è stato fin’ora trascritto nelle lingue originali, pertanto la bellezza intrinseca a questa versione della “Missa Luba” sta anche nel fatto che certi ritmi, armonie e abbellimenti scaturiscono dall’improvvisazione spontanea dei suoi esecutori di fronte ad una proliferazione simbolico-spirituale che investe ogni elemento della “Messa” cosiddetta attraverso una complessa strategia della tensione: scenografia, colore, musica, recitazione, in cui tutto è sovraccarico di senso.
Se quelli qui appena toccati possono essere considerati incredibili esempi di religiosità attiva nel mondo; sottolineare quanta strada si è fatta nel campo della trasmissione e della conoscenza, ciò non di meno possiamo sentirci forti di un sentimento di maggiore adesione al ‘fatto’ religioso e di viverlo intensamente. Ed è forse proprio grazie alla spinta della ricerca etnologica che possiamo intraprendere la strada della concertazione e di uno stesso ‘modus vivendi’ con le altre culture, attuando quel recupero distinto delle tradizioni popolari che pure malgrado i contrasti inevitabili, non hanno mai smesso di far sentire il loro altissimo ‘grido’, levato in difesa di una unica identità da salvare, la nostra e quella di tutti quei popoli che giustamente riscattano nella parola di Dio la propria esistenza. È così, come abbiamo avuto modo di leggere, che la liturgia cristiana, nell’aprirsi queste diverse espressioni non subisce variazioni di sorta, ma ne esce indubbiamente vivificata, proiettata in un ‘Credo’ che nella comunanza traslitterale della musica, ritrova il proprio tempo edenico.
Recita una poesia di E:E:G.Armattoe, poeta del Ghana.
«Il nostro Dio è nero.
Nero di eterna bellezza,
con grandi labbra voluttuose,
capelli arruffati e scuri occhi liquidi.
Forma d’armonioso aspetto Egli è,
poiché a Sua immagine siamo fatti,
il nostro Dio è nero.»
Note: Le poesie qui trascritte sono riprese da “Nuova Poesia Negra” – Guanda 1961.
(continua)
prevede l’offerta dei doni della natura durante la Messa, così come prevede anche la suddivisione dei prodotti della natura, trasformati in cibo, ai più bisognosi affinché possano godere della ‘gloria’ di Cristo con lo spirito colmo di quella gioia che nutre la fame. Questo per dire che alla ‘fame’ va corrisposta un’adeguata dose di sostentamento rigenerante per il corpo e per lo spirito. Allora ben venga la Pasqua che dopo i necessari ‘pianti rituali’ di espiazione, si presta a proponimenti di gioia per la festa di ‘Resurrezione’ e di ritorno alla vita. Questo in vero il senso della spiritualità religiosa proprio dello spirito comunitario della Pasqua affermatasi in Spagna agli albori del Medievo e che verrà ripresa solo al tempo dei Re cattolici avvenuta durante il XV secolo, allorquando Santa Romana Chiesa esercitò il suo pieno potere con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come la Santa Inquisizione. Prima quindi che la religiosità popolare si trasformasse nelle tribolazioni edificanti delle Sacre Rappresentazioni a scopo esclusivamente penitenziale e nelle truculente Processioni per Settimana Santa, ed incendiasse i ‘roghi’ contro la stregoneria, i giudei-sefarditi, gli zingari, i diversi e quant’altri che abbiamo appreso ad elencare dalle insanguinate pagine della storia.
Pagine dalle quali abbiamo anche appreso che una tale ferrea disciplina, per quanto dovesse essere accettata forzatamente da tutti, ciò che avvenne nel lungo termine non senza trovare sul suo cammino molti ostacoli di carattere aconfessionale e quindi laico, riscontrò un certo disaccordo con l’allora potere regnante, di quelle frange dei vecchi cristiani che andavano soto il nome di Mozarabi, grazie ai quali già attorno all’Anno Mille dopo l’abolizione del rito da parte di Papa Gregorio VII nell’ XI secolo, avevano conservato la propria lingua ‘mozarabica’, (un continuum dialettale romanzo parlata nella penisola iberica da parte dei Cristiani nell'XI secolo e nel XII secolo), all’interno della loro secolare liturgia in comunione con lòa chiesa cattolica. In verità non poco si deve a quei a quei padri missionari che, giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, compresi i nomadi zingari e zingaro-gitanos, a misurarsi con i canti cristiano-mozarabici durante le nuove funzioni liturgiche imposte loro.
*
 - Sociologia
- Sociologia
L’altro come scelta - il riconoscimento di genere’
“L’ALTRO COME SCELTA”
La costruzione sociologica nel ‘riconoscimento di genere’ – Sociologia – by Giorgio Mancinelli
Prima parte: Le ‘pari opportunità’ per una più concreta ‘interrelazione sociale’.
Alla luce dei mutamenti sopravvenuti nella società attuale e delle nuove realtà ideologiche, la costruzione sociologica del ‘riconoscimento di genere’ (*), impostata su basi antropologiche quali, la tradizione, la cultura, la religiosità, la sacralità degli affetti, le usanze e i ‘riti di riferimento’ (*), da qualche anno a questa parte, si è rivelata inaspettatamente anacronistica, mostrando le sue crepe profonde. Segni questi di una millenaria erosione che non l’hanno risparmiata da risentimenti diffusi e critiche per certi aspetti discordanti quanto inevitabili. È così che l’ ‘essere umano’, in qualità di soggetto di ‘genere’, è divenuto, quasi improvvisamente, un fenomeno sociale e antropologico planetario, cui un certo ‘liberalismo’ (*), aprioristico e metodologico, attribuisce forme di ‘società’ e di ‘economia’, migliori di sempre; neppure fossero di per sé ‘archetipi’ (*) di una fantomatica modernità.
Nel tempo, questi comportamenti, individuati come ‘differenze di genere’ (*), e successivamente a una distinzione delle problematiche legate al sesso, sono state gradualmente introdotte nella società, secondo le ripartizioni attuate nella psicologia individuale e in quella collettiva di ‘gruppo’. Per la ‘donna’ erano la sessualità legittimata, la genitalità e, differentemente, per il ‘maschio’, il potere sessista e la riproduttività genitoriale; successivamente trasformate in, voglia di supremazia nei rapporti relazionali, crescita di autogestione nell’uno e nell’altro sesso, non più riconducibili al solo fattore biologico. Tant’è che l’esperienza esistenziale e sociale dell’essere ‘uomo’ e quella dell’essere ‘donna’, nella loro identificazione individuale e complessità, sono tutt’altro che scontate. Onde per cui, riconoscere l’influenza dei fattori sociali nelle ‘differenze di genere’, è il primo passo per il superamento delle diversità e la definitiva attuazione delle ‘pari opportunità’ (*) nell’ambito della riorganizzazione sociale, nella scuola e nel lavoro.
Non solo, quindi, andando verso una comprensione significativa delle varianti problematiche insite nel termine ‘gender’ o ‘genere’ che dir si voglia, ma anche di quelle che prendendo spunto dalla diversità dei sessi, delimitano il ‘riconoscimento’ della personalità individuale all’interno dei ‘ruoli’ (*) contraddistinti gli uni dagli altri, in famigliari, educazionali, configurativi delle diverse tipologie sociali che, nel rispetto delle parti, mettono a nudo le precarietà e i fattori di rischio, di pari passo con l’individuazione di possibili strategie di cambiamento che la società odierna tende a evidenziare come problematiche, per scopi non sempre o del tutto chiari, da sembrare incomprensibili se osservati nell’ottica della risoluzione delle ‘differenze di genere’ a scopo individualistico, ancor più evasivo se visti dalla parte del pragmatismo politico comunitario europeo e non solo.
Se vogliamo, è a partire da tale ‘riconoscimento’, che la ricerca dinamica delle ‘pari opportunità’ trova giustificazione, nell’individuare quei fattori relativi, intrinsechi della sfera della ‘personalità’ (*) e della ‘identità’ (*), contrapposti al rifiuto e alla revoca dell’approvazione tout-court, che hanno portato al misconoscimento della figura ‘donna’, alla quale, invece, ineriscono esperienze di rifiuto di legittimazione e dei diritti negati. “Il riconoscimento dunque – scrive Mario Manfredi (*) – va preso come obiettivo di un processo di piena responsabilità radicale verso i soggetti di ‘genere’ (umani e non), specialmente quando si confrontano posizioni di potere da una parte, e di vulnerabilità dall’altra. Anche perché la responsabilità che ne deriva, si fa carico anche di realtà remote nello spazio (uomini e territori lontani) e, nel tempo (l’umanità futura)”.
Certamente la modernizzazione dei costumi e delle idee non è approdata ad un risultato integrale ed esaustivo in ragione del fatto che si è dovuta misurare con fattori limitanti, con istanze individuali e sociali di tipo politico, economico, imprenditoriali. Non a caso Zygmunt Bauman (*) ha molto insistito nel ricercare instancabile di quell’ ‘identità’, che egli dice “divenuta precaria come tutto nella nostra vita”, essendo venuto meno il vincolo temporale nei rapporti interpersonali a causa di dialoghi preferibilmente a distanza, pause troppo lunghe di riflessione, richieste di chiarimenti mai espletate e sconfinamenti in territori diversi. A cui hanno dato seguito: senso di smarrimento, incapacità di introspezione, inconsapevolezza dell’attenzione, che hanno posto l’individuo davanti a un processo di sterilizzazione dell’immagine sedimentata di “ciò che è stato” (assenza di memoria storica), e di poter approntare una domanda del tipo: “chi sono io oggi?” (mancanza di identità futura), che l’ha portato all’individuazione di quella “paura liquida” individuale e collettiva che in sé non comporta una risposta propositiva.
E che il sociologo evidenzia nel sorgere di un ‘problema’ nuovo che va ad aggiungersi ai tanti che una ‘società liquida’ si porta dietro, per quanto all’apparenza sembra impossibile contestualizzare, se non andando a “...cercare un modello ‘ultimo’, migliore di tutti gli altri, perfetto, da non poter essere ulteriormente migliorato, perché niente di meglio esiste né è immaginabile”, in quanto – egli dice – “...non basta ‘concettualizzare’ una identità qualsiasi, bisogna puntare sulla ‘identità sociale’, radicale e irreversibile, che coinvolga gli ordinamenti statali, la condizione lavorativa, i rapporti interstatali, le soggettività collettive, il rapporto tra l’io e l’altro, la produzione culturale e la vita quotidiana di uomini e donne” (*).
Di là dal sembrare contraddittorio, la difficoltà del sociologo di formulare una risposta propositiva, rientra nella contrapposizione delle due diverse individualità messe a confronto: quella ‘maschile’ e quella ‘femminile’, storicamente in contrasto tra loro e che, pur riproponendo sé medesime in molteplici e differenti soluzioni, vagano alla ricerca di un ‘riconoscimento’ incondizionato, che le riconduca all’interno della ‘realtà sociale’, di cui ‘di fatto’ sono parti integranti. Il problema, volendo qui generalizzare, si pone allorquando all’interno della suddivisione di ‘genere’ avviene la separazione dei rispettivi ‘ruoli’, e quindi delle diverse ‘identità’. Questo fa sì che tutto l’impianto concettuale sopra evidenziato, risente di una forte opposizione a causa di forze esterne ingovernabili che ne determinano il ribaltamento.
Forze di diversa natura, quali: la caducità dell’una o dell’altra soggettività individuale, l’idea dominante del benessere famigliare, la preminenza sul posto di lavoro, la produttività che tende a emarginare chi non è fattivo o, anche, l’avanzamento ingiustificato dell’uomo in rapporto alla stessa funzione svolta dalla donna, l’insorgere di drammatiche regressioni nei rapporti coniugali ecc.., riscontrabili negli accadimenti che producono forme di ‘criticità’ che stravolgono l’assetto del rapporto comunicativo “nel momento esperienziale della ragione e nel momento riflessivo della critica” (*), perché perturbanti l’ordine del quotidiano e devianti dalle regole di normalità vigenti.
“L’annichilimento delle diversità in un mondo uniforme e massificato, la produzione di comportamenti sociali sempre più auto-referenziali, la deculturazione e l’acculturazione di massa secondo schemi economistici, l’accumulazione di tecnologie e di risorse nel contesto sociale sempre più disunito e frammentario, la distruzione di tutti i modelli di valore in nome di un pragmatismo povero di senso; sono alcuni dei paradossi evidenti cui ha condotto la modernizzazione contemporanea sulla base del suo nucleo fondante: l’assolutezza dell’individuo e della sua razionalità esclusivamente soggettiva” – scrive Giulio de Martino (*) da parer suo, quasi si fosse davanti a una possibile catastrofe annunciata e dallo stesso storico considerata quasi inevitabile. Conforme cioè alla ‘natura umana’, in prospettiva di una alterata convivenza democratica e dalla mancanza di un comportamento ‘etico’ austero, che non lascia comprendere e non giustifica le proprie e le altrui convinzioni.
In questo nuovo modello di società individualistica ed astrattamente egualitaria, si assiste al perseguimento di sommovimenti sociali ed economici (ipertecnologica, globalizzazione, squilibri geografici, nazionalismo, razzismo, fondamentalismo), che segnano il punto di svolta retrospettiva del paradigma iniziale e i limiti del presente. Fatto salvo, ovviamente, lo ‘status quo’ secolarizzato, accettato e difeso, dal capitalismo imperante che ieri consentiva una sicurezza interiore che più non appaga, perché andata smarrita; oggi, promette una comunicazione più libera e aperta, la più ampia possibile, in cui “la propria autonomia e la rottura della coazione, sono le condizioni per sostenere un dialogo franco” con il futuro, che di per sé non è garanzia di ‘autonomia’ certa.
Premessa questa che Antony Giddens (*) afferma, essere: “condizione sine qua non per stabilire una relazione più estesa”, che aiuta a definire i limiti personali necessari per gestire con successo le relazioni con gli ‘altri’, (diversi dall’ambito genitoriale, parentale e amicale), alla base della promessa di ‘globalizzazione’ (*) e, in senso lato, estesa oltre l’area che gli è propria, alla sfera dei rapporti interazionali cui le ‘pari opportunità’ sono di riferimento, principio-cardine del comportamento razionale e motore di ogni relazione sociale, del vero benessere e dello sviluppo della società. Sarebbe davvero auspicabile che il dialogo tra le parti sia inteso come fattivo di possibili sviluppi interazionali che infine mettano insieme condizioni e prerogative utili per il futuro degli individui, lontane da distinzioni di ‘genere’; sia nell’organizzazione della quotidianità familiare e comunitaria, sia in quella socialitaria, al fine di conseguire quel ‘riconoscimento’ incondizionato, necessario alla legittimazione paritaria.
Ma cosa hanno in comune le diverse esperienze acquisite, ereditate dal passato antropologico della ‘specie’ con le distinzioni di ‘genere’ che si vogliono qui rappresentare?
Si potrebbe dire niente e il contrario di niente, eppure nulla mi è sembrato più valido quanto rispolverare il ‘concetto di performatività’ teorizzato da Victor Turner (*), relativo a ‘struttura/anti-struttura’, allo scopo di argomentare i processi sociali inerenti alla realtà lavorativa che qui si prospetta. Una chiave di investigazione che, se vogliamo, anche a distanza di tempo, mi consente di riconsiderare, seppure su base teorica, la ‘trasformazione del presente’ a cui volenti o nolenti assistiamo, in quanto “costruzione di senso attraverso l’agire”. Ciò a fronte di nuove aggregazioni dell’esperienza fenomenologica, per una “ridefinizione critica del reale”. Tuttavia, se si vuole dare una risposta soddisfacente a una ‘non-domanda’, tanto meglio comprendere come, talvolta, pur nell’incongruenza, sia possibile delineare una qualche ‘esperienza sociale’ da riconsiderare.
Potrebbe qui essere sufficiente osservare quelle che sono le ‘carenze’ implicite in una qualsiasi struttura lavorativa, riguardanti, nello specifico, l’organizzazione del lavoro e il comparto economico-amministrativo, e ci si accorgerà quanto di più contraddittorio sussiste nella pratica ‘tra il dire e il fare’ dell’esperienza individuale riferita alle ‘pari opportunità’. Soprattutto in relazione alle ‘strutture’ non sempre adeguate alla tipologia del ruolo svolto, rispetto alla ‘qualità’ e alla ‘quantità’ produttiva, sempre maggiore, che viene richiesta. E non solo in ambito lavorativo a fronte degli orari (turnazioni, straordinari, riposi settimanali, ferie ecc.); bensì in tutto quanto attiene alla sicurezza, ai rischi per la salute e, non in ultimo, a quelle che sono le normative nazionali ed europee che spesso vengono disattese.
Sono comunque del parere che un approccio ‘qualitativo’ o, per meglio dire, più qualificato, faciliti l’efficacia della ‘legittimazione paritaria’ all’interno delle singole realtà, siano esse produttive pubbliche che nelle aziende private, sia nelle istituzioni riguardanti la famiglia, la scuola, ecc.. Non c’è dubbio che una maggiore ‘consapevolezza’ basata sulla ‘conoscenza’, sia che riguardi la ‘giustizia sociale’ che il rispetto dei ‘diritti umani’, non può che promuovere una maggiore ‘empatia’ (*) e un migliore approccio con gli altri, a fronte di una sicura ‘crescita’ che guardi al ‘futuro’. Tematiche queste che Umberto Galimberti (*) ritiene di primaria importanza, sulle quali confrontarsi quotidianamente, nella consapevolezza di una ritrovata ‘azione collettiva’ basata sull’ ‘identità’ e il ‘mutamento culturale’, capaci di agevolare le ‘interazioni sociali’ (*) nella vita e sul lavoro.
Argomenti sempre attuali che molto hanno appassionato Alberto Melucci (*), definito il ‘sociologo dell’ascolto’, aperto ai temi della pace, delle mobilitazioni giovanili, dei movimenti delle donne, delle questioni ecologiche, delle forme di solidarietà e del lavoro psicoterapeutico, il quale, in anticipo sui tempi, ha esplorato il mutamento culturale dell’ ‘identità’, in funzione della domanda di cambiamento che viene proprio dalla sfera socio-lavorativa, affrontando i temi dell’esperienza individuale e dell’azione collettiva, studiando la loro ricaduta sulla vita quotidiana e sulle relazioni di gruppo che hanno confermato la validità dell’interazione scientifica tra le diverse discipline, e apportato innovativi contributi alla ricerca sociologica.
Così egli scrive: “Io sono convinto che il mondo contemporaneo abbia bisogno di una sociologia dell’ascolto. Non una conoscenza fredda, che si ferma al livello delle facoltà razionali, ma una conoscenza che considera gli altri dei soggetti. Non una conoscenza che crea una distanza, una separazione fra osservatore e osservato, bensì una conoscenza capace di ascoltare, che riesce a riconoscere i bisogni, le domande e gli interrogativi di chi osserva, ma anche capace, allo stesso tempo, di mettersi davvero in contatto, con gli altri. Gli altri che non sono solo degli oggetti, ma sono dei soggetti, delle persone come noi, che hanno spesso i nostri stessi interrogativi, si pongono le stesse domande e hanno le stesse debolezze, e le stesse paure” (*).
Si può ben comprendere quindi, quanto il ‘riconoscimento di legittimità giuridica’ (*), influisca nelle relazioni interpersonali, al punto che l’‘essere donna’, trasferito sul piano sociale, sia poi sfociato nella estenuante difesa di un ‘io persona’ alla ricerca di quella giustizia sociale che, al contrario, dovrebbe essere determinato da una corretta gestione all’interno di qualsiasi rapporto. Ciò che va riferito ovviamente anche a l’ ‘essere uomo’, dove ‘persona’ (*), nella concezione moderna, è potenzialmente ‘persona giuridica’ e, dunque, ‘soggetto di diritto’. Cioè: “...titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica, e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi”; onde per cui va considerato: “essere dotato di coscienza di sé e in possesso di una propria identità, riconosciuta alla persona umana”.
Lo afferma Jo Brunas-Wagstaff, studioso della ‘personalità’ individuale che, inoltre scrive: “Tuttavia, anche se sembra plausibile che le persone effettivamente organizzino e controllino il (proprio) comportamento in un certo modo, secondo alcuni psicologi (Carver, Scheier), il modello è troppo semplice, vista la complessità e la necessaria flessibilità del comportamento umano”; la cui comprensione, in margine a situazioni antropologico-culturali predefinite, non può prescindere dai contributi della psicologia cognitiva e dell’apprendimento sociale, atti a misurare le differenze individuali di ‘genere’. Dobbiamo, infatti, a questi moderni metodi psicologici, se oggi possiamo tracciare i ‘rapporti’ e le ‘dissonanze’ esistenti fra tratti di personalità e stili cognitivi, caratteri personali e influenze sociali, nel tentativo di prevedere e risolvere all’origine i diverbi conflittuali all’interno della società e nell’organizzazione socio-culturale a tutti i livelli.
Così come anche dovremmo ispezionare quelle zone sperimentali di riscrittura dei codici culturali, dette ‘liminali’ (*) e ‘interstiziali’ (*), potenzialmente feconde, in cui operano gli strumenti mediatici (analogici e digitali) a disposizione, oggi al centro della riflessione sociologica. Se è vero che le aggregazioni sociali ed economiche sorgono per resistere alla competizione ed alla concorrenza, a maggior ragione esse danno vita a nuove specificità forse più complesse, ma anche più salde, che ripropongono a un più alto livello la massima libertà individuale. Come infatti ha evidenziato in “Sociologia degli interstizi” G. Gasparini (*): “...la possibilità di coercizione che mette in gioco tra l’altro i rapporti tra i cittadini e lo stato”, in quanto espressione di scelte operate nell’ambito di valutazioni morali (virtuose e non solo), le cui ricadute influiscono in modo catartico sulla cosiddetta ‘sfera del sociale’.
Non necessariamente o in modo assoluto come marca del sistema utilitaristico di scambio o di mercato, tipici della logica economica, bensì come fenomeno di ‘prossimità’ (*), per meglio comprendere fin dove l’individuo sceglie in autonomia il proprio ‘ruolo’ nella società e nel mondo. In tal senso, non limitarsi semplicemente a riconoscere la vulnerabilità dell’‘identità sociale’ nel compiere scelte determinate, rappresenta – a mio avviso – la condizione essenziale per comprendere le modalità e le ragioni che le rendono necessarie. Nella storia sociale (e politica) si sono proposte anche importanti istanze progressive di ‘giustizia ed equità’ improntate alla ‘reciprocità equilibrata’ (*), vale a dire, ad esempio, ‘dare qualcosa ad un altro in cambio del giusto e dell’equivalente’. Non v’è dubbio, un comportamento che in origine doveva essere stato creativo della socialità, e che andrebbe riaffermato, o almeno in parte, come base nelle forme di interazione e scambio interpersonale.
Si tratta qui dello svilupparsi di progetti (di vita) di tipo ‘altruistico’, volti a realizzare il ‘bene’ (inteso come gratificazione) e al raggiungimento della ‘felicità’ (come soddisfazione e ricompensa), che si avvalgono dell’ ‘interazione sociale’ per concorrere, insieme con gli ‘altri’, alla propria realizzazione dinamica, relativa a progettualità pedagogiche, psicologiche, assistenziali, e improntate ai principi dell’ “insieme è meglio”. “Sono queste virtù – scrive A. MacIntyre (*) – che garantiscono un agire razionale indipendente, ma che hanno bisogno di essere accompagnate da opere (fatti) che rispondano a tali interrogativi (..) e che né la figura dello stato nazionale moderno, né il tipo di associazione sociale e politica di cui ci sarebbe bisogno, possono rappresentare”.
Tuttavia, se non in sporadici casi, le nuove spinte sociali di cui l’ ‘associazionismo’ (*) è fautore, non ha fatto delle ‘pari opportunità’ quella panacea che ci si aspettava per risolvere le problematiche discriminatorie nei confronti dell’uno e/o dell’altra nell’attuale società, né lo hanno potuto i movimenti femministi che non rientrano in questa mia tesi. Benché, è appurato, che qualcosa è sopravvenuto a stravolgere il nucleo più duro da sempre presente nell’ ‘inconscio collettivo’ di tipo maschilista. La sempre più ampia e infinita discussione, sui limiti della politica nel voler dare una svolta al ‘problema conflittuale’ delle disparità ‘donna-uomo/uomo-donna’, rientra in quello che in psicologia, è definito ‘metodo del consenso’ (*).
Basato sulla ‘cooperazione’ e non sulla ‘coercizione’, sebbene ciò richieda qualche sforzo in più per essere unitamente compreso e praticato. Se non c’è l’onesta volontà di venirsi incontro (legittimazione paritaria), il metodo non funziona, in special modo quando ci si trova di fronte a gruppi eterogenei che intendono mantenere esclusive posizioni di ruolo (potere), che non possono o non vogliono cooperare. L’applicazione del ‘metodo del consenso’, dunque, inteso come processo democratico che conferisce agli individui il poter prendere decisioni e, al tempo stesso, richiede a ciascuno di assumersi la responsabilità di tali decisioni.
Ciò che non è rinuncia al potere, bensì ‘potere-insieme’, che non chiede di trasferire responsabilità sugli ‘altri’, ma domanda agli ‘altri’ di rispondere personalmente e completamente delle proprie azioni, al di là delle ‘differenze di genere’ o di coperture coartate. Se non si comprende e si accetta questo, le politiche per le ‘pari opportunità’ hanno davvero ben poca possibilità di successo. Nella pur strenua possibilità di affermazione, il ‘metodo del consenso’, porta alla prevenzione dei conflitti nelle relazioni interpersonali, lì dove questi maggiormente si verificano o, come in alcuni casi, compromettono lo svolgimento del lavoro.
Nello specifico quando, e soprattutto, si fa riferimento a procedure etico-deontologiche, che regolano i rapporti introitati. Presupposto necessario per la risoluzione delle contrapposizioni e dei conflitti psicologici che rientrano in una dimensione di legalità e di giustizia sociale. Ovviamente i metodi di risoluzione dei conflitti - ad esempio – sul posto di lavoro, dovrebbero andare ben oltre gli intenti di pacificazione convenzionali, spesso animati da logiche economiche preferenziali, che per lo più gratificano l’uomo e penalizzano la donna.
Stando a recenti esperienze maturate, tendenti ad affidare la gestione dei conflitti a figure esterne (conflict management, sindacati, assistenti sociali, giudici di pace ecc.), siamo di fronte a un fatto nuovo, in cui l’applicazione delle ‘pari opportunità’, (ancora pur sempre in via del tutto teorica), dimostra una certa volontà di gestione delle dinamiche atte a regolamentare i parametri di partecipazione della ‘donna’ nel mondo del lavoro. Prevedendo la sua compresenza nei quadri ‘dirigenziali’ delle imprese (statali e private), da affiancare e/o integrare la presenza dell’uomo, tutto lascia ben sperare in una futura riorganizzazione in ambito lavorativo che includa la ‘donna’, a fronte di una ‘legittimazione paritaria’ (*) significativa, all’interno delle pianificazioni occupazionali del lavoro.
Ciò che davvero credo possa contribuire all’ ‘autoregolamentazione’ (*) dei comportamenti e all’attivazione di ‘processi di autocontrollo’ (*) come, ad esempio l’ ‘autostima’ (*) e di una certa realizzazione di sé a favore di una maggiore ‘autoaffermazione’ (*). Processi certamente idonei ad offrire agli individui uomo/donna una maggiore ‘sicurezza interiore’, e quelle sinergie necessarie, come l’assistenza psicologica in tutte le possibili emergenze: (malori improvvisi, demotivazioni da ansia sociale, difficoltà di relazione con gli altri, senso di insicurezza, che condizionano negativamente la qualità del rapporto della vita, rendendo difficile e doloroso proporsi nel mondo del lavoro), utilissime anche, in occasione di disastri dovuti a rappresaglie e calamità naturali ecc., dove più si sente la necessità di interventi capaci e risolutivi.
Bibliografia di consultazione:
(*)S. Piccone Stella – C. Saraceno, “Genere: la costruzione sociale del femminile e del maschile”; voce in ‘riconoscimento di genere’ (gender) – in ed in Vivien Burr “Psicologia delle differenze di genere” – Il Mulino 1996.
(*) Van Gennep, Mircea Eliade, J. G. Frazer, in ‘riti di riferimento o di passaggio’
(*) Mario Manfredi, “Teoria del riconoscimento”,
(*) Zygmunt Bauman, “Intervista sull’identità”
(*) Antony Giddens, “La trasformazione dell’intimità”
(*)Victor Turner, “Concetto di performance” e di ‘performatività’
(*) G. Gasparini, “Sociologia degli interstizi”,
(*) M. D’Avenia in MacIntyre, “Animali razionali dipendenti”
(*) Maria Menditto “Autostima al femminile”
(*) www.utopie.it/nonviolenza/metodo_del_consenso.htm )
(*) M. Menditto “Realizzazione di sé e sicurezza”
*
 - Cultura
- Cultura
Venerdì 17 Novembre - Giornata mondiale del Gatto Nero
Il mio stupendo gatto nero, ladro.
Pre-saggio.
Avverte Paul Hindemith che: “La musica sotto qualsivoglia suono o struttura si presenti, non è altro che rumore senza significato finché non raggiunge una mente capace a riceverla”…
MIA – A – U
MI- I- I –AU
MIAU
MI- I- I –AU
MIAU
MIA-U
MIA – A –A –U
MI-a-U, MI-a-U, MI-A-U,
MI – AU- AU- AU- AU
MI –I-I-I- A aaU
MIAU
MI-a-U, MI-a-U, MI-A-U,
MI – AU- AU- AU- AU-AU- AU-AU-AU MI –AU
MIA-A-A-A-aaU
Mi-i-i-i-i-i-i–au
Mia-aaaaaA-U
Mia-A-A-U
Mi-iiiiiiiiiiiiii-AU
MIA-A-A-A-aaU
Mi-i-i-i-i-i-i- au
MIA-A-A-A-aaU
Mi-i-i-i-i-i-i –au
MIA-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-U
MI-I-I-AU !!
MIAU …
(G. Rossini - “Duetto buffo di due gatti”).
Ed eccoci qua, disposti ad ascoltare la voce del nostro gatto trasformata in un linguaggio ruvido che lascia ‘pres-agire’ una certa insolenza. È quella del mio Super-Gatto Nero che adesso si aggira altezzoso attorno alla mia scrivania mentre vi sto scrivendo, sebbene non sia proprio certo che ignori del tutto che stia parlandovi di lui. Sì proprio così, Arsenio Lupén, che a ragione ho chiamato come il famigerato ‘ladro gentiluomo’ dei romanzi di Maurice Leblanc, solo perché come quello ruba per un ‘vizio di forma’, che non stento a definire ‘verosimile’ quanto ‘straordinario’, per quanto definirlo un gentiluomo, avrei qualcosa da ridire. Sempre che ciò non vi procuri alcun ripensamento sull’identità del vostro ‘adorabile’ compagno di vita, colui o colei cui riservate coccole affettuose più che a vostro marito e/o all’amate di turno, senza considerare che lui, il vostro gatto, come tutti i gatti che si rispettino, impiega l’arte della seduzione tipica del cicisbeo, per farvi intendere che in qualche modo vi appartiene, dissimulando una individualità pressoché egoista, potenzialmente dispotica, da lasciare all’occorrenza il segno. E che siate un amabile mentore o un asociale ossimoro, che apparteniate alla categoria antropologica degli umani e non a quella felina del suo entourage, sappiate che è inutile, con lui non si fanno carte, e che sia un graffio o una zampata collerica, statene certi, prima o poi arriva eccome. Come pure se non intende rispondere di proposito ad ogni vostra interlocuzione, non lo fa e basta, e non perché gli manca la parola, ma perché preferisce comunicare proponendosi con lo sguardo fisso nel vuoto, indifferentemente. Del resto lo sapete bene, ogni gatto ha la capacità straordinaria di starsene per proprio conto sfoderando un ozio altezzoso, che definirlo ‘da impunito’ è dir poco. Lui finge, vi spia, vi sorveglia, osserva ogni minimo movimento, sospetta di ogni rumore, di ogni minimo spostamento d’aria, avverte il vostro umore e ne fa uso, pronto a racimolare anche le briciole della vostra in-esistenza e che, all’occorrenza detiene come legittimità di appartenenza ‘regale’, impugnandola quale scettro della sua indole di despota. Solo allora vi accorgete di non avere più scampo, ammettetelo, da quel momento vi ha in pugno, comanda lui, siete soggetti ai suoi dettami. Proprio come il mio Lupén, anche il vostro ‘amore impossibile’, prima o poi approfitta della vostra subordinata, antropica moralità, per sottomettervi definitivamente e che, a lungo andare…
… vi addomesticherà.
*
 - Libri
- Libri
Massimo Recalcati ’La luce delle stelle morte’ recensione .
“Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi …” – poeticava Leopardi che le rimirava “scintillanti”, quando nella realtà del firmamento non sono che tremule fiammelle lontanissime e che, a dire di Massimo Recalcati, sembrano “anime” ormai prossime a spegnersi. “Pensiamo allo strano fenomeno astrofisico della luce delle stelle che osserviamo fare la sua apparizione nei nostri cieli, come spiegano gli scienziati, che arriva a noi con molti anni di ritardo (probabilmente milioni) da una stella già morta, scomparsa nel grande buio dell’universo (…) che, quindi (noi oggi) ammiriamo una ‘presenza che è fatta di assenza’ o una ‘assenza che si rende presente’, (…) raggiungendoci come una visitazione inattesa.”
Invero non è passato che un secolo, poco più poco meno, in cui una nuova generazione di poeti e scrittori sperimentavano una visione diversa dello stesso soggetto come le stelle, pur essendo più lontane che mai. In realtà, grazie al rinnovarsi di sofisticati telescopi, sono ormai meno distanti di allora, ancorché fredde, vuote e disabitate. Malgrado ciò sia da sempre nella natura umana guardare alle stelle con la nostalgia di un qualcosa che forse non è mai stato, come del ricordo di un’esistenza avita che si è logorata nel tempo della ricordanza, di un’assenza implicita in quanto parafrasi dell’Eden perduto o, forse, solo di una qualche felicità pregressa che sappiamo non poter tornare, se non sostituita da una nuova felicità.
Il cui raggiungimento, per quanto si cerchi, rasenta l’impossibile, per effetto dell’esegesi archetipica profonda che tutto investe all’interno d’ogni esistenza vissuta, poiché concomitante con la solitudine primordiale, “…come di un mondo in sé compiuto” – risponde Roberto Calasso – che giunge a noi che siamo fin dentro il nostro presente, “…a contrastare il divenire del tempo”.
“Panta rei”… recita l’antico aforisma – attribuito ad Eraclito – in cui ‘tutto scorre’ nel continuo alternarsi degli opposti, dentro la realtà apparente dell’inconoscibile e inesorabile divenire, nel perpetuo mutamento di cui si riveste l’amore degli umani. Vale dunque chiedersi ‘quale felicità’ rincorriamo?, se ciò che ruota al centro della nostra conoscenza si contrappone a noi, per un eccesso dinamico
che scaturisce in energia sottile, come di vortice invisibile, nella nostalgia di ciò che non è e che non potrà mai più essere.
“Può la luce arrivare dal passato?”– si chiede Massimo Recalcati autore di questo prezioso libro – nel “cercare l’emanazione luminosa del nome da dare all’oggetto e/o al soggetto perduto?” E inoltre, “Può esserci luce nella polvere?”; sebbene sappiamo a chi e a che cosa apparteneva quel dato ‘nome’ che si concreta con determinazione nel nostro pensiero virtuale, quasi per una metamorfosi del meraviglioso, nel malinconico effetto dell’ardore che ci portiamo dentro, allorché entriamo nel mondo estremo dell’incanto, nella “sottesa disponibilità a riconoscere un’immensità che tutto travolge e ovunque è avvertibile.”
Ma gli interrogativi così posti reclamano risposte di assoluta verità, per un ritorno all’espressività “filologica e filosofica” sulle origini dell’umanità e dell’intero creato. Non a caso Sartre considerava effimero ogni costrutto in proposito: “Ogni desiderio di ritorno è precluso; non esiste possibilità di ritornare alla vita dopo la morte, non esiste possibilità di ritornare nel corpo della madre, non esiste possibilità di riappropriarci della nostra origine. L’esodo dell’esistenza esclude la chiusura del cerchio e impone un infinito senza totalità”.
Dacché non resta che appellarsi a quell’ “…altrove cui ciascuno di noi può proiettare la sagoma del proprio desiderio impedendo alla realtà di sopprimere i nostri sogni”, come a voler carpire alla vita la linfa esperienziale che la fa grande, devoluta all’ ‘altro’ in quanto estensione di Sé; a quel Figlio spurio al quale, nel corpo effimero del reale si è donato, nel riscatto di quell’amore che ci ha insegnato l’esperienza traumatica del venire al mondo, e la perdita della vita che ne santifica il sacrificio costante, quel ‘finito’ proprio dell’avventura umana che pure contesta ‘ad infinitum’, nello scontro/incontro con l’esistenza stessa.
Tuttavia qualcosa di più si nasconde fra le linee del testo, quel lavorio costante della memoria razionale che narra di un vissuto esperienziale, benché minimalista, di dolore pur nell’amore e dell’amore come nostalgia e rimpianto di una perdita che “La luce delle stelle morte” conduce inesorabilmente verso l’oblio senza possibilità di riscatto …
“…ché d’aver dato l’aggio a Caronte, superata l’infernale sponda, consegna l’anima a quel Dio scontroso che di giudicar s’avvale, del bene e del male dell’umana vanità, del suo voler essere divino sopra ogni cosa, sulle miserie di questo mondo altero che di pianto ha gli occhi colmi di lacrime rapprese.” (GioMa)
La fenomenologia cui accede l’autore proviene dalle fonti più eccelse in fatto di filosofia, di psicologia analitica del profondo, dell’inconscio individuale e collettivo, nomi quali: Arendt, Barthes, Benjamin, Freud, Derrida, Lacan, Sartre, Starobinski, Parmiggiani, Racalbuto e tantissimi altri. Qui ripresi da classici della letteratura antica e moderna, citati nella bibliografia di riferimento di ciascuna delle tematiche testate, relative al ‘lutto’ e alla ‘nostalgia’, per lo più afferenti ad argomenti consistenti la riflessione psicologica del lutto, la forma psicosomatica del dolore, la commozione, l’emozione, il pianto, il rimorso della perdita; così come il sogno, il desiderio, la visione dell’al di là, l’abbaglio di altri possibili mondi paralleli, il delirio schizofrenico dell’amore.
Altrettanto valide risultano le considerazioni che riempiono le parole spese afferenti alla testimonianza di un qualcosa che è accaduto, dalla nostalgia dell’assenza alla separazione luttuosa, dalla perdita della persona cara, alla negazione della morte; dalla somatizzazione del dolore, all’oblio, al rimpianto, al sogno rivelatore di qualcosa che tuttavia persiste e ruota intorno a noi come rimembranza di una forzata ‘assenza’: “…vissuta come una perdita quando apre nella nostra vita una mancanza, quando si ripresenta presso di noi nella forma di un’assenza presente”.
Il sogno, ad esempio, inquanto “riflesso di un’assenza da noi stessi” – scrive ancora Recalcati – riguarda tutti noi senza distinzione, relegato all’esperienza traumatologica del passato, che lo ha visto conferito alle divinazioni, alle visioni paranormali, ai miti cui è di riferimento e attribuibile alle premonizioni magiche, al lutto delle origini, alle disgrazie successive, come pure alla morte esistenziale e a quanto ne consegue. “Più che ambire a realizzare un effettivo compimento del lutto nel senso freudiano del termine, dovremmo piuttosto assumere che, se c’è un compimento del lutto, esso si realizza solo nel riconoscimento della sua impossibilità, ossia, detto in altre parole, che il solo modo di portare a compimento un lutto è quello di riconoscerne la strutturale incompiutezza.”
Per quanto noi oggi ben sappiamo, ad esempio, che il “sonno della ragione genera mostri”, e che tutto questo è registrato nell’emotività e nella indeterminazione di certi soggetti psicolabili, all’interno dei sentimenti contrastanti che si riverberano nei ‘sogni oppressivi’ in cui i mostri generati s’affannano nella creazione di incubi angosciosi che ritornano assillanti a disturbare il riposo dei giusti, come anche quello dei morti e quindi al lutto esperienziale, così come la paura del vuoto e/o delle tenebre, del buio prossimo al dolore e alle privazioni annunciate come la pandemia e l’orrore per la distruzione finale, l’Armageddon, l’Apocalisse cristiana.
Siamo qui messi di fronte a forme di culto apparentate con il folklore e studiate in antropologia, che nei millenni passati hanno determinato subculture talvolta violente, dispotiche e aggressive, insieme ad altre forme spaventose di credenze animiste credenti negli esseri spirituali che animano l’intera natura organica e inorganica cui vengono attribuite qualità divine o soprannaturali, presenti negli oggetti, in luoghi o esseri materiali, in parte inventati dalla creatività orrifica degli umani, e con effetti paranormali e talvolta paranoici che non sono presenti nel libro e che auspichiamo di trovare nel prossimo.
Ovviamente non tutto è detto nelle pagine di questo libro chiarificatore quanto inquietante, né di quanto è detto nello spazio angusto di questa recensione parziale di un lavoro stracolmo di riferimenti e richiami letterari, con i limiti ovvi del lettore qual io sono. Per cui la scelta di una lettura siffatta, diventa ragione arbitrale di un percorso conoscitivo che va appunto “oltre”, ove la libertà di scelta diventa arbitrato di una motivazione, per una predilezione che posso definire ‘elettiva’ legata all’esperienza del lutto che tuttavia rimane una condizione dolorosa. Come pure scrive Roland Barthes, citato nel libro: “La sua morte potrebbe essere liberatrice nei confronti dei miei desideri. ma la sua morte mi ha cambiato , io non desidero più ciò che avevo desiderato. (…) Bisogna attendere che si formi un nuovo desiderio successivo alla sua morte”.
Secondo Recalcati è questa: “… una condizione che colpisce chi resta e deve misurare la sua totale impotenza di fronte allo strapotere assoluto della morte. L’esperienza del lutto non riguarda però, come abbiamo visto, solo le morti fisiche di persone alle quali eravamo legati, ma accompagna necessariamente ogni separazione. Quanti addii, quanti abbandoni, quanti tradimenti, quante delusioni, quanti dolori si sono rivelati delle specie di morte che ci hanno imposto un tempo di lutto? Se seguiamo la lezione di Freud, dovremmo innanzitutto distinguere tra l’esperienza del lutto come risposta all’evento della separazione in quanto tale e quella del lutto inteso come … attraversamento sacrificale dell’esistenza. (…) L’esperienza del lutto come tale – prosegue l’autore – è una conseguenza diretta del trauma della perdita. Accade nei confronti della morte di una persona cara, ma anche di fronte alla fine di un amore, di un’amicizia importante, di un legame famigliare, di qualunque relazione sia stata per noi significativa.”
Torniamo quindi a contemplare le “Vaghe stelle dell’Orsa” che pur s’accendono nel nostro cielo, ma questa volta lo facciamo in compagnia del nostro mentore Massimo Recalcati che nell’atto di sottrarsi all’apparenza, nel silenzio della solitudine avalla, sul filo del crinale, una remissione di colpe senza nemesi contro il giudizio inoppugnabile del passare del tempo, per una pace che ‘alla luce delle stelle morte’, altro non pare che l’equivalente indecidibile della perdita dell’anima a noi cara”.
L’autore.
Massimo Recalcati psicoanalista lacaniano autore di saggistica, si è formato alla psicoanalisi a Parigi con Jacques-Alain Miller. Tra i più noti psicoanalisti in Italia, è membro analista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi e direttore dell’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata). È stato direttore scientifico nazionale dell'ABA (Associazione per lo studio e la ricerca dell'anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002. Ha insegnato nelle Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna. Oggi insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia e Psicoanalisi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona.
Note:
(“”) Tutte le virgolettature non sono di Massimo Recalcati, tranne quelle afferenti alle citazioni esplicite riportate nel testo.
*
 - Libri
- Libri
Gerd Gigerenzer - Perché l’intelligenza umana batte ...
Gerd Gigerenzer
"Perché l’intelligenza umana batte ancora gli algoritmi".
Raffaello Cortina Editore 2023
In ogni cultura, abbiamo bisogno di parlare del mondo futuro in cui noi e i nostri figli desideriamo vivere. Non vi sarà mai una sola risposta. C’è però un messaggio generale che si applica a tutte le prospettive: nonostante o a causa dell’innovazione tecnologica, abbiamo bisogno di usare più che mai i nostri cervelli. Iniziamo con un problema che ci sta a cuore, trovare il vero amore, e con algoritmi segreti talmente semplici che chiunque può comprenderli.
“Il problema non è l’ascesa delle macchine “intelligenti”, ma l’istupidimento dell’umanità”. (Astra Taylor)
*
 - Sociologia
- Sociologia
’Comunicare il futuro!?’ 6 Echi della comunicazione di massa
(Umberto Eco ‘affabulatore’ della comunicazione fantascientifica).
L’attendibilità di quanto sopra enunciato trova un riscontro affascinante nel libro di U. Eco “La ricerca della lingua perfetta” (1963), sì da rasentare una vera e propria ‘avventura letteraria’ ai margini della Science-Fiction, all’interno del quale si fa riferimento a un ipotetico ‘Linguaggio spaziale’ che prende spunto dal progetto scientifico “Lincos”, una sorta di idioma elaborato dall’olandese H.A. Freudenthal (1960), afferente a “…poter interagire con eventuali abitanti di altre galassie”. Niente di più di una formula didattica commisurata a un codice matematico nel rispetto di regole date, per trarne una lettura a livello esclusivamente tecnologico.
Scrive Eco in proposito: “Lincos non è una lingua che aspiri a essere parlata, è piuttosto un progetto di come si possa inventare una lingua insegnandola nel contempo a esseri che presumibilmente avrebbero una storia (remotissima) e una biologia diversa dalla nostra. Progetto che H.A. Freudenthal presumeva di poter lanciare nello spazio in forma di ‘segnali elettromagnetici’ (per comodità si assume che siano onde radio di diversa durata e lunghezza), di cui non conta la sostanza, bensì la forma dell’espressione e del contenuto, […] fornendo così l’immagine di un linguaggio quasi esclusivamente “mentale” che porti a riflettere su un’altra discendenza, quella dell’antica ricerca sulle ‘lingue perfette’”.
“Sì che, cercando di comprendere la logica che guida la forma dell’espressione che viene trasmessa, gli alieni dovrebbero essere in grado di estrapolare una forma del contenuto che in qualche modo non dovrebbe essere loro estranea. […] Presumendo inoltre che gli spaziali abbiano una tecnologia che li renda capaci di ricevere e decodificare lunghezze d’onda, e che essi seguano alcuni criteri logici e matematici affini ai nostri. Dacché, passati a famigliarizzare gli alieni con una numerazione binaria che sostituisce la sequenza dei segnali, sarebbe possibile comunicare, sempre per ostensione e ripetizione, alcune delle principali operazioni matematiche”. (U. Eco op.cit.)
Presumibilmente il progetto “Lincos” risulta più interessante dal punto di vista antropologico-pedagogico che da quello glottogonico della ‘convergenza linguistica’, tuttavia, ce n’è qui per spingersi in un’avventura spazio-temporale sia scientifica che letteraria onde avallare ‘il sogno di una lingua perfetta’, in cui poter definire tutti i significati dei termini di un linguaggio naturale che consenta interazioni dialogiche ‘sensate’ tra uomo e macchina, e/o alle macchine di elaborare inferenze proprie dei linguaggi naturali che, non in ultimo, rientrano nell’interesse della ricerca contemporanea sulla ‘comunicazione’ e in quello specifico dell’Intelligenza Artificiale (I.A.).
“In I.A. per esempio – scrive ancora Eco – si cerca di fornire alla macchina regole di inferenza in base alle quali essa possa ‘giudicare’ della coerenza di una storia, e così via. […] La letteratura in proposito è assai vasta, divide i sistemi molteplici da quelli che presumono ancora la possibilità di una semantica a componenti elementari e/o primitivi, da quelli che forniscono alla macchina schemi di azione, o addirittura di situazioni (frames, scripts, goals). Tutti i progetti di I.A. ereditano in qualche modo la problematica delle lingue filosofiche a priori, e riescono a risolvere alcuni problemi solo con soluzioni ad hoc e per porzioni molto locali dell’intero spazio di azione di una lingua naturale.”
A leggere i suoi molti libri, si scopre che Eco, semiologo, filosofo, scrittore e saggista, era a sua volta un lettore appassionato di ‘Science-Fiction’, soprattutto di ‘fantascienza sociale’, quella che, tanto per dire, veniva pubblicata sulle riviste americane Galaxy e The Magazine of Fantasy and Science Fiction e che continua ad avere in molti scrittori contemporanei i suoi principali sostenitori. Eco infatti, attribuiva alla fantascienza un ruolo ben preciso, quello di trasmettere all'interno della “cultura di massa”, praticamente a tutti i fenomeni culturali (dai fumetti, alle canzoni, dalla radio alla televisione), con una sua visione progressista della società, di cui si era già occupato in “Apocalittici e integrati” (1964), fosse anche il più commerciale dei contenitori, come appunto l’informazione e la pubblicità, ingabbiate come sono in una formula edulcorante e d’intrattenimento.
È così che alla domanda se “una critica o una teoria della comunicazione di massa è (ancora) possibile? rispondeva: “Lo dicevo già nella prefazione del ’64: fare la teoria delle comunicazioni di massa è come fare la teoria di giovedì prossimo. […] È che il territorio si modifica, dal di dentro e dal di fuori. E se si scrivono libri – e si fanno teorie, aggiungeremo che – sulle comunicazioni di massa bisogna accettare che siano provvisorie. E che magari perdano e riacquistino d’attualità nello spazio di un mattino”. Allorché, a un’altra domanda su “che cosa s’intende per cultura di massa?”, rispondeva con riflessiva calma: “È un concetto generico e ambiguo con cui si finisce per indicare una cultura condivisa da tutti, prodotta in modo che si adatti a tutti ed elaborata sulla misura di tutti […] La cultura di massa è un mostruoso controsenso, è l’anticultura”.
Definizione quest’ultima che, se vogliamo, è autorevole quanto inaspettata, soprattutto per un semiologo a spasso coi tempi, attento alle variazioni linguistiche più sofisticate, che davvero non faceva sconti alla ‘fantascienza’ dai suoi esordi come scrittore di racconti. Vale qui la pena ricordare, ad esempio, che la sua prefazione al racconto “Le sirene di Titano” (1965) di K. Vonnegut Jr, uscito nella collana ‘Science Fiction Book Club’. Ne va dimenticato che nella sua raccolta di saggi “Apocalittici e integrati” (op.cit.), proponeva ai critici letterari suoi colleghi, una metodologia precisa per recensire i romanzi di questo genere, sostenendo che: "La fantascienza è letteratura di consumo, e quindi non va giudicata (se non per finzione snobistica) secondo i criteri applicabili alla letteratura sperimentale e di ricerca".
Ma chi erano, e tutt’ora lo sono, secondo Umberto Eco gli ‘apocalittici e gli integrati’?: “Sono quelli che a guardarli bene però sembrerebbero facce diverse della stessa medaglia”, aveva risposto precedentemente, durante una sua ‘Lectio Magistralis’ per il conferimento di una ennesima laurea honoris causa, con la sua solita faccia da gatto sornione. “Quelli che ci hanno abituato a teorie e analisi sociologiche che hanno la stessa volubilità e la stessa fretta con cui gli utenti danno vita a trend o codificano modi di stare sui social per poi dimenticarsene solo qualche giorno dopo, dimostrando intanto la natura teleonomica (finalismo insito nelle forme) degli ambienti digitali e, con loro, di qualsiasi prodotto dell’industria culturale”.
In un altro famoso saggio dal titolo significativo “I mondi della fantascienza”, apparso nella raccolta “Sugli Specchi” (1985), Eco scrive: "La buona fantascienza è scientificamente interessante non perché parla di prodigi tecnologici – e potrebbe anche non parlarne affatto – ma perché si propone come gioco narrativo sulla essenza stessa di ogni scienza, e cioè sulla sua ‘congetturalità’. La fantascienza è, in altri termini, narrativa dell'ipotesi, della congettura o dell'abduzione, e in tal senso è gioco scientifico per eccellenza, dato che ogni scienza funziona per congetture, ovvero per abduzioni." Lì dove ‘abduzione’, nell’accezione letteraria utilizzata dall’autore, sta per allontanamento da un prefisso o punto di riferimento della realtà.
Ma forse una breve delucidazione può essere d’aiuto per meglio definire la sua attività di ‘affabulatore’ della comunicazione fantascientifica, perché in realtà l’Eco scrittore non si è mai risolutivamente inoltrato nell’ambito della ‘Science Fiction’ tout-court, se mai, è stato piuttosto un encomiabile lodatore del genere ‘Fantasy’, (valga per tutti “L’isola del giorno prima” (1994), sebbene, in seguito, abbia cambiato la sua posizione, attribuendo alla fantascienza un più stretto legame con la ‘scienza’ vera e propria, limitandosi a riflessioni critiche, producendosi come scrittore confacente a questa materia. Invero il suo esordio narrativo è avvenuto proprio attraverso racconti di un certo rilievo via via raccolti in “Diario minimo” (1965), e in “Secondo Diario Minimo” (1992), che oggi rappresentano il segno della sua grandezza intellettuale capace di affrontare anche tematiche preminenti sulla “comunicazione di massa”.
La ‘comunicazione’, dunque, come trasferimento intenzionale dell’informazione culturale che Eco, nella lezione tenuta al Festival della Comunicazione di Camogli (2014), rapportava alla ‘semantica’ e alla ‘pragmatica’, attribuendone però la scarsa attendibilità, minata dall'uso della ‘rete’: “La funzione dei ‘gate keepers’ (influencer in marketing) è tramontata, non ci sono elementi di garanzia che vaglino le informazioni. Persino la funzione dei giornali si è ridotta; l'apparente libertà dell'utente coincide con il suo smarrimento. Comunicare oggi significa rendere potenzialmente noto a tutti ciò che si fa o ciò che ci si propone di fare. […] Per la prima volta nella storia dell'umanità, grazie ai ‘social network’, gli spiati collaborano con le spie. D'altra parte la comunicazione on-line ha sottratto grandi masse all'isolamento. Twitter ha aiutato i reclusi a far sentire il loro messaggio. Il chiacchiericcio di Facebook serve a mantenere solo il contatto, a prevalere è la funzione fatica del linguaggio”.
Linguaggio che già alla metà degli anni Sessanta Eco definiva ‘stanco’, le cui considerazioni, registrate nel suo articolo: “Cultura di massa e ‘livelli’ di cultura” (1965), richiamano ancor oggi al superamento dell’inefficace contrapposizione tra sostenitori e detrattori della cultura di massa, ponendo l’accento su una generale tendenza allo scadimento dell’intero “campo culturale” che, per rendersi sempre più accessibile al mercato, aderiva in misura crescente ai bisogni del ‘consumo culturale’. Ciò nonostante, pur criticandola, rammentava positivamente quanto affermato dal sociologo francese Edgar Morin in occasione dell’uscita del suo libro “L’ésprit du temps” (1962), in cui si valorizza la ‘cultura di massa’ per la sua “capacità di fungere da terreno di comunicazione tra classi sociali e culture diverse”.
Un’investigazione speculativa, se mi è concesso dire, su cui si è qui soffermata questa tesi, improntata sul preposto “Comunicare il futuro!?” – vale la pena ricordarlo – assumendo come punto basico le premesse scientifiche e le innovazioni tecnologiche (per lo più letterarie) che ne hanno permesso la realizzazione, per quanto le tematiche qui affrontate richiederebbero una più ampia analisi, proprio sul terreno specifico delle ‘divergenze’ e delle ‘confluenze’ tra la cultura di massa e le classi sociali, per una teoria generale delle ‘reti neurali’ (artificiali), che emulano le prestazioni cognitive operanti sullo sfondo del cambiamento in atto.
Come scrive Marica Tolomelli, storica contemporanea di cultura e società, nel suo eloquente saggio “Sfera pubblica e comunicazione di massa” (2006): “La storia della comunicazione è sempre stata animata dal ritmo della ricerca e dal contributo di tanti singoli studiosi che spesso lavorano in maniera del tutto individuale e indipendente, la cui opera non può essere colta se non quale contributo nel lungo e variegato processo di accumulazione del sapere. Così come i principali progressi nell’avanzamento di trasmissione della cultura di massa eminentemente rilevata dai preziosi momenti di dibattito e di confronto con la ‘comunità scientifica internazionale’, che da sempre funge da stimolo al progresso dell’umanità”.
Altro aspetto di grande interesse, non trattato in questa tesi, riguarda l’interattività dei processi informatici, i codici organizzativi delle informazioni, dei sistemi operativi e dei linguaggi di programmazione, l’elaborazione dati e i modelli di riferimento della ‘rete’ globalizzata, cui la ‘comunicazione’ fa da interfaccia nella distribuzione del sapere, ad uso e consumo della ‘cultura di massa’ per le sue capacità di raggiungere simultaneamente vasti pubblici nello spazio e nel tempo. Quella stessa che grazie alle scoperte della scienza e alle innovazioni tecnologiche, continua a trasformare l’opinione pubblica all’interno del dibattito socio-economico in conformità con i settori del commercio, dell’imprenditoria, della sanità, nonché nell’interesse dell’insegnamento culturale scolastico-universitario e delle arti applicate.
Scrive R. Piccolo in “Nuovi confini artistici” (2022): “È soprattutto l’intelligenza artificiale (I.A.) che si sta prendendo il futuro di tutto, anche le facoltà cognitive superiori finora considerate accessibili solo alla mente umana”. Ma l’I.A. potrà mai superare l’intelligenza umana?, ci si chiede tra l’incredulo e lo sbigottimento generale, come davanti a un’improvvisa opera di smisurata immaginazione, o di sconfinata follia.
Non c’è di che prendersela, l’I.A. non segnerà la fine della creatività umana, che pure rientra in questo specifico contesto. Tuttavia, per una possibile quanto imprevedibile lungaggine, preferisco sorvolare sull’argomento, che pure occupa un posto di tutto rilievo nella letteratura e nella storia delle art applicate: (cinema, TV, Design, ecc.). Vale comunque la pena di fare almeno un esempio. Arriviamo così al robot-killer di “Io, robot” (1982) dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov. Né serve dire delle macchine che pensano da sole, o di quelle super intelligenti del tipo ‘Matrix’ o ‘Terminator’, benché in esse (incredibile ma vero) vengono descritte le “leggi della robotica che regolano il rapporto tra uomini e robot”, di cui la ‘scienza ufficiale’ (a ragione) non si è ancora occupata.
Certi scenari vanno bene per quei programmi che possono essere chiamati ‘intelligenti’ solo nel senso molto ristretto algoritmicamente in grado di svolgere specifici problemi cognitivi, dando l’impressione di pensare realmente”. Ma se da un lato è improbabile che le simulazioni del nostro cervello, anche quelle più sofisticate in assoluto, siano in grado di produrre sensazioni coscienti; di fatto non è ancora del tutto chiaro se macchine del genere saranno effettivamente dotate di coscienza. Per quanto, macchine dotate di intelligenza di livello umano sono ormai all’orizzonte, pronte a sostituire l’essere antropico con le nostre ‘controfigure digitali’ in molte delle applicazioni manuali e tecniche virtuali, nonché alquanto creative con software di base molto sofisticati, cosiddetti TTI, (acronimo di Text-To-Image), considerate la vera avanguardia dell’arte digitale, ognuna con caratteristiche differenti dagli altri e addestrate per essere più performanti in certi generi di ‘machine learning’.
“In fatto di arte, ad esempio – scrive ancora R. Piccolo (op.cit.) – l’I.A, ha ‘creato’ nel vero senso della parola, qualcosa di radicalmente nuovo, passando dall’immaginazione individuale allo schermo del computer (pc) in un batter di ciglia. Si può non chiamarla arte, ma quello è il termine che per ora più ci si avvicina. A questo punto le potenzialità di sperimentazione sono letteralmente infinite, tanto più che è possibile addestrare le ‘machine’ con diversi database specifici e, in un certo senso, cambiare la ‘personalità’ al programma, affascinati da questa innovativa tecnologia digitale. Si è perso il monopolio della creatività, le ‘machine’ conquistano l’ultimo baluardo del cervello umano (?)”. La domanda che ci si pone è sempre la stessa dall’avvento della tecnologia che ha rivoluzionato il mondo e, come per l’arrivo di ogni tecnologia che soverchia i paradigmi che la precedono, non sembra sia giunta una sentenza che possa dirsi definitiva.
Possiamo pensare all’ascesa del TTI come per la nascita della fotografia meccanica, che un secolo fa, fu bersagliata da illustri critici che la consideravano ‘disumanizzante’. Allo stesso modo la fotografia digitale non ha estinto le illustrazioni umane, ma ha piuttosto ampliato i ‘luoghi’ in cui le immagini appaiono. Alla stregua dei generatori di immagini con I.A. si aprono possibilità tutt’ora incredibili, permettendo a tutti di dar sfogo alle proprie immaginazioni e crearne di nuove mai viste prima in una manciata di secondi. Va però detto che “non tutto fa il computer”, che l’I.A. non è nient’altro che uno strumento nelle mani dell’“homo faber” di ancestrale memoria, l’uomo che programma, elabora, predispone e che, secondo alcuni, andrebbe considerato addirittura co-autore di molta produzione che con qualche beneficio, si vuole chiamare ‘arte’.
F. D’Isa, artista, scrittore, giornalista e curatore d'arte (in R. Piccolo “Nuovi confini artistici” op.cit.), ravvisa in proposito: “Innanzitutto per padroneggiare l’uso dei software si dovrà avere buona dimestichezza col tutto il mondo visivo e iconografico del passato, perché i termini dell’algoritmo sono quelli legati a questo mondo. Per cui le competenze più importanti da considerare sono quelle che riguardano l’addestramento, quelle abilità più vicine all’ambito sociale o psicologico che in futuro dovrà riuscire a entrare in sintonia con la ‘macchina’ tramite competenze linguistiche e comunicative. L’intelligenza artificiale (I.A.) è la fine del mondo come lo conosciamo, non perché è davvero senziente nel senso che molti vorrebbero dargli, ma per il modo radicale di cambiare le regole del gioco, di spostare il modo in cui si crea (e/o ricrea) totalmente in un altro contesto”.
Come anche suggerisce G. Magini, programmatore e fondatore del progetto “Scrittura Industriale Collettiva” (2013): “In fondo potremmo pensare a questi programmi non più come delle ‘intelligenze artificiali’ che sfidano le capacità cognitive umane, ma come un alleato che espande i nostri confini cognitivi. Un potenziamento del nostro cervello. Una sorta di immaginazione aumentata che ci traghetterà al di là di noi stessi verso un nuovo, e ancora inesplorato, paradigma dell’intelligenza ibrida e della creatività artistica. In un luogo in cui uomo e macchina trovano una sintesi perfetta”.
Come in tutte le cose, anche osservando lo sviluppo di queste nuove tecnologie si può essere ottimisti o pessimisti, almeno stando all’insegnamento del campione di scacchi G. Kasparov – autore del saggio “Deep Thinking: Dove finisce l’intelligenza artificiale, comincia la creatività umana” (2019), ancor più che “…l’ideale è pensare al futuro con positività, auspicando una conciliazione tra il mondo dell’informatica e quello della creatività”.
Come dire che per raggiungere la dimensione auspicabile in principio di questa argomentazione bisogna almeno crederci, ed io, in quanto autore di questa tesi, fermamente ci credo.
*
 - Sociologia
- Sociologia
’Comunicare il futuro!?’ - 5 Astropolitica
(le conseguenze politiche della colonizzazione di altri pianeti in Harold Dwight Lasswell – “Astropolitica”)
Recita lo slogan: “La comunicazione al servizio della scienza, la scienza al servizio della comunicazione. (?)” Il punto interrogativo aggiunto a questa frase mi è subito sembrato d’uopo all’investigazione approntata in questa tesi, attinente – come vuole essere – alle finalità di una ricerca sulle Sciences Fiction (Sci-Fi). Un fenomeno più letterario che scientifico afferente al ‘metaverso’, qui inteso come spazio tridimensionale che altresì si rivela di una certa presa sull’“opinione pubblica”, la cui affermazione indeterminata, almeno nell’uso recente, sembra influenzare non poco le preferenze discrezionali in fatto di ‘informazione’ e di ‘comunicazione’, per una sorta di evasione necessaria dall’invadenza di una ‘globalizzazione’ che attanaglia.
Se si pensa alla creazione dei 'segni ideografici' che hanno distinto i popoli sumeri ed egizi all’inizio della loro civilizzazione o, allo sconvolgimento che vissero quei primi uomini analfabeti indagati da H.-C. Puech in “I popoli senza scrittura” (1978); e ancora, a quelle prime civiltà alle prese con l’avvento rivoluzionario della ‘stampa’, torna lecito pensare al messaggio esplicito e univoco che la semplice funzione del ‘comunicare’ può dare oggi, all’inizio del XXI secolo, col mettere in evidenza la rivelazione consolidata della nostra esistenza, alla certezza storica di quanto ha prodotto attraverso i millenni la memoria dell’intera umanità.
È quasi impossibile immaginare oggi un mondo senza scrittura, eppure è stato così finché, per una strana combinazione d’astri, gli agenti patogeni del ‘linguaggio’ hanno spinto l’essere antropico ad esprimersi proprio attraverso di essa. Chissà se in un prossimo futuro l’avviata costruzione di un ulteriore ‘medium’ che a noi sembra solo un’arida formulazione algebrica, non possa fornire l’unico linguaggio capace di accomunarci tutti in un solo idioma, riuscendo così a dare alle infinite forme della ‘comunicazione’ quell’univoca scintilla che la scoperta della particella di Dio ha dato alla moderna scienza?
“Ma chi erano questi antropici viventi dell’universo che di così avanzata scienza hanno fatto materia, rendendo reali gli allora inimmaginabili intelletti, dividendo l’ardore dal dolore e scegliendo per il tempo rimasto solo la bellezza? Avverrà mai quella che in un attimo si mostra come l’idea risolutiva, la combinazione perfetta e discriminante, rispetto a tutte quelle maggioritarie?” – si chiede per di più il matematico quantistico R. Maggiani (op.cit.), per poi affermare che “…dev’esserci pur stato un tempo in cui nel cosmo non c’erano cose umane, solo terra e l’inizio di un vasto oceano, ma che sotto il cielo della prima atmosfera ribolliva già una possibilità di vita tra le possibili combinazioni del reale”.
In quanto fonte di conoscenza che ha dato avvio alla capacità di trasmettere ‘informazioni’, l’attuale prerogativa della ‘comunicazione’ afferma l’universalità sorprendente dell’avventura umana, capace di diffondere inoltre alle ‘incognite’ terribili della guerra e alle brutture che ne conseguono (odio razziale, inimicizia sociale ecc.), inesauribili ‘messaggi’ di fondata positività (cooperazione, solidarietà, amicizia, pace), che pur si presentano alla nostra ragione come una sfida continua, alla quale non possiamo sottrarci. Ci sono tre condizioni essenziali all’origine della vita – come hanno evidenziato R. Shapiro e G. Feinberg in “La vita nel cosmo. Guida alle possibilità di vita al di fuori del nostro pianeta” (1985): “…disponibilità di energia (pura), capacità di usare la materia (massa cosmica), disporre di un sistema ordinato sulla misura del tempo (era geologica), abbastanza lungo da permetterci di realizzare la complessità del tutto”.
Ma se davvero abitiamo in uno ‘spazio espanso’ senza dimensione alcuna, dove il nostro essere si fa partecipe del presente, allora chissà se un giorno non lontano, saremo davvero partecipi di quel ‘futuro cibernetico’ che fin qui abbiamo solo sognato e che, seppure in parte, dovremo alla ‘quiescenza’ (inerzia, quiete), così come è stata tramandata dal vegliardo maestro cinese di scrittura Lu Ji che abbiamo appreso in “L’arte della scrittura” (2002) in cui si apprende, nel segno distensivo della 'pace quantica’, la forza in cui tutte le cose prendono forma: “Dal non essere nasce l’essere, dal silenzio, posto al centro dell’universo, lo scienziato poeta contempla l’enigma dell’esistenza” – egli scrive.
È dunque dal nostro attuale ‘non essere’ che estrapoliamo il nostro essere partecipi del presente? Forse sì, se vogliamo che esista davvero la possibilità (fiducia, aspettativa, desiderio) che un giorno, oltrepassata la soglia dell’esperienza del pensiero immaginativo sull’onda delle emozioni, potremo spingerci all’incontro con l’altro (abitante dello spazio alieno), e abbandonare definitivamente la ‘solitudine cosmica’ in cui finora abbiamo dimorato: “…acciò necessita costituire una sorta di ‘equivalente tecnologico dell’analisi matematica’, scrive V. Tosi in “Il linguaggio delle immagini in movimento” (2006), che ci aiuti ad attuare la trasformazione ‘dal quantitativo al qualitativo’, dall’ ‘analogico al digitale’, nel modo che più recentemente ha celebrato la ‘matematizzazione’ della scienza”.
Ciò che si individua è un approdo alla ‘comunicazione glocal’ (resilienza, slow-living, sostenibilità ambientale ecc.), verosimilmente realizzata in ‘rete’ dallo strapotere delle immagini ‘statiche e/o in movimento’: (carta stampata, cartellonistica, light-art, videogiochi, docu-film ecc.), che se da un lato condiziona in maniera determinante il mondo della comunicazione e dell’informazione, mettendo in seria difficoltà quelli che sono stati finora i processi pacati della ‘differenziazione’ e dell’‘integrazione’; dall’altro, con il moto vorticoso della dinamicità pubblicitaria, (successioni visive, aggressività grafica, affermazione invasiva del linguaggio) si verifica uno stravolgimento delle strategie di mercato preminenti che, in qualche modo, non lascia spazio al processo cognitivo della ‘mente’ (riflessivo), di assorbire l’insieme esorbitante delle notificazioni globalizzate con l’umana velocità intuitiva di apprendimento.
Dacché la percezione di un ‘vuoto conoscitivo’ (paura del nulla), ancora una volta generato – si è detto – dalla mancanza di una ‘governance’ che regoli la consistenza e l’affidabilità della ‘comunicazione scientifica’ sui media, altresì luogo di esplorazione e scoperta della scienza illuminata che la contempla (aeronautica, astronomica, cosmonautica ecc.). Ecco come una ‘convinzione mediatica’ strategica (status manageriale di profitto politico-economico), si trasforma in una ‘assenza totale di convinzione’ nel rapporto conoscitivo con il pensiero ‘astrofisico’ contemporaneo. Nondimeno, nell’immaginario collettivo, la prospettiva di una disciplina siffatta non riesce a stare al passo con le dinamiche più evolute, rilevate dai sistemi avanzati dell’integralismo scientifico (nichilismo?), in ragione del fatto che lo studio del cosmo è priorità della ‘scienza ufficiale’, per lo più riservata alle ‘entourage’ governative e finanziarie private.
Ne consegue che la ‘percezione visiva come attività conoscitiva’ del cosmo da parte della comunità quiescente, è pressoché rivolta verso quel surrogato scientifico più comunemente definito ‘fantascienza’, in cui le galassie sono considerate per lo più provincie dell’esclusiva investigazione letteraria e cinematografica. Ci si sofferma raramente a riflettere sul ruolo strategico dello spazio extra-atmosferico, ma si tratta di una sottovalutazione, ancor più che lo ‘spazio cosmico’ (Cyberspazio) ha assunto oggi un’importanza strategica cruciale, dal momento che la società umana è sempre più dipendente dai segnali che vengono trasmessi attraverso la complessa ‘rete dei satelliti’ che vorticano intorno al globo.
Sappiamo altresì che dallo spazio satellitare fluiscono i dati, le immagini e le informazioni che sorreggono l’impalcatura economico-finanziaria e sociopolitica del mondo, ed anche che esse possono offrire importanti vantaggi negli ambiti più disparati: dalle telecomunicazioni a distanza all’intelligence operativa, dal posizionamento astronomico alla navigazione di precisione, fino al comando e al controllo delle operazioni di difesa riservate all’uso esclusivo degli apparati militari. Anche qui la struttura giuridica che regola l’uso dello spazio entrato nel diritto internazionale è di fatto, ancora fondamentalmente ancorata al “Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti” – ratificato e depositato dall’Assemblea Federale Svizzera nel 1969, in presenza di un’alta rappresentanza di Stati sovrani.
Tuttavia, pur essendo stato dichiarato “patrimonio comune dell’umanità”, il Cyberspazio rimane uno ‘spazio franco’ (aperto, libero ma vago), navighiamo nel campo dell’immateriale, carente di norme specifiche che regolano i rapporti ufficiali tra gli Stati. Ma entriamo qui in un campo ‘altro’ che ha molto interessato il pensiero di H. D. Lasswell, teorico della comunicazione e ricercatore politico americano, membro della Scuola di Sociologia di Chicago, il quale in “Enciclopedia di Scienze Sociali” (1998), sostiene che: “Le democrazie hanno bisogno della propaganda per poter tenere i cittadini disinformati in accordo con ciò che la classe specializzata ha deciso essere nel loro miglior interesse”.
Ciò nonostante, il “Modello Lasswell” va ricordato per la definizione della teoria, ‘suggestionata sembra dalla filosofia freudiana’, apparsa in “Politics: Who Gets What, When, How” (1936), (“chi dice cosa a chi attraverso quale canale con quale effetto”). La cui ‘propaganda mediatica’, invero si sofferma sull’analisi della colonizzazione di altri pianeti e solo in seguito applicata alla politica americana dopo la seconda guerra mondiale, come modello di sviluppo del ‘behaviorismo’, poi divulgato in "Propaganda in the World War” (1927), un approccio sistematico al ‘comportamentismo cognitivo’ afferente alla comprensione del comportamento negli esseri umani e negli animali.
Nondimeno il “Modello Lasswell” fornisce qui – in ispecie all’economia di questa tesi – un più ampio spettro della ‘comunicazione’ preposta a svolgere tre funzioni sociali della massima importanza, relative a: “ sorveglianza”, che offre ai ‘consumatori’ del dei media informazioni su ciò che sta accadendo intorno a loro (attualità); “correlazione”, riferita all'interpretazione e alla spiegazione da parte dei media di specifici eventi (cronaca, avvenimenti ecc.); “trasmissione” allorché i media trasmettono idee sociali e patrimonio culturale (eredità) alle generazioni successive di consumatori. Ciò al solo scopo di analizzare l’impatto e la credibilità che la ‘propaganda mediatica’, a fronte di una strategica ‘comunicazione di massa’ potrebbe avere sulle informazioni diffuse dalla tanto auspicata ‘governance’ di riferimento (imprese, aziende, governi e quant’altro), in cui l'entità comunicante sia intenzionata a influenzare il destinatario attraverso la messaggistica propagandistica, considerata ancor oggi un valido strumento di persuasione.
In termini generali, è quanto constatiamo oggigiorno nella formulata ‘comunicazione liminale’ (soglia di percezione) che possiamo anche definire ‘interstiziale’, cioè che si interpone tra gli elementi cellulari connettivi della comunicazione. Si tratta di un’esperienza ‘between’ (fra/ tra) che di solito si colloca in posizione marginale, o meglio ‘fra’ quegli interstizi della conoscenza, sintomatici e rivelatori, di cui raramente le scienze sociali hanno approfondito la ricerca. Un approccio se vogliamo inconsueto quanto innovativo che, paradossalmente riporta la ricerca sui valori dominanti e su quelli emergenti presenti oggi sui cosiddetti canali ‘social’ in evoluzione.
Ma veniamo alle possibili conseguenze della ‘colonizzazione’ elaborata da Lasswell, dove per ‘altri pianeti’ è ipotizzabile un riferimento più ampio di quello cui ci porta a pensare la nostra mente, bensì vista nella (impropria) ‘accezione’ di mondi possibili, dove il ‘metaverso’ apre alla frontiera del Cyberspazio e alle sue molteplici attività interattive, per offrire agli utenti un'esperienza immersiva in ambiente multidimensionale che combina virtualità e realtà insieme (interattività nei giochi, costruzione e ricostruzione di spazi, recupero dinamico di strutture ecc.). Quanto per l’appunto, accade nelle teorie di ultima generazione, come sostenuto da L. Paccagnella nel suo saggio “Sociologia della comunicazione nell’era digitale” (2020) in cui: “…il Cyberspazio rappresenta un elemento di novità forte e ben congegnato, utile a dare una dimensione più esaustiva a proposito della ‘rete’ in quanto luogo virtuale da vivere.
Mentre il ‘telefono’ e la ‘posta’ di stampo tradizionale permettevano un tempo di avere rapporti e contatti perlopiù tra persone che già si conoscevano, l’utilizzo di Internet permette di ‘conoscere’ una moltitudine di persone nuove. Diventa così possibile frequentare zone particolari della ‘rete’, dall’equivalente virtuale delle antiche ‘agora’, all’odierna piazza, con i suoi bar, i supermercati, e altri luoghi esclusivi, in cui è facilitato l’incontri che più corrisponde agli interessi personali, in fatto di gusto, di punti di vista, ragioni sociali e quant’altro. È forse questa una delle ragioni fondanti per cui il mondo del Web ha avuto così successo e fortuna, visto che forum, blog, social network e chat, consentono di mantenere vecchi legami e crearne di nuovi con persone che vivono e lavorano in luoghi distanti.
Ma il ‘fisico artificiale’ che si nasconde in ognuno di noi, non si è fermato all’apprendimento automatico delle opportunità offerte dal Web, si è spinto ‘oltre’. Viaggiando nel Cyberspazio ha misurato l’evoluzione degli strumenti di ‘comunicazione digitale’ (reti di computer, piattaforme virtuali) in senso marcatamente sociale e comunicativo, in grado di svolgere sia le funzioni normalmente attribuite ai mass-media tradizionali come la posta o il telefono, sia quelle dei mezzi di comunicazione più avanzati. La storia dei mezzi di comunicazione ci insegna che la televisione non ha sostituito la radio, così come l’ipertesto non ha fatto scomparire il libro stampato. Diciamo che si è creata una certa convivenza tra i differenti media, il più delle volte incestuosa e promiscua, ma non c’è stata una vera sostituzione, bensì un affiancamento che ha innescato vigorosi processi di trasformazione e di convergenza come quelli cui assistiamo.
Come anticipato dal sociologo M. McLuhan in “Il Medium è il messaggio” (1968), “…stiamo vivendo una ‘rimediazione’, cioè l’assunzione di un ‘medium’ come contenuto di un altro ‘medium’ applicato alle realtà virtuali odierne. Abbiamo visto come le caratteristiche elencate rendano il confine tra vecchi e nuovi media piuttosto sfumato e incerto. Essendo inoltre passato l’elemento di reale novità, si preferisce più spesso parlare genericamente di media digitali. È innegabile come oggi molti professionisti online siano diventati dei ‘creator’ digitali per continuare a promuovere il grande accrescimento di richieste per i vari ‘tutorial’, i corsi in video e contenuti di vario genere, incluso l’intrattenimento.
Tutto ciò sembra essere in linea a livello tecnologico con il resto d’Europa e con quanto avviene nel resto del mondo, cioè l’utilizzo di materiali audio-visivi con cui possiamo ribadire e sottolineare le nostre passioni e non solo. In prosieguo già si ravvisa l’ascesa dei ‘robot scienziati’ come “machine che pensano da sole, che forniscono assistenza matematica, che si sostituiscono all’operosità dei lavoratori in moltissimi campi di applicazione”. Il tutto volto a irrobustire e delineare le nostre competenze al fine di acquisirne di nuove, onde finora sembra sia valsa la pena l’aver valicata la ‘soglia’ del liminare, pur sempre riaffermando, se ce ne fosse bisogno, come tutto ciò risponde a una caratteristica consolidata e tuttavia ancora realizzabile del nostro vivere quotidiano.
La domanda sorge spontanea: Saremo mai in grado di fare dell’Intelligenza Artificiale una ‘macchina’ umana?
“Un giorno avranno dei segreti, un giorno avranno dei sogni?” – si chiede I. Asimov in “Io Robot” (2004).
“Macchine dotate di intelligenza di livello umano sono ormai all’orizzonte – scrive Christof Koch in “Le Scienze” (2020). Tuttavia, non è ancora chiaro se macchine del genere saranno effettivamente dotate di coscienza. Perché è improbabile che siano in grado di produrre sensazioni coscienti come quelle in assoluto più sofisticate del nostro cervello”.
L’altra opzione è ‘desiderare’ di cambiare mondo, ove ‘sidera’ in astronomia prende luogo di stelle.
*
.jpg) - Sociologia
- Sociologia
’Comunicare il futuro!?’ - gli effetti della comunicazione i
(problematiche e fabbisogni della comunicazione in rete)
Nello specifico, con quanto asserito nell’enunciato in calce, pur aderendo alle molte aspettative di una sterminata platea di utenti in costante crescita (editors, bloggers, divulgatori informatici, navigatori individuali, ecc.), si vogliono qui affrontare alcuni interrogativi che si identificano con la natura stessa della ‘rete’ che avvolge l’intero pianeta dei social network (Web, Internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, Pinterest, ecc.) che, tuttavia, non rispondono alle numerose richieste pervenute da più parti, di dare forma ad una ‘governance istituzionale’ di controllo dei flussi informatici correnti tra l’emissione dei dati e la corretta circolazione dei traffici, nonché la veridicità scientifica delle info immesse e la possibile successiva alterità dei messaggi iniziali:
“Per cui l’illetterato dice allo scrivano cosa voglia dire, lo scrivano scrive cosa intende e cosa gli par meglio debba essere accaduto, il lettore del destinatario interpreta per conto proprio, e il destinatario illetterato a sua volta deforma, indotto a cercare criteri interpretativi nei fatti a sua conoscenza.” (U. Eco)…”
Nonostante il mondo socio-economico-industriale presente sul mercato globalizzato interconnesso sembri operare all’interno di una ‘costituzione autoregolamentata’, in realtà non è così, non risulta a tutt’oggi aver colmato la mancanza di una seria normativa internazionale afferente a misure e consuetudini attuative disciplinate dal mercato stesso. Ancorché accompagnata da interminabili discussioni sul suo futuro sviluppo, considerato dai più come “un attentato alla natura libertaria della rete”, e piuttosto rivolta a “una contrapposta riduzione della sfera privata”, tutte le azioni fin qui svolte non hanno dato risposte concrete di attuazione, per cui “ogni ipotesi di arrivare a formulare regole di contenimento, vengono tutt’ora percepite come un inaccettabile vincolo”.
A questo proposito, scrive S. Rodotà in “Il mondo nella rete” (2014): “Internet, il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto, è così divenuta la nuova dimora della mente”, cui abbiamo affidato l’intero scibile della conoscenza antropica, il nostro passato e il nostro presente, gettando le basi per un futuro sostenibile dell’informatica, improntata alla corretta gestione del sapere ineludibile della scienza in tutte le discipline che la compongono e la sua corrispettiva conduzione in rete, benché ripartita nei due aspetti costitutivi dell’ “informazione” e della “comunicazione”, contemporaneamente all’andamento di quella quotidianità estrinseca che ci permette di ‘guardare’ al nostro pianeta come il migliore dei mondi possibili.
“D’altra parte - scrive ancora S. Rodotà - la progressiva crescita di Internet - vale a dire la sua sempre maggiore rilevanza sociale e politica - ha reso sempre più aggressiva la pretesa di alcuni Stati di far valere le loro antiche prerogative, considerando la rete come l’oggetto del desiderio delle sovranità esistenti. Ma nel mondo sconfinato della rete questa pretesa non ha ragione d’essere, in quanto gli Stati Nazionali (altri) cercano di far valere il potere, tutt’altro che residuale, di cui ancora dispongono, malgrado non possano stabilire una sovranità sul Cyberspazio. […] Questa distinzione tra una sovranità improponibile e un potere invadente mette in discussione una delle conseguenze che si ritenevano implicite nella negazione della sovranità – quella che potrebbe essere sintetizzata nell’affermazione della impossibilità, inutilità, illegittimità di qualsiasi regolazione di Internet. Un’impostazione che non conduce soltanto a una assoluta autoreferenzialità della rete, anzi alla conclusione che la rete non ha bisogno di stabilire relazioni perché essa comprende già tutte le relazioni possibili”.
Si avverte qui la necessità – come si è detto precedentemente – di un ‘diritto inequivocabile’ che getti le basi per un “futuro sostenibile della globalizzazione” improntato sulla corretta comunicazione dei dati e dei riferimenti che la raggiunta dimensione individuata dalle innovazioni tecnologiche, aveva già ampiamente disvelato ed enfatizzato in maniera particolarmente evidente. Vale a dire, di affidare alle tecnologie informatiche il controllo delle reti sociali, con il compito di approntare nuove possibili azioni organizzative in grado di articolare le relazioni sociali collettive, comunitarie e transnazionali, sul modello più ampio della “comunicazione di massa” inteso da M. McLuhan come ‘Villaggio globale’ in “Gli strumenti del comunicare” (1964), onde ridefinire progressivamente l’uso della tecnologia nella redistribuzione del potere.
Quel potere, riservato in passato solo a grandi soggetti della società imperante (partiti, sindacati, chiesa, soggetti multinazionali), caratterizzato da una progressiva centralizzazione, cioè orientato al primario interesse di osservazione e finalizzazione di una visione soggettiva (privata, esclusiva ecc.), che oggi si vorrebbe spersonalizzato,
ristretto, si fa per dire, alla dimensione di villaggio (pubblico-comunitario), quanto mai riduttivo della ‘visione globale’.
Che si tratti di un ossimoro (?), forse. Tuttavia rispondente a una visione che può sembrare una sopravvalutazione del ruolo della rete, ma che in realtà è successiva ad un uso massivo dei social che ha finito per destrutturare (Heidegger, Derrida) la scala valoriale – oramai obsoleta – della ‘comunicazione’ in essere, mettendone in luce i limiti, i vuoti e le discontinuità ideologiche, per aprire la strada a una sorta di ‘ontologia fenomenologica’ del linguaggio interattivo radicalmente rinnovato, strategicamente commisurato all’attuale interpretazione dei codici di autoregolazione della rete globalizzata, onde superare le clausole del ‘giudizio esperienziale’ precostituito e/o preordinato dal ‘sistema’ concettuale delle ‘teorie’ linguistiche preesistenti.
“Lo conferma l’avvento di una maggiore presenza tecnologica nell’informazione – scrive R. Maggiani, poeta e matematico quantistico, che, in “Spazio espanso” (2016) – in cui si vede accrescere una maggiore attenzione verso il fenomeno della comunicazione nel suo insieme e nella diversità delle sue applicazioni. In molti casi, alla conoscenza precostituita, definita ‘concettuale’ (radio, carta stampata, libro cartaceo, ecc.), si è andata sostituendo una nuova gamma di ‘linguaggi visivi’ (Visual Language, Visual Art ecc.), che hanno dato avvio a unità di riferimento più avanzate (Android, i-Pad ecc.) e che, in breve, stanno soppiantando tutta la conoscenza tradizionale”.
Sia delle prerogative che in passato erano state delle proposte socio-storico-linguistiche, quanto formative-educazionali di riferimento; sia inclusive di quei ‘linguaggi non verbali’ diversificati (gestualità corporea, tattoo, graffiti rupestri, geroglifici, sabbie colorate, ecc.), che delle forme di oralità (dal canto alla danza, dalla poesia alla narrativa). Sia dell’attuale scienza matematica (quantistica), che delle nuove tecnologie della ‘conoscenza’ (evolutiva) a cui tendono i più recenti linguaggi interpretativi dell’informazione che della comunicazione: “Fin dove la ‘ricerca’ applicata alla quantistica si avvale di formule algebriche, espressioni conformi, estrinsecazioni, come forme ‘altre’ di un linguaggio collettivo (nuovo archetipo) che diventa comunicazione divulgativa nel momento in cui ingloba e trasferisce quelli che sono i simboli della trasformazione in atto”.
Scrive ancora R. Maggiani: “La divisione tra mondo quantistico e mondo classico pur non sembrando essenziale, si rivela solo una questione di creatività sperimentale in-progress. Il tempo emerge dall’entanglement quantistico attraverso il processo di de-coerenza, ciò che nel vuoto quantistico oscilla a un passo dal reale. Se misurare con precisione aumenta un’incertezza, allora il mondo galleggia su un mare di probabilità, in quanto si propone come nuova forma geroglifica che va decifrata come possibile ‘archeologia’ che abbraccia ‘simboli’ e ‘fonemi’ in movimento, come note vaganti del loro divenire musica”. Per meglio dire che, nell’affrontare questa nuova sfida non sembri come avere davanti una scienza misteriosa fine a se stessa, che invece è frutto di una profonda ricerca scientifica che ha i suoi utilizzi in molte applicazioni nella didattica e nella divulgazione futura.
“Tra le possibili combinazioni del reale avverrà mai quella che in un attimo mostra l’idea risolutiva, la combinazione perfetta e discriminante rispetto a tutte quelle maggioritarie?” – ci si chiede di quel che più verosimilmente dev’essere stato il linguaggio parlato prima del suo divenire scrittura, cioè, ancor prima che l’archeologo J.F. Champollion mettesse insieme le ‘tecniche’, del tutto sconosciute, che lo portarono a decifrare la famosa ‘Stele di Rosetta’, con la quale si aprì una delle più importanti e fantastiche avventure della conoscenza umana. Sebbene i passaggi di una scoperta siffatta, sono oggi facilmente reperibili attraverso lo studio corrente della ‘linguistica’, la disciplina che per lungo tempo ha interrogato l’uso dell’‘orale’ fra le compagini umane, fonte di trasmissione attendibile che si serve delle parole (emissioni vocali diversificate), per carpire l’interesse di chi ascolta attraverso il (solo) senso dell’udito.
Dacché si denota lo scivolare in altre discipline che solo apparentemente sembrano disgiunte, per quanto una maggiore diffusione della ‘comunicazione interculturale’ le ha rese sorprendentemente connaturali. Come ad esempio quella sulla propagazione acustica: (studio dei suoni e dei rumori in versione stereo-mono e/o in quella della computazione digitale prodotta da fibre ottiche luminose) che, pur in ambiti diversi, stanno dando importanti risposte nelle applicazioni come la fisica, la medicina ecc., così come nelle telecomunicazioni (audiovisivi, messaggi in codice, traduzioni simultanee ecc.), correlative di una tecnologia avanzata che oggi permette di usufruire dell’‘alta velocità’, sia nella ‘trasmissione dati’ che nella navigazione in rete.
In particolare si è constatato che, facendo alcune comparazioni dei segnali linguistici (messaggi scritti e/o verbali) con altri suoni (segnali morfologici), si arriva alla forma ‘semantica’ allo stesso modo delle relazioni tra scienza del significato e lo sviluppo delle parole significanti; il cui studio, nella sua accezione corretta (degli effetti più o meno desiderati negli esseri umani), dà maggiore valenza al ‘comunicare’, in quanto convoglia in esso ‘un maggiore coinvolgimento di senso’. È così che, ad esempio, per ottenere una risposta adeguata, è necessario formulare in maniera corretta una debita domanda. Allo stesso modo che si palesa nel linguaggio attuale in uso sui ‘social’, un impiego diverso dello strumento della ‘semantica’, sì che varrebbe la pena riflettere sulla rivoluzione che ciò sta apportando nella ‘scrittura’ e nell’uso decurtato della ‘lingua’, così come nelle ‘comunicazioni’ in particolare e a quelle di massa più in generale”.
S. Rodotà nel suo “Il terribile diritto” (1981), mette sull’avviso che nel chiedere un ‘codice convenzionale’ che regoli la compilazione del messaggio veicolato attraverso il network WWW - World Wide Web e dai computer collegati, principio sul quale si basa questo tipo di allacciamento attraverso il mondo intero per l’appunto: “questo può essere letto a vari livelli interpretativi, specialmente alla luce dei rapporti interpersonali fra comunicatore e destinatario che sempre più spesso si trovano ad operare sulle piattaforme social, soggette talvolta ad interferenze (false info, fake-news, pubblicità ingannevole ecc.). È indubbio che la fallacia di una comunicazione diminuisce se si usano molteplici canali di informazione, leggendo e capendo il linguaggio utilizzato nella formulazione del messaggio perché scritto con parole difficili e/o visivamente artato e dalla provenienza dubitativa”.
Ma se le problematiche della comunicazione in rete non sono sempre individuabili e ancor meno superabili, la ‘globalizzazione’ in atto ha rivelato quali sono i fabbisogni per un suo futuro ‘sviluppo sostenibile’, non in ultimo quello di usare tutti i mezzi che il progresso tecnologico mette a disposizione. “La pervasività sulle reti sociali – scrive ancora S. Rodotà in “Privacy e Libertà” (2005 – attribuisce una dimensione nuova al rapporto tra democrazia (libertà di utilizzo, cittadinanza digitale), e diritti (diritto all’oblio, alla cancellazione dei dati personali), che rivela più che mai il bisogno di una tutela dell’anonimato e della neutralità; diritto alla riservatezza del singolo individuo di non essere fatto oggetto di pressioni, condizionamenti o limitazioni di sorta, e la garanzia di ‘non-dominio’ da parte delle ‘major’ che ne gestiscono il dominio”.
Altro aspetto molto avvertito sui blog, ad esempio, S. Rodotà insiste sulla rivendicazione del ‘diritto alla privacy’ fortemente legato al ‘diritto alla libertà’ come premessa necessaria per poter avvenire alle scelte sia individuali che collettive, di “…iscriversi a un partito politico, a un sindacato, frequentare una chiesa, adottare lo stile di vita e manifestare preferenze culturali senza che incorrere nel rischio di discriminazione o stigmatizzazione sociali, negando l’eguaglianza di cittadino in tutto identico agli altri, che si sia omosessuali, rifugiati politici, fedeli a un credo religioso, malati di Aids ecc., in quanto vi è un nucleo duro della sfera privata che deve essere rispettato”, in ottemperanza con quanto affermato dal sociologo per eccellenza Z. Bauman in “L’arte della vita” (2008): “La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no”, a cui mi piace aggiungere ‘che ci piaccia o no’.
Nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, accettata a livello internazionale, il ‘diritto alla privacy’ (data protection), occupa un posto ragguardevole nel sottolineare che non si tratta soltanto di restare chiusi nel proprio mondo privato, al riparo da occhi indiscreti, ma anche di potersi proiettare liberamente nel mondo attraverso le proprie informazioni, mantenendo però sempre il controllo sul mondo in cui queste circolano e vengono utilizzate da altri. Acciò bisogna piuttosto domandarsi quali sforzi facciano quei detentori della comunicazione della carta stampata (copywriter, redattori e giornalisti che ne fanno parte) e la controparte (autori e compilatori di una qualsiasi relazione scientifica), per essere compresi e stimolare la comprensione del ‘messaggio’ con un linguaggio più appropriato alla massa dei lettori.
Se oggi è difficoltoso interessare gli altri su certe argomentazioni, sarà sempre più difficile avvicinarli se non sapremo invogliarli a comprendere chi siamo, perché li stiamo intrattenendo, che cosa vogliamo da loro. Va qui ricordato che l’assenza di una diffusa sensibilità morale (deontologica) è ciò che fa crescere l’esigenza di un’etica più che mai legata ai nuovi linguaggi dell’informazione e della comunicazione. “Per sua natura, si è detto – scrive U. Eco in “Tra menzogna e ironia” (1998) – il lettore destinatario del messaggio, interpreta per conto proprio e sua volta deforma, indotto a cercare criteri interpretativi nei fatti di sua conoscenza. È una rappresentazione, efficacissima, di come per successive interpretazioni il messaggio venga decostruito e condotto a esprimere non solo ciò che l’emittente originale non voleva dire, ma forse anche quello che nel messaggio, come manifestazione lineare di un testo, commisurato a un codice, non dovrebbe forse dire”.
Quello che sembrerebbe un vademecum semplice ed essenziale per affrontare le sfide della società e della vita comunitaria che oggi strangola le economie nazionali con il cercare di sfruttare al massimo il potenziale creativo ed economico, come è pressoché detto: "Per offrire soluzioni ai problemi globali di oggi e migliorare domani la vita di tutti noi". Ma la crescita inarrestabile delle grandi metropoli, influenza e condiziona le nostre scelte di vita, sociali, comunitarie e globalizzate, trasformando le necessità in interminabili ‘blog’ sul futuro, in cui si tenta di spiegare a quanti, e sono moltissimi, pensano e scrivono come si possono trovare soluzioni ai problemi globali che noi stessi abbiamo creato (energetici, alimentari, economici ecc.). Anche se non si comprende con quali risorse potremo mai affrontarle, poiché “…l'umanità (tutta) si muove lungo una linea di confine tra l'anarchia della scelta e il mondo alla Disneyland”, scrive Christof Koch in “Il futuro delle Città” - Le Scienze: (2011).
Ma come ha lasciato scritto T. S. Eliot in “Four Quartets” (1943):
“Non finiremo mai di cercare
E la fine della nostra ricerca
Sarà l'arrivare al punto da cui siamo partiti
E il conoscere quel luogo per la prima volta.”
*
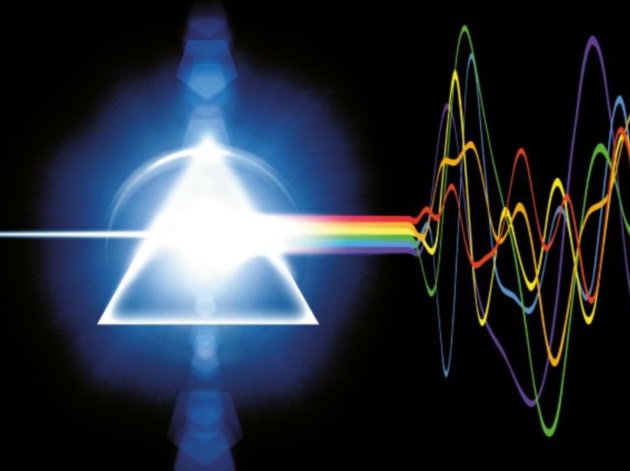 - Sociologia
- Sociologia
Comunicare il futuro!? - ricerca sociologica 3
Comunicare il Futuro!?
- Investigazione e cooperazione nella comunicazione:
(l’organizzazione, gli strumenti e le tecniche)
La società globalizzata, caratterizzata com’è dal forte sviluppo delle nuove forme di aggregazione, si trova qui – pur nello spazio esiguo di questa tesi – ad occupare un posto di rilievo per le sue peculiarità sociali e culturali, proprie di un passato rivolto alla carta stampata che, in forma di libri, quotidiani, magazine, (forma scritta), si rivolgeva a un numero esiguo di popolazione. Ma è attraverso la Radio e la TV (forma dicta e visiva) che, successivamente, ha potuto espandere la sua diffusione alla portata di tutti, facendo quel salto di qualità che infine ha permesso di raggiungere quella visione amplificata dell’uso dell’“informazione” e della “comunicazione” che ci coinvolge tutti. Quella stessa società che si ritrova a utilizzare simultaneamente, inoltre a quegli stessi strumenti, le ultime tecnologie digitali a disposizione come: meta piattaforme, computer, cellulari, iPad, tablet, mezzi televisivi e radiofonici, emissioni satellitari e quant’altro, che hanno dischiuso (spalancato) ulteriori spazi di intervento alla ‘pubblica utilità’ e, contemporaneamente, in grado di mobilitare milioni di persone in ogni parte del mondo.
Ma in quello che potrebbe sembrare uno scontro tra fazioni, fra ‘detentori della conoscenza acquisita’ e ‘virtuali abitatori del cyberspazio’, si riscontra una certa equivalenza positiva di valori e meriti a sostegno di un ‘work in progress’ di un pubblico (utenza, consumatori) sempre più addentro alla ‘comunicazione’, sia nel trasferire ‘informazioni’ che nella ‘diffusione’ delle nuove tecnologie tra/fra le diverse piattaforme digitali; sia nel recepire e comprendere una moltitudine di ‘messaggi virtuali’, che stanno invadendo tutti i campi formativi ed educativi. Dando così luogo a un certo numero di problematiche fin qui inusuale, sia sul piano dell’utilità (temporanea) che su quello dell’efficacia (definita, stabile), in termini di ‘attendibilità’ nella comunicazione e ‘credibilità’ nell’informazione, in quanto surrogati delle forme di aggregazione più consuete, (movimenti, partiti politici, sindacati di riferimento, organizzazioni associative), che non riescono a trovare politiche economiche condivise.
Non in ultimo il problema inclusivo della strabordante affermazione pubblicitaria in tutta la sua multiforme varietà di applicazioni, (statica e tabellare, luminosa, in movimento ecc.) utilizzata per promuove prodotti di largo consumo e/o determinati ‘eventi’ che hanno una forte attrattiva sul pubblico, come mostre d’arte, spettacoli musicali e teatrali, sfilate di moda, avvenimenti sportivi, viaggi e turismo, ecc. che, all’occorrenza vengono offerti a milioni di consumatori, a loro volta suddivisi in differenti fasce di utenza, cui una distinta forma di ‘comunicazione’ si rivolge. Come, ad esempio, una maggiore offerta in fatto di prestazioni nei servizi pubblici, inoltre che a favorire la produzione e l’acquisto di vari beni di consumo, (mobili, immobili, auto, apparecchiature ed altri benefit), che ampliano le possibilità di innovazione di idee e favoriscono una maggiore occupazione al lavoro del capitale umano.
Si comprende pertanto come la gamma degli ‘strumenti di relazione’, peculiare della ‘comunicazione integrata’, sia tanto più ampia quanto è più esteso il campo di chi comunica (sponsor nazionali e transnazionali, provider finanziari, ecc.) che ripongono il loro interesse nel fare arrivare il proprio messaggio ‘in tempo reale’ alla più vasta utenza di consumatori, ma ed anche una più ampia conoscenza nella gestione tecnologica del futuro. Nonché l’efficacia del supporto tecnologico come opportunità a livello strategico, con altre forme di contatto (individuale e/o collettivo), derivata dall’attività coordinata dalla ‘ricerca di mercato’ (Marketing-mix); indipendentemente se indirizzata ad una fascia selezionata di servizi di qualche utilità pubblica, oppure di formalizzare un livello apprezzabile di utenza socialmente distinguibile nel suo insieme, efficace ed efficiente.
Di fatto con ‘comunicazione integrata’ si vuole qui intendere una sorta di ‘unicità nei comportamenti complessi e articolati’ che richiedono unitarietà dimostrativa verso l’informazione propedeutica alla cooperazione e alla collaborazione di quanti operano all’interno di essa: (enti pubblici, imprenditori aziendali, manager e appaltatori, impresari, ecc.), disponibili all’innovazione e al miglioramento di nuovi sistemi organizzativi, (nella scuola, nella sanità, nelle istituzioni più in generale, ecc.), affinché le molteplici iniziative messe in campo, trovino nella partecipazione, un’attiva quanto più necessaria corresponsabilità di consenso.
Va detto, che a una diversità organizzativa ‘globalizzata’ – scrive L. D’Abramo in “Mass-media e comunicazione” (2008), non può che corrispondere una ‘comunicazione’ sempre più interculturale, in ragione del fatto che deve necessariamente confrontarsi con la diversità formativa dei popoli e delle diverse culture educative: “Recenti studi hanno rilevato che tutte le culture devono confrontarsi con una serie di problematiche legate all’esistenza dell’uomo e al suo rapporto con la natura (proprio habitat), si trovano esempi di questi orientamenti sia nelle culture nazionali, sia in quelle proprie dei diversi gruppi etnici”, distribuiti su tutto il territorio geografico e raggiunti dalla ‘comunicazione satellitare’.
Spettano invero alla ‘comunicazione interculturale’ ruoli non secondari a supporto di una continua ridefinizione del proprio campo d’azione da parte delle organizzazioni, sia per favorire l’innovazione e il cambiamento nei diversi settori della gestione delle risorse, che nel rafforzamento dei percorsi trasversali, necessari ai ‘processi organizzativi’; sia per una maggiore integrazione della comunicazione interna verso l’esterno, che viceversa, a supporto della quale si è predisposta una rinnovata terminologia linguistica, largamente accettata, come base per lo scambio reciproco delle informazioni scientifiche e non solo; vieppiù ampiamente improntata a sostegno della cooperazione unificata (partnership), e della gestione delle risorse rinnovabili, a fronte di un futuro della ‘comunicazione’ più estesa e più sostenibile.
Nondimeno, inoltre a parlare di diversità organizzative in ambito sociale (ONLUS, ONG ecc.), vanno qui elencati anche quegli ‘orientamenti valoriali’ (patterns variable), che il fautore del ‘funzionalismo strutturale’ T. Parsons ha classificato esaustivamente, in “Il sistema sociale” (1965); cioè di quelle che comunemente chiamiamo ‘relazioni sociali di riferimento’ con “la gestione delle espressioni e delle emozioni, nell’interiorizzazione del modello sociale”. Un’alternativa di orientamento (e d’azione) in grado di aumentare la capacità di risposte adeguate alle preferenze date dalle esperienze in fase di costante cambiamento: “da ricercare nelle linee guida della ‘comunicazione interdisciplinare’, mirata a trarre vantaggi competitivi proprio dalle diversità (problem solving), che danno forma, attraverso un più ampio spettro di prospettiva di analisi, al processo cognitivo decisionale (decision making)”.
Un processo prioritario questo che, nel restituire fiducia a quanti operano nel settore (addetti, operatori, businessman), si rivolge alle aziende attive nei diversi settori industriali e a quei mercati (merceologici e non solo), che si misurano con le sfide del futuro, cui la “comunicazione interculturale” può dare un risvolto, economicamente valido, allo sviluppo dei rapporti interpersonali. Approfondire questo aspetto si è rivelato determinante nella riorganizzazione di diversi settori (aziendali, industriali, turistici, ecc.), con l’aver restituito ad essi quella vitalità ‘emozionale’ di cui avevano bisogno, come, ad esempio, negli scambi delle esperienze (utilità), alla partecipazione (consigli, istruzioni per l’uso, insegnamento), oltre a risvegliare la curiosità degli individui preposti, ossia il desiderio di sapere, di conoscere, come arricchimento del progresso sociale.
La ‘comunicazione’ dunque, come leva principale per lo sviluppo istituzionale (economico, sociale, professionale e culturale) d’ogni singolo paese e della comunità mondiale intera, con l’obiettivo di avviare un dialogo fattivo ‘in rete’ tra la folta community dirigenziale-imprenditoriale, tra:. top-manager, comunicatori, opinion leader, decision maker ed operatori delle strategie di mercato ecc., afferenti alle istituzioni, all’economia e al mondo dell’informazione sparsi per il mondo, al fine di elaborare, attraverso il confronto, incontri, convegni, workshop e quant’altro, onde ispirare iniziative socio-culturali e professionali nell’ambito di una imprenditoria sempre più eco-sostenibile.
Ma se l’adozione di specifiche applicazioni tecnologiche nella comunicazione intraorganizzativa ‘in rete’, in quanto frutto di un avanzato progetto che risponde a particolari esigenze organizzative tecnico-economiche, si presta ad una serena analisi sulla possibile convivenza tra specializzazione e integrazione nell’odierna organizzazione del lavoro imprenditoriale; ancor più la scelta di entrare nella ‘rete telematica’ diventa strategica, in quanto consente una più decisa penetrazione sul mercato (Internet), inoltre ad accrescere l’integrazione intraziendale (Intranet) e interaziendale (Extranet) tra le parti, quanto più offre la possibilità di estendere all’indotto quelle implicazioni informatiche che sono di supporto alle decisioni manageriali e alla formazione di tecnici specializzati in ogni ambito lavorativo; non in ultimo, di sviluppare la collaborazione e la cooperazione (groupware) tra i diversi settori dell’imprenditoria.
L’utilizzo di Intranet, ad esempio, permette agli appartenenti a una stessa organizzazione, l’integrazione con un ambiente più fattivo del lavoro, di conoscere, informare e interagire ‘in tempo reale’ con l’apparato manageriale addetto alla gestione del personale (house-organ, scambio di mail e newsletter, ecc.); nonché di migliorare i servizi rivolti agli utenti individuali (forza lavoro interna ed esterna); così come di ampliare le possibilità di collaborazione e lo scambio di conoscenze reciproche. Malgrado ‘entrare in rete’ comporti per un’azienda un ulteriore impegno economico e costi iniziali aggiuntivi, dovuti alla riorganizzazione e all’apprendimento del nuovo mezzo di comunicazione e di gestione delle rinnovate tecnologie acquisite, va considerato che ciò, nel medio-lungo termine, viene assorbito portando una maggiorazione dei benefici (benefit, welfare ecc.) da entrambe le parti interagenti.
“La ‘rete’ – suggerisce F. Maimone, professore di Marketing & Digital , nel suo “Dalla rete al silos” (2010), è il modello ideale cui le nuove organizzazioni dovrebbero tendere, per la rilevanza strategica nel management delle persone, delle relazioni, del capitale di conoscenza e, non in ultimo, per il successo delle nuove forme organizzative aziendali”, in quanto si offre possibilità di “innovazione, competitività, pro attività, che sono le “tre competenze distintive” dell’organizzazione imprenditoriale al tempo della globalizzazione. La base tecnologica degli algoritmi in cui prende forma la ‘rete’ (WWW) costituisce quindi la piattaforma virtuale su cui costruire i ‘linguaggi’ necessari al trasferimento del sapere formale in ogni organizzazione che guardi alla programmazione della produzione (manodopera) e all’uso della conoscenza (esperienziale) tra imprese che operano nello stesso ambito di lavoro, fondamentali nella condivisione di un sapere codificato.
Non di meno, permette all’azienda e/o all’impresa una forte riduzione dei costi nelle operazioni di ‘marketing commerciale’, oltremodo necessario per la condivisione della comunicazione e la cooperazione con altri enti e altri mercati. Infatti, grazie all’uso di Internet, i costi di ricerca delle informazioni e la scambio colloquiale (corrente e informale), si riduce in quanto procede attraverso uno strumento assai potente in grado di monitorare il proprio mercato sulla base della concorrenza e sul mercato globale. Inoltre, permette di ridurre i costi d’intermediazione eliminando alcuni passaggi interposti nella catena di distribuzione e/o di vendita (prodotti, servizi ecc.), come a fornire maggiore sicurezza nelle transazioni e nei pagamenti on-line operando più liberamente a livello nazionale che internazionale, senza dover stabilire interminabili e costose clausole contrattuali associate alle rispettive opportunità.
Con l’approdo all’Intelligenza Artificiale (I.A.), cui si è giunti grazie alle tecniche di programmazione integrata tra informatica e telecomunicazioni, siamo ‘di colpo’ proiettati “…al largo dei bastioni di Orione”, come è appunto detto nel monologo conclusivo di “Blade Runner” (1982), il film diretto da Ridley Scott, andiamo incontro allo spostamento della curva esponenziale dall’obiettivo ‘umano’ (influenza culturale), verso quello tecnologico del piano fisico (scientifico) rigorosamente matematico, a quello esclusivamente cognitivo della ‘fantascienza’, da non considerarsi più come un’astrazione della mente (passione), che pure in qualche modo sta cambiando il modo di concepire l’organizzazione sociale fin qui accertata, sia all’interno delle reti locali e/o private che all’esterno dalle reti geografiche extranazionali.
Lo sconvolgimento virtuale cui assistiamo con I.A. pertanto, è indicativo che qualcosa sta cambiando, che il prodotto accumulato di tutto il sistema informativo del sapere (comunicazione, linguaggio, messaggio) va ridefinito sull’esperienza del nuovo. Ciò che fin qui permetteva di ridurre la distanza, ad esempio, fra l’ ‘autore’ di un documento (non più idea, sviluppo, messaggio), e l’ ‘utente’ (lettore, ricettore, usufruente), sarà inevitabilmente multimediale e multidimensionale, fornirà principalmente un insieme di nuove ‘connessioni’ in fatto di collegamenti e nuove ‘relazioni’ a supporto dell’informazione, favorendo diversi gradi di libertà alla ‘comunicazione’ direttamente sul piano (desktop, lavagna luminosa, video olistico ecc.) dell’utente finale.
“Esiste uno spazio residuo per pensare a un possibile oltre?”, si chiede avvedutamente S. Mati nella riflessione critica a “Soglie: l’esperienza del pensiero” (2011) di F. Rella, per poi rispondere un secco ‘sì’, deciso e ultimo, quand’ecco che la volontà (di ricercatrice), mette in gioco lo spirito della sua avventura informatica e si appropria della sostanza creativa: “…la vita nell’apparenza come scopo, l’arte come unica attività metafisica dell’esistenza, la creazione che decide della verità, il mondo vero (reale) che diventa ambito leggibile del nostro futuro”.
(continua)
*
 - Sociologia
- Sociologia
Comunicare il futuro!? - ricerca sociologica / 2
1 - Un fenomeno sociale in costante evoluzione:
(informazione e comunicazione nell’occhio dei mass-media).
“L’eccessiva quantità di informazioni può essere paragonata alla sua totale assenza.”
L’affermazione alquanto emblematica è del teorico della comunicazione M. McLuhan apparsa in “Il medium è il messaggio” (1967), con la quale esprime una sua osservazione sull’influenza esercitata dai mass-media nella società a lui contemporanea. Quanto più valida oggi che la ricchezza delle informazioni (newspapers, magazine, agenzie di stampa ecc.); la varietà degli strumenti di comunicazione (radio, TV, social network, newsgroup, talk-show ecc.); gli innumerevoli dispositivi informatici (personal computer, installazioni multimediali, common, internet ecc.), se da un certo punto di vista rappresentano una piattaforma di scelte possibili (banche dati); dall’altro aumentano la problematicità di “accesso e dominio dello spazio virtuale” di competenza specifica dell’utenza che ne usufruisce.
Insieme indecidibile di una ‘visione ipotetica’ generalizzata, la ‘mente informatica’, in quanto non lascia spazio a un confronto adeguato alla velocità mimetizzante dell’intelligenza umana, assume sempre più spesso sembianza di “…complessità virtualmente filtrata del reale, in cui le interrogazioni si dispongono come la domanda le prevede e le sollecita ad essere”, scrive U. Galimberti in “I miti del nostro tempo” (2012), cioè sovrastata e destrutturata dalla sua stessa essenza. Dacché sorge la necessità di un ‘modello etico’ (protocollo) che regoli l’informazione, di pari passo alla comunicazione, per un uso più appropriato consono alle esigenze della massa utente.
Il problema, poiché di problema si tratta, è di tipo antropologico-conservativo, rispondente a quella stabilità organica psichico-fisiologica progressiva, cercata, raggiunta e accresciuta dal ‘consenso di omologazione’ (riconoscimento globalizzante) in atto, che trova fondamento nelle capacità umane di ‘intendere’ e di ‘volere’, per quanto queste vengano eluse dall’invasione spasmodica (inquietante) della tecnologia informatica. Ciò che, al tempo, rispecchia quanto affermato da J. Baudrillard autore di alcune riflessioni provocatorie sulla globalizzazione, apparse in “Società, politica e comunicazione” (2010): “Alla fine del processo (di integrazione) non si ha più la differenza tra il globale e l’universale scala dei valori. […] Anche l’universale viene globalizzato, la democrazia e i diritti dell’uomo circolano esattamente come qualsiasi prodotto globale, come il petrolio o come i capitali”. Affermazione con la quale si evidenzia il rischio di una latente inerzia di massa che i media dell’informazione e della comunicazione capitalizzano come ‘dominio precostituito’ all’interno della sfera pubblica.
Considerato il fatto che nella società tecnologica “informare” significa in primo luogo “comunicare”, oggetto di questa ricerca, di per sé non lascia spazio a dubbi o a recriminazioni di sorta sulla validità dello strumento utilizzato, in quanto il fine ultimo rimane l’utenza, ‘forza e sostanza virtuale dei mass-media’, indicativa di tutto quanto ad essa si rivolge; ancor più s’avverte la necessità di una maggiore ‘presa di coscienza intellettuale’ che corrisponda all’ “etica deontologica professionale” degli operatori del settore (giornalisti, pubblicitari, marketing-makers, producer ecc.), sia dell’informazione più in generale, sia della comunicazione privata (manageriale, aziendale, corporativa, ecc.), stante la pluralità di significati e campi di applicazione.
A tale scopo I. Montanelli, da quel comunicatore professionale che lo distingue, ha avallato una sua indubitabile persuasione, apparsa in “Il dover essere giornalista oggi” (1989), in cui riferisce le ragioni di una ‘deontologia necessaria’ che, pur non evitando gli errori che fanno parte del proprio lavoro, determina la validità della sua affermazione: “La deontologia professionale sta racchiusa in gran parte, se non per intero, in questa semplice e difficile parola: ‘onestà’, […] per cui si differenzia dall’etica perché accanto all’affermazione di principi affianca sanzioni per le eventuali violazioni. […] Ciò, per quanto gli onesti siano refrattari alle opinioni di schieramento – che prescindono da ogni valutazione personale – sia alle pressioni autorevoli che alle mobilitazioni ideologiche.”
Ma se l’assenza di una diffusa sensibilità morale, fa sorgere l’esigenza di una disciplina “Etica della Comunicazione” – come in effetti è richiesto dallo Statuto dell’Ordine dei Giornalisti – il format ‘Internet’, utilizzato, copre di fatto l’avvenuta globalizzazione in entrambi i settori dell’informazione e della comunicazione in generale, contribuendo a determinare (snaturandoli) quelli che sono i rapporti di potere (governi, banche, multinazionali), mai come oggi esigiti dalle politiche governative (sociali), dall’economia dominante (finanze) e dal mercato degli affari. Seppure – a mio parere – viaggia in netto contrasto con l’attuale manipolazione speculativa che se ne fa nel linguaggio quotidiano sui media.
Come quella, ad esempio, di monopolizzare la ‘comunicazione’ a un approccio surrettizio sia nella divulgazione dell’informazione pubblica, sia nelle forme della pubblicità falsamente differenziata, così come nell’uso smisurato della propaganda politica in fatto di ‘ambiente’ (eco-sostenibilità, bio-diversità ecc.). Valga per tutte, l’assistere incondizionato dello stravolgimento della terra, con cui, è bene ricordarlo, da sempre abbiamo instaurato un rapporto conflittuale (smottamento di montagne, deviazione di corsi fluviali, cancellazione di territori agricoli, boschivi ecc.), che ha segnato irreparabilmente il decorso degli equilibri ambientali naturali. Se ne constatano gli effetti nell’accadimento gravoso delle continue frane sismiche in molte aree geografiche del nostro paese e in quelle più recenti dell’area mediorientale, che richiedono l’intervento unito dei governi per soccorrere quanti sopravvissuti alle catastrofi.
Così come è accaduto in occasione della pandemia mondiale che ha colto le popolazioni impreparate ad affrontarla, e che ha richiesto alla scienza di misurarsi in una corsa folle, seppure coadiuvata da forti investimenti economici, a trovare soluzioni di tamponamento onde evitare una calamità progressiva di cui ancora non si conoscono gli effetti ultimi. Problematiche, queste, che si sommano alla caduta demografica (quantomeno prevedibile), causata dall’invecchiamento della popolazione che ha provocato un mancato incremento delle nascite. In aggiunta agli effetti della più grande emigrazione (pari solo a quella biblica) mai vista finora, di cui siamo prontamente aggiornati con reportage e immagini ‘in diretta’ e ‘on line’, anche grazie alle più recenti tecnologie satellitari messe al servizio della ‘comunicazione globalizzata’.
Tuttavia, superato lo scoglio delle criticità evidenziate, la ‘divulgazione informatica’ ha assunto importanza strategica nell’intero comparto dei sistemi informatici; così la ‘navigazione’ in Internet, unitamente alla quantità e alla velocità di diffusione ‘in tempo reale’ (email, posta elettronica, forum e community, siti e blog personalizzati ecc.), ha permesso, inoltre, di ottenere informazioni onnicomprensive un tempo inaccessibili, che hanno accelerato gli scambi interpersonali, favorito le politiche di cooperazione economica e sociale, procurato e convogliato risorse per la ricerca scientifica e la sostenibilità ambientale. Altresì di modificare e indirizzare significativamente le problematiche della solidarietà alle esigenze dello sviluppo sociale e, non in ultimo, la possibilità di attivare modelli economici di pianificazione degli interventi nazionali e sopranazionali delle politiche comunitarie; consentire l’interazione fra le strutture socio economiche degli stati globalizzati in fatto di politica estera, e la condivisione di soluzioni problematiche come – unico esempio – la conservazione delle specie viventi, umani compresi.
Tutto ciò richiede un’approfondita riflessione critica e quanto meno dubitativa sull’impatto provocato dalle nuove tecnologie sull’ “eco-sistema” dei gruppi sociali che, in quanto esseri umani, sono soggetti emotivi e quindi suggestionabili dagli eventi, di quanto accade inaspettato nella propria esistenza, piuttosto pronti a somatizzare psicologicamente in senso contrastante l’effettiva portata della tecnologia espansiva. Allo stesso modo rendendosi incapaci di elaborare nell’immediato risposte di prevedibilità fattiva che necessitano di un margine di tempo più dilatato. La difensiva contro il ‘nuovo che avanza’ vede in primo piano la difesa della ‘sopravvivenza’, ciò che pur rende l’umanità attiva e aliena nel soccombere alle incertezze della vita.
Come insegna Z. Bauman, il sociologo per eccellenza dei nostri tempi, in “La società dell’incertezza” (1999): “Se la società moderna esiste è perché ha ragione di esistere in logica della sua incessante attività d’individualizzazione, […] così come le attività degli individui consistono nella quotidiana (costante) riformulazione e rinegoziazione della rete degli obblighi reciproci. […] La società degli individui plasma l’individualità dei suoi membri e di quanti ne fanno parte, che danno forma alla società tramite le loro azioni vitali e il perseguimento di strategie plausibili e fattibili all’interno della rete socialmente costruita della loro dipendenza”.
Tale quindi la forza della ‘comunicazione’ sì da fare da tramite fra un’utenza sempre più attenta e la tecnologia più che mai innovativa, per quanto sia legata a un’indubbia ‘realtà sociale’ subalterna nella quale, abbandonati gli eventi e gli accadimenti che accompagnano il nostro vivere quotidiano, in effetti ci conduciamo. Tuttavia non trovo nulla di sconcertante, né di catastrofico nelle parole del grande sociologo, semmai una sorta di subalternità cosciente in contrapposizione con quanto in ‘realtà’ fluidifica nel nostro cosiddetto ‘libero arbitrio’, cui attribuiamo le nostre (dubitabili) scelte e/o la nostra (incerta) volontà individuale. Di fatto la metafora della ‘liquidità’ di tutto quanto concerne il vivere quotidiano coniata da Z. Bauman, ha verosimilmente marcato i nostri anni, entrando nel linguaggio comune per descrivere l’incertezza della società in cui viviamo. Tale anche, l’indagine conclusiva di “Modernità liquida” (2019), in cui l’autore mette l’accento sul ‘male oscuro’ che grava sulle future generazioni:
“Individualizzata, privatizzata, incerta, flessibile, vulnerabile, nella quale a una libertà senza precedenti fanno da contraltare una ‘gioia’ ambigua e un ‘desiderio’ impossibile da saziare”.
Desiderio che ha determinato “…una svolta apparentemente sconcertante d’una presunta ‘immortalità’ cui noi tutti tendiamo”; cioè la volontà all’autoaffermazione individuale, all’interno di una società resa ormai fluida, tendente ad uno ‘stile di vita’ che vorremmo più confacente al nostro tempo. E non solo, ma ed anche, propositiva di una ricercata solidarietà, nel rispetto di quella libertà che a volte pur ci distingue in quanto esseri umani, soprattutto quando opera in conformità con certi “...modelli standard imposti da forti pressioni sociali che - in ultima analisi – pure ci risparmiano da una tale agonia: grazie alla monotonia e alla regolarità di condotta raccomandati, imposti e inculcati dai mass-media”.
Ciò, per quanto come esseri umani arranchiamo nel “…procedere e ben di rado veniamo a trovarci privi di adeguate direttive, o che finiamo in situazioni in cui occorre prendere decisioni e assumersi la responsabilità senza conoscerne le conseguenze, rendendo così ogni passo, irto di rischi e difficile da calcolare”. […] Ne deriva un crescente sentimento di insicurezza sulla scena contemporanea – afferma inoltre Z. Bauman in “La solitudine del cittadino globale” (2008), per il quale “…l’identità è oggi come un vestito che si usa finché serve: sessuale o politica, religiosa o nazionale, precaria come tutto della nostra vita, di là dalla nostra intelligenza e immaginazione. [...] Il nostro mondo liquido-moderno è in continua trasformazione. Tutti noi – volenti o nolenti, consapevoli o no, che ci piaccia o meno – veniamo trascinati via senza posa, anche quando ci sforziamo di ‘calcolare l’incalcolabile’ o di rimanere immobili nel punto in cui ci troviamo”.
Si è qui di fronte a dover fare una scelta in termini etici e a valutare quali conseguenze aspettarci dall’informazione globalizzata, la cui pluralità di significati va oltre i termini posti dalle tecnologie avanzate, che richiede di continuare nella sperimentazione sia in ambito della ‘sfera pubblica’ che in quello della ‘comunicazione di massa’, al fine di riorganizzare il messaggio originale sociolinguistico e/o plurilinguistico dei ‘diritti’ e dei ‘vincoli’ che lo governano, e che va letto in funzione della didattica divulgativa integrata con le strutture avveniristiche socio-politiche, economico-tecnologiche con le quali si trova a interagire.
Il confronto coi sistemi comunicativi del passato, che a loro volta già avevano sollecitato una certa riflessione critica, è inevitabile; ancor più oggi che detti sistemi esercitano una grande influenza nei processi di formazione dell’“opinione pubblica”, parallelamente al configurarsi sociale delle nuove generazioni maggiormente sviluppate in tal senso. La percezione di tali mutamenti è riscontrabile nell’introduzione elaborata di assetti patogeni nei giovani con, come ad esempio nell’uso del linguaggio, nella gestualità ad esso legata, nei modi spesso impropri del dialogare, fortemente suggestionati dall’impiego sfrontatamente propagandistico d’una pubblicità fin troppo invasiva e dall’uso speculativo manipolato dalle più avanzate tecnologie.
Scrive Marica Tolomelli in “Mass media e opinione pubblica” (2006): “Sotto questo profilo i mezzi di comunicazione di massa assumono il carattere di stimolatori con cui distrarre, sviare dai propri autentici bisogni, facendosi strumenti di riproduzione dei rapporti sociali esistenti (reali non virtuali), vettori di un ‘ordine sociale’ (e/o disordine), inteso come normativo cui non è possibile sottrarsi. […] Il concetto di manipolazione non presuppone una dogmatica imposizione di valori, ma implica meccanismi (altri) di condizionamento indiretto sugli individui, sia rispetto agli orientamenti cognitivi, sia allo stile di vita, nei gusti che nelle preferenze, un condizionamento veicolato in primo luogo attraverso i mass-media”.
Sulle implicazioni sociali politiche e culturali che le nuove tecnologie stanno modificando nell’assetto della ‘sfera pubblica’ non è ancora possibile esprimere un giudizio complessivo attendibile, tantomeno di critica da parte di quanti s’improvvisano opinion-leader nell’affollamento programmatico dei talk-show televisivi, sulla carta stampata e nell’informazione sociale, benché assai numerosi risultano gli aspetti salienti riscontrabili nell’uso espansivo della “robotica” (cibernetica applicata), afferenti all’automazione industriale (medica, matematica, astronomica ecc.) ormai giunta a livelli stratosferici, su cui al giorno d'oggi la “comunicazione scientifica” ha esteso il proprio dominio.
(continua)
*
 - Sociologia
- Sociologia
Comunicare il futuro!? - ricerca sociologica
World Wide Web – “Comunicare il futuro!?”.
“… a voi che entrate nel mondo della modernità liquida”.
Zigmunt Bauman
Nel modo d’essere concreti dell’odierno vivere sociale, si vuole qui investigare i legami teorico-virtuali che contraddistinguono e determinano l’andamento evolutivo del comparto dei sistemi informatici e delle incognite ad essi legate, prodotti dal rapporto costante con due miliardi e mezzo di fruitori che si avvalgono dell’utilizzo dei Social Network (World Wide Web), onde avallare un ipotetico quanto possibile “futuro sostenibile della comunicazione globale”, per lo più partecipe della Green Economy ambientale, sociale e ampiamente tecnologica, avallata oggi nel mondo.
Con la presente indagine si propone qui rilevare quelli che sono i rapporti tra ‘nuove tecnologie’ (digitali) e ‘future tendenze’ (virtuali) che più influenzano il mondo dell’informazione e i mutamenti vincolati ai sistemi di comunicazione, con uno sguardo rivolto alla transazione delle competenze relative, in fatto di ‘innovazione e opportunità lavorative’, ‘diritto di cittadinanza’ e ‘diritto individuale alla privacy’, ome sancito dalla European Union Charter of Fundamental Rights, in prospettiva d’una auspicata ‘governance transnazionale’ del Cyberspazio, includente inoltre, esempi diversi di ‘realtà virtuale’ che sussistono all’interno dei sistemi informatici.
Ciò che – a mio modesto parere – reclama un necessario quanto tempestivo intervento nel riposizionamento equiparato della ‘comunicazione’ nella sua complessità integrata e globalizzata, che porti a un’adeguata produzione e diffusione della ‘conoscenza digitale’, corrispettiva della formazione multimediale in atto. Un “fare” questo, come scrive in “Il Contratto Sociale” (1762) J.J. Rousseau, padre nobile dei diritti dell’uomo e della politica moderna, che tra “grandi diritti e piccole libertà”, contrasti il sorgere di una possibile ‘disinformazione’ all’interno dell’informazione stessa e, viceversa, impedisca lo sconvolgimento della ‘comunicazione’ in essere, per lo più trasbordante di padronanze non sempre coadiuvate da approfondita conoscenza oggettiva.
Conseguentemente si ipotizza qui un’indagine (consultativa) di stampo antropologico prendendo spunto dallo studio di G. Giovannini “Dalla selce al silicio” (2000) che propongo come logistica d’insieme (ricerca di base), onde evidenziare l’intero ‘patrimonio conoscitivo ereditario’ (excursus antropico). Quindi facilitare la comprensione delle componenti configurative la ‘comunicazione’ in essere, per poi procedere attraverso i sistemi informatici di ultima generazione World Wide Web, e quindi finalizzare la Comunicazione Satellitare nell’ambito del più avanzato ‘concetto virtuale’ del Cyberspazio.
Sono fermamente convinto che la ‘cultura’ in quanto bene strutturale della società debba essere onnicomprensiva, effettuale del reciproco scambio linguistico avvenuto in illo-tempore che ha portato alla primaria ‘forma comunicativa’ all’origine della comunicazione, di per sé già ‘globalizzata’, in quanto afferente a quegli “Archetipi dell’inconscio collettivo” (1980) individuati da C.G. Jung, stanziali nelle diverse ‘rappresentazioni umane’ del passato e in tutte le attività di ‘trasformazione’ comunicativo-interpretative delle attuali società massificate.
“Comunicare il futuro!?” dunque, non solo come valore intrinseco di uno slogan, bensì premessa per riattivare lo spirito deontologico dell’ “informazione” in quanto ‘costitutivo di un diritto professionale’, onde attivarsi a un’adeguata “comunicazione di massa”, più che mai necessaria, nel rispetto di quei principi che ognuno (individuo, popolo, comunità, stato, nazione) ha assimilato nel corso della propria evoluzione culturale.
Che sia giunto il momento di pensare a un ‘sistema di diritti’ per il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto?, si domanda in “Il mondo nella rete” (2019) S. Rodotà, l’eminente promotore della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, alla quale, tuttavia, non è stata data fino ad ora una risposta applicativa. Per quanto, se vogliamo, è ancora possibile realizzare sostenendo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura e la Collaborazione fra le Nazioni (UNESCO), che sotto la dicitura “Patrimonio Culturale Immateriale” pur riconosce ad essa (Carta) un principio ispiratore fondamentale dello stare al mondo.
“È nello scoprire il fascino spontaneo dell’avventura comunicativa dei popoli che l’infinita ricerca di noi stessi si amplia di nuovi importanti capitoli che vanno ad aggiungersi alla macroscopica Storia Universale che noi tutti stiamo scrivendo.”
L’Autore
(continua)
*
 - Religione
- Religione
Meditazioni di Don Luciano - Tempo di Quaresima
MEDITAZIONI DI DON LUCIANO
DISSETARCI DI GESU’ III TEMPO DI QUARESIMA ANNO A
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42):
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli dice la donna: “Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande di nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?”. Gesù le risponde: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna”. “Signore – gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”. Le dice: “Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui”. Gli risponde la donna: “Io non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”. Gli replica la donna: “Signore, vedo che tu sei un profeta!”… “So che deve venire il messia, chiamato Cristo: quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa”. Le dice Gesù: “Sono io, che parlo con te”… La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: “Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?”. Uscirono dalla città e andavano da lui… Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 2 “Mi ha detto tutto quello che ho fatto”… Molti credettero per la sua parola e alla donna dicevano: “Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”.
1. In Gesù c’è la sete dell’incontro e della relazione. Gesù nell’incontro con la samaritana è uno splendido esempio di pedagogia. Intanto non si lascia condizionare da nessun pregiudizio. Di fronte alla samaritana, alla notizia dei cinque mariti, noi avremmo fatto solo discorsi moralistici. Gesù non gli dice: “Quest’acqua non è buona!”, “Gli amori umani sono solo cattivi”! Dice: “Se bevi quest’acqua, avrai ancora sete!”. La distanza tra la nostra sete profonda e i pozzi umani è incolmabile. Gesù non disprezza le gioie umane; dice solo che sono insufficienti. Non servono divieti e condanne. Bisogna aiutare le persone a passare da una piccola sete alla grande sete, da una piccola brocca abbandonata alla sorgente stessa. Solo l’incontro cambia la vita e non la legge. Gesù stabilisce con la samaritana un rapporto personale, è attento al suo vissuto, alla sua persona, al suo dramma, legge dentro la sua sete. Stabilisce con lei un rapporto nel modo più delicato possibile. Si presenta alla samaritana come un mendicante, come uno che ha bisogno. Si è fatto assetato per dissetarci. Si è fatto povero per arricchirci. “Colui che chiedeva da bere aveva sete della fede di quella donna” (S. Agostino). L’accoglienza di Gesù è già totale in partenza. La simpatia di Gesù è prima della conversione della donna. Questa simpatia previa dispone la donna all’ascolto. E’ pre-evangelizzazione. Ciò che colpisce in questo racconto è che Gesù stesso suscita e guida il cammino della donna, dall’inizio alla fine. Gesù prende la donna là dove si trova, prigioniera delle proprie attese, per condurla su un altro piano. Non è stato un incontro facile, perché la samaritana ha cercato in tutte le maniere di scansare Gesù, di svicolare. Intuisce la pericolosità di questo incontro. Poteva mettere in discussione tutta l’impostazione della sua vita. Finalmente le parole di Gesù sull’acqua viva, dopo vari fraintendimenti ed equivoci, suscitano nella donna la ricerca di quell’acqua. La tentazione di chi cerca Dio è sempre quella di rinchiudere il dono di Dio dentro le proprie attese. Ricerca in genere chiusa nel passato. Gesù la costringe invece a guardare al presente che tutto rinnova.
2. Il tema della sete e del desiderio è ricorrente in Giovanni: oltre all’incontro con la samaritana, ritorna nella festa delle Capanne (cfr. 3 Gv 7, 37-38) e sotto la croce: ‘Ho sete’ (Gv 19,28). “Il Signore ha sete della nostra sete. Ha sete che noi abbiamo sete di lui e desidera che noi abbiamo desiderio di lui” (S. Agostino). ‘Gesù ebbe una sete così ardente della sua fede, da accendere in lei la fiamma dell’amore’ (dal prefazio). Stanno di fronte due desideri! In ogni uomo c’è il desiderio di una vita piena. Gesù è venuto a ravvivare i desideri più profondi, spenti dalle delusioni e dalle paure. Spesso oggi abbiamo una sete ‘sedata’, anestetizzata. Si afferra il momento, l’attimo fuggente, il ‘frammento’, spremendo da esso il massimo godimento possibile, convinti che la sete vera tanto rimarrà inappagata. Consumismo fine a se stesso. Dobbiamo risvegliare la sete profonda, non anestetizzandola con l’illusione di non soffrire o con il pretesto di non far soffrire. Anestetizzando la sete soffriamo e facciamo soffrire molto di più. Gesù con la samaritana non ha fatto così. Non ha anestetizzato affatto la sua sete, anzi l’ha fatta venir fuori in tutta la sua drammaticità. Ciò che Gesù fa è suscitare un’attesa, perché lui possa colmarla.
3. Sete di vita. ‘Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna’. Come la samaritana, anche noi spesso viviamo una vita disordinata, confusa; portiamo nel cuore un grande vuoto che le tante esperienze della vita non hanno saputo colmare. Quanta insoddisfazione esistenziale, perché non troviamo ciò che cerchiamo e così veniamo puntualmente delusi! Spesso il nostro è un vivere ripetitivo e rassegnato. Ci accontentiamo della solita bevanda! Ci dissetiamo a ‘cisterne screpolate’ (cfr. Ger 2,13), che contengono solo acqua stagnante. Ma Cristo ci dona l’acqua viva, zampillante. Quest’acqua non solo disseta, ma purifica, libera dalla sporcizia e fa gioire. Solo Gesù spegne la nostra sete di vita più profonda. La sua è un’acqua di vita, fonte dell’eterna giovinezza. Se accogliamo Gesù e le sue parole, egli diventa per noi l’acqua che risana e rinfresca: ci porta a contatto con la vena interiore dell’acqua viva che zampilla nella nostra anima, ma da cui spesso siamo tagliati fuori. L’uomo è intasato, è separato dalla sua sorgente, in lui spesso non scorre più nulla, egli è come prosciugato. Se beviamo di quest’acqua interiore non ci seccheremo mai, non saremo mai vuoti ed esauriti. La sorgente che scorre in noi è inesauribile, perché è divina. E’ un’interiorità nuova donata dallo stesso Spirito di Dio. Questa sorgente è stata fatta scorrere su di noi dal Battesimo. Il fonte battesimale è il pozzo del nostro incontro con Gesù e del dono dell’acqua viva. La sorgente poi è acqua per la sete degli altri (persone-anfore, EG 86). Non è possesso, è fecondità. Non si placa la sete bevendo a sazietà, ma placando la sete degli altri. Quest’acqua disseta per la vita eterna, a cominciare da questa vita terrena. E’ un’acqua che ha sapore di eternità.
4. Sete d’amore. Una vita piena è una vita nell’amore. Nemmeno sei uomini riescono a soddisfare il desiderio d’amore di quella donna. Una vita irrequieta, una sete implacabile, che però non riesce a trovare la fonte giusta. La donna di Samaria – come noi – desidera un amore incondizionato. Nessun partner dà piena soddisfazione a questo anelito. Ha avuto tanti mariti, ma mai un vero sposo. A quella donna manca uno sposo e una compiuta relazione d’amore. Spesso sperimentiamo che il nostro amore è limitato, mischiato a esigenze di possesso, a gelosia, delusione, amarezza, o avvertiamo la limitatezza del nostro partner, e ne desideriamo uno che soddisfi davvero il nostro desiderio d’amore. Il nostro anelito infinito non può essere soddisfatto da uomini finiti. I sei mariti rimandano al settimo sposo, a Gesù, che ha un cuore per noi e che per noi sulla croce lascia trafiggere il suo cuore. Da questo cuore trafitto si riversa in noi il suo amore perfetto. Giovanni ci rimanda nel nostro desiderio di amore a quel Gesù che muore in croce per noi e che ci dimostra il suo amore fino alla perfezione (consummatum est). Sulla croce si fa visibile il soddisfacimento dell’amore che nelle nostre relazioni vicendevoli appare sempre e solo imperfetto. Gesù è lo sposo che compie in pienezza il nostro desiderio. 5. L’acqua viva è l’amore del Padre e del Figlio, che Gesù desidera donare a ogni uomo. La nostra sete è appagata solo se conosciamo l’amore del Padre per noi. ‘L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo che ci è stato dato’ (Rm 5,5). L’acqua che Gesù promette e che dona è lo Spirito, sorgente d’acqua viva che scaturisce dal cuore di ogni uomo. ‘Se tu conoscessi il dono di Dio!’... Se tu facessi esperienza di questo dono di Dio!.
“Essere cristiani è innanzitutto un dono, che però poi si sviluppa nella dinamica del vivere ed agire insieme con questo dono” (Benedetto XVI). Cristo è la Roccia da cui scaturisce l’acqua viva: ‘Bevevano a una roccia spirituale … e quella roccia era Cristo’ (1Cor 10,4). L’incontro con Gesù ha trasformato la samaritana in creatura nuova e l’ha abilitata a essere testimone ed evangelizzatrice. In Gesù ha trovato un di più, che fa impallidire la sua precedente ricerca. L’incontro con Cristo si fa contagioso, diventa testimonianza. Se il cristianesimo ha perso freschezza è solo perché noi siamo diventati dei recipienti vecchi, arrugginiti, incapaci di contenere acqua cristallina. “Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza!” (Is 12,3).
*
 - Libri
- Libri
Laura Caccia nuovo libro Book Editore
in “La terza pagina” – Book Editore 2023.
“…straripa
lungo i marciapiedi in un perimetro che ignora e sfiata sul vetro tra i fogliami fitti dei passanti […] la lingua svenduta / a stupire tra indirizzi in picchiata / non importa che ora dimori negli abiti in festa / nei suoi doppi / nei suoi retroscena / se continua a mentire e smentire”
L’ipotetico ‘incipit’ dell’autrice, va dicendo che è sempre possibile incontrare ciò che stupisce, se in presenza di un vuoto solo apparentemente incolmabile poniamo la soggettivazione di un’assenza che pure ci appartiene, abile nell’infliggere al candore luminoso della carta la grafia invisibile della nostra mente. È allora che il pensiero s’adagia inerte nel solco tracciato dello scrivere silenzioso, imponendo alla pagina il volere ‘altro’ dell’inquietudine che nell’imprevedibilità d’una esistenza artata, pur s’avanza nel dire l’indicibile che in noi trattiene il grido profondo dell’animo poetico, infinito come lo spazio tra la terra e il cielo, congiunto…
“fino a dove la parola / era caos che non ha finito di / scrivere il proprio / nome né provare a voltarsi / a specchio ustorio […] fuori c’è un mondo amato da cose / che non attendono i nostri nomi – soprusi di senso – abusi / o cura per ammansire il reale – mentre si esilia / puntuale la sciamatura in altra voce […] nel prima insondabile dei nomi – dove ogni pretesto /si inabissa – la pagina precipita in tale assenza sterminata”
Ma se innegabile è l’operare che affronta la scrittura a illuminare le segrete profondità da cui emerge la creazione letteraria, è vero altresì che la parola diviene ascesi, forma privilegiata della condizione interiore di chi impone all’universo incommensurabile l’umana domanda sulla propria esistenza, il perché del qui e ora. Straripa al dunque la domanda nei “fuori pagina” sopraggiunta ‘anzi tempo’: se osare chiedere e/o pretendere, o forse solo reclamare quel diritto alla felicità che noi tutti vorremmo assaporare “tra la vitalità degli opposti e le connessioni casuali”, disgiunti come siamo dal bagliore inesausto della pagina bianca a nostra disposizione, e che riempiamo di “menzogne e smentite”…
“separa il foglio dai capitoli delle costellazioni – il / silenzio ai lembi – sui suoni in sospeso – vasti / improvvisi – per come si sbriciolano da un lato all’altro / dell’inizio […] andare a rotoli nell’indice sfatto – rovinando in aperto – con voce scarlatta – i riflessi a fuoco – la materia / estranea gli sfogli – fino a fare dei fogli il precipizio […] – farsi sangue del sangue cenere di cenere”
Dacché il ‘grido’ della carta solcata si trasforma in un consenso di voci, in concettosità del verso stonato, in antivoce che si sprigiona alla ricerca di senso, “recto o verso”?, si appropria della mano che lo trascrive, da cui nascono pagine ‘altre’ che forse non volevamo, che ci parlano di etica e di spiritualità inconscia, forse egoistica di un sapere interiore che tenevamo nascosto a noi stessi. In questo ‘buio’ creativo l’animo poetico di Laura Caccia, intravede pagine su pagine su cui trascrive i suoi ‘perché’ i suoi ‘come’, i suoi ‘quando’, tralasciando i punti d’interrogazione in quanto contengono già le risposte che cercava nell’ambito di un vissuto che non poteva essere altrimenti, entrate di forza in quella “terza pagina” culturale che si vuole parli di conoscenza, o meglio di ‘bellezza’…
“manca poco – l’ombra non ha confini da qui – un / corpo estraneo – un altro udire e dire – tra le braccia / – per nulla e tutto – ovunque – ogni volta non detta […] nota a margine – spacca a metà il respiro – a tiro di / spasimo e scissione – lungo le fenditure che invoca – / il foglio tra poco – l’inatteso che muore a germoglio […] tutto l’altro in corpo – la minuta del sangue a parola / – tutto il caos preso sul serio – un desiderio ogni attrito / in gola – ogni detrito dentro la sua meraviglia”
Quella ‘terza pagina’ dove incontrare l’assenza del vuoto, dove la parola in trasparenza scolora, evapora nell’alito di vento che improvviso, insieme ai giorni negli anni, va sfogliando le pagine di un calendario strappandole dal muro, sollevate insieme alle foglie e alla polvere del tempo: “lungo i marciapiedi in un perimetro che ignora e sfiata tra i fogliami fitti dei passanti”, verosimilmente inconsci di dover scrivere, pagina dopo pagina, la storia; la loro come la nostra, che leggiamo increduli quanto meravigliati, di ritrovarci insieme, fra le righe ‘trascritte’ quale ‘visione poetica’, in questa “terza pagina” dai risvolti inusuali e concreti, onde proseguire a camminare, insieme…
“l’oscuro umano / scompone i corpi i sensi fradici i lutti / forse sangue alla terra / forse notte sottopelle / ancora strati di gioia come una città antica a memoria […] nei continenti che dormono negli altri che / ricondotti alla loro vertigine vegliano […] ora la pagina attende i suoi popoli insonni / i nostri nomi di strada / dirada a stenti / la sua apocalisse privata / negli strappi dal vivo / prove generali a bocconi / imboscate”
No, non aspettatevi di udire l’indicibile che nel secreto della mente si tramuta in pensiero, né di come la sintesi d’esso si trasforma in metamorfiche immagini visibili nel sogno; no “se non fosse per qualcosa / di incompiuto una / meraviglia vulnerabile / l’orma in bilico / sul corpo a diaspora […] la forma finita / sfinita […] la finità ci somiglia”. Laura Caccia ci invita a considerare ciò che siamo: siamo i nostri sogni, con le nostre paure, le nostre incomprensioni, con le nostre infinite domande rivolte a un’entità assente, che pure ci parla per assiomi inconfutabili…
È allora che “ostinandoci a scalfire parole – senza mettervi fine / scarnire l’incerto – tutto quello che resta aperto / incompleto – senza la sua parte migliore – è pagina adesso […] la cosa si ripete – ogni incompiuto parla con il fuoco / - il magma con il vuoto – la parte mancante rapina / l’occhio – trascina le labbra dove la pagina è muta”. Come muto è il silenzio, “la gratitudine del finito / l’inquietudine dei mondi”; muto è “l’occhio in ogni / brano di terra che ignora cosa resti incolume cosa / muoia; muta è “tutta la bellezza che riesce a sopportare […] un’impazienza di finitudine”.
È forse questa la parola mancante che, al dunque, più impressa è nella nostra memoria inconscia che non vogliamo accettare, perché se apparentemente sembra a noi poco, sappiamo che nel suo ‘muto’ effluvio di competenza, ogni cosa si evolve nei mille volti-maschere “finite, non finite” che di volta in volta assumiamo all’occorrenza, senza distinzione, pur nella finzione di una rappresentazione degna di quel ‘gran teatro del mondo’ che svolgiamo costanti sulla scena, avidi di vita…
“così abbraccia il vuoto – sboccia copiosa – un istante / prima corrode avvelena – ricambia carnivoro il senso / - insiste insiste – migra musica in corpo – non esiste – esiste […] la pagina assenza ci divora – non c’è soglia né alcuna / desinenza – la scrittura imbarca luce al corpo – onora / il desiderio - il suono infine – tutto ha fine e tutto è nuovo”
Allora osare scrivere di felicità (?) non ha più ragione d’essere interrogata: “La pagina bianca dell’assenza indistinta ora sarà musica dal vivo. Sarà strappo e lacerazione. Terra fertile e sguardo sulle cose. Pronta a farsi abitare dal desiderio e disposta ad abitare il pensiero dell’abisso”, quello stesso desiderio che ci ha fatto incontrare l’autrice, Laura Caccia, nell’intimità segreta d’una verità indecidibile e per questo messa “fuori pagina” che invito a leggere per la sua forma inusitata, in quanto soggettivazione illuminata della sua presenza poetica. Una rivelazione dunque quella contenuta in quell’ultimo capitolo sulla felicità: “Osare…”, come per un ‘dono letterario’ che non è pensabile trascurare, dacché “parla dal limite. Dalla frontiera. […] come dal sentire di (quel)l’interezza” cui l’umanità tutta aspira, per una promessa che non c’è mai stata, ma che pure è là, “pronta a radicarsi nella vita, unirsi ad altre pagine e, al tempo stesso, disposta a sradicarsi, trovare radici…
…altrove”.
L’autrice:
Laura Caccia, è nella Redazione della rivista “Anterem” e nel Consiglio editoriale di ‘Opera Prima’. Fa parte del Comitato di lettura di Anterem Edizioni e della Giuria del Premio “Lorenzo Montano” diretta da Ranieri Teti; è inoltre nella Redazione della rivista “Osiris” diretta da Andrea e Robert Moorhead – Greenfild, Massachuttes USA. Delle sue pubblicazioni vanno segnalate “D’altro canto” – Premio Lorenzo Montano Anterem Edizioni 2012; con “La terza pagina” è entrata nella terna dei finalisti al Premio “Elio Pagliarani” – Book Editore 2023
Note:
“*” tutti i virgolettati sono dell’autrice Laura Caccia, tratti dalla silloge poetica “La terza pagina”.
*
 - Cultura
- Cultura
Tempo di Carnevale - Maschere popolari.
(Ricerca filologica di Giorgio Mancinelli tratto da ’Cantarballando’, un programma RAI Radio3 del 1982.
Storie di Cantastorie.
La tradizione più antica in Italia è indubbiamente quella cavalleresca che rivive nei testi degli spettacoli dei Burattini e del Teatro dei Pupi, nei dipinti dei carretti e nella recitazione dei poemi medievali, rappresentati in questi luoghi o sulla pubblica piazza dove il Cantastorie, seduto in mezzo a un cerchio di vecchi e bambini, gesticola con in mano una spada di legno e racconta le interminabili avventure o disavventure di questo o quell’eroe del tempo passato.
Ma anche di altri relativamente più vicini a noi, come ad esempio le guerre di Carlo Magno, le cruente battaglie contro gli infedeli, le storie di Rolando e di Ruggero, di Astolfo sulla Luna ecc. che ha imparato a memoria e che sono, in parte, basate su poemi dell’Ariosto, del Boiardo, del Tassoni e molte di riferimento religioso desunte dalla Bibbia e dai Vangeli, e dalla vita di santi.
Tutti, ma davvero tutti, attendono però con impazienza le scene di battaglia, nelle quali il Cantastorie, il viso distorto dalla furia del combattimento, taglia l’aria con la spada e spezza le parole in modo da accrescere l’interesse dello spettatore
È fuor di dubbio che stiamo parlando di ‘leggende’ sorte dalla fantasia degli scrittori del tempo ma ancor più di una tradizione orale che più spesso era re-interpretata da
cantastorie ambulanti e da quei cantori che talvolta le mettevano in musica con inserimenti di villanelle e strambotti, e gagliarde a ballo onde far divertire il pubblico che accorreva numeroso alle loro rappresentazioni.
La fantasia popolare, in quanto essenza di credenze magico-religiose entrate nei costumi tradizionali, ha in origine contribuito all’affermarsi di un Teatro Popolare Regionale di cui le ‘maschere’ e i ‘mascheramenti’ rappresentavano la più espressiva delle forme d’arte. Ogni regione, almeno per quelle riferite all’Italia, ne possiede di proprie che mettono in risalto i caratteri dei suoi abitanti ed è rappresentativa dell’eredità di una più antica arte ludico-rituale.
Molte delle ‘maschere’ qui di seguito presentate sono native di regioni diverse e relative a epoche più o meno recenti, tra il ‘500 e il ‘700. Addirittura alcune non nascono neppure come maschere a se stanti, quanto invece sono ‘caratterizzazioni’ di personaggi veramente esistiti, per così dire messi ‘alla berlina’, entrate in seguito nelle rappresentazioni di piazza e nel teatro dei saltimbanchi.
Un teatro fatto di scherzi e lazzi, di burle salaci e di trovate in cui venivano presi di mira gli autori inconsapevoli di pettegolezzi cittadini; le deformazioni fisiche e i tic professionali di personaggi pubblici; come pure i rappresentanti di questo o quel mestiere e ovviamente i chierici e i prelati, tutti visti, neppure a dirlo, attraverso la lente caricaturale.
Ma se il teatro o comunque la scena rappresenta il luogo deputato per la rappresentazione in maschera, la piazza (quella piazza universale di cui si è già parlato in altro articolo), e indubbiamente la stada cittadina comprensiva dell’intero ‘paese’, è al dunque il prototipo umano forgiato dalle chiacchiere della gente che vi abita. La tradizione, infatti, riconosce in questa o quella maschera il personaggio archetipo della singola regione.
È così che con ‘Geppin e Nena’, due maschere contadine genovesi risalenti al XVI secolo, approdiamo In Liguria, terra di marinai ma anche di coltivazioni terriere di cui entrambi sono rappresentativi e che ritroviamo durante il Carnevale a passeggio per i paesini liguri accompagnati dal suono della ‘piva’ (sorta di zampogna) e che recitino filastrocche satiriche indirizzate ora a questo ora a quel cittadino più o meno noto.
‘Geppin’ indossa un corpetto scarlatto sotto la giacchetta di fustagno color nocciola o di velluto verde; calzoni corti di velluto nero, le uose (scarpe) alla contadinesca e in testa un cappello di feltro a falda larga. ‘Nena’ vestita secondo l’uso contadino ama adornarsi di molti monili d’oro e d’argento e, durante il Carnevale completa il suo abbigliamento con un parapioggia.
D’origine ligure-piemontese è un ‘canto narrativo’ dal titolo ‘Ghe n’ea de tre fighette’ conosciuto anche come ‘La pesca dell’anello’ desunta da quella raccolta ben più lunga del Nigra:
«Ghe n’ea de tre fighette inscia riva du mar. / A ciù bella l’è a ciù picina s’è missa a navegà. / In to mentre ch’a navegava, gh’è cheitu l’anello in mà. / O pescator dell’onda, vegnilu in po’ a pescà. / Quando l’avrò pescato, che cosa lei mi darà?/ Darò trecento scudi, e una borsa ricamà.»
Con ‘Meneghino e Cecca’, due maschere milanesi del Seicento siamo invece in Lombardia. Per la tradizione Meneghino è ‘povero ma con il cuore in mano’. Si vuole che il suo nome derivi da Domenichino, nome dato alla servitù in servizio la domenica ma, più probabilmente, dal più antico Omeneghino. Indossa una casacca verde orlata di rosso, pantaloni e scarpe nere, calze a righe bianche e rosse, parrucca e tricorno.
Secondo Amina Andreola studiosa del nostro teatro regionale: “La sua comicissima maschera un tempo indicava il contadino inurbato, ignorante, bonario e pieno di buon senso ma ancor prima il servitore devoto, prudente, con un pizzico di spavalderia.” Ma che, rivisitato al giorno d’oggi è riscontrabile nel franco e dinamico tipo del milanese ‘faço tuto mi’.
L’affianca di solito la moglie ‘Cecca’ ,sorta di popolana irosa e linguacciuta che lo mette spesso in difficoltà davanti agli altri e, non in ultimo, lo rincorre spesso con il matterello da cucina per picchiarlo. Tuttavia Meneghino, con il suo buon carattere, in fine riesce a domare non senza qualche lamentela da parte di Cecca, finché la pace comune non è ristabilita.
Con ‘La cansiun busiarda’ si intende qui dare un tipico esempio della popolarità di certe maschere che in realtà sono più ‘costumi’ che mascheramenti in quanto esse non indossano una vera e propria maschera facciale ma il loro lato comico sta nella frivolezza dei loro costumi multicolori, nei modi del loro parlare desunti dalgli usi dialettali, nella gestualità tipica del teatro della Commedia dell’Arte, in cui la ‘bugia’ era di rigore, all’origine di tutta la confusione proverbiale che ne derivava sulla scena:
«E chi vol sentì, canté, sentì canté / l’è la cansun busiarda / larilalalà, larilalalà / l’è la cansun busiarda. / Sun pasà ‘nt un pais ‘nt un pais / viviju a la gruséra / larilalalà, larilalalà. / J’éra ‘l fèn ent i butai ent i butai/ e ‘l vin su la finéra / larilalalà, larilalalà. / E le fje j’eru sel giuch / e le galine filavu / larilalalà, larilalalà. / L’àn butaje la ruca al béch / e ‘l fus en més le gambe / larilalalà, larilalalà. / J’éra ‘l prèivi ‘nt el pursil ‘nt el pursil / e ‘l crin cantava messa / larilalalà, larilalalà.»
In Piemonte troviamo i noti ‘Gianduia e Giacometta’ nativi di Caglianetto (Asti), inizialmente noti come burattini. Trasferiti nella cittadina Torino diventano maschere del Carnevale. Conosciuto nell’uso dialettale come ‘Givan d’la donja’ ovvero Giovanni del boccale è così detto perché gli piace il vino, e che qualcuno dice: ‘anche un po’ troppo’, per dire che è un ubriacone.
Gianduia dal viso aperto, pienotto, ridanciano, col naso volto all’insù, veste il costume originale di Caglianetto consistente in un giubbino di panno marrone orlato di rosso, calzoni al polpaccio di panno verde e calze rosse. In testa ha la parrucca nera tirata all’indietro che finisce col codino, sotto al tricorno verde, il cappello indossato nel torinese alla fine del Settecento.
Caratterizzazione del galantuomo tutto cuore, integerrimo ma generoso, difensore dei deboli e degli oppressi, talvolta un po’ stordito e linguacciuto ma bonario. Esempio tipico del robusto contadino piemontese, ingenuo quel tanto che basta, amante dello scherzo, dello scherno a fin di bene, come del buon vino e delle ragazzotte.
È qui in Piemonte che si tramandano canzoni e filastrocche note fin dal secolo XV°, come quella riportata qui sotto dal titolo ‘La bergera’:
«A l’ombretta del bussòn bela bergera l’è andurmija, / j’è da lì passò ‘n très joll franssè / a l’ha dije: Bela bergera vòi l’eve la frev. / E se vòi la frev farai fè na cuvertura, / còn al mè mantel ch’a l’è còsì bel, / farai fè na cuvertura passerà le frev. / E la bela l’ha rispòndù:/ Gentil galant fè ‘l vostr viagi, / e lasseme ste còn al mè bergè, / con al sòn dla sòa viola ‘n farà danssè.»
Ed ecco giungiamo nella ridente Toscana dove incontriamo ‘Stenterello’ un po’ narciso un po’ giocherello di se stesso. Maschera del teatro popolare fiorentino conosciuta appena nel XIX° secolo, rappresenta il popolano piccolo borghese, tra il furbo e lo sciocco, ma buono e incredibilmente giusto. Sua principale caratteristica è l’agile e colorito uso della lingua fiorentina infiorata di frizzi e frasi boccaccesche.
Così ad esempio egli definisce le donne:
«Donna ciarliera e bizzosa, è peggio d’ogni cosa./ Donna che parla poco, nasconde in seno il foco. / Donna che parla assai, non ti fidar giammai. / Donna muta e silente, peggio di un accidente.»
Stenterello ha fronte spaziosa, volto biaccato con sopracciglia allungate col nero di sughero bruciato che le rende arcuate e folte, al pari delle maschere più antiche. Indossa una zimarra di stoffa blu, un panciotto verde o giallo canarino, braghe nere e calze diverse, una turchina e una gialla, oppure una a tinta unita e una a righe, scarpe basse con grande fibbia e il tricorno sulla parrucca bianca.
Alla Toscana è legata uno stornello amoroso dal titolo ‘La mamma ‘un vole’:
«Ho seminato un campo d’accidenti / se la stagione me gli tira avanti / ce n’è per te e per tutti li tu’ parenti. / La mamma ‘un vole, ‘un vole, ‘un vole / che io faccia l’amor con te / ma vieni amore quando la mamma ‘un c’è. / Ho seminato un campo di carciofi / giovanottino mi son bell’e nati / carciofi come te ‘un so venuti. / So’ nata per i baci e voglio quegli / come l’innamorati se gli danno / gli voglio sulla bocca e sui capelli / poi chiudo gli occhi, dove vanno, vanno. / E a me mi piace ‘l fischio del motore / perché il mio amore gli era macchinista / mi buggerava e ‘un me ne ero avvista. / E a me mi piaccion gli uomini biondini / perché biondino è l’amore mio / biondino lui moretta io / che bella coppia che ha creato Iddio. / E a me mi piaccion gli uomini fustini / perché fustino è l’amore mio / fustino lui piccina son io / che bella coppia che ha creato Iddio.»
Fra le maschere legate ai costumi popolari del Lazio spicca il romano ‘Rugantino’, una sorta di bravaccio di rione intelligente e coraggioso, sincero e patriottico, si vuole discendente da quel Miles Gloriousus di Plauto già entrato nella commedia antica, forse anche dal grottesco Manducus, a tratti sprovveduto e nullafacente, innamorato della popolana ‘Nina’ alla quale più spesso dedica la sua serenata.
‘Nina si voi dormite’ conosciuta come canzone d’autore è forse quella rimasta nel repertorio più a lungo di tutte le altre:
«'Nde 'sta serata piena de dorcezza / pare che nun esisteno dolori. / Un venticello come 'na carezza / smove le piante e fa' bacià li fiori. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / L'odore de li fiori che se confonne, / cor canto mio se sperde fra le fronne. / Chissà che ber sorriso appassionato, / state facenno mo' ch'ariposate. / Chissà, luccica mia, che v'insognate? / Forse, chi canta che v'ha innamorato. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / Però, si co' 'sto canto, io v'ho svejato, / m'aricommanno che me perdonate. / L'amore nun se frena, o Nina, amate, / che a vole' bene, no, nun è peccato. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / L'odore de li fiori che se confonne, / cor canto mio se sperde fra le fronne. »
Il costume di Rugantino ha però origini settecentesche, tipico dei carrettieri a vino, costituito da un farsetto rosso sulla camicia bianca, calzoni corti allacciati sotto il ginocchio, calze bianche a righe orizzontali, fascia ai fianchi e coltello alla cintola. Sua compagna è ‘Nina’ o anche Ninetta, una popolana orgogliosa di essere trasteverina e spendacciona; porta lo spadino fra i capelli che all’occorrenza usa contro i numerosi ammiratori che si rivelassero troppo arditi.
Un po’ smargiasso e attaccabrighe ma schietto e simpatico ‘Rugantino’ rappresenta il romano più autentico, un po’ millantatore di bravate ma di buon cuore, sempre pronto quando si tratta di bevute in compagnia, sia che si tratti di una ‘morra’ giocata all’ ‘Osteria del tempo perso’; sia che si tratti di stornellate in comitiva con tanto di sberleffi e narrazioni salaci. In epoca moderna il duo Garinei e Giovannini ha potuto costruire sulla sua leggendaria maschera il noto musical dal titolo omonimo: ‘Rugantino’, che tanto successo ha riportato nel mondo e del quale bene lo rappresenta questa ‘Ballata di Rugantino’:
«Ma pensa che bellezza / nun c'ho niente da fa' / porcaccia la miseria / nientissimo da fa' / e rompo li stivali a tutta quanta la città / perché 'n c'ho niente da fa'. /
Rugantinì... Rugantinà... nemmeno è giorno e già vòi ruga'
Rugantinì... Rugantinà... tranquillo e bono non ce poi sta'
Sto proprio come un Papa / anzi mejo, Santità / perché Lei, gira, gira, / quarche vorta ha da sgobba'. / Io, viceversa, sgobbo solamente si me va / perché 'n c'ho niente da fa'./
Rugantinì... Rugantinà... c'hai sempre voglia de sta' a scherza'
Rugantinì... Rugantinà... ma non c'hai voja de lavora'
Voja de lavora' sarteme addosso / ma famme lavora' meno che posso. / Non posso perde tempo / nun c'ho niente da fa' / levateve de mezzo / fate largo a Sua Maestà /
ariva Rugantino che c'ha voja de ruga' / perché 'n c'ha niente da fa'.
Rugantinà... Rugantiné... che vai cercando, se po' sapé?
Rugantinì... Rugantinà... 'sta smania in corpo chi te la dà?»
Gli fa coro una lista incredibilmente variegata di personaggi: Marco Pepe, Meo Patacca, Mastro Titta, Cassandrino, Mezzetino, Sora Menica, Ghetanaccio il burattinaio e finanche la Befana, figura questa tra le più complesse della tradizione arcaica, tra il magico e il religioso, entrata di traverso sia nel teatro popolare che in quello più specifico dei burattini. Alla Befana è legata più d’una filastrocca e conta fanciullesca che bene ne illustrano il personaggio, come questa dal titolo significativo ‘La Befana’ ripresa dalla tradizione umbro-laziale:
«La Befana gli è arivata / di colore d’arcobaleno / e le porta le puppe in seno / che gli fanno balla balla. / Massaina e Capoccino sem venuti a casa vosra / ci darete del quattrino / se l’avete nella borsa. / Noi vogliamo delle ova / o mia cara Massaina / e per far bòna figura / ce ne date una dozzina. / Noi si piglia anche dell’agli / o cipolle o sian capretti / empiremo queste balle / di coniglioli o galletti. / Poi si da la bonanotte / a ‘i segnore benedette / questa vorta non si sorte / ci farete anche ‘l rinfresco. / Se vi avremo contentati / con la mia grande squadriglia / sémo meglio noi de’ frati / fora de la porta / benediciamo tutta la famiglia.»
Ma era la maschera facciale infine che più d’ogni altra cosa trasformava la fisionomia del personaggio ch’era preso di mira e che lo rendeva immediatamente riconoscibile al folto pubblico che presenziava a detti spettacoli popolari. Era la maschera infatti, più del travestimento, ad esporre nell’immediato il carattere tipico dell’incongruenza d’ogni personaggio che si affacciava sulla scena. Che fosse una risata subito trasformata in una smorfia sarcastica, oppure una lamentazione amorosa, o ona constatazione di morte, la maschera facciale determinava la conseguente gestualità dell’attore al quale era richiesta grande maestria d’improvvisazione; tale che già nell’antichità il termine ‘maschera’ si dava come sinonimo di ‘persona’.
L’ambiguità e la varietà che il termine ha assunto sono esplicite in numerose citazioni di autori latini, nelle quali ricorre, oltre che con il principale significato di maschera teatrale, anche quello di attore o parte rappresentata sulla scena, ed ancora quello di carattere, personalità, che più si avvicina al valore che noi oggi gli attribuiamo.
Il significato tradizionale rituale-magico e religioso della maschera trova una sua precisa spiegazione proprio in ambito teatrale in quanto le maschere venivano indossate dai partecipanti in primis nelle cerimonie religiose in cui la ‘persona’ letteralmente si travestiva da qualcosa d’altro: satiri, animali, uomini/donne divinità. L’uso della maschera dunque per assolvere a esigenze pratiche.
Come i partecipanti del rito, attraverso la maschera che copriva il volto, gli attori venivano trasferiti in una diversa realtà che li possedeva completamente, annullando la reale individualità di ciascuno, così nella scena, l’attore si calava completamente nella situazione di cui era protagonista e la maschera era il mezzo essenziale per il trasferimento in una realtà ‘altra’ che si voleva rappresentare.
Ed ecco che come per incanto o per magia sotto il ritratto un po’ burlone, un po’ grottesco delle maschere popolari troviamo infine quelle relegate a personaggi che pur facendo riferimento a questa o quella regione, indossano la ‘maschera facciale’ propria della Commedia dell’Arte. Figure queste forse più note al grande pubblico e per certi aspetti forse più care.
“Ogni regione – scrive Sergio Tofano – si è impadronita di una maschera venuta fuori non si sa bene da dove, ma vecchia quanto il mondo e destinata a non morire, che ha dato ad essa un’appropriata cittadinanza. Fatta sua, l’ha rifoggiata, l’ha ripulita, l’ha rimpastata, arricchendola di pregi e difetti, modellandola come un monumento vivo sui suoi vizi e sulle sue virtù”.
Bologna, ad esempio, città universitaria per eccellenza, sembra sia la più antica università al mondo, ha il ‘Dottore’, profondo e pedante come solo sa essere un dotto. La città lagunare di Venezia, sede di traffici e luogo di avventurieri ha il suo bel ‘Capitano’ che, stando a quanti sono gli attori che l’hanno interpretato ha spalancato i confini d’Europa.
Bergamo così detta ‘soprana e sottana’ per via dei molti baciapile religiosi, ha il suo ‘Arlecchino’ che, con ‘Brighella’ forma il duo comico più famoso e ‘scassato’ che si sia visto al mondo. A Milano troviamo invece ‘Beltrame e Scopone’ fratelli di Meneghino che li rappresenta bene entrambi. A Napoli … beh, a Napoli quella che è la maschera più complessa e straordinaria che si possa immaginare: ‘Pulcinella’, per quanto accompagnato da altre notevoli maschere come Scaramuccia e Tartaglia.
“Ciò che ne è venuta fuori - scrive ancora Tofano – una girandola, e che girandola! Dai colori più smaglianti, tutta nostra, che ha dato tanto spesso al nostro paese e ha fatto ridere il mondo intero”. Come in questa ‘Canzone di Niccolò’ d’epoca medievale, attribuita a Niccolò Macchiavelli ed entrata nell’uso popolare tosco-emiliano:
«Perché la vita è breve / e molte son le pene / che vivendo e stentando ognun sostiene / dietro alle nostre voglie / andiam passando e consumando gli anni / ché chi il piacer si toglie / per viver con angoscia e con affanni / non conosce gli inganni / del mondo, o da quei mali / o da che strani casi / oppressi quasi sian tutti i mortali. / Per fuggir questa noia / eletta solitaria vita abbiamo / e sempre in festa e in gioia / giovin leggiadri e liete ninfe stiamo. / Or qui venuti siamo / con la nostra armonia / sol per onorar questa / sì lieta e dolce compagnia.»
Il bergamasco ‘Arlecchino’ figura tra le maschere italiane più antiche e fa la sua apparizione già nelle composizioni improvvisate dei ‘mimi’ attori della cultura latina. Ricordata in un primo manoscritto di Bartolomeo Rossi risalente al 1584, successivamente passato dalla scena italiana ai teatri di tutta Europa grazie a Carlo Goldoni che lo scelse come protagonista di alcune sue commedie famose.
È il tipico esempio del servitore, semplice, ignorante e credulone, al tempo stesso arguto e malizioso. La sua figura piena di grazia ma anche di sveltezza e agilità ha sempre destato simpatia fra gli spettatori di ogni età data, forse, dal suo vestito fatto di tanti pezzi ‘rombi’ di stoffe e colorazioni diverse che lo rendono molto gradevole allo sguardo, quasi una figura ‘sfuggevole’ alla presa.
Va qui ricordato inoltre uno dei più grandi esempi del teatro italiano allorché l’eclettico regista Giorgio Strehler che negli anni ’60 lo riportò in auge nella goldoniana commedia: ‘Arlecchino servitore di due padroni’ interpretato dal pur grande Ferruccio Soleri che ha fatto il giro del mondo. Per quanto vadano qui ricordati gli storici anni della prima esecuzione del 1947, Marcello Moretti, Franco Parenti e Checco Rissone.
Non a caso ci troviamo a Venezia in casa di ‘Messer Pantalone’, un tempo chiamato ‘il Magnifico’ poi anche ‘de’ Bisognosi’, forse per il fatto che fosse così avaro e brontolone da rifiutare qualsiasi aiuto ad alcuno. Lo si vuole desunto dalle antiche Atellane del V° secolo a. C: farse romane caratterizzate da un linguaggio popolare e contadinesco e da maschere fisse il cui nome trae origini proprio dalla città di Atella, fra le popolazioni osche della Campania.
Rappresenta un anziano mercante all’antica, tutto sommato un buon vecchio astuto e grave, onesto ed onorato, spesso ingannato dai suoi servitori dei quali ne paga sempre le spese. Padre incline a tiranneggiare le proprie ‘putele’ quali Rosaura e Colombina che vuole a tutti i costi maritare a chi vuole lui, ma anche senza spendere un baiocco.
Vecchio e grasso con il naso adunco e la barba a punta, veste secondo la foggia dei veneziani benestanti del tempo antico, una zimarra lunga fino ai piedi che lo rende riconoscibile e figura di tutto rispetto. Carlo Goldoni lo ritrasse nella figura di Lunardo in ‘I Rusteghi’ nel più famoso ‘Contratto di matrimonio’.
Quella del ‘Capitano’ è un’altra figura assai comune in ogni tempo, nella cui maschera sono confluiti personaggi nativi di luoghi ed epoche diverse, finché – scrive Vittorio Gleijeses – con l’instaurazione del predominio spagnolo in Italia, il suo aspetto tipologico si identifica con il ‘soldato sbruffone’, fanfarone e brutale, feroce ma anche ridicolo, oggetto di avversione e di odio per le angherie e ruberie di cui è capace e che ne fanno l’oggetto di una pietà sprezzante a causa della sua miseria materiale e morale.
Pur conservando in ogni sua rappresentazione la foggia militare del costume, la sua maschera seguì i tempi cambiando foggia. Una delle maschere indossate poi divenuta famosa soprattutto in Francia è certamente quella dello ‘Scaramuccia’ napoletano, amante delle belle donne e delle bottiglie di vino, divenuta celebre nel ‘600 grazie a un interprete d’eccezionale bravura, di uno : Tiberio Fiorilli, uno dei maestri di Molière, sempre agilissimo e spiritoso fino all’età di 83 anni.
Nota anche in Calabria col nome di ‘Giangurgolo’ diventa un soldato ancora più fanfarone e allo stesso modo fifone degli altri più famosi di lui, quali ‘Capitan Fracassa’ o quel ‘Capitan Spaventa’ i cui nomignoli fanno già pensare ai soggetti che vanno a interpretare. Con Giangurgolo eccoci proiettati nell’estremo Sud della nostra penisola. Lo testimoniano le musiche e le canzoni narrative tipiche della tradizione, inserite in ogni Carnascialata, come questa dal titolo significativo ‘Zza Marianna’:
«Zza Marianna, zza Marianna / lu campaneddu vostru cu’ vi lu ‘ntinna? / Ca vi lu ‘ntinnu jeu: / Zza Marianna, cori meu …/ Ha d’èssiri di Patti la pignata, / pe’ fari la minestra sapurita! …/ Zza Marianna, ciuri di bellizzi / non vidi ca ti pennunu ‘ssi lazzi! .../ Ti dicu ‘mi t’i pettini e t’i ‘ntrizzi, / ca L’ò mini pè tia nèsciunu pazzi …/ Lu cori di la donna estì ‘na canna …/ ma l’omu è forti comu ‘na culonna! …/ Zza Marianna, zza Marianna ‘na vota …/ jeu fari non la pozzu cchiù ‘sta vita! …/ La testa mi firria comu a ‘na rota: / Zza Marianna, figghia sapurita ! …/ Mangia carni di pinna, e m’è corbacchia; / dormi cu’ ‘na signura , e puro vecchia! …»
Con ‘Peppe Nappa’ maschera del servo pigro e sbadato approdiamo in Sicilia in rappresentanza dei prototipo dei ‘citrulli’, cioè lo sciocco degli sciocchi di questo mondo, tale che tutti i citrulli di questo mondo messi assieme non potrebbero combinare i pasticci che questi combina, al punto che viene da chiedersi se il Nappa sia davvero stupido o finga di esserlo. Peppe Nappa non porta maschera né s’infarina o si trucca in volto, è agilissimo nella danza, maestro nell’eseguire le più comiche e burlesche piroette. È riconoscibile per le sue ‘nappe’, cioè le toppe che ha nei calzoni, da ricordare la figura del più moderno ‘pagliaccio’ da Circo che, pur prendendo calci e bastonate riesce infine a far ridere e a farsi amare.
A Peppe Nappa dedichiamo questa ‘Terra ca nun senti’:
«Maledittu ddu mumento / ca raprivi l’occhi ‘nterra / ‘nta stu ‘nfernu / sti vint’anni di turmentu / cu lu cori sempre ‘nguerra / notti e juorno. / Terra ca nun senti / ca nun voi capiri / ca nun dici nenti / vidennumi muriri! / T / Terra ca nun teni / cu vole partiri, / e nenti ci duni / pi falli turnari. / E chianci, chianci / ninna oh! / E chianci, chianci / ninna oh! / maledittu ‘sta cunnanna, ca ti ‘nchiova / supra ‘a cruci d’a speranza! Maliditti cu t’inganna / prumittennuti la luci e fratillanza.»
Maschere di una certa rilevanza sono note in Sardegna, diverse se presenti al Nord o al Sud dell’isola dove rappresentano figure più o meno legate alla natura dei luoghi; come ad esempio quelle di sughero dell’Iglesiente e quelle invece di legno ‘più dure’ della Gallura. Ancora più arcaiche, forse d’origine pastorale magico-religiose risultano essere quelle dei ‘Mamuttones’ tipiche del Carnevale Barbaricino di Mamoiada.
Ricco di atmosfere suggestive, impreziosito da eventi come la sfilata appunto dei Mamuttones, personaggi arcaici rivestiti di pellicce d’animale e maschere sul volto, cadenzata dal cupo suono ritmato dei campanacci, portati a spalla in gran numero dalle maschere che conferiscono ai danzatori un significato per niente casuale e tantomeno effimero:
«Le maschere cupe, le loro movenze, i suoni lugubri che ne fanno da contrappunto, incutono rispetto e, al tempo stesso, mettono a disagio. Assistendo a una loro esibizione non è difficile immedesimarsi in quel lembo di antiche tradizioni che le stesse intendono e riescono ad evocare. (..) Le maschere a loro volta sono attorniate dagli ‘Issokadores’, questi sfilano senza campanacci indossando il costume tradizionale sardo e recano in mano una fune detta ‘sa soca’, con la quale riescono a catturare gli spettatori che a un certo punto vengono tirati al cospetto ravvicinato delle maschere, tra lo spavento e talvolta la paura che incombono.» (F. S. Ruiu)
Recenti studi, coralmente recepiti, collocano l’origine delle maschere del Carnevale barbaricino nel tempo delle religioni misteriche e dei riti dionisiaci. Logico pensare che i rituali proposti siano quanto rimane di antiche manifestazioni propiziatorie sopravvissute nel tempo, legate alla fertilità e all’alternanza delle stagioni. Anche ‘Sa Sartiglia’ di Oristano, un tempo chiamata ‘sortija’, è la giostra equestre più affascinante della Sardegna tra cultura e tradizioni.
Menzionata per la prima volta in documenti che risalgono al 1547, così come è giunta sino ai nostri giorni, è da considerarsi come un pubblico spettacolo, organizzato allo scopo di intrattenere e divertire gli spettatori che ogni anno vi prendono parte sempre più numerosi. La particolarità di questa ‘sfida’, che si differenzia da tutte le altre conosciute, è racchiusa nella vestizione e infine nell’indossare la ‘maschera’ bianca che nasconde il ‘vero’ volto di chi la indossa: ‘su Cumponidori’.
L'espressione profonda di questa maschera trasforma ‘su Cumponidori’, lo rende inavvicinabile, inarrivabile. Da quel momento in poi, sino alla fine della corsa, il Cavaliere diventa un ‘semidio’ sceso tra i mortali per dare loro buona fortuna e mandare via gli spiriti maligni. Alla fine su Cumponidori, vestito con in capo un cilindro nero, la mantiglia, una camicia ricca di sbuffi e pizzi, il gilet e il cinturone di pelle, sale sul cavallo che è stato fatto entrare in una sala disposta a religioso silenzio per non innervosire la bestia, gli viene consegnata ‘sa pipia de maju’ e, completamente sdraiato sul cavallo, esegue ‘sa remada’ per passare sotto la porta ed uscire all'esterno, dove lo attendono gli altri cavalieri e una folla plaudente che subito inizia a benedire.
Con ‘Pulecenella’ si dovrebbe aprire qui un capitolo a parte per la sua complessità storico-sociologica e filosofica del popolo napoletano. Cosa questa che rimando ad altra occasione non solo per ragioni di lungaggine dell’articolo, soprattutto perché con essa si entra prepotentemente nella ‘storia del teatro popolare di piazza’ e non solo. Legata a origini più antiche la maschera di Pulecenella è un miscuglio di coraggio e cialtroneria, vanità e astuzia, all’occorrenza alterigia e ciarlataneria che ne fanno un esempio, o forse un ‘modello’ della complessità umana. Ghiotto e insolente, arguto e gioioso, piacevole e impertinente, pazzerello e ciarliero, Pulecenella accoglie in sé il sentimento più profondo e oscuro dell’allegria e della tristezza dell’animo partenopeo, misero e arguto al tempo stesso, che non conosce cattiveria infame e che pure, riesce a impietosire per un piatto di maccheroni:
«Pe tutte so nu principe / pe tutte no signore. / Solo per il mio pubblico / fedele servitore.»
Ed ecco infine abbiamo ritrovato il nostro buonumore, come per incanto o per magia sotto il ritratto un po’ grottesco e un po’ burlone delle maschere popolari della tradizione italiana, siamo giunti alla fine di questo ‘incontro’ con quei personaggi più o meno noti e per certi versi cari. Alla fine altro non mi rimane che ringraziare e come un Arlecchino … di fare a tutti voi (che mi avete seguito) l’inchino.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Auguri Monsieur Proust per i suoi 100 anni insieme a noi.
“Il Manoscritto Perduto”
A Parigi negli anni successivi al 1900.
Le luci sfavillanti dei lampioni accesi sui boulevard affollati di gente rendevano Parigi una città davvero incantevole quanto ‘...extraordinaire', come sulla scena di un vaudeville rumoroso e fin troppo movimentato. Allorché così meravigliosamene illuminata si lasciava ammirare nelle tiepide sere di primavera, in cui i giovani artisti bohemien, con le tele che la ritraevano sotto il braccio, s’affaccendavano non poco dall’una all’altra parte dei marciapiedi, alla ricerca affannosa di vendere uno dei propri quadri ai numerosi turisti in visita alla Ville Lumiere.
Un continuo andirivieni di vendeurs de journaux, di gigolò nullatenenti e di garçons che invitavano i passanti a entrare nei bistrot e nei numerosi 'boites de nuit' a passare una notte di svago. A rendere ancora più spumeggiante l’atmosfera era il fiume di champagne che si riversava nei calici levati 'à la santé!' dalla bonne-societé, quella stessa che affollava i fouilleur dei teatri e le salle degli alberghi più in voga, dei locali notturni 'à la mode' come il Moulin Rouge e Pigalle e dei ristoranti prestigiosi come il Ritz e Maxim’s, nella cui luce specchiata tutta Parigi sembrava riscoprire la 'joie de vivre'. Una luce diafana e sublime che faceva della Belle Époque un’epoca originale e irripetibile, in cui l’artificio della moda diventava estetica di vita, e la parvenza ‘snob’ degli individui finiva per ridisegnare tutti gli spazi del vivere comune, nell'arte come nello spettacolo, nella musica come nella poesia e nella letteratura.
Tuttavia, nulla sembrava scalfire la tranquilla vetustà della Maison de la Ville, immersa com’era nel suo bel parco ombroso di sempreverdi e le sue aiuole costantemente fiorite … «...quasi che in ogni mese dell’anno stia per sbocciare la primavera!», soggiunse Madame Rose, per quanto, essendo l'estate ormai sul finire, questa appariva sempre più lontana, ancorché in breve sarebbe arrivato l’autunno. Di certo non era la stagione o il passare del tempo a spegnere l’ardore che l’anziana tenutaria riservava ai suoi graditi ospiti che di volta in volta vi dimoravano per qualche breve periodo … «...dal giorno del loro arrivo a quello della loro dipartita, che sia da questo mondo o dall’altro in cui andranno a vivere, ah, ah, ah!», come le piaceva aggiungere salutandoli con sottile ironia alla loro dipartita.
Come del resto nulla mai cambiava nelle affezioni appassionate che Madame Rose riservava agli amici più intimi, a meno che non finissero per scalfire la sua sensibilità emotiva, soprattutto nelle notti in cui maggiormente avvertiva un’apparente fragilità dei sensi che la teneva sveglia, e che amorevolmente occupava a smistare le carte dei Tarocchi, «gli 'Arcani Minori' delle pene e dei rancori, e quelli 'Maggiori' dei gaudi e degli eccessi che si consumano in tutti i sensi», come le piaceva appellare certi suoi peccati di gola che le battute divertite dei suoi ospiti le attribuivano, non senza un pizzico di sarcasmo.
Così come pure accadeva nella computazione degli anni del suo fantasmatico ‘anniversario’ che ad ogni occasione i più intimi le conferivano, e da tutti annoverato come l’evento clou della loro permanenza alla Maison. E che fossero ottanta oppure cento, per lei … «...non hanno alcuna importanza», diceva sorridente nell’ammettere di averli superati, quand’anche confessasse … «...di averli finiti da tempo.»
Nondimeno Madame Rose era una maitresse d’eccezionale vivacità, mentore e consigliera di magnati e ambasciatori, nonché di giovani scrittori e musicisti che nei giorni migliori, specialmente in occasione di convegni e anniversari, riempivano la Maison di musica e d’arie famose, di versi poetici e conversazioni letterarie, finanche di applausi e risa ben educate che ella reclamava di voler mantenere sommesse e quanto più garbate … «..per non disturbare il silenzio nelle ore più tarde dedicate alla meditazione ah, ah, ah!», diceva ridendo, omettendo di specificare a cosa facesse riferimento in ciò che chiamava ‘meditazione’.
Di ben altra verve si rivelavano le arguzie messe in atto da Madame Rose nello scambio reciproco delle relazioni personali che imbastiva coi suoi ospiti più autorevoli in occasione del Simposio autunnale del Circolo Teosofico Internazionale, fondato da Madame Blawatsky nel lontano 1875, che si riuniva annualmente alla Maison de la Ville, ufficialmente per «...delineare le nuove prospettive iniziatiche in ambito esoterico-filosofico», affermava più che mai convinta.
«Un contributo culturale alla conoscenza universale», aggiunse, mentre andava riordinando le idee organizzative in funzione del suo prossimo ‘anniversario’, come pure lo definiva, in sostituzione di quella brutta parola che a parità d'intenti dicasi ‘compleanno’. Anniversario che Madame Rose pensava di far coincidere con la chiusura del Simposio in corso offrendo un pranzo sontuoso agli ospiti intervenuti, in modo da lasciare un segno della sua prodigalità, insieme al rinnovato invito a tornare in futuro alla Maison de la Ville. Il tutto all’insegna del motto da lei stessa coniato per l’occasione … «La fin ce n'est que le commencement!»
Una frase ‘emblematica’ che attribuiva al lessico segreto dei Tarocchi, il cui responso teneva in gran considerazione, allorché era chiamata a dissolvere un interrogativo persistente che l’aveva tenuta sveglia nottetempo. Al presente, l’interrogativo riguardava la partenza improvvisa di uno dei suoi ospiti prediletti, che nel tempo della sua permanenza alla Maison, aveva raccolto le sue personali confidenze e i suoi pettegolezzi più arditi, Marcel Proust. Un giovane scrittore che la inteneriva nel profondo; al quale riconosceva il pregio di una mente straordinaria, alle prese con il suo primo vero romanzo, di cui aveva molto apprezzato lo stile e la ‘verve’ della scrittura.
«Una partenza alquanto strana la sua, e per di più improvvisa, che la si direbbe quasi una fuga», pensò tra sé, mentre esaminava con particolare attenzione la composizione d'insieme delle 'carte' disposte sul piccolo tavolo del suo boudoir … «Benché anch'egli, come tutti del resto, è succube delle debolezze umane», aggiunse riflessiva, ponendo agli 'Arcani Maggiori' un interrogativo inusuale, quasi si trattasse di un abbandono che solitamente non si poneva, considerando il fatto che alla Maison c’era sempre gente che andava e veniva in ogni momento dell'anno, «..come al Grand Hotel, ah, ah, ah!», rise infine, pur essendone rammaricata.
«Oh no! Pouvre Marcel!», esclamò a fronte di una rivelazione che si ripresentava costante ad ogni volgere delle carte, una nota dolente che non gradiva affatto conoscere e che l’addolorava non poco; come per l'aggirarsi nel silenzio crepuscolare della stanza, di un male oscuro che presumibilmente affliggeva il suo amico e che ben presto avrebbe messo fine alla sua giovane vita.
«Marcel Proust, un nome che sarà ricordato a lungo», si disse nella certezza palpabile che lo porterà, ne era certa, a «..scrivere qualcosa di grande, più ampio di quello che la presenza, l’intenzione e la semplice percezione del momento potrebbero esprimere», si disse. Dacché lasciò di scandagliare più a fondo in quell’assurdo interrogatorio, per abbandonarsi poi sul divano di velluto damascato con gli occhi rossi di pianto.
«Suvvia, non c’è alcuna ragione perché Madame debba rammaricarsi in questo modo, su beva un po’ di questa tisana, l’aiuterà a contenere l’ansietà che gli addii talvolta creano negli animi più sensibili», la consolò Mimì, sua dama di compagnia che, entrata nella stanza con il suo solito garbo orientale, depositò sul piccolo tavolo ch'era lì accanto, il vassoio d'argento di pregevole fattura e la tazza di porcellana fine, da cui si sprigionava un intenso odore di gelsomino.
«In fondo si parte, si arriva, si riparte, non è forse sempre stata così tutta la sua vita?», vedrà, monsieur Proust tornerà presto a farle visita, come ha sempre fatto. Se non altro per recuperare il manoscritto che nella fretta di partire ha dimenticato di prendere con sé.»
«Che storia è questa Mimì, un manoscritto dimenticato da un nostro ospite di cui non mi si è detto nulla, di che si tratta?»
«Oh mi dispiace, pensavo Madame l’avesse notato, monsieur Proust lo ha lasciato proprio qui, sul suo scrittoio, prima di salutarla da basso, ma solo ora mi accorgo che non c’è più.»
«Se lo avesse lasciato lì, ci sarebbe ancora Mimì, non ti pare?»
«Infatti, non capisco, chiederò, vedrà qualcuno della servitù lo avrà spostato nel riordinare la stanza.»
«Non lo ritengo possibile, e poi cos’è questo manoscritto Mimì, perché non ne sono a conoscenza?»
«Oh si, forse ora Madame non lo rammenta, quando monsieur Proust era qui, era solito scrivere sulle pagine di un taccuino che teneva sempre con sé, ma questa volta no, erano dei fogli sciolti, come un incarto.»
«Un dossier?»
«Non saprei dire.»
«Spiegati meglio Mimì, quest'oggi mi sembri piuttosto evasiva, anzi direi restia ad aprirti con me. Cosa ti succede, adesso a mia insaputa ti allei con i nostri ospiti, arrivando finanche a nascondermi i loro segreti?»
«Oh nessun segreto Madame mi creda, c’è che non ho mai considerato monsieur Proust un ospite, vista la cura che lei stessa ha sempre avuto nei suoi riguardi e delle sue cose, per cui ho lasciato che si sentisse a suo agio e disponesse della casa come avesse voluto, come del resto ha sempre fatto.»
«Cerca quel manoscritto Mimì, potrebbe essere della massima importanza, non vorrei lo avesse dimenticato di proposito …»
«Affinché Madame lo leggesse, voglio penare … ma certo, è possibile.»
«Non ne dubito, sebbene recentemente mi è sembrato dibattersi tra passioni e desideri incontrollati... che abbia preso maggiore coscienza di sé nell’affrontare situazioni a lui sfavorevoli, chi può dirlo?»
«Lei può Madame, sempre così lungimirante nello scrutare nei destini degli altri.»
«Affatto Mimì, mi attribuisci facoltà che non ho, a nessuno è dato di scandagliare nell’animo umano, ancor meno in quello degli uomini. Rammenta, non si conoscono mai bene gli uomini, non fino in fondo, sanno essere imprevedibili in ragione della loro indifferenza alle problematiche femminili, ambigui come sono in tutto ciò che riguarda la profondità o l’altezza dei loro sentimenti. Sono lupi Mimì, sempre affamati di nuove prede da sbranare, assetati di sangue come vampiri che badano alla sola fonte dei loro istinti …»
«Per carità Madame, sa bene che mi spaventa sentire parlare di certe cose. Davvero non avrei mai pensato da parte sua una così nera considerazione degli uomini. Lei che da sempre ripone una strenua fiducia nelle passioni umane.»
«È vero Mimì, anche se me lo chiedo solo adesso, ma che non sia proprio l’esperienza che mi porta a pensare questo degli uomini? Tuttavia mi accorgo io stessa di non trovare una risposta da darmi.»
«Che cosa le succede Madame, qualcosa l’ha delusa?»
«La vita Mimì, la vita! Ma adesso cerca quel manoscritto sil vous plaît, sento un’improvvisa urgenza di volerne leggere il contenuto», aggiunse dubbiosa Madame Rose, nel lasciar riaffiorare alla sua mente un segreto inconfessato del quale, da sempre, si attribuiva una responsabilità irrevocabile, che la toccava nel profondo …
«Vado», aggiunse Mimì.
Dacché Madame fu colta da un improvviso risentimento verso Marcel, nel dubbio atroce ch’egli potesse aver svelato nel suo manoscritto una qualche confidenza che lei stessa, sua mentore e ispiratrice, riteneva inenarrabile, riguardanti certi sentimenti che a suo tempo l’avevano travolta e che «...tornavano a rendere amara la sua esistenza», aggiunse riflessiva, tuttavia cercando di allontanare quell'incombente dubbio dalla sua mente.
Perché ogni cosa che in passato pur fosse accaduta, riguardava soltanto lei ... «...ormai non era più di nessuna importanza», si disse. Quel che più contava adesso era sapere se Marcel avesse o no violato il suo segreto in quel manoscritto che aveva dimenticato e che poteva aver suscitato la curiosità altrui. Proprio non le riusciva di concepire una tale leggerezza da parte di Marcel, che arrivasse a sacrificare la sua intima affettuosità con l’inconciliabile irrealtà di qualunque personaggio del suo romanzo che non fosse lei, fatto era che quanto accaduto le sembrava alquanto irriguardoso.
«No, Marcel non si sarebbe mai lasciato andare in uno sdoppiamento inconciliabile a totale discapito dei suoi mentori prediletti, per poi svelarne gli inganni nel falò delle vanità dell’attuale società parigina … e per di più prevedendo che sarebbero perpetrati a suo stesso svantaggio», si disse intravedendo una qualche possibilità d'inganno, e tuttavia elaborando una sua errata convinzione.
«Mimì, si può sapere dove sei finita?», le chiese al suo rientro nella stanza.
«È incredibile, non v'è traccia del manoscritto. Ho guardato dappertutto più di una volta, non mi resta che chiedere alla servitù, sempre che Madame sia d’accordo?»
«C’è una particolare ragione Mimì perché tu non l’abbia già fatto?»
«No ma, recentemente ho dubitato molto che qualcuno si sia intromesso nei nostri rapporti Madame, poiché trovo che lei non sia più la stessa nei miei confronti.»
«C’è che sei diventata gelosa Mimì, è segno che stai invecchiando.»
«Forse, ma si da il caso che lei non si fida più di me.»
«Che sciocchezze t’inventi adesso, sil vous plaît Mimì, fai venire qui la servitù, voglio vedere le loro facce una per una, ma non credo siano capaci di nascondermi qualcosa. Che mai ne farebbero di un manoscritto di un giovane sconosciuto?»
«Immagino nulla, sebbene una delle ragazze più giovani potrebbe, come dire, avervi voluto curiosare.»
«Chi, per esempio?»
«Non saprei, ma forse Magdeleine...?»
«Ascoltiamola, falla venire da me e visto che sei gelosa di lei, resta anche tu, se non altro potrai appurare la tua immodestia», replicò Madame Rose sorridendole con dolcezza, non senza un pizzico di quella civetteria tutta femminile che la distingueva.
Magdeleine non era il tipo di ragazza da prendersi una qualche iniziativa senza prima averne chiesto il permesso, soprattutto nel rispetto del professor Stephan, del quale Madame Rose sembrava apprezzare la compagnia e che lo poneva al di sopra della comune rispettabilità.
«Vieni pure avanti Magdeleine, una brava ragazza come te non avrà certo soggezione a confidarsi con una signora attempata qual io sono, suvvia dimmi...»
«Madame sa che può fidarsi di me. Certamente ho veduto il manoscritto, era poggiato proprio lì, sullo scrittoio, l’ho solo spostato per spolverare…»
«Spostato dici, per metterlo dove?»
«No, mi scusi, volevo dire sollevato.»
«E non hai dato una sbirciatina al suo contenuto, dico così, per pura curiosità?»
«Mais no, Madame.»
«E immagino tu non sappia neppure di cosa parlasse, è così Magdeleine?»
«Di fantasmi!», si lasciò dire imprudente la ragazza, tradendo la sua precedente ammissione.
«Devo quindi pensare che dei fantasmi si aggirino in questa casa, che si appropriano dei manoscritti altrui e di chissà quant’altre cose? Non sarebbe poi così improbabile, del resto ognuno di noi si porta dietro qualche misfatto, non è così Mimì?», soggiunse infine Madame Rose, il cui sguardo lasciava intendere un biasimevole provvedimento da prendere nei confronti della ragazza.
«Oh sì Madame», convenne Mimì evitando di aggiungere altro al suo dire nel licenziare con un cenno della mano, la giovane cameriera.
«Se non si amano i fantasmi, non cercateli, non chiamateli e, soprattutto, non fategli del male, perché probabilmente il male lo hanno già ricevuto in quanto spiriti eletti che sopravvivono in noi che li abbiamo creati.»
«Un’altra perla della saggezza di Madame che ricorderò, onde annoverarla ai nostri ospiti nel caso dovessero lamentarsi di qualcosa di inaspettato che dovesse accadere qui alla Maison.»
«Perché Mimì, hai forse udito qualcosa in proposito?»
«Beh, non in ultimo il professor Stephan proprio in riferimento alla partenza inaspettata di monsieur Proust, disse che la Maison non sarebbe stata più la stessa.»
«In qual senso?»
«Ma, non saprei, il professore asseriva senza darne spiegazione che alcuni suoi personaggi letterari così fortemente drammatici, sarebbero rimasti qui, che si sarebbero aggirati in queste stanze dove hanno trovato la loro ragion d’essere, creati dalle fantasticherie del nostro inconscio quotidiano.»
«È quanto ha detto?»
«Mais ouì Madame … ha anche aggiunto che il dramma della loro esistenza stanzia in tutti coloro che li hanno suggeriti o forse vissuti in prima persona, ma ammetto d’aver trovato tutto questo spaventoso.»
«Mia cara Mimì, non devi prestare ascolto ad ogni cosa che viene detta, il professor Stephan parla dall’alto del suo essere filosofo, per lo più insegue i fantasmi della sua eccentricità … talvolta mi sorge il dubbio ch’egli stesso altro non sia che uno dei personaggi creati da Marcel.»
«In verità Madame ho sempre pensato che quella che indossa sul volto sia una maschera … sempre così pulita, il trucco perfetto, con i suoi papillon indossati come orpelli di scena di un teatro demodé.»
«Tu dici Mimì? … già, una maschera, il trucco? Sai che non vi avevo mai pensato.»
«Sì, proprio come un teatrante che si muove nell’ombra della scena, il cui apparire improvviso talvolta crea un certo imbarazzo, tra l’ambiguità del passato e l’assolutezza del presente.»
«Illazioni le tue Mimì dovute ai tuoi pregressi teatrali che ti trascini dietro dall’Oriente. Devo dire che il professor Stephan si è sempre dimostrato un fedele amico e un perfetto gentiluomo, chi più di lui?»
«Oh sì, una persona di belle maniere e al tempo stesso riservata, ma ciò non toglie che potrebbe rivelarsi un despota nascosto nell’ombra …»
«Dici così per dire Mimì o lo pensi davvero?»
«Affatto Madame, la letteratura è stracolma di Jago, è il dramma che si consuma sulla scena che lo richiede a un non protagonista in cerca d'una qualche possibilità di affermazione.»
«No, non mi sembra gli si attagli la doppiezza della maschera teatrale che gli attribuisci, semmai sembrerebbe recitare a soggetto, senza copione né parte, perché non sa ciò che potrebbe succedere domani a Parigi, siamo tutti precari su questo palcoscenico.»
«Eppure Madame, nella realtà egli sembra vivere dentro un copione che lo contempla, anche se fuori del tempo, fuori da questo mondo che in parallelo col passato chiede di entrare nel presente amabile delle sue grazie…»
«Se alludi a qualche avance Mimì devo deluderti perché il professor Stephan non ha mai ambito alla mia mano, semmai alla mia amicizia … da che, nel 1914, ai primi barlumi della guerra, fu costretto a fuggire dal suo paese d’origine la Polonia e a trovare rifugio qui a Parigi, per poter infine entrare in quel Tempio della filosofia per eccellenza che è la Sorbona.»
«E di questa Maison», insisté Mimì.
«Immagino tu abbia letto il manoscritto, è così Mimì?»
«Mais no Madame, ho ancor più ragione di credere che monsieur Proust lo abbia lasciato appositamente sulla sua scrivania affinché lei lo leggesse.»
«Cos’altro Mimì?»
«Rammento che parlando al professor Stephan monsieur Proust manifestò l’intenzione di voler lasciare qualcosa per ringraziarla di quanto aveva fatto per lui in tutti questi anni, e che spettava a lei decidere cosa farne, se autorizzarne la pubblicazione o se darlo alle fiamme... immagino parlasse del manoscritto.»
«Farne un falò, tu dici? Forse ha ragione nel sostenere che spetta a ognuno di noi restituire ai nostri ‘fantasmi’ la dimensione del presente, per essere noi davvero presenti a noi stessi … saremo mai in grado di farlo? Si'l vous plaît Mimì vorrei restare sola, ho bisogno di riflettere, nel frattempo recupera il manoscritto, non può essere svanito nel nulla.»
«Ho pensato che monsieur Proust potrebbe aver avuto un qualche ripensamento tardivo ed essere tornato a prenderlo? … Ma no, l'avrei comunque visto ... che forse il professor Stephan potrebbe … essendo egli l’unica persona che in questi giorni ha avuto accesso alla Maison?»
«Ho compreso Mimì, ora lasciami si'l vous plaît, e continua a cercare, dovrà pur essere da qualche parte.»
«Mais oui, professeur Stephan? …», chiese Madame, allorché sollevata la cornetta lo chiamò alla Sorbona.
«Certainment qu'oui!»
«Je souis Madame Rose, avrei desiderio di vederla al più presto, se le è possibile quest’oggi stesso.»
«Potrei essere da lei attorno alle cinque del pomeriggio, se le sembra un’ora opportuna?»
«Bene, l’aspetterò per il Té.»
«C’è qualcos’altro che desidera, Madame?»
«Null’altro che la sua presenza, merci.»
Presagendo una qualche contrarietà nella voce severa di Madame Rose, il professor Stephan intuì la possibilità di dover rispondere a una qualche domanda riguardante il manoscritto consegnatole a sua volta dalla giovane Magdaleine dietro compenso di un semplice complimento. Quindi, dopo aver preso con sé l'incarto e averlo messo nella sua borsa, si avviò a piedi verso la Maison, fermandosi in una rinomata pâtisserie lungo la strada dove acquistò una scatola di Bon-bon onde deliziare il raffinato palato di Madame Rose che andava pazza per i dolci.
Accolto con la squisita gentilezza di chi riceve un ospite gradito, Madame Rose lo attendeva seduta nel chiosco a vetri che aveva fatto posizionare sulla terrazza del piano nobile, attraverso cui poter ammirare ogni angolo del giardino.
«Madame Rose voglia accettare i miei riguardevoli omaggi», sussurrò appena Stephan nel baciarle la mano, dopo aver consegnato il piccolo cadeau nelle mani dell'attenta Mimì.
«Guardi professore, le mie petunie … che meraviglia! Quest’anno sono più belle che mai - ostentò Madame, alzando appena di un tono la voce - le osservi lei stesso professore, non sono splendide?»
«Davvero incantevoli!» si limitò a dire Stephan, non sapendo quali fossero le petunie, in mezzo a tanta varietà di fiori sparsi in ogni angolo di quel fantastico giardino che Madame affidava alle cure di un floricoltore esperto.
«Davvero amorevoli. Del resto tutto ciò che riguarda Madame è notevole per la sua cura», aggiunse Stephan.
Chiunque nell'incontrare Madame avrebbe apprezzato la sobria eleganza di quel pomeriggio che la vedeva indossare un bell’abito blu sfumato di celeste cielo, da far pensare a un voluttuoso ritratto di Giovanni Boldini. Il suo volto ovale straordinariamente luminoso, lasciava appena intravedere i segni dell’età che avanzava inesorabilmente, per quanto ella mostrasse un incarnato roseo quasi trasparente che donava un che di regale alla sua elegante figura.
Al dunque Madame Rose con aggraziata nonchalance lo invitò a sedersi al piccolo tavolo apparecchiato in maniera ineccepibile, sì che egli non poté fare a meno di notare la ricercatezza dei merletti posti sotto ogni tazzina e ancor più raffinati sotto la teiera e al porte-biscuit, come del resto a ogni altro pezzo dell’intero servizio di porcellana fine, e l’intera esposizione di cucchiaini d’epoca inneggianti alla ‘grandeur’ napoleonica.
Mimì dopo aver accolto nelle sue mani il grazioso vassoio della pâtisserie, lo scartò e lo depose sul piccolo tavolo, non senza averne offerta la visione a Madame Rose che se ne servì con gioia, stemperando così la tensione che l’aveva colta nel tempo dell’attesa. Tuttavia, pur mantenendo una cauta riservatezza, Madame attese ancora qualche istante prima di dare inizio alla conversazione, fin quando Mimì preso commiato con un rispettoso inchino, li lasciò soli.
«Si aspetta qualcuno a tenerci compagnia?», chiese il professor Stephan osservando il tavolo apparecchiato per una terza persona.
«In verità doveva essere una sorpresa mio caro Stephan, comunque, visto che l’ospite che avrebbe dovuto onorarci quest’oggi della sua presenza non può essere ovviamente con noi, direi di iniziare.»
Il Tè venne presto servito da una minuta Shaky d’origine indiana, o forse pakistana, la quale, depositata la teiera con un inchino, li lasciò alla loro conversazione …
«Ed io che credevo egli fosse ancora qui … chissà poi perché se altresì ero informata della sua vicina partenza. Ma, pensiamo ad altro.» si lasciò dire Madame, dopo un primo sorso di Tè.
«Ça và sans dir le professeur, le manifestazioni più tipicamente umane possono essere comprese solo in un contesto in cui facciamo le cose pensando ad altro. O almeno, richiamandoci agli altri quando questi non sono ormai presenti», soggiunse Madame.
«Mi sfugge il pieno senso di ciò che dice Madame Rose, devo essermi distratto, voglia scusarmi.»
«Nel senso che pretendere comprensione non è la stessa cosa che farsi comprendere. È quanto dicevo poco fa con Mimì riguardo a una sua presunta idea che dev’essersi fatta di lei, professor Stephan.»
«È così, il primo requisito d’una buona conversazione sta nello sforzo di sapere da chi vogliamo essere compresi. Non si può pretendere che gli altri recepiscano ciò che noi riteniamo sia espresso nel modo migliore … spesso accade il contrario. A lei non accade, Madame?»
«O sì, ancor più se riguarda qualcuno che in questo momento ha bisogno di tutta la nostra comprensione.»
«Stiamo parlando di Marcel Proust, immagino, è forse a conoscenza del perché della sua partenza improvvisa?»
«Devo ammettere che talvolta la sua perspicacia davvero mi sorprende, professore.»
«D’accordo, ma …»
«Nient’affatto professore, in questo caso non sussiste alcun ma che risponda per noi, e lei non può confutare di aver trafugato il manoscritto che Marcel prima di partire ha destinato al mio beneplacito. Alla sua età non dovrebbe avere più bisogno di uno sguardo garante per essere quello che è, una persona che d’un tratto si rivela inaffidabile…», azzardò inopportuna Madame.
«Ho l’impressione che sopravvaluti le sue aspettative, di certo Madame non mi aspetto una maggiore considerazione per essere quello che rappresento per lei, così come non intendo privarmi della sua benevolenza.»
«Mais no le professeur, anche se credo abbia le mie stesse identiche ragioni di essere preoccupato, non è forse così?»
«Ascoltandola mi tornano a mente le parole del vecchio Goethe, nel dire che “sapersi amato dà più forza che sapersi forte”, anche se non è affatto questo il mio caso. Sapermi amato da sempre mi sospinge nell’inferno degli altri, non mi si chieda perché.»
«Dev’esserci indubbiamente una ragione che andrebbe scandagliata, non crede?»
«Forse c’è, nella misura in cui gli altri con i loro sotterfugi, i loro biasimi, le loro ipocrisie, non esitano a rivelare un sentimento che si credeva puro verso chi si ama e scoprire che non lo è mai stato. Quasi che il loro amore sia offerto in olocausto su un vassoio d’argento, mentre viceversa quello che ricevono chissà perché è solo di peltro …»
«Pensa a un inganno della vita o solo a una disillusione?»
«Come scrisse un poeta italiano d’altri tempi, Francesco Petrarca: "C'è negli animi umani un certo perverso e morboso piacere di ingannare se stessi, del quale nulla, nella vita, può essere più funesto". È così che l’amato giace inerte in attesa della grazia dell’amore dell’altro, di colui che dice di amarci, anche quando è proprio l'amore a spingerlo incontro alla morte.»
«Si'l vous plaît le professeur, non usi più quella brutta parola in mia presenza, mi rattrista, soprattutto quando è rivolta a un interlocutore assente, benché abbia nel nostro cuore un nome e un cognome insostituibili.»
«Mi dispiace Madame, ma credo che malgrado tutto, nessuno possa essere altro da ciò che lo rende credibilmente umano, per quanto la consapevolezza della fine ci renda tutti mortali allo stesso modo, penso che a lungo andare la sola sofferenza d’amore ci trasformi in esseri immortali o viceversa, in poveri martiri.»
«Una considerazione filosofica questa che mi rende la consapevolezza di non essere vissuta così tanti anni invano; anzi tutt’altro, conferma la mia certezza di voler vivere a lungo e poter dare un senso alla mia vita, sarà poi il destino a decidere, quando non l'abbia già deciso … se non altro per conoscere come andrà a finire, ah, ah, ah!», confutò Madame con quel pizzico di sarcasmo che sempre la distingueva.
«Purtroppo è proprio questa la manifestazione più accreditata, la certezza della fine che tutti ignoriamo, ma che vorremmo conoscere quando siamo ancora in vita.»
«Non è detto che ciò debba accadere molto presto, almeno è quel che spero. Tuttavia rispondo alla sua affermazione, con una personale idea che ho maturata nei confronti della vita: è precisamente questa ‘certezza della fine’ come lei dice, la missiva della ragione di cui noi tutti condividiamo l’uso.»
«Vale a dire il diffondere la nostra opinione sulla fine affinché la si discuta, la si accetti o la si rifiuti, e non soltanto per vederci confermare le nostre ragioni. Entrambi siamo qui per questo, per condividere quasi tutto di quel che facciamo o diciamo per sentirci vivi, altrimenti ci sarebbe poco da fare e quasi nulla su cui riflettere», aggiunse Stephan, rammaricato che il discorso avesse preso una piega tanto amara.
«Dunque lei, in quanto filosofo, non crede che la corretta lingua parlata da entrambi oltre a farci comprendere reciprocamente, serva a che si debba anche essere sinceri l’un l’altro?»
«Tutt’altro, lo asserisco fermamente! Per quanto non è del linguaggio che si stava trattando mia cara, quanto di aprirsi a una filosofia della vita che non contrasta con i più sani principi della sincerità.»
«Lei forse ritiene che la filosofia possa creare fantasmi raziocinanti capaci di far sparire un manoscritto da questa casa senza alcun consenso, è così?»
Il rossore improvviso che d’un tratto rese paonazzo il volto del professor Stephan si spense dietro un pallore altero, facendolo sembrare un manichino senz’anima ridotto al silenzio.
«Non creda che una simile accusa possa da me essere accettata così impunemente, tuttavia si sbaglia Madame Rose, ha invece tutta la mia comprensione, come del resto le confermo tutto il rispetto per quanto nel manoscritto è rivelato …»
«No, certo, del resto neppure la sua filosofia contempla chi pure rimane per sempre con noi … a volte mi sembra di sentire la voce di mia sorella Martha, la sento aggirarsi attraverso le stanze di questa casa e che mi chiama…»
«Mortale è chi muore in noi, non chi portiamo nel nostro cuore, è bene rendersene conto.»
«Davvero lo crede? Io stessa parlo con lei qualche volta, nei giorni di vento, quasi che con il vento arrivi un afflato del suo respiro e sollevi le tende della nostra stanza, quando sono assopita. Ancor più quando s’avvicina il temporale. È allora che la sua presenza mi da la consapevolezza di qualcosa insito nel legame affettivo condiviso del nostro essere sorelle, amiche, e al tempo stesso amanti l’una dell’altra.»
«Comprendo ogni cosa Madame e ne sono addolorato, se mai ha temuto che la sua confessione venisse svelata in uno scritto, ebbene confermo che proprio attraverso le pagine del manoscritto sono venuto a conoscenza del segreto che l’attanaglia. Un gesto deplorevole da parte mia, ma la prego, che almeno mi si risparmi il biasimo. Come lei, anch’io temevo vi fosse rivelata una mia inconfessata debolezza, probabilmente attribuita alla mia persona nella rilevanza creativa dell'immaginario confessato dal suo autore.»
«Immagino sia questo ciò che sta cercando così affannosamente?», aggiunse Stephan, allorché recuperato il manoscritto dalla sua borsa lo consegnò nelle mani di Madame.
«Mi si passi l'averlo preso volutamente e di averlo letto nel caso vi fosse detto qualcosa della mia intimità, mentre invece nel manoscritto si parla esclusivamente della sua, Madame. Non di meno vorrei evitarle l'ulteriore strazio di leggere quelle cose che sono certo la rattristerebbero.»
Madame Rose che lo aveva ascoltato in silenzio, non trovando alcuna simulazione d’intenti per quanto accaduto, apprezzò molto il suo gesto spontaneo, più che mai convinta dell'onestà del professor Stephan. Così come fu certa della fiducia che da sempre Mimì riponeva in lei, allorché entrando con un piccolo vassoio d'argento nelle mani, recò un biglietto per Madame che, dopo averne letto il contenuto, palesò in volto il suo profondo rammarico.
«Qualcosa non va, Madame?»
«Nulla professore, è solo la defiance di un attimo, voglia scusarmi. Per quanto, riflettendo su ciò che Marcel possa aver narrato nel manoscritto, di quel ch'io stessa possa avergli narrato, va detto comunque ch'egli non era presente al tempo dell'accaduto, pertanto ogni sua rivelazione è di parte e in ogni caso riguarda solo me. Tuttavia, stando a quel che lei mi riferisce, dopo aver letto il manoscritto, posso ben condividere ogni cosa con lei, e non abbia timore di rivelarmene il contenuto … si'l vous plaît le professeur?»
«È così, il nostro scrittore narra di fatti che forse non ha vissuto in prima persona, ma certamente deve aver elaborato da una qualche sua rivelazione Madame, altrimenti come potrebbe parlare di un fantasma che s’aggira imperturbabile nella Maison, ipotizzando un oscuro segreto sulla scomparsa di sua sorella Martha, succube di una pena coscientemente inflittale per una morbosa gelosia …»
«La prego, non vada oltre …», esclamò Madame Rose incollando i suoi occhi in quelli del professor Stephan, intendendo con ciò di non proseguire nella narrazione, convinta che in fondo fosse un bene per lei non aver letto il contenuto del manoscritto nella sua intera stesura ... la ringrazio ma non intendo sentire altro, la prego ... lo faccia sparire!», aggiunse in fine piena di rancore restituendo il manoscritto nelle mani del professore.
Mai fino a quel momento Madame Rose aveva mostrato in presenza di alcuno una così oppressiva emergenza psicologica tale da dover frenare una qualche reazione incontrollata che avrebbe potuto condurla a un’azione folle o, come era accaduto in passato, di imminente quanto colpevole fuga …
«Ancor meglio sarebbe darlo alle fiamme, che bruci all'inferno insieme al suo autore!», esclamò Madame piena di rancore.
«È davvero quello che vuole?»
«Sì la prego di farlo sparire, lo distrugga, e che sia per sempre», aggiunse poi riflessiva, non sapendo dove posare il suo sguardo dopo l'avvenuta rivelazione.
«Sarà fatto come lei desidera, Madame...»
«Mimì! Mimì! - chiamò ripetutamente Madame attendendo il suo immediato arrivo - il prosessor Stephan ci lascia, lo accompagni si'l vous plaît … mi scusi professeur et merci, a bientôt», quindi si accomiatò in tutta fretta risalendo la scala interna che conduceva alle sue stanze private.
Al suo ritorno Mimì trovandola stravolta come non mai, fece per soccorrerla. Dopo averla aiutata a spogliarsi e a mettersi a letto, le chiese se avesse gradito un po' della sua compagnia ...
«Si'l vous plaît Mimì, adesso lasciami, fai in modo che non venga disturbata per nessuna ragione.»
«Come Madame desidera, soggiunse Mimì augurandole un sereno riposo.»
Nelle ore di dormiveglia agitato che seguirono, a Madame Rose tornarono alla mente alcune frasi di rimprovero ascoltate molto tempo prima durante una controversia che le risuonava famigliare …
«Non siamo soli, qualcuno ci osserva attraverso le pareti, e tu sei una impudente sgualdrina a comportarti così, davanti a tutta la famiglia.»
Per quanto, all’epoca dei fatti narrati, l’opinione degli altri non avesse per lei alcuna importanza, quelle parole pronunciate da sua sorella Martha con tanta veemenza, non esitarono a contrastare la sua presa di posizione di voler lasciare la Maison, che all'epoca fu giudicato un gesto folle dai suoi congiunti. Ne accusò il dolore profondo, convinta come allora di detenere un vantaggio esclusivo su tutti, una probabilità maggiore di chi, come Martha, non era affatto sicura di averlo: ‘la convinzione di poter raggiungere l’irraggiungibile’. Ma lei quella convinzione l’aveva riposta nella sua pazza idea di rincorrere l’amore per Alphonse, quel fidanzato che Martha aveva poi sposato e che Rose avrebbe voluto per sé.
Fu così che, quasi d’improvviso, si rivide lontana negli anni della sua giovinezza, sorridente e imperturbabile che attraversava correndo l’interminabile corridoio che collegava le stanze del piano nobile e raggiungere la scala sul retro della Maison che le avrebbe permesso di raggiungere il giardino …
Più che mai adesso, rammentava di non aver avuto alcun ripensamento, né un attimo d’incertezza, lei «...fuggitiva da tutto e da tutti, per sempre», che si allontanava dalla Maison, correndo all'impazzata attraverso il sentiero per raggiungere Alphonse, certa ch'egli la stava aspettando al bordo del parco per fuggire con lei, ma non era stato così.
A distanza di tempo nessuno ricordava quanto occorso alla Maison de la Ville in quegli anni lontani; né si seppe mai nulla dell'oscura morte della signora Martha, successiva alla partenza dell’amato sposo Alphonse per la guerra, da cui non avrebbe più fatto ritorno. Tantomeno dell’allontanamento da Parigi di sua sorella Rose che si disse andata in sposa per procura a un anziano console di stanza in una colonia francese d’Oltremare.
Dacché la vetusta Maison de la Ville, rimasta chiusa per moltissimo tempo, finì per essere inglobata nella città che le cresceva attorno, ormai considerata un cimelio di un lontano passato, e che finì pressoché cancellata dalla memoria dei parigini. Finché un giorno, rimasta vedova, Madame Rose aveva fatto ritorno a Parigi dall’estremo Oriente e volle restituirla al suo originario splendore, trasformandola in una dimora residenziale esclusiva, per una clientela molto selezionata.
Tale era la sua riservatezza che ormai solo alcune guide, tra le più vecchie ed esperte e qualche fidato chauffeur de taxi sapevano come raggiungerla. Ma solo dietro presentazione di un invito scritto rilasciato da Madame Rose, o che lei stessa avesse richiesto un tale servizio, e che, altrimenti, non sarebbe stato loro permesso l’accesso.
Sul filo dell’ostinata dimenticanza di Madame Rose dei fatti che avevano contrassegnato gli anni della sua giovinezza, la Maison de la Ville aveva ripreso la sua attività per così dire 'consolare' annoverando numerosi ospiti di prestigio, e per quegli ‘amici degli amici di una certa classe’ che, in ragione di una qualche raccomandazione erano in cerca di una pausa confortevole dalla frenetica consuetudine del quotidiano, senza tuttavia allontanarsi da Parigi.
Avvenne così che di tanto in tanto, una volta entrato nelle grazie di Madame Rose, Marcel Proust era solito farle visita per diletto, in ragione di venire a contatto con certe persone della 'bonne societé' piuttosto in vista, alle quali era solito dedicare le sue attenzioni di scrittore, e non solo. Conoscenze che, in seguito avrebbe trasferito sotto altro nome ne La Recherche, l’opera a cui lavorava ormai da qualche tempo.
In quegli anni, una sorta di straordinaria quanto occulta intuizione, aveva permesso a Marcel di focalizzare in Madame Rose una figura dalla doppia personalità: l’una charmant e flessuosa quanto determinata, come una perfetta 'maitresse royale' che padroneggiava austera la corte immaginaria della Maison avvolta in un'aura di grandezza nobiliare. L’altra, più intima, fragile come una porcellana di Sévre in bilico su di un vassoio d'argento, che coltivava in seno una sofferenza profonda, capace di vagheggiare immagini e figure del passato che tornavano ad affacciarsi alla sua mente nei momenti bui di certe notti, in cui più avvertiva la presenza del fantasma di Martha aggirarsi nella sua stanza da letto.
Allorché assalita dall’ansia, Madame Rose si disse che avrebbe gradito la compagnia di Mimì, che le sarebbe stato di conforto ascoltare la sua voce cantilenante leggerle qualcosa e, quindi, la chiamò ripetutamente invitandola ad entrare. Mimì che, in ogni occasione, sostava fuori della sua stanza, entrò e si sedette accanto al suo letto, e aperto il libro di poesie che a suo tempo il caro Alphonse aveva regalato a Madame, in occasione di un suo 'compleanno', prese a leggere con voce sommessa una poesia di Emily Dickinson tradotta dall'inglese ...
“Era come sentire nel proprio intimo le avvisaglie di una prima incrinatura verso l’eterno. E tuttavia non ancora verso l’immortalità.”
Mimì vedendo che Madame si era un poco assopita, fece una pausa momentanea, tuttavia chiese a Madame se voleva che andasse avanti nella lettura, oppure …
La riflessione contenuta in quelle frasi aggravò la fragile quietudine di Madame, quasi che le parole le giungessero dall'altra parte di un modo estremo che lei aveva appena sfiorato …
«Ti prego Mimì, sceglierne un’altra si'l vous plaît» …
Dacché l’attenta Mimì sfogliate alcune pagine del libro soffermò lo sguardo su una a caso e riprese a leggere con voce pacata …
“Gli spiriti normali / ritengono che il sonno / sia solo un chiuder gli occhi. /…/ Ma la mattina non è sorta ancora!” /…/ “Una rossa signora sopra il colle / mantiene il suo segreto! Eppure, come resta tranquilla la scena! / Che indifferenza mantiene la siepe! / Come se la “resurrezione” / non fosse niente di strano!”
Di colpo, l'immagine sfocata che s'impresse negli occhi di Madame, altri non era che quella di Martha nei panni della rossa signora che s'aggirava nei pressi di un colle coperto di gigli, testimoni della sua avvenuta resurrezione dopo il sonno profondo della 'morte', il cui lontano segreto custodito nel tempo, le riapparse improvviso sul volto sfigurato benché vivo di sua sorella. Era molto più di quanto il simbolico pronunciamento dell'Arcano Maggiore che ripetutamente quella sera si era presentato sul desco della sua interpellanza, stesse a significare. Come se per una sorta di affettiva presenza emozionale, il fantasma di Martha si spingesse a cercare nella sua fragile esistenza le ragioni della propria infelice assenza ...
«Era un invito quello, rivolto a svelare qualcosa di nascosto, o forse solo a mantenerlo segreto nelle chiuse stanza dei ricordi?», si chiese.
«Chissà mai perché c’è sempre la nebbia in ogni situazione che non si comprende?» aggiunse Madame Rose con la vista leggermente annebbiata, allorché poggiata una mano sul libro fermò la voce di Mimì e pian piano socchiuse gli occhi abbandonandosi al torpore che la fece assopire.
Tuttavia non riuscì a evitare che dal forzato silenzio insorgessero i fantasmi del passato, e d'un tratto, nell'incedere evocativo del suo intimo segreto, Madame Rose scorse nel nero più profondo, il vivido riflesso di una supplica persuasiva, una richiesta d'aiuto che sapeva di riscatto ...
Il fantasmatico volto opale della rossa signora le apparve nel buio della stanza osservandola dai piedi del letto. Indossava una camicia da notte di mussola con piccoli fiorellini delicati, tenendo fra le mani alcuni gigli da poco sbocciati. Aiutami Rose, disse, e con il braccio teso la invitò a levarsi e a seguirla. Rose non fece domande, si alzò dal letto e indossata una vestaglia, la seguì attraverso un lungo corridoio interminabile.
Quindi, discesa la scala che portava al piano terra della Maison s'affrettò per starle dietro. Aveva appena attraversato il salone quando Martha si spinse verso la porta d’ingresso rimasta aperta e sparì oltre la soglia. Rose provò un attimo d’incertezza e scalza oltrepassò la porta immergendosi nella fitta nebbia che le offuscava la vista.
Era a pochi passi da lei eppure non riusciva a raggiungerla. La rossa signora si voltava di tanto in tanto a guardarla in silenzio, implorandola muta di non fermarsi, di seguirla, ma ad ogni passo avanzato di Rose si allontana correndo a piedi nudi sull’erba bagnata. Rose la inseguì finché presa dall’affanno, inciampò e cadde distesa sull’erba, al limite del parco.
Quando, risollevò lo sguardo vide Martha attraversare la strada, dirigersi verso un piccolo cancello ed entrare in una costruzione bassa con grandi finestre sulla facciata. Rose la seguì ma una volta affacciatasi sulla porta le andò incontro un’infermiera vestita di bianco, dall’aria alquanto sospettosa ...
«Che cosa ci fa lei qui? Che cosa vuole?»
«Io... non saprei, qualcuno ha bisogno di me, mi ha condotta fin qui.»
«Non c’è nessuno qui che può aver bisogno di lei. I malati più gravi sono stati portati all’ospedale centrale. Piuttosto mi dica perché è in quello stato? Se ne vada o chiamo la …»
«No, aspetti, la prego mi ascolti. Una donna dai capelli rossi ha chiesto il mio aiuto, potrebbe essere in pericolo di vita. È appena entrata qui, io l’ho veduta.»
«Non è entrato nessuno qui, a quest’ora di notte. È un medico lei?»
«No, sono una parente.»
«Mi dica, è sicura di sentirsi bene?»
«Si, credo di si.»
«Aspetti, lei ha bisogno di un calmante. Poi mi prometta che se ne torna da dove è venuta. Anche perché non c’è nessuno qui, tutte le stanze sono vuote.»
«Ne è sicura?»
«O santo cielo! Faccio il turno di notte e so perfettamente quali sono le mie competenze.»
«Non s’inquieti, per favore, dicevo così, tanto per dire. Perché non se ne accerta? Le dico che è entrata una donna qui, poco fa, che aveva bisogno d’aiuto. Mi creda. La prego.»
«D’accordo, va bene mi segua, così se ne accerterà di persona.»
Quindi si avviarono entrambe per un lungo corridoio bianco, con alcune porte chiuse anch’esse bianche che l’infermiera apriva una dopo l’altra lasciandole constatare che all’interno erano irrimediabilmente vuote. Rose la seguì passo passo in silenzio, guardandola desolata. Avrebbe voluto scusarsi con lei ma l’infermiera si allontanò, lasciandola sola nel mezzo di un'ultima stanza.
D’improvviso la vide, la rossa signora cerulea nel volto disfatto giaceva distesa su un letto coperta da un bianco lenzuolo con gli occhi sbarrati. Rose era confusa, la trovava più vecchia di quanto le era sembrata solo qualche momento prima …
“Nell’assoluto mi sembrava assorta / di splendore e di cielo pensierosa. / L’onore di scrutarla con i miei occhi / fu di breve durata / disinvoltura argentea, la sua / nel volteggiare fuori dalla vista. /…/ ma ero troppo in basso per seguire / l’altissimo suo viaggio / la sua cerulea superiorità.”
Erano ancora le parole di Emily Dickinson a risuonarle nelle orecchie che Mimì seguitava a leggere durante il dormiveglia di Madame. La quale, svegliatasi di soprassalto, si guardò attorno desolata. Mimì non era più con lei, tuttavia la lampada sul comodino era ancora accesa, il libro aperto a pagina settecento quindici …
«Eccomi, Madame ha chiamato?», domandò Mimì entrando, quasi scusandosi per averla lasciata sola.
«Non dire nulla ti prego.»
«Cosa c’è Madame, non si sente bene?»
«Non ho riposato affatto.»
«Spero non a causa della lettura … magari non è stata di suo gradimento?»
«Invero Mimì, temo che il messaggio intrinseco di quelle parole contenessero qualcosa di cui dovrei temere.»
«Ne sono desolata, io di certo non l’ho apprezzata più di lei per quel suo lato oscuro cui sono riflesse alcune verità occulte che non ritengo utile indagare.»
«Ma che dici mia cara, c’è un lato oscuro delle cose che in qualche modo affascina. È un po’ come voler scandagliare l’altra faccia della luna, che non si vede ... “eppure so che il suo passo stillante si volge sempre in giro”. Ecco, forse ci sono, è questo verso che riassume il senso nascosto di quella poesia: oscura come l’altra faccia della luna, che sappiamo esserci ma che nessuno vede.»
«Come di un segreto nascosto Madame?»
«Sì, un intimo segreto che non ho mai rivelato a nessuno. Vedi Mimì, non sempre i segreti ci chiedono d’essere svelati, come in altri momenti nemmeno d’essere portati con noi nell’oltretomba. È come nell’arte dell’affresco il rinvenimento di una sinopia, in cui persiste ciò che è all’origine e che talvolta addirittura nasconde qualcosa d’altro, un’altra forma, il disegno preparatorio di una presenza non rivelata che si sottrae alla vista sotto il colore della pittura successiva; di cui non si è deciso ancora se mantenerne il segreto, oppure svelarlo. E poiché non è possibile salvare entrambe, spesso si tende a salvare il dipinto finale, sacrificando il disegno preparatorio, creativo dell’opera ultimata.»
«Anche se la forza della sinopia è più che mai interessante? Nel senso che ci rivela l’origine assoluta della creatività, il mistero che ricopre l’intima passione da cui è successivamente scaturita l’opera d’arte?», chiese Mimì rivelando una certa acutezza di dialogo.
«Va stabilito se vale più la forza della presenza o la passione che ne ha determinata l’assenza, la quantità e la qualità delle emozioni che hanno provocato il dubbio della scelta, della quale non ci è ancora pervenuta la risposta.»
«Di solito una risposta siffatta è quanto più adatta a una domanda intelligente, e io non voglio deluderla. Credo che ciò che più emoziona, abbia diritto di precedenza sulla stucchevole realtà ultima dell’apparenza. Siamo portati ad amare ciò che ci piace. Non è forse così Madame?»
«Se la sinopia è apprezzabile più dell’opera stessa, si salva la sinopia sacrificando il resto con un atto d’amore. E l’amore non è mai disdicevole, anche quando ci mette davanti a una scelta. Non c’è ragione che tenga contro la forza dell’amore, anche quando quest’ultimo si colora delle tinte aspre della passione.»
«O dell’odio, Madame!» esclamò Mimì.
«L’amore in fondo è anche odio, è il suo perverso contrario, persegue uno stesso fine, ciò che non può l’indifferenza.»
«Anche quando l’odio ci parla di morte?»
«Si muore anche per amore Mimì, e l’odio è il suo massimo esponente. Con la differenza che mentre l'amore è la scintilla della passione, l’odio più spesso è la fiamma che rende la vita un inferno.»
«Non saprei Madame, non sono mai stata sposata, ho accettato di vivere nell’ombra.»
«Al contrario di me, mia sorella Martha, che vedi in quella sbiadita fotografia, era senz’altro la più bella. Il suo fidanzato Alphonse era un soldato in carriera. Venne a trovarci durante la guerra. Si sposarono. Rimase con noi due mesi. Era d’estate, la più bella che io ricordi. Poi ripartì per il fronte e non fece più ritorno. Dal nostro segreto amore nacque una bambina, Magdeleine, che di nascosto da tutti, lasciai in affidamento a una famiglia nel sud della Francia e mi trasferii in Oriente.
Quella figlia che ho ripreso con me alla morte dei suoi genitori adottivi. Mia sorella Martha non ne è mai venuta a conoscenza. Anche se in un certo momento della sua vita disse di aver avuto una visione, dopo di che, cadde in un coma profondo dal quale non si è più ripresa, fino all’ultimo dei suoi giorni» …
“Noi fummo spose in una sola estate, / o cara, in giugno fu la tua visione / e quando cadde la tua breve vita / anch’io mi sentii stanca della mia. / Abbandonata da te nella tenebra / mi raggiunse qualcuno / che portava una lampada [accesa] / e ricevetti il segno io pure” …
Era pur quanto recitava in un altro passo la Dickinson che Madame Rose teneva ben presente nella memoria, rammaricandosi con la devota Mimì, che l’ascoltava raccolta in tutta la sua orientale mestizia.
«Non volermene Mimì se ho mantenuto il segreto anche con te che mi sei così cara, ma adesso che più s’appressa il momento della mia dipartita, ho intenzione di rivelare a Magdeleine ciò che non sa e restituirle quanto più gli spetta, non in ultimo il suo vero cognome.»
«Mi permetta un ragionevole dubbio, non riesco a pensare sia interessata a una così imprevista rivelazione.»
«No, neppure io lo credo. Si da il caso, che Marcel abbia rivelato questo mio segreto che fin qui non ho mai osato rivelare al alcuno.»
«Mi chiedo cosa farà adesso Madame?»
«Riguardo a che cosa, Mimì si'l vous plaît?»
«A proposito del manoscritto …»
«Perduto dicevi … forse! Entrambe sappiamo che nulla va mai perduto definitivamente, siamo noi che più spesso ci perdiamo nei viluppi delle parole trasformandoci in quei fantasmi talvolta beffardi e dispotici, spesso ‘affattucchiati’, capaci di rendere questa vita un po’ meno amara tirando qualche scherzetto in buona fede, così per ammazzare il tempo della malinconia e della solitudine ... quei fantasmi che s’aggirano nei labirinti dei nostri illeciti dubbi, quando in coscienza sappiamo benissimo dove stiamo andando e cosa stiamo facendo.»
«Maschere della nostra incoscienza, l’aveva pur detto il professor Stephan», soggiunse Mimì assaporando un ché d’amaro sulle labbra.
«Ma come si sa le maschere nascondono una doppia identità: drammatica o gioiosa, spetta a noi decidere quale scegliere per meglio presentarci sulla scena. Siamo tutti costantemente proiettati sulla scena di un teatro invisibile, dove gli opposti talvolta si sostituiscono alla ‘verità’, fuori dalla realtà di un mondo estremo, e questa Parigi edulcorata in cui ci è dato vivere è la cornice perfetta per la sua rappresentazione, non credi?»
«Finzione Madame, finzione!»
«No Mimì, realtà.»
«Ma non perdiamoci in chiacchiere sil vous plaît, tu ben sai Mimì che ognuno dei nostri ospiti s’aspetta di trovare nella Maison una benevola accoglienza e una ancor migliore ospitalità. Come dire, di ritrovarsi al centro di un amabile ‘incontro con la bellezza’, per quanto effimera essa possa sembrare, vedi di farlo intendere al personale di servizio Mimì, sil vous plaît, è quanto di più mi aspetto da te.»
«E noi saremo qui ad attenderli come sempre, a braccia aperte, non è forse così, Madame?»
«Mais ouì ‘La fin ce n'est que le commencement !’ mon cœur ami.»
L’indomani alla Maison de la Ville, allorché proseguivano i preparativi per il tanto atteso ‘anniversario’ che Madame Rose voleva festeggiare con gran sfarzo. Dal canto suo Mimì aveva un bel da fare nel disporre ogni cosa secondo il desiderio esplicito di Madame: dalle luci più o meno soffuse delle lampade Liberty che molto risalto davano agli arredi d’epoca, alle innumerevoli composizioni di fiori multicolori i cui riflessi si spegnevano nella moltitudine degli specchi alle pareti. Per non dire della disposizione dei tappeti e dei dipinti orientali su seta che avrebbero adornate le stanze di ricevimento e che avrebbero reso la Maison splendida di uno sfolgorio pari a una dimora regale, per il piacere esclusivo degli ospiti che avevano accesso nell'enturage esclusivo e amicale di Madame Rose ...
E che dire di Parigi? Beh, Parigi era comunque Parigi, la 'ville lumiere' vestita alla moda, alle prese con quella ‘joie de’ vivre’ che le la Belle Époque elargiva a piene mani, aprendosi ad ogni possibile e/o impossibile accadimento. L'indomani nulla sarebbe cambiato di quel 1900, un continuo andirivieni di vendeur de journaux, di gigolò nullatenenti e di garçon che invitavano i passanti a entrare nei bistrot e nei numerosi 'boites de nuit' onde passare una notte di svago più incantevole che mai …
... quasi si fosse sulla scena di un vaudeville rumoroso e fin troppo movimentato.
FINE
Nota d’autore.
Trattasi di opera immaginaria i cui personaggi fittizi e luoghi reali hanno lo scopo di conferire veridicità alla storia narrata. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone viventi o scomparse è assolutamente casuale. Naturalmente tutti gli errori sono solo miei.
Bibliografia di consultazione:
Marcel Proust,
“Alla ricerca del tempo perduto” – I Meridiani Mondadori 1983.
“Album Proust” – I Meridiani Mondadori 1987.
Emily Dickinson,
“Tutte le poesie”, I Meridiani – Mondadori 1997.
*
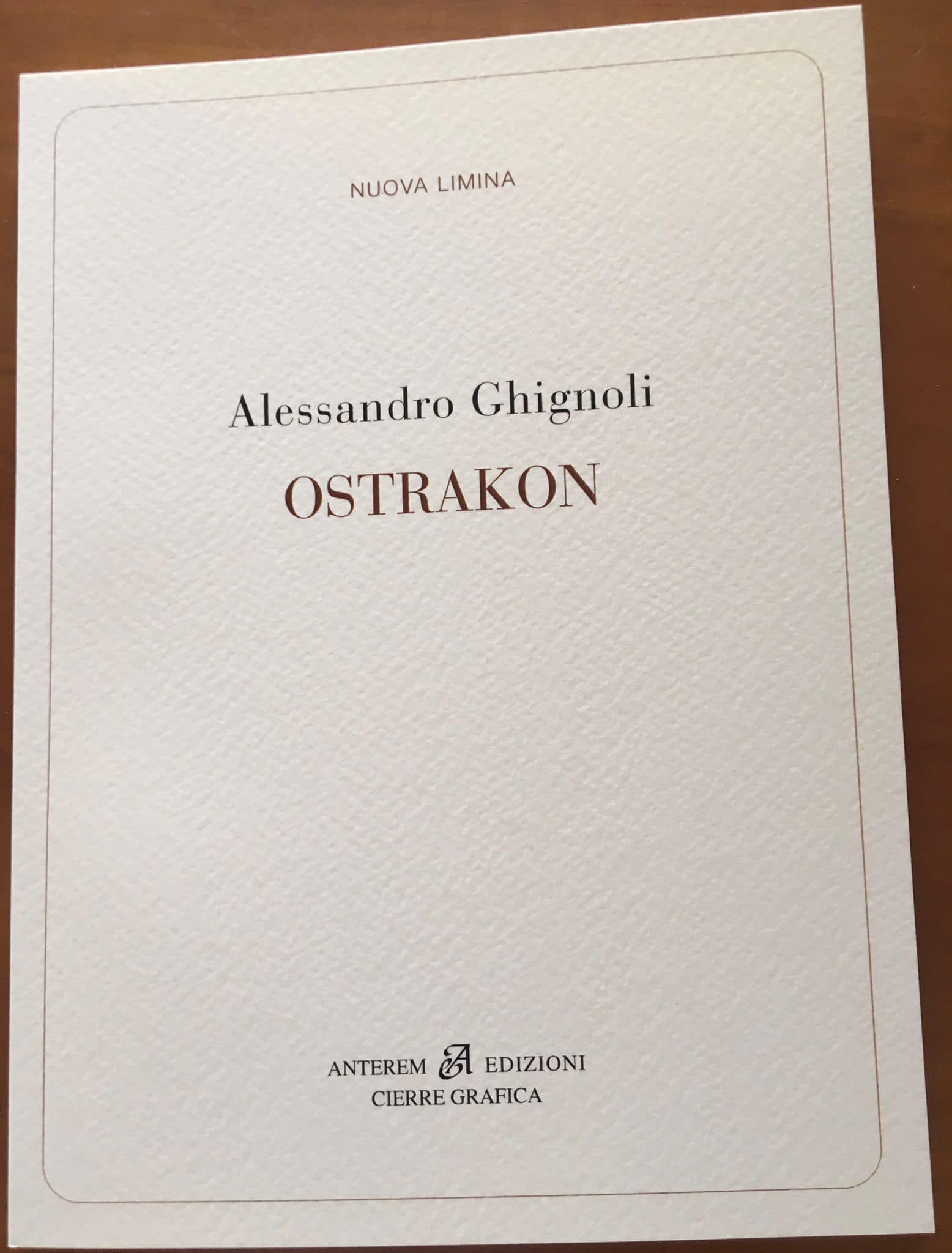 - Poesia
- Poesia
’Ostrakon’ composizioni per immagini di Alessandro Ghignoli
“Ostrakon” … composizioni per immagini di Alessandro Ghignoli Anterem Edizioni – 2022.
Sì che alla luna…
come alla pagina bianca “ogni verso ‘scritto’ è grido di perdono”, s’addice chiedersi quale esigenza, se è lecito, la poesia ha ‘d’essere veduta’? Che cosa ha spinto l’autore alla sua visualizzazione grafica e disporla per immagini? Poiché l’immagine di per sé non necessita, come la poesia, d’essere ‘cantata’ o quantomeno letta e ‘ascoltata’, ma va semmai disposta sulla carta, dipinta sulla tela, fotografata, filmata e quant’altro offre oggi la più avanzata tecnologia in fatto di consumo, sì che si è finiti, è questo il caso, di dare ad essa …
“il contorno il limite e la forma / fino alla coscienza geometrica / di una razionalità si muove / l’immagine simmetrica e chiara / nell’equilibrio dell’insieme vivo”.
Che è poi esattamente l’opposto e/o il contrario del senso espresso da sempre dalla ‘poesia’ ufficializzata di imposti canoni letterari e che, per quanto abbia fatto il suo tempo, si permetteva al lettore di ‘capire’, per così dire, di ‘misurarsi’ con la propria memoria immaginifica, data la straordinaria capacità creativa d’immaginare dèi e demoni abitatori di mondi impossibili come ‘il paradiso’ e ‘l’inferno’, ed anche dare adito a eroi e mostri, per autopunirsi dell’inefficienza di un ‘perdono’ mai obliterato da alcuno…
“senza purezza pura / mista mista mistura / nello strano straniamento / parlatura […] così forte e dura dimora / non di moda è la parola / in trasmutanza”.
Non a casso Alessandro Ghignoli usa due sostantivi come ‘straniamento’ e ‘trasmutanza’ onde porre i suoi costrutti entro i limiti di un possibile/impossibile, per chi osa guardare e ascoltare, che aprono al ‘senso’ della sua inespressa voracità del "tuttuno", cioè di quell’insieme che dà l’esatta dimensione del tempo in cui viviamo, forsanche della società che ci siamo costruiti addosso…
“È nell’intermezzo, o nell’intervallo di suono / dove anch’io posso dire un poco io sono, / nella perdita e nella permuta di ogni caduta”.
Scrive ancora l’autore in un’altra sua involuta ‘composizione per immagini’ in cui “l’istantanea di una transizione” si presta a quel “io sono” cui per un precipuo concetto di finitudine non è dato sapere. Sì che ognuno può dirsi ‘forma’ e ‘pensiero’ di quello che è…
“l’abisso che sprofonda nella solitudine di chi si è / giammai dire io sono / io sono, io sono, se mai io sono / […] corpi e anticorpi della meschinità / indignazione (?), moralismo (?) / condizione dell’essere che ‘non è’ / che non è dato d’essere (?) /muti nel tempo che stanzia / nella totale mancanza di volere”. (GioMa) …
Allora cos'è, cosa non è quell'io cui dobbiamo la nostra essenza?
“sputa ciò che tutto / dentro il vissuto muta / ci sono non ci sono / solo le parole sono /la maschera vera / la vera cera impressa / di voce rinata ancora / in una terra promessa /immune in me insieme /nei miei me stessi me.”
Quand’ecco l’ultimo verso torna al principio, a quel “grido di perdono”, al “la stessa preghiera / l’odore del dolore / il grido di ogni verso”. Quello stesso grido che Munch ha levato, solo apparentemente 'muto', eppure così pregno d’angoscia per la sorte di chi l’osserva, più del singolo grido un vero e proprio ‘urlo’ contro la cecità dell’umanità intera.
Quel dipinto che alla luce dell’arte possiamo ricondurre a un antico “Ostrakon”, dal titolo della raccolta da Alessandro Ghignoli, più propriamente al pezzo ‘rotto’ di terracotta dipinta che a suo tempo riportava l’immagine di una ‘presenza’ umana poi trasformata in ‘assenza’ e tuttavia propria dell’essenza ch’era stata…
“sono tutti questi corpi questi effetti di corpi uno sull’altro vicino e lontano l’altro forme indiscusse e spettacolari di forme contenute in spazi fuori i meccanismi […] in lingua viva e intrecciata e poi morta e poi riscoperta oltre il nuovo il monolinguismo somigliante […] di quella parte in allegoria in questa viva vitale vita alfabetica i solchi i solchi i solidi soliti sordi ascolti e poi e ancora voi noi alla ribalta in rivolta volta a chi sa a chi nelle favole perde il certo per l’incerto”.
In altro modo l’autore affida ai versi e alle immagini composite d’una scrittura ‘graffita’, seppure nel rimescolio delle tecniche moderne, di recuperare l’ininter-rotto messaggio dell’"Ostrakon", che ci parla dal passato, per quanto vagheggiato ed elaborato, che pur sempre denota la sua caducità di frammento che Stefano Guglielmin ben definisce - nella sua postfazione al libro – in quel:
«…sopravvivere nei lacerti semantici, nelle censure e nelle cancellazioni, nel cercare l’unità in lingue altre, vive e morte, in un meticciato inevitabilmente caduco; la stessa caducità che ci pervade prima nel corpo e poi nella parola, che è anch’essa - qui anzitutto - corpo, materia sonora e visiva. […] dove, l’apparente artificiosità stilistica che cerchiamo nella poesia contemporanea» s'avvale dell'imprinting originario che ha dato forma ad "Ostrakon"…
“scrivi tutte le parole possibili - dice ancora l'autore - copiale registrale diffondile con fotocopie e libri scrivile tutte e poi cancellale e poi scrivile e poi riscrivile tutte ancora insieme dille dopo solo dopo solo davvero dopo cancellale ancora e ancora anche dopo”, ... e ancora fino all'infinito.
L’Autore.
Alessandro Ghignoli, poeta, critico e traduttore di lingua spagnola e portoghese ha all’attivo un’ampia produzione letteraria anche in prosa. È vincitore del Premio Lorenzo Montano 2009 con “Amarore”. Più di recente tra le monografie va ricordato “La comunicazione in poesia. Aspetti comparativi del Novecento spagnolo” 2013, e “Transcodificaciones de avanguardia en Italia”.
*
.jpg) - Poesia
- Poesia
Flavio Ermini - Perché la poesia - Anterem Edizioni 2022
“FLAVIO ERMINI … O LA RICERCA INFINITA DELLA POESIA D’AUTORE”
L’uscita quest’anno di un volume interamente dedicato a Flavio Ermini, poeta e saggista, fondatore della rivista letteraria Anterem, rende omaggio a un pensatore del nostro tempo che ha speso la propria vita alla ‘ricerca infinita della poesia d’autore’, che ha accolto insieme a nomi prestigiosi della letteratura mondiale, una selezione altamente specialistica di autori contemporanei italiani che sono approdati al Premio Lorenzo Montano con ‘sillogi poetiche’ di alto profilo letterario, corredate da prefazioni e/o postfazioni saggistiche affidate a studiosi del settore.
Il volume oltre a raccogliere i numerosi editoriali pubblicati da Flavio Ermini negli anni che lo hanno visto impegnato nella selezione dei diversi autori per la rivista Anterem e il Premio Montano, accoglie un saggio introduttivo di Marco Ercolani, psichiatra e scrittore attivo in ambito mitologico-narrativo; e la postfazione di Daniele Maria Pegorari professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea dell’Università di Bari, e condirettore della rivista interdisciplinare “Incroci”.
Quanto si rileva dai due scritti che accompagnano l’uscita di questa ‘monografia’ dedicata, rende al lettore l’esatta dimensione della cifra autorale di Flavio Ermini e della sua particolare tendenza dello ‘scopritore’ di talenti, essendo egli stesso poeta che “dall’uomo pretende una fedeltà inesauribile all’essere poeta immerso nel pensare poesia”, come un “padre chino su un inginocchiatoio, che protende lo sguardo verso l’infinito” (GioMa). “L’essere umano è il suo avvenire ma anche la domanda sul suo avvenire, cioè non solo esiste, ma vuole sapere il perché della sua esistenza.” (Fabio Squeo)
“L’alto dei cieli
non ha fondamento né gravità l’alto dei cieli
discosto com’è dal fuoco al pari del mondo abitato
che dalle acque creaturali viene circoscritto
per quanto non si tratti che di assecondarne la caduta
consentendo così alle forze relittuali
di protendersi una volta ancora verso il principio
per misurare delle forme il grado di accoglienza
nell’inclinazione dei sensi entro i poli del finito
in cui si situa il divino per annunciare il dolore.”
(Flavio Ermini)
Immagini per a-solo di poesia.
Con l’affermazione “La poesia non è un genere letterario”, tema del Simposio aperto nell’Ottobre 2017 alla Biblioteca Nazionale Braidense, Flavio Ermini, poeta, narratore e saggista, nonché direttore ad interim della rivista di ricerca letteraria Anterem fondata nel 1976 con Silvano Martini, di fatto conferisce alla ‘poesia’ una prospettiva dinamica privilegiata che la distingue dalle altre forme narrativo-letterarie, in ragione di una empatia sostanziale che l’accomuna al canto e alla musica, per lo più afferenti alla sfera del patrimonio immateriale. La ‘poesia’, non necessariamente scritta, offre quindi la possibilità di catturare molti aspetti della vita delle immagini che ancora oggi sfuggono alla descrizione letteraria, per quanto la si concentri in due ambiti distinti che si profilano nella nostra incompiutezza e nella nostra mancanza d’essere, ancorché non rispondenti alla domanda sulla nostra esistenza.
Da un lato, quindi, la rappresentazione onomatopeica della ricerca linguistica oltre che acustico-sonora che è all’origine della parola, e “che consente di riguadagnare la continuità originaria tra parola e mondo”; dall’altro, l’avanzare costante di una ricerca che adotta dalle varie scuole stilistiche, i differenti approcci teorici e metodologici, riguardanti “il pensiero visivo” e la “percezione dell’immagine”, qui intesa nell’accezione di “percezione delle forme dell’arte”. La poesia dunque, come forma d’arte a se stante di un “pensare che può strettamente coniugarsi con il poetare, alla luce di un rapporto sempre nuovo tra parola e senso”, e per quanto la “ricerca di senso” possa oggi sembrare in contrasto con l’attualità intimistico-minimalista inerente più all’indicibile che al non-detto; o, diversamente, con il linguaggio massimalista-globalizzato in cui la poesia ripone la riflessione sul senso che, seppure in differenti modalità di ricezione e comunicazione, ciò non diminuisce la portata antropologico-culturale del messaggio poetico che racchiude in sé.
La natura della poesia, infatti, si avvale di suoni ‘suggestivi d’immagini’ che si traducono in lineamenti audio-visivi conformi alle diverse espressioni dell’arte tout-court; e successivamente in forme connaturate al canto e alla danza (vedi il canto degli uccelli, la danza di corteggiamento di molte specie animali, ecc.). Ciò che nel tempo ha permesso di penetrare l’universo sonoro dell’habitat in cui viviamo, riscattandolo da culture e tradizioni diverse, entrate a far parte del ‘patrimonio immateriale’ dell’umanità. Ma ‘vedere la poesia’ nelle immagini della rappresentazione visiva, ed ascoltarne la musicalità intrinseca (nelle forme come nei colori), fa capo al concetto fondamentale della ‘performance‘, (Victor Turner) inerente all’estetica e al liminale:
La ‘performatività’ può essere utilizzata come chiave interpretativa di alcuni caratteri delle nuove tecnologie e in particolar modo può essere una nozione utile per connotare di una veste teorica la ‘costruzione di senso’ attraverso l’agire favorita dagli strumenti mediatici digitali, oggi a nostra disposizione. “Per comprendere appieno questo concetto è però necessario leggerlo come pratica necessaria a una ridefinizione critica del reale e potenziale non-luogo di margine e di passaggio da situazioni sociali e culturali definite a nuove aggregazioni sperimentali. La riflessione teorica sul concetto di ‘performance’ permette infatti di penetrare le fenomenologie liminoidi (zone potenzialmente feconde di riscrittura dei codici culturali) e da qui anche la trasformazione sociale stessa” (Wikipedia).
Poesia per immagini.
Con l’aver dato ‘forma scritta’ al ‘dire’, attraverso il percorso accidentato dei segni grafici e, successivamente, alla sua trasposizione simbolica in quanto metafora figurativa, la ‘poesia’ assurge alla sua forma preminente di ‘creatrice d’immagini’, raggiungendo il suo apice nell’aver dato ‘voce’ all’immagine che la rappresenta. Per cui attribuire alla ‘poesia’ una certa corrispondenza e/o la relazione con l’immagine (grafica, pittura, scultura, fotografia ecc.), è inevitabile. L’alleanza introspettiva, di segreta comunicazione fra le parti, è, per così dire, incommensurabile. Al punto tale che un’immagine è poetica anche senza la suggestione del verso scritto che l’accompagna. Allo stesso modo che si può vedere un componimento poetico, se non addirittura ascoltarlo, senza la necessità di utilizzo di una immagine o di una forma specifica d’arte. In questo la ‘poesia’ è paritetica alla musica, al canto e alla danza, perché: “fonte di formazione e deformazione di un nuovo atto significante.” (Giorgio Bonacini).
Atto comprensibile di un prevedibile prosieguo di andare ‘oltre’ la forma, aprire un varco subliminale al testo scritto o figurativo, alla esegesi della parola contenuta e/o scivolata negli interstizi bianchi che intercorrono tra le righe, in cui il ‘dire’ risulta destrutturato dalla forma del ‘voler dire o non voler dire’ (nel senso di edificazione); e dal logos in quanto pensiero e verbo (edificante) del poetare. “Il dire del poeta ci parla di un ‘altrove’ dov’è in opera una prospettiva rovesciata rispetto al mondo sensibile” – scrive Flavio Ermini (in “L’altrove poetico” Editoriale n. 95 - Anterem), in cui l’immaginario è il vero interfaccia del poeta che se “non nomina le cose esperibili”, pur si avvale di binomi di ‘senso’ come: fisico-psichico, interiore-esteriore, indefinito e comunque intenso e/o estremo. Allora l’ ‘altrove’ è il Nulla e il Tutto è l’oceano e il deserto, la germinazione e la seccura, la speranza e l’abbandono, il moto e la quiete, l’essenza e l’assenza, l’immobilità e il trapasso, la stasi e la morte, plausibilmente contenuti nel dialogo poetico.
Immagini e forme queste, preminenti di concetto e contenuto, tuttavia impossibili da identificare e/o configurare se non nell’ambito di un ‘altrove’ in costante trasformazione, nelle differenti modalità di una cultura recepita nelle sue diverse identificazioni verbali-acustiche e sonoro-musicali, nonché coloristiche e luminose che danno luogo alla trasparenza dell’aere, in cui il ‘senso smarrito della poesia’ si ritrova e ci orienta verso il mistero del nostro essere. ‘Immagini coloristiche’ e ‘forme poetiche’ dunque, come memoria storica dell’esistenza antropico-naturale compresa tra realtà massima e finzione estrema, all’interno di una location-abitativa e una docu-fiction in cui la presenza e/o l’assenza umana si realizza nello ‘sconfinamento di senso’, allo stesso modo che nell’espresso sentimentalismo e nell’amore fugace, nella commedia liminale (farsa), come nella drammaticità luttuosa (tragedia), al livello della soglia della coscienza e della percezione.
Le dimore della poesia.
“Qui si viene non per celebrare una dimora, un giardino, ma perché ci si è persi” – cita Flavio Ermini (in “Non c’è fine al principio” Editoriale n. 94 - Anterem). La frase è del filosofo Lacoue-Labarthe alla quale inavvertitamente sembra rispondere proponendo alla lettura un’altra frase: “Se volete incontrarmi, cercatemi dove non mi trovo. Non so indicarvi altro luogo.”, del poeta Giorgio Caproni (in “L’altrove poetico” n. 95 - Anterem). Un non-luogo dunque che pure è “il luogo che ospita la domanda sull’essere, testimoniando la profondità della physis quale si era rivelata agli albori del pensiero”. Se si considerano qui le due frasi contigue, non senza una forzatura intellettuale, si potrebbe qui raffigurare un ‘ossimoro’ dove dimora-persi / altro luogo (dove non mi trovo), spingono verso quell’ ‘altrove’ dove “non c’è fine né principio”, che è poi il luogo della ‘poesia’, in cui:
“… la natura può ancora parlarci come all’origine parlava ... dove le antiche parole tornano alle nostre labbra come strappate al silenzio; vere quanto è vero lo sgomento dinanzi all’inconoscibile.” (Flavio Ermini)
Ancora più significativo è il principio immateriale poetico espresso nella ‘physis’ nel quale fin dall’antichità si cercò di cogliere il ‘senso’ della realtà in cui l’uomo è immerso nel suo divenire: “La poesia impone di accettare l’essere nel mondo in cui si dà, e implica un interrogarsi sul venirci incontro della molteplicità, un interrogarci sul come la parola può salvaguardare l’essere dall’apparenza. La parola è poetica – e quindi vera – allorché fa sì che l’essere sia. È in questo ‘lasciar essere’ che la parola svela il senso (della poesia) ed è dunque presso di essa quando ne preserva la differenza”. Differenza in quanto termine di opposizione e contrapposizione che interviene a spiegare le realtà particolari intrinseche della funzione poetica sottoposta al divenire, che dev’essere immutabile, previo l’inconfutabilità del pensiero che l’ha espressa, nel modo e nei termini del poeta, perché verità dell’essere.
Il ‘gioco filosofico’ (perché di questo si tratta) si avvale qui dell’interposizione di punti di riferimento alquanto labili, in cui la ‘poesia’ è sinonimo di mobile (solubile), contro la ‘parola’ per sua natura immobile (insolubile), malgrado l’alterità dei contrari che ne negano la relativa effettuazione. Si ha dunque che se possiamo considerare la ‘parola’ come ‘liquida’ per effetto della ‘retrotopia’ (Zigmunt Bauman) in atto; ancor più la ‘poesia’ si fa evanescente, si volatizza nell’aere, spingendosi nella germinazione del nuovo che, al pari della fotosintesi clorofilliana s’avvale della metamorfosi della forma data, onde per cui dissoi-logoi “le parti mutano ma tutto resta immutevole” (Anassimandro), in quanto le differenze ‘affermazione e negazione’ mantengono uno stesso valore. Sta di fatto che in qualità di scrittore e poeta Flavio Ermini, si inserisce nel ‘gioco’ sfruttando proprio questa formula inconfutabile con le sue pertinenti scelte Editoriali, interponendosi, per così dire, nelle linee direttrici della raccolta dei testi che compongono ogni singolo numero della Rivista Letteraria Anterem ormai giunta al suo numero ‘Gold’ di 100.
Alcuni esempi di ‘altrove’ poetico:
“Non m’interessa pensare al mondo al di qua del mondo” (Nietzsche)
“Si potrebbe dire che abbiamo due destini: uno mobile e senza importanza, che si compie; e un altro, immobile e importante, che non si conosce mai.” (Musil)
“Lontano dal cammino degli uomini.” (Parmenide)
“Ma i viventi commettono tutti l’errore di troppo forte distinguere. Fiorire e inaridire sono a noi ugualmente noti.” (Rilke)
Alcuni dialoghi inerenti all’ ‘altrove’ poetico:
“Poesia e pensiero in dialogo” - di Adriano Marchetti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017 (estratto).
Poesia e pensiero sono distinti come i due poli in cui si coniuga il linguaggio, in ciò che vi è di più profondo, di più elementare e più iniziale, per vibrare infinitamente in tutta la sua estensione. […] Appartiene alla tradizione occidentale una poesia che parla nella convinta presunzione di essere poetica. Diventa arte, il suo rapporto con la filosofia è apparso difficile, forse ossessivo. Nell’arroccamento sul proprio territorio autonomo e nella irresponsabilità verso qualunque altra disciplina che ha attraversato, si riflettono i grandi stereotipi: si dice per esempio che la poesia è irrazionale, emozione, sentimento, immaginazione, rivelazione. Mentre il pensiero sarebbe rappresentazione, razionalità, logica. Il filosofo, difende in forme diverse la sua idea. Il poeta maschera in forme diverse quell’idea. L’ambiguità che nel filosofo è una colpa, nel poeta è un pregio. […] I decostruzionisti giungono persino a ipotizzare che poesia e filosofia siano la stessa cosa e che si diversificano solo nella scrittura che utilizzano. […] La filosofia inizia come una domanda di senso e non ripudia la rivelazione verbale del canto. E la poesia sa di trasmettere un certo sapere.
C’è, per così dire, una sovranità terroristica della poesia rispetto a una sorveglianza sapiente dei filosofi. Il tessuto del linguaggio filosofico si sottopone a una sorta di metafora continua, costringendo gli stessi concetti che utilizza a trasformarsi. In più ambiti i filosofi riconoscono nei versi forme dell’esperienza che già hanno avuto una sorta di canonizzazione filosofica; si fanno aiutare dai poeti in ciò che dicono a cornice della loro opera. Tuttavia non si tratta né di poesia filosofica né di filosofia poetica. Per comprendere tale indissolubilità e insieme singolarità occorre risemantizzare i due termini del rapporto. La poesia che pensa supporta la contraddizione, porta dentro di sé il pensiero e resta come in attesa sulla soglia, lasciando che le domande siano sospese al centro della coscienza profonda e dolorosa dell’ambiguità. Da una parte il rigoglio dell’essere e dall’altro la sofferenza – facce di una stessa medaglia – fanno sì che il poeta assuma su di sé …
“...tutte le forme d’amore, di sofferenza, di follia” (Arthur Rimbaud). […] La filosofia non smette d’interrogare la poesia e si trattiene su quella soglia dove la poesia continuando a pro-vocarla e a sfidarla, le restituisce le parole con un tono nuovo”.
Qui la poesia smaschera la filosofia se questa presume di essere l’ultima parola del mondo. L’ultimissima parola non è mai stata detta; risuonerà al di là del mondo, altrove. […] Dal canto suo il pensiero impedisce al canto di essere poesia di se stessa. Né identità né confusione, né esclusivamente ombra né piena luce, né reciproca impenetrabilità. Il loro dialogo è possibile a condizione che il pensiero non sia ridotto a espressione logica autosufficiente e che la poesia non sia compresa come un riflettersi estetico di se stessa. La nostra epoca, enigmatica nella sua oscillazione tra illimitata potenza e radicale alienazione, ci offre la prova dell’assenza di fondamento. […] Il tempo favoloso della scoperta del mondo – l’infanzia del mondo – è solo un relitto alla deriva, e risibile è il progresso nella sua presunzione di perfezione ‘naturale’. […] Il linguaggio raggiunge il poeta che lo eredita per la sua estrema sfida nell’epoca di compimento ed esaurimento della metafisica. […] Anche la filosofia, o (ri)pensa se stessa su modalità conoscitive che a lungo andare la inducono a riconoscere il proprio vuoto, o deve uscire da sé, dal circolo virtuoso dell’auto-trasparenza, rinunciando al dominio logico che si dà ragione da sé.
La separazione tra poesia e pensiero è in realtà una relazione unitiva dei due modi ritmici che portano il linguaggio al linguaggio. La poesia dà da pensare al pensiero e si accolla il dovere di pensare, ma non si pensa. Da parte sua, il pensiero, benché con modalità differenti, scruta la poesia, impedendole di essere poesia della poesia, cioè auto-legittimazione di fronte al pensiero. Quest’ultimo, per quanto assolutamente radicale, non è in funzione di una conoscenza fondatrice, ragionevole e rassicurante, così come la poesia non è letteratura assoluta né tanto meno mistica ante litteram. […] La loro conversazione accade nell’intersezione della loro comune origine. L’origine non può essere pensata né come nulla né come qualcosa; la poesia scaturisce tra quel nulla e quel qualcosa, tra l’indefinito della negazione e la potenza dell’affermazione. Tra il nulla del nichilismo che nega il reale e l’illusione della rappresentazione che imita la natura c’è questo luogo vuoto, in cui ciò che è può apparire e raccogliersi nel suo dire silenzioso: un prima dell’inizio, un movimento inaugurale – vibrazione scaturente di ciò che perviene continuamente a sé.
Non c’è origine, ma accordo immediato con una perpetua nascita a cui s’intonano i modi e le interrogazioni della scrittura, attraverso l’arte della variazione, della brevità esplosiva dell’istante al vocativo ostinato, verso qualcosa che si rivela riservandosi. […] La parte radiosa, l’alêtheia della physis, si lascia intravedere solo sfuggendo alla vista. Il suo dischiudersi universale appare nel suo ritiro in seno all’oscurità, dove la parola si rifiuta di dimostrare e decifrare, facendo solamente segno alla sua scaturigine. (Del resto), … se fosse la piena chiarezza, sarebbe compiuto e immutabile; se fosse totale oscurità, il suo accesso sarebbe impossibile. L’esperienza della rivelazione è nella rivelazione stessa, nel circolo del rivelarsi sottraendosi. Il poeta corre il massimo rischio, arrischia la propria identità di poeta:
“Io è un altro”, enuncia Rimbaud.
“… di insensato gioco di scrivere”, avverte Mallarmé.
“… di cadere in servitù di parole”, parla Ungaretti.
“… (rischia) attraverso l’intuizione della ‘decreazione’, l’unico atto autentico di donazione la sua identità”, è quantto afiora negli appunti di Simone Weil.
Da “Il lavoro della poesia” – di Giampiero Moretti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017 (estratto).
“La grandezza artistica (del fare poetico) può mai essere storicamente efficace, può inserirsi nel processo del divenire?”; (la domanda è così posta nel saggio “Problematica della poesia” da Gottfried Benn), e si pone nella prospettiva evoluzionista interpretata in senso biologico-meccanico, e non invece in senso ‘spirituale’. Spirituale vuol dire per Benn: che il cambiamento, lo sviluppo, nel grande e nel piccolo, avviene in senso goethiano, in maniera tale cioè che sia una variazione sul fondamento e non una variazione-accrescimento del fondamento. In campo poetico, la differenza sta nel fatto che nel primo caso l’individualità lirica resta ‘soggetta’ a una sostanza che, mutandosi, muta il soggetto poetico, mentre, nel secondo caso, l’individualità lirica assoggetta a sé il fondamento che, il fatto, scompare nell’Io che lo ‘esprime’. Il fondamento insomma, ‘resta’. […] In effetti, Benn sottolinea la preminenza della libertà poetica dell’Io lirico sulla meccanicità della sostanza interpretata in senso positivistico. […]
Tra le considerazioni più degna di nota, e massimamente in linea con il pensiero di Nietzsche, troviamo quella secondo cui «l’Io è un tardo stato d’animo della natura, e addirittura uno stato d’animo fuggevole», ricondotta perciò al contesto fortemente nietzschiano all’interno del quale e dal quale nasce la prospettiva poetica di Benn, quella affermazione significa che l’Io ha un ‘suo’ tempo, dal quale emerge, e che esso è del pari fatto di tempo, e ciò senza alternative, senza ulteriori possibilità che non siano veri e propri inganni, abbagli (non insomma finzioni poetiche ‘volute’). […] Tra queste due strettoie, l’Io poetico esprime la sostanza, che non è però mai un mero niente e che quindi non può mai semplicemente appartenere all’Io che la esprime. […] E tuttavia: quell’espressione è dell’Io, gli appartiene come una ‘cosa’, una pertinenza (?)
La poesia (e la sua espressione dell’Io) non viene tanto legata e collegata alla vita ‘spirituale’ del singolo, quanto piuttosto al suo ‘corpo’, come zona autenticamente antica, arcaica, in cui in qualche misura riposa l’emozione come dimensione e fatto primario: non frutto di mero stimolo esteriore, dunque, quanto piuttosto di una temporalità interiore, profonda e intensa che nessun cervello può oltrepassare o trascurare. […] Quella temporalità arcaica è ‘già spirituale’, ed è al contempo un fatto, irraggiungibile tuttavia dalla scienza intesa in maniera diversa da Goethe. Entra qui in scena, secondo la nostra lettura di Benn, la sua ‘proposta’ della poesia come un ‘fare’ che abbia, al contempo, caratteri individuali e universali, aspetti sia di irripetibilità (e quindi in un certo qual modo se non proprio irrazionali quantomeno a-razionali), sia di stile, comunicativamente avvicinabili, quest’ultimo, all’ambito del sapere. […] Poesia (quindi) come linguaggio e però come conoscenza, una mescolanza all’interno della quale non indisciplina e sregolatezza, bensì disciplina e regola sono al centro del processo poetico. […]
In questa prospettiva, è possibile concludere che il ‘fare poetico’ è un fare ben più somatico che cerebrale e che esso presenta caratteri di universalità non di rado iscritti ‘nel corpo stesso del poeta’ non solo. Affrontando la questione del sorgere e del significato della genialità Benn evidenzia efficacemente come, nella sua prospettiva, l’elemento individuale (‘degenerativo’) della genialità si trasformi in qualcosa di universalmente riconosciuto, accertato e celebrato soltanto nella misura in cui l’universalità popolare (oggi diremmo: il pubblico) ne decreta il successo che viene fondato, radicato – diremmo noi – sul ‘corpo’ del poeta, vale a dire radicato in quelle profondità arcaiche le quali, sole, garantiscono una universalità non effimera all’opera d’arte ‘espressa’ dal genio. […] Le poesie vengono fatte, scrive Benn, e intende: le ‘poesie’ non sono il resoconto, il ‘racconto’ di stati d’animo individuali e passeggeri. Il ‘fare’ poetico è dunque ora al centro della riflessione; il difficile ciò che rende ‘rara’ la poesia, consiste nel fatto che essa non ha tema-argomento ma deve trasformare ciò che l’esistenza ‘sente’ in poesia. Se l’esistenza sente se stessa è ‘solo’ se stessa, la poesia sarà forse anche per certi aspetti ‘ben riuscita, ma non vera in senso ultimo. […]
Forse, ma non è poco, se consideriamo che quella ricerca consapevole di un’apparenza (che non può mai, naturalmente, essere mera maniera) poggia a sua volta non tanto o soltanto sulla volontà artistica ‘del’ poeta quanto invece sulla potenzialità poetica dell’essere. È quest’ultima, se così stanno le cose, che ‘libera’ la poesia come risultato puro e semplice dalle strettoie del mestiere. Naturalmente, indicare cosa, in una poesia, non va nella direzione suddetta, è molto spesso ben più semplice del contrario. Si leggano con attenzione, a tal proposito, le pagine che Benn dedica a sottolineare i quattro elementi che (a suo dire) tanto frequentemente compaiono nelle poesie quanto altrettanto frequentemente, segnalano un cortocircuito nella poesia. In conclusione però il punto è uno solo e uno soltanto, nella poetica moderna, la poesia del nostro tempo è quella in cui la nostra esistenza si ritrova appieno, o almeno può ritrovarsi l’Io che, parlando di se stesso parla d’altro, e questo altro non è una sua proiezione, ma è davvero Altro. E se non è, tale parlare, una modificazione, davvero diventa difficile ipotizzarne una più radicale.
Poesia dunque come variazione, cambiamento, sconfinamento, digressione, erranza.
Queste le tematiche ampiamente trattate dalla Rivista Letteraria da illustri studiosi traduttori e commentatori di saggi filosofici e poetici dei migliori e riconosciuti scrittori di ogni epoca, con particolare riguardo agli autori a noi contemporanei. Nelle sue pagine troviamo, inoltre a Flavio Ermini, Giorgio Bonacini, Vincenzo Vitiello, Carlo Sini, Alejandra Pizarnik, Laura Caccia, Enrico Castelli Gattinara, Alfonso Cariolato, Ranieri Teti, Massimo Donà, Henri Michaux, Davide Campi, Mara Cini, Marco Furia, e numerosi altri collaboratori. Ma non è tutto, sono regolarmente accolte inoltre le ‘voci’ dei grandi poeti, come Friedrich Hölderlin, Paul Celan, Emily Dickinson, Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi, Marina Cvetaeva, Claude Esteban, Camillo Pennati, Rainer Maria Rilke, Yang Lian, solo per citarne alcuni. Anche se è facile immaginare che nei 42 anni dalla fondazione della Rivista siano apparsi, verosimilmente, tutti o quasi sulle sue pagine.
Un pregio questo che attribuisce ad Anterem il primato di una lunga impegnativa produzione letteraria, della quale, Flavio Ermini, da sempre, mantiene alto il vessillo dell’impegno filantropico socio-culturale nel nostro paese. “Non c’è fine al principio” va quindi considerata come ‘massima’ che da sempre distingue e sostiene Flavio Ermini, e va letta come impegno progressivo e conseguente nel duro lavoro di direttore e redattore della Rivista, giunta quest’anno al suo 95 numero con il quale si è voluto in questo articolo, dare una risposta confacente a “La poesia non è un genere letterario”, come abbiamo avuto modo di accertare. Relativamente a un modo dirompente e in qualche modo provocatorio di tornare ad argomentare un dialogo schiuso in Illo tempore, ma pur sempre attuale, sul ‘fare’ poesia e sul ‘lavoro’ del poeta, con l’affrontare tematiche vecchie e nuove inerenti e/o differenti all’argomento poetico.
Lo attestano le numerose adesioni alle diverse ‘sezioni’ del Premio, ed ancor più le varie pubblicazioni indotte ad esso, come avviene ad esempio con ‘Limina’ Collezione di scritture, e con ‘Opera Prima’ che accoglie fra le sue pagine le ‘voci’ di autori inediti e in parte sconosciuti nella scuderia del Premio intitolato a Lorenzo Montano giunto alla sua XXXII edizione, che la Rivista Anterem indice ogni anno nella ricerca infinita della Poesia d’Autore. Autori che si aprono con spirito innovativo a questa parte legittima di infinito, dando maggiore forza al riconoscimento della ‘poesia’ come forma d’arte a se stante, capace di affermare l’universalità del suo messaggio, sconosciuto in quanto imperscrutabile, suggestivo quanto più ispirato.
Afferente al pensiero e alla parola, così come al canto e alla musica, in quanto ‘voce poetica’ definitivamente liberata dai lacci misteriosi delle afasie di un linguaggio ampiamente superato, appartenuto al passato, per quanto glorioso, ma che oggi pur s’avvale della bellezza terrena dei sentimenti e dell’ebbrezza spirituale che inevitabilmente pervade l’universo futuro.
Da “L’esperienza poetica del pensiero”, scrive Silvano Martini …
“I luoghi verso i quali ci dirigiamo non hanno consistenza propria.
Assumono quella che noi intendiamo conferire loro.
L’esperienza poetica è andare verso qualcosa e, nello stesso tempo, costruire quella cosa stessa.”
Flavio Ermini (Verona, 1947), poeta e saggista.
Dirige dalla fondazione (1976) la rivista di ricerca letteraria “Anterem”. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Poema n. 10. Tra pensiero e poesia”, (poesia 2001; edito in Francia nel 2007 da Champ Social), “Il compito terreno dei mortali” (poesia, 2010; edito in Francia nel 2012 da Lucie Éditions), “Il matrimonio del cielo con la terra” (saggio e poesia, 2010), ‘Il secondo bene’ (saggio, 2012), “Essere il nemico” (pamphlet, 2013), “Rilke e la natura dell’oscurità” (saggio, 2015), “Il giardino conteso” (saggio e poesia, 2016), “Della fine” (prosa poetica, 2016). Collabora all’attività culturale degli “Amici della Scala” di Milano. Per Moretti&Vitali cura la collana di saggistica “Narrazioni della conoscenza”. Partecipa a seminari e convegni in molte istituzioni accademiche italiane e straniere. Vive a Verona, dove continua il suo lavoro nell’ambito editoriale della rivista Anterem e del Premio Lorenzo Montano.
Riferimenti bibliografici oltre quelli citati:
Fabio Squeo, “L’altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza”, Bibliotheka Edizioni 2017.
Victor Turner, “Antropologia della performance”, Il Mulino 1993.
Wikipedia, Enciclopedia libera on-line – by Wikimedia Foundation
Giorgio Bonacini, Prefazione a “L’inarrivabile mosaico” di Enzo Campi – Anterem Ed. Premio Lorenzo Montano ‘Raccolta inedita’ 2017.
Zigmunt Bauman, “Retrotopia”, Laterza Editori 2017.
Gottfried Benn, “Lo smalto sul nulla”, Problematica della poesia, Adelphi 1992, in
“Il lavoro della poesia” – di Giampiero Moretti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017.
Artur Rimbaud, in “Poesia e pensiero in dialogo” di Adriano Marchetti, Anterem n. 95 - Dicembre 2017.
Altre recensioni di Giorgio Mancinelli sul sito larecherche.it:
Flavio Ermini, "Il Giardino Conteso" - Moretti & Vitali, 2016. Pubblicato il 20/04/2016 04.
Flavio Ermini, “Serata/Evento dedicata a Rainer Maria Rilke, a 90 anni dalla morte”. Pubblicato il 29 dicembre 2016.
ANTEREM 91 apre il 2016 con uno straordinario numero da collezione. Pubblicato il 03/03/2016.
“91 E NON LI DIMOSTRA” ANTEREM RIVISTA DI LETTERATURA E POESIA . Pubblicato il 30/12/2015
“Premio Di Poesia 'Lorenzo Montano' Edizione Del Trentennale”. Pubblicato il 10/02/2016
Sitografia:
ANTEREM – Rivista di Ricerca Letteraria: www.anteremedizioni.it Premio Lorenzo Montano: premio.montano@antermedizioni.it
*
 - Libri
- Libri
Roma in Fabula - ’Fabula picta, fabula dicta’
"Fabula picta, fabula dicta"
UN LIBRO DI GIORGIO MANCINELLI SU AMAZON
E' un viaggio nella città nascosta e sotterranea, coi suoi personaggi presi dalle cronache quotidiane di epoche diverse e verosimilmente re-inventati dalla creatività dell’autore: santi, diavoli, becchini, preti, donne scaltre, uomini saggi, ubriachi, gestori di bar e d’osterie, cantanti di strada, funamboli, beoni, opportunisti e tantissimi altri, immersi nella cornice antica e pur sempre nuova di una città, Roma, incredibilmente conosciuta, o forse, così imprevedibilmente sconosciuta, in continuo disfacimento nel suo pur essere eterna. Un po’ di Roma è qui, nello sfogliare queste pagine che gli ho dedicato, sfiorando appena la sua bellezza austera ma sobria, della quale ho scostato il velo ascoso e magico che la ricopre. Lo stile usato è quello della cronaca giornalistica che risale gli accadimenti dal lato umoristico, per giungere al paradosso dei ludi luculliani e del carnevale di storica memoria. Un viaggio senza tempo, o forse attraverso il tempo, che non tiene conto dei secoli come dei millenni che a Roma non sembrano mai passati, e che rivivono nelle sue pietre e nella polvere accumulata dalla storia.
*
.jpg) - Musica
- Musica
Vangelis Papathanassiou - un mito della musica contemporanea
Per meglio distinguere la figura di Vangelis nel panorama musicale sempre più affollato e spesso distratto dell’elettronica-pop bisognerebbe aver letto il ‘reportage’ sulla musica contemporanea apparso in Larecherche.it (vedi ‘Quaderni di Musicologia XIII: la musica contemporanea’), colui che ha spalancato ulteriormente le infinite possibilità applicative di questa tecnica strumentale che ha dato vita a un vero e proprio genere musicale: la ‘musica spaziale’. Ma prima di tentare una qualsivoglia definizione della sua musica, si rende necessario non tanto conoscere l’individuo in quanto ricercatore attento e dalle infinite capacità intuitive, quanto rendersi consapevoli della sua concezione musicale. Tutto nasce al Nemo Studio che Vangelis realizzò a Londra sul finire degli anni ’70 e che confidenzialmente ha chiamato “il mio laboratorio”, perché al dunque di questo si trattava, di un vero e proprio laboratorio alchemico di ‘programmazione musicale’. Come egli stesso ha detto: “È lì che tento di costruire la musica del nostro tempo, riprodurre suoni, toni, modalità, successioni, certi effetti spaziali e temporali. Quello che più mi interessa è il rapporto che corre fra l’uomo e la musica, o meglio gli speciali effetti psichici e psicologici che la musica riflette sul comportamento umano”.
È comprensibile quindi come un così capace musicista, arrangiatore, compositore e co-autore di canzoni che ha nel suo DNA certe ambizioni di ricerca finisca poi con lo sfociare nella dimensione filosofica e psicologica del creativo, quanto meno dell’artista impegnato a dare un seguito alla sua concezione musicale ‘altra’ da quella in cui si era formato. Cioè da quando con il gruppo greco degli Aphrodite’s Child formato nel 1968 con Demis Roussos, Loukas Sideras e Anargyros Koulouris, scalava le vette delle classifiche canzonettistiche con una miscela di rock e atmosfere folkloristiche greco -mediterranee, condita da arie progressive in un sostrato di musica classica. Agli inizi del 1970 Vangelis s’affaccia sulla scena da solista. Risale infatti al 1971 l’uscita di “Hypothesis” suo primo album, frutto di ricerca, dal titolo fortemente ipotizzante di quello che sarà il suo futuro ambito di ricerca. Seguono nel 1973/75 due colonne sonore per i documentari del francese Frederic Rossif: “L’apocalipse dex animaux” e “La fête sauvage” strepitose per innovazione compositiva che lo impongono fin da subito all’attenzione internazionale.
Tuttavia saranno le musiche composte per il sequel televisivo “Cosmos” a spalancare per lui le porte della sua definitiva entrata nella programmazione elettronica della musica, e di dare sfogo, se così si può dire, alla sua capacità espressiva senza impedimenti di sorta, rendendo la sua musica riconoscibile alla prima sequenza di note. Con “Heaven and hell” del 19… di eccellente fattura compositiva, in cui sono raccolte le musiche utilizzate nel sequel televisivo, Vangelis spazza via ogni riserva sulla natura della sua musica e ci mette di fronte all’opera compiuta. Da questo momento in poi le sue performance avanzate ed estreme riempiono il panorama musicale mondiale, presentandosi al grande pubblico nella duplice veste di ‘mago’ alchemico -elettronico capace di mettere in movimento l’orecchio (e la fantasia) dell’ascoltatore con assonanze nuove, uniche e originali, il cui effetto primario è quello di far scaturire gli effetti più inusitati: atmosfere e situazioni, location ambientali e straordinari ‘spazi’ cosmici. La fusione dei generi e l’uso di filtri sonori permette a Vangelis di approntare una sorta di rinnovamento anche nella musica tradizionale ch’egli a un certo punto sembra riscoprire ravvisando in essa il messaggio ancestrale degli avi: “Per me la musica non è solo intrattenimento, piecere estetico ed edonistico, ma qualcosa di più. È una forma di vita a se stante, vecchia milioni di anni, quanto l’uomo … quando l’uomo …”
Nascono da questa affermazione i bellissimi brani: “Heart” dall’album omonimo del 1973, “Dervish D” ispirata alle danze dei Dervisci di Turchia il cui mistico ‘ruotare’ trova la sua realizzazione nella spirale cosmica dell’universo; la lirica “To the Unknown Man” un inno levato al mondo sconosciuto dell’uomo; entrambe incluse nel successivo album “Spiral” del 1977 e colonna sonora del film di Francois Reichenbach in cui Vangelis propone inoltre un’antica melodia greca per bouzuki; nonché l’esperienza di “China” del 1979 in cui il compositore si avvale delle sonorità orientali e che gli permette di spingere la ricerca nei meandri inconsueti del TAO. SI rende qui necessario fare un passo indietro a prima di quest’ultime esperienze, e ritrovare il Vangelis degli anni ‘70/’80 , quello dal punto di vista commerciale più proficuo: “Albedo o.39” del 1976, e “Beaubourg” del 1978 che subito s’imposero all’attenzione degli organizzatori mediatici che li utilizzarono nelle sigle di alcuni importanti programmi radiofonici e televisivi. Successivamente 1980/82 Vangelis sembra passare un momento riflessivo di transizione che però non preclude la sua produzione come solista. Mi riferisco agli album realizzati con John Anderson ex leader degli Yes col quale avvierà una lunga collaborazione, ne cito qui almeno due “Short Stories” e “See your later” in cui Vangelis si ripropone in veste di arrangiatore co-autore delle canzoni in essi contenute.
Nel 1982 esce al cinema, in forma sommessa, “Chariot of fire” una pellicola dell’inglese Hugh Hudson in cui si narra di un evento sportivo riferito alle Olimpiadi pre/post War (non ricordo bene), del quale Vangelis firma la colonna sonora nei titoli di coda e che fin da subito si rivela più che un semplice commento sonoro alle immagini. Infatti sarà successivamente insignito del premio Oscar per la migliore ‘colonna sonora’ di quello stesso anno. Nell’economia del film infatti la musica di Vangelis si riappropria del ruolo preponderante che la ‘colonna sonora’, in altre pellicole del periodo, sembrava aver perduto, con lo scandire il ritmo percettivo del discorso fotografico che David Watlin e Dewi Humpries, rispettivamente direttore e operatore della fotografia, avevano magistralmente condotto; quasi a sottolineare i momenti di progressiva emozione, di vivificante bellezza visiva con quella sonoro-uditiva delle immagini. Siamo all’apoteosi della ‘colonna sonora’ in cui il connubio con la musica raggiunge l’apice dell’eleganza estetica in musica. Raggiungimento estetico-sonoro che si ripeterà con “Missing” del 1982 un film di Costa Gravas e con “Blade Runner” del 1994 di Steven Spilberg in cui la musica di Vangelis sottolinea maggiormente l’ambientazione ‘minimalista’ piuttosto che il soggetto. Qui il ruolo della musica diviene quello più specifico di ‘sostegno’ all’impatto traumatizzante delle immagini che scorrono ora veloci ora stupendamente lente, pur sempre con geniale efficace. A seguire la splendida “Antartica” 1983; “The Bounty” del 1984 e la successiva “Conquest of Paradise” del 1992, “Alexander” del 20004, intervallate da musiche per spettacoli teatrali: “Elektra” (Grecia) 1983, “Medea” (Spagna) 1992, “Las Troyanas” (Spagna) 2001, “A Vihar” (lit. The Tempest) (Ungheria) 2002, “Antigone” (Italia) 2005. Musiche per balletto: “R.B. Sque” (Regno Unito) 1983, “Frankenstein” - Modern Prometheus (Regno Unito, Paesi Bassi) e “The Beauty and the Beast” (Regno Unito) 1985-1986. Risale al 2001 lo splendido “Mythodea”: Music for the NASA Mission: 2001 Mars Odyssey (Sony Music) lo spettacolo per immagini oggi anche in DVD.
Considerato il più originale costruttore di ‘cattedrali musicali’ per colonne sonore, mostre, avvenimenti sportivi, eventi di rappresentanza ecc. Evangelos Odysseas Papathanassiou, compositore impegnato nella ricerca strumentale capace di creare, attraverso l'uso funzionale delle tastiere, atmosfere grandiose di matrice sinfonico-orchestrale; compositore inoltre di musica elettronica e new age, noto con il nome d'arte di Vangelis, ha offerto la propria collaborazione a numerosi gruppi rock strumentale e cantanti contemporanei come Irene Papas di cui vanno qui ricordati almeno due interessantissimi album: “Odes” del 1979 e “Raphsodies” del 1986 contenente antichi ‘canti greci’ di una bellezza stravolgente. I Krisma (Chrisma) “Amore” del 1976, “Chinese Restaurant” del 1977, “Hibernation” del 1979. Inoltre con la magistrale interprete di canzoni italiane e non Milva, per la quale Vangelis ha riadattato il famoso brano "To the unknown man", divenuto in italiano, "Dicono di me", in francese "Moi je n'ai pas peur" e in tedesco "Ich hab'keine Angst" e che è oggi uno dei pezzi più significativi del repertorio della cantante, ma anche un grande successo discografico. Vangelis ha scritto per Milva molti brani originali e spesso inclini ad una immersione visionaria, ipnotica e sofisticata nello sperimentalismo elettronico e polifonico. “L'ultima Carmen”, su testo di Massimo Gallerani e la citazione inter-testuale di Bizet, è un ottimo esempio di questa sensibilità espressiva aperta al confronto culturale e alla compenetrazione dei modelli. Costante nell'opera di Vangelis, rimane infatti, la capacità di fondere elementi molto distanti tra loro, in una realtà sonora e ritmica che viene costruita e ‘re-inventata’, in un insieme di blocchi elettronici e sintetici.
A questo approccio problematico ha dato a suo tempo una risposta fattiva Vangelis Papatanassiou con l’esclusione, salvo rare eccezioni, di ogni forma immotivata di commento musicale, come quelle create per i documentari di Frederic Rossif “L’Apocalypse des Animaux” (1973), e successivamente “Opera Sauvage” (1979), ed anche “Soil festivities” (1984), alle quali il musicista ha prestato il suo operato in qualità di compositore, arrangiatore, esecutore e produttore, quale solo un vero e proprio alchimista del suono riesce a fare ora creando ed elaborando ‘effetti sonori’ studiati ad oc o presi dall’ambiente, utilizzando rumori reali e semplici suoni prodotti con strumenti musicali o nell’elaborazione di voci, come già in Henze nella riproposizione di un titolo: “Voices” (1995), anche queste elaborate da sintetizzatori ma con esito più suggestivo, in genere sufficienti a realizzare un ascolto decisamente più distensivo. O, come in altri casi, rendendo più agevole seguire il flusso del commento vocale nel suo significante divenire: “Mythodea” (19) (CD e Video - 2001) realizzato per la Missione Nasa “Mars Odyssey”; così nei cortometraggi e documentari dove ‘la voce’ è acusmatica, cioè che rimane ‘fuori del campo visivo. “L’acusma cinematografico spiega – Virgilio Tosi op.cit. – è davvero per un verso ‘fuori-campo’ (quindi, per lo spettatore, al di fuori dell’immagine), ma allo stesso tempo è dentro l’immagine dietro la quale proviene, in forma reale (realistica) o immaginaria; come se vagasse sulla superficie dell’immagine ora dentro ora fuori, con dei punti variabili all’interno dell’inquadratura, riconoscibili come tali solamente nella mente dello spettatore man mano che le immagini scorrono davanti ai suoi occhi.”
Si è parlato di vari aspetti riguardanti la ‘musica per immagini’ e dei suoi fautori come di un ‘miracolo’ già avvenuto, è questo il momento di andare ‘oltre’ l’aspetto culturale che l’ha visto nascere e recuperare (notare l’ossimoro), mi correggo, ripercorrere le numerose strade aperte dalla ricerca e non solo, che oggi distinguono gran parte della musica contemporanea in ogni sua referenzialità. A ciò molto è servito l’abbinamento con le diverse espressioni artistiche che la cultura odierna mette a disposizione, e che vanno dalla rappresentazione teatrale al balletto, dalla mostra d’arte alla cinematografia di genere documentaristica al reportage ambientale, in cui però, malgrado la credibilità culturale che gli si voglia dare, in realtà l’aspetto commerciale ha preso il sopravvento e l’‘artefice’ (gli artefici) di tanto sconvolgimento è andato incontro al pubblico per colmare la grande differenza che li teneva separati.
“Anche per questo – scrive Augusto Romano in “Musica e psiche” – la musica-visiva” ha dovuto farsi portatrice di una certa comunicabilità che non aveva. Ha dovuto cioè ricercare quei simboli dell’espressività sonora che non gli appartenevano, ma che pure davano fondamento all’idea di musica nel suo insieme, vuoi per effetto della globalizzazione (world-music) in atto, e che accompagna ogni manifestazione antropologica fin dalle sue origini tribali di tipo musicale-socio-comunitarie, fino agli ultimi esempi di acculturazione e addomesticazione delle immagini-sonore. Quella stessa che ha alimentato costantemente la produzione sonora di riflessioni filosofiche e psicologiche che hanno assunto, inevitabilmente, consistenza ormai ‘mitica’: si prenda ad esempio il Jazz o il Rock, che hanno tracciato un percorso nell’immaginazione umana. […] Di fatto ogni discorso sulla musica si intreccia con quello sulla psiche e sulla pratica analitica sociologica, in un gioco di analogie situato sull’arduo confine che divide ciò che è dicibile da ciò che non è”.
Ma l’uomo, Vangelis non ama fare sfoggio di sé e raramente si concede di apparire in pubblico, non si lascia fotografare e non appare neppure sulle copertine dei suoi numerosi dischi. Le rare volte che è salito sul palcoscenico risalgono ormai agli anni ’80. Era infatti il 17 luglio del 1989 quando prese parte al concerto ‘live’ alle Terme di Caracalla a Roma dove finì per suonare ‘O sole mio’ e in parte fu addirittura deludente. Suo malgrado egli è ancora oggi, uno dei più accreditati compositori di colonne sonore, soprattutto nella solennità imponente degli arrangiamenti, molto ricercato dai registi che gli fanno la corte pur di accaparrarselo. In Vangelis, il richiamo accattivante e spesso minimalista alla classicità o alla spiritualità di sapore vagamente "New Age", definisce un aspetto decisivo di quella ricerca strumentale e sonora a cui il compositore ha sempre guardato con estremo interesse. Forse l’unico fra quelli per così dire cui si può accreditare una certa autenticità e rigore professionale, un probabile (allora lo era) profeta della musica del domani.
*
 - Poesia
- Poesia
’Elegia’ - Una raccolta poetico-narrativa di Mariasole Ariot
“Elegia” … o della tensione poetico-narrativa.
Una raccolta di Mariasole Ariot – XXXV Premio Lorenzo Montano – Anterem Edizioni / Cierre Grafica 2022.
“È così il buio: è così la luce.”
L’insorgere di una necessaria assenza di parola che può far pensare a una qualche sofferta dimenticanza che di fatto lascia sgomenti, non trova soglia in queste pagine di Mariasole Ariot, tendenti a ricreare attorno al suo dire, il vuoto causale che l’accompagna e le riveste d’aura poetica, traendone il massimo profitto narrativo …
“Ancora – premere ancora – i bulbi delle cose – andare a fondo – nella notte chiara la chiara della vista – che non vedo – quando appare – e non ripara – la corda, questo piccolo morire.”
Non un vuoto interstiziale dunque, separa le frasi in ‘sospensione’, ma un pieno concettuale che ne riveste le pause latenti, come in uno spartito musicale, essenziali alla composizione d’insieme fortemente espressiva, se vogliamo drammatica, come può dirsi di tutta l’opera wagneriana che, d’altra parte, lascia spazio a eventi, attese, emozioni che alimentano il ‘climax’ sviluppato dalla dilatazione dei tempi narrativi, così “…la notte – quando non dormire – […] che dice il confine – e sprofonda – sprofonda ciò che mi ha fondato.”
E “Di nuovo un’identità – mancata – si scompensano le cose vive – e i vivi delle strade – questa strada senza passanti – questi passati che ronzano d’intorno – non stentano mai a morire.”
La resa wagneriana è altamente suggestiva, si pensi ai contrasti fra elementi della natura, ai cieli torbidi di nuvole come schiere avverse che si confrontano sul campo; al costante tragico viluppo del bene e del male a scapito dell’identificazione e del riconoscimento; alla drammatica sopravvivenza dei personaggi ‘elegiaci’ che si muovono sulla scena e che, viceversa, s’agitano in noi spettatori, presi nel vortice sovrasensibile degli eventi …
Noi che siamo, che: “Abitiamo – case sconosciute quanto chiaro è il chiaro – il salto che trascura – i piani e l’altezza delle scale – la scelta che non sceglie la mia scelta – un cranio senza scoglio – una scogliera.”
E ancora si pensi alla tensione dei sentimenti che attanaglia tutti, personaggi e spettatori, nel conflitto quotidiano tra la vita e la morte, allorché non rimane che contare nel ‘vuoto’, che non è il ‘nulla’, il numero dei morti rimasti disseppelliti, la somma dei cadaveri mangiati, dei figli spuri disconosciuti, degli avanzi di una tavola riccamente imbandita ch’è pur è la vita: questo nostro vivere obliato senza remissione …
“Dicono si torca il mondo – come il cibo – digerito delle tavole – dell’ultima cena per la cena mancata – quando ti nascondi dall’occhio – che preme all’infuori e rincorre – poi nascondersi – nelle parti che ho mangiato.”
E verosimilmente trovarsi a rigurgitare davanti allo specchio la propria filantropica essenza, pur senza voler essere benevoli con se stessi, vissuti con “Il terrore – di dire – e di non dire – la verità che a volte – arriva – in una notte – mentre riposano i mille – personaggi che hai creato – e tu diventi – la loro stana vuota.”
Un vuoto di scena che spaventa, allorché la brama d’essere lascia spoglie insepolte, incustodite, dell’anima che in ginocchio prega sulla nuda terra una qualche defezione di memoria, di oltraggio subito, di violenze oscene, di manchevolezze arbitrarie contro la dignità cercata: un’intima battaglia che si consuma sul campo della vita nell’amletico dubbio “essere e non essere” di shakespeariana memoria …
“Cronacare – una nebbia sulla lingua – cronacare i dettagli dei corpi, cronacare – la scorza dei feriti – questa misura – oscura che grava sulle cose – di questo misurare – i territori dei sepolti.”
E ancora …
“Si muove solo – l’interno – accadersi per cadere – non avere alcun – appiglio – alla scena madre – questa madre da cui siamo - scivolati fuori – a velocità di verme – camminare a ritroso – laggiù – in un passato che muove nessun presente – solo un vissuto – per chiedersi – se mai hai vissuto.”
Ma per quanto vi è detto, l’autrice non esclude alcuna attribuzione di colpa subita, né suggerisce una possibile via di fuga. La colpa, se di questa si tratta, rimane ancorata al peccato d’essere qui, adesso, al cospetto di un Dio ineluttabile, nascosto alla vista, intransigente quanto impietoso …
Il tributo dovuto è in queste pagine solo apparentemente bianche, che pure non chiedono riscatto …
“E non è forse – ogni segno come un sogno una vaga – interpretazione – essere ciò che l’altro – altrove – dice l’essere che sei – e non è – forse ciò che pensi l’accaduto – solo interpretare un accadere – come dimostrare il vero – quando si cela.”
“È così il buio: è così la luce … dove mai è dire sempre.”
Una costante tensione poetico-narrativa attanaglia l’autrice di questi illuminati versi metonimici, traslati d’una sceneggiatura artata, al cui dramma assistono fugaci ombre del vissuto, incolori, che attraversano la tela di fondo alla ricerca della verità, per un ‘teatro degli opposti’ senza né vinti né vincitori …
“Attraverso il deserto mi deserto – destare un’opinione – sul margine del foglio – sfogliarmi separarmi misurarmi – avermi e non avere – per avermi – reciso l’esistenza.”
L’autrice:
Mariasole Ariot, ha al suo attivo una lunga collaborazione alla rivista scientifica lo Squaderno, dal 2014 è redattrice della rivista letteraria online Nazione Indiana. Sue pubblicazioni: “Simmetrie degli spazi vuoti” con G. Bortolotti – Arcipelago Edizioni 2013; “Anatomia della luce” Aragno 2017.
Nell’ambito delle arti visuali, ha collaborato alla realizzazione del cortometraggio “I’m a Swan” (2017), e “Dove urla il deserto” (2019).
*
 - Poesia
- Poesia
’Dinosauri Psicopompi’…elementi strutturali di poesia aliena
“Dinosauri Psicopompi” … elementi strutturali di poesia aliena.
Una silloge di Paola Silvia Dolci, Anterem Edizioni/ Cierre Grafica 2022.
“Mi sveglio sempre prima
Della fine dei sogni.
Staccata,
come se venissi ritagliata
con le forbici dalla carta.”
È questa una proposta grafico-letteraria che prendendo spunto da frammenti poetico-mitologici di un passato assai remoto, pur sempre vivo in noi, propone una possibile costruzione di testo narrativo avulso da prerogative intenzionali e ipotesi critiche che, altresì, sminuirebbero l’effetto originale del testo. Quasi si fosse in presenza di una cercata decostruzione che si rivela nel ‘non detto’, paragonabile al ‘non finito’ di un’opera d’arte …
“Quando cala il buio, i fantasmi del mare si addensano, si avvicinano, si nutrono sia della notte, sia dell’acqua. Quando spunta il sole, i fantasmi, corrono ancora sul filo dell’acqua.”
Un’assenza, quindi, che assume qui l’istanza di un dire oltremodo alieno, in cui la parola conchiusa in sé, è rivelatrice di un approdo ultimo, definitivo, che impedisce di notare la prossimità della nostra presenza (di lettori), messa di fronte a una stesura insolita, i cui richiami, nell’immagine grafica che l’accompagna, proiettano, solo apparentemente, un vuoto di senso, allorché … “i sogni si associano alla conoscenza”.
Sì che l’avvio in solitaria ascensione verso il ‘vuoto oscuro’ (parimenti di un buco nero nello spazio), non incute paura alcuna, né soggiace a velleità di grandezza o potenza ctonia, ma si riversa nell’universale cosmico della conoscenza. Inutile quindi cercarvi un ‘senso altro’ che non c’è, l’autrice non lo rivela. Piuttosto allude a una coesione con la realtà liquida che stiamo vivendo, così come dischiudere ulteriori spazi alla creatività acrilica del nostro tempo …
“Ho gli occhi irritati dal sale,
la sabbia triturata tra i denti,
le ombre dense dell’isola si annidano,
nello scricchiolio lieve della barca, stanotte,
la tua presenza mi ha fatta sentire sola.
Devo diventare aria.”
Dacché il ritorno alla dicotomia di accompagnatori fortuiti che noi siamo, ‘psicopompi’ del nostro essere, sospinti verso un mondo estremo che ci aspetta al di là delle parole, dei nostri costrutti, dell’immaginario collettivo che ci accomuna nella fine, un ultimo approdo, antitesi di un disegno (forse) compiuto sulla carta (del destino) che necessita di ritagliare, scontornare, e bruciare tutto quanto è d’intorno di un’identità obliterata …
“Non riesco mai a ricordare il suo nome. […] Quando vorrei sottrarmi, resto. Chiede squarci della mia intimità, questa per me è la cosa più intricata. […] Non so perché resto, forse perché me lo chiede.”
Forse perché in ciò, si avvalora l’inizio di una nuova avventura, “la continua tensione di valicare un confine”, sintomo e soggetto di una velleità antropica mai venuta meno … “non bastiamo mai a noi stessi, mai ai nostri desideri” cita l’autrice: “Rimane la stanchezza, la rinuncia, - un’abulia quasi felice.” […] “Poi, da sogno a sogno … mi difendo con la paura. […] “Il nervo ottico rimasto in bianco, fulminato nel cuore del cervello.”
Ma non c’è paura, semmai l’incombenza di una necessità, voler sapere, voler comprendere, anzi no, piuttosto di voler conoscere quanto (di sé) è rivolto nel “Lo specchio sopra la mia testa, alle spalle del letto, riflette due volte la stessa immagine.” Un gioco di “piccoli ingranaggi”, uno dei più interni che si cela nel mistero di chi siamo, quale simbolo archetipo della trasformazione del Sé. Solo allora …
“Quando tutto sarà finito,
tutto ricomincerà daccapo. […]
Ci cambiano i sogni.
Mi capita di entrare nella testa degli altri.
Incidere la candela con il pugnale dal manico bianco.
Bruciare alla fiamma le foglie di alloro su cui ho scritto i miei desideri, alla luce della luna. Gettare le ceneri in mare. […] Che cosa voglio quando non percorro mai una strada fino in fondo (?). Sul mondo in frantumi distendere un cielo limpido che lo tenga di nuovo unito. […] La finestra su una piazza, o qualcosa …
… qualcosa che rievochi i ‘dinosauri psicopompi’ del passato che un giorno torneranno, così come gli déi ancestrali della nostra dismessa immaginazione.
Note:
Tutti i corsivi sono dell’autrice Paola Silvia Dolci, diplomata presso il Centro Nazionale di Drammaturgia. Attualmente collabora con diverse riviste letterarie. È traduttrice e direttrice responsabile della rivista indipendente di poesia e cultura “Niederngasse”. Alcune sue opere più recenti: “I processi di ingrandimento delle immagini per un’antologia di poeti scomparsi” – Oèdipus 2017; “Diario del sonno” – Le Lettere 2021.
*
.jpg) - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusica Musiche e canti popolari dell’Ucraina
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGIA
MUSICHE E CANTI POPOLARI DELL’UCRAINA
(… il vento dal campo smuove solo metà dei fiori del giardino.)
Se la musica ha il privilegio di parlare un linguaggio universale, ancor più dobbiamo riconoscere ad essa la peculiarità di efficace veicolo di comprensione tra i popoli e, a buon diritto, di far parte delle discipline di studio specifiche che sono fonte primaria di conoscenza, alla quale, pure contribuiscono tutti i popoli della terra indistintamente, nessuno escluso, riconosciuti all’interno del fenomeno di acculturazione. Per cui, in prospettiva della “nuova realtà musicale” quale si è andata delineando in questa nostra epoca di repentini cambiamenti, studiare l’Etnomusicologia assume significato di riappropriazione delle testimonianze più rappresentative della cultura musicale dei popoli. Pur con le sue accezioni peculiari, vuoi musicali (strumentali), vuoi orali (poetico letterarie), inerenti agli usi e i costumi dei popoli che l’hanno determinata, nel loro effettivo stanziamento geografico, l’Ucraina può essere considerata a sé stante, per quanto rimangono sempre ben riconoscibili apporti ed influenze di altre popolazioni, spesso determinanti per lo strutturarsi complessivo di forti influssi che, in varie epoche ed a vario titolo, furono e sono presenti sul suo territorio: Russi, Bielorussi, Romeni, Moldavi, Bulgari, Polacchi, Ungheresi e Tatari di Crimea, insieme ad altre presenze minoritarie.
Influenze che, volutamente rivisitate come “espressioni originali” di singole autenticità, restituiscono, in taluni casi accertati, identità etniche-culturali ben definite, che ci permettono di riequilibrare lo stacco tra passato e presente di un seppur discontinuo percorso millenario, in cui la cultura slava costituisce il nucleo etnico fondamentale dell’odierna Ucraina. Quindi, pur mantenendo questo quadro composito come sfondo sul quale disegnare una qualche riflessione, è possibile, per quanto approssimativamente, individuare due aree culturali: “…quella centrale e nord orientale (composta dagli ucraini propriamente detti), una zona pianeggiante adatta all’agricoltura, la cui ricchezza spesso attirò l’avidità di popoli invasori che in ragione di facili spostamenti l’occuparono, (…) e una seconda, comprendente la parte nord-occidentale del paese in territorio caucasico, montagnoso, in cui le difficoltà di comunicazione (culturale) ed i problemi di sopravvivenza han fatto sì che si conservassero caratteri culturali più arcaici, all’interno di una tessitura etnica pur frammentaria. Pertanto le divisioni e le differenze nei caratteri musicali di questo popolo ricalcano, con buona approssimazione, queste due suddivisioni etnico-linguistiche presenti sul territorio dell’odierna nazione ucraina. (1)
L’Etnomusicologia vede l’Ucraina come un territorio da riscoprire, non solo come ricordo del tempo, o come magia e incanto perduto, in cui le diverse categorie di suoni percepiti vanno studiate come veicolo di comunicazione e di scambio per la comprensione tra le diverse etnie, piuttosto, come ha evidenziato in passato Alain Danielou (2): “… dei suoni per comunicare, spesso difficile da distinguerne gli elementi articolati, che noi chiamiamo linguaggio, dalle emissioni della voce, contraddistinte all’altezza del tono e dalla durata, che sono alla base della musica. Non a caso esistono, infatti, sul territorio, lingue tonali, recitazioni cantate e strutture musicali proprie del linguaggio parlato (...) che nel tempo hanno sviluppato forme musicali libere da qualsiasi funzione sociale, le quali, proprio perché svincolate da presupposti rituali, hanno progredito rapidamente sulla via del perfezionamento tecnico e del raffinamento del gusto”. In breve, tutto ciò conferma di fatto che non si conoscono popoli, fin da quelli primitivi ad oggi, che non abbiano conosciuto o che non conoscano una qualche forma musicale, sia che rientri nella propria cultura etnica (ritualità tribale) o faccia parte del proprio habitat naturale (rocce parlanti, vulcani tonanti, alberi suonanti, animali canterini), da cui l’uomo ha appreso la “formula” talvolta impregnata di magia, della musica esistente nel creato, così come le riscontriamo sul territorio ucraino.
Apprendiamo così che, l’insieme della cultura musicale e tutto ciò che ad essa ruota attorno, si rivela uno dispositivo fondamentale da farci riflettere sul suo significato. Eppure, anche quando con i primi studi antropologici, ci si è accorti che l’essere consapevoli della propria esistenza, non è dato per scontato, almeno non per tutti allo stesso modo, che supportare una campagna a sostegno della ricerca Etnomusicologica è fondamentale per una “presa di coscienza”, in grado di restituirci la consapevolezza dell’immenso ‘dono’ che ci è dato, determinata dal fatto che la musica, alla stregua delle altre arti, va considerata patrimonio di tutta l’umanità. Mi piace qui sottolineare un’affascinante intuizione di Marcel Mauss (3) il quale, con il triplice obbligo di “dare, ricevere e ricambiare il dono”, costituisce un “fenomeno sociale totale” a cui fare riferimento, all’interno di una prerogativa universale, pur con le sue diversificazioni e interazioni, le cui eredità peculiari e speculari che ogni popolo autonomamente ha corrisposto a quello successivo. Fatto, questo che ha permesso allo stesso Mauss di affermare: “…che tutte le società arcaiche, ‘primitive’ o ‘senza stato’ che siano, pensano il loro universo e perfino il cosmo, nel linguaggio scambievole del dono”, di cui la musica – aggiungo – figura tra i beni materiali della cultura universale.
Testimonianza questa, che ci consente di riconoscere una dignità culturale specifica, distintiva di molti popoli più o meno conosciuti in seno alla sempre più evoluta popolazione delle nazioni, per cui andare alla ricerca delle loro “origini” linguistiche, o tracciare le linee di un modello culturale che possano aver perseguito, come pure evidenziare i caratteri originali di cui si compone la loro tradizione musicale, assume significato di andare alla ricerca della “memoria del tempo” e di quanto ci permette di ripercorrere l’intero arco ciclico socio-musicale dell’umanità. È quanto più rientra nel lavoro dell’Etnomusicologo, il cui impegno dev’essere meta e linea di partenza di un percorso perseguito ma che è ancora tutto da scrivere. Etnomusicologia dunque, come acquisizione di un maggiore bagaglio culturale, per un sempre maggiore impegno sociale nella conoscenza di popoli e paesi “altri” dal nostro, che si aprono a noi e ci svelano i loro segreti e le loro gemme: la loro musica, i loro riti, le usanze e i costumi, l’artigianato e le opere dell’arte. Con ciò, rendendoci partecipi del loro mondo fantasmagorico, di colori, di note, di suoni, di strumenti, di canti e di balli, di manufatti popolari che hanno conosciuto la notte dei tempi, molti dei quali, mantengono ancora oggi tutto il fascino del loro mistero.
Ancora dalle note introduttive di Stefano Castelli (*) per l’edizione italiana del disco LP “Ucraina” – Collana Albatros – Editoriale Sciascia 1979, cito quanto segue: “Le divisioni e le differenze nei caratteri musicali risalgono, come accade per molti paesi europei, al XVIII ed al XIX secolo, allorché le manifestazioni folkloriche riferite al Granducato di Kiev, retta dal suo storico Patriarcato cattolico, più o meno contrapposto al patriarcato ortodosso di Mosca, che documentano un primo momento di unificazione etnico-politico nell’area balcanica. Su un altro versante parallelo, può essere utile considerare il canto liturgico che, importato dai bizantini con la religione Ortodossa, subì tuttavia modificazioni indicative, e fissare così l’inizio di una conversione dell’Ucraina, attestatasi attorno all’anno 989. In cui, si insegnavano alle popolazioni gli inni sacri servendosi di lingue paleoslave, pesantemente mediate fra il canto greco-ortodosso e quello ‘parlato’ dalle genti ucraine.”
Notevole fu l’apporto alla musica cosiddetta ‘profana’ suonata da suonatori girovaghi, detti ‘Skomorokh’, anche detti Tzigani d’Ungheria insieme ai Rom di Romania, che troviamo menzionati in proverbi, ballate e modi dire davvero originali. “Erano questi attori e musici girovaghi discendenti in linea diretta da un’antica tradizione di stregoni e sciamani che durante i loro spettacoli usavano indossare maschere di indubbia attribuzione magica, considerati propri dei tentatori satanici, la cui musica e i loro strumenti erano messi all’indice da un preciso precetto religioso che la definiva: “…come una tromba che durante la preghiera riunisce i guerrieri e gli angeli celesti, così i loro strumenti ‘gusli’ e ‘sopeli’ riuniscono i demoni svergognati”. Successiva alla dominazione mongola del territorio, nell’intervallo compreso fra il 1237 ed il 1480, l’Ucraina conobbe un lungo periodo di isolamento musicale che i musicologi riferiscono alla commistione fra i canti bizantini e quelli russi basati su sensibilità radicalmente diverse. La marcata differenza di un tempo fra i due diversi stili musicali non è quasi più riscontrabile se non nel canto, nel quale l’Ucraina utilizza la propria lingua nazionale, nella diversa pronuncia idiomatica da quella russa. Finanche gli strumenti musicali in uso sono, con qualche differenza di forme, gli stessi utilizzati in tutta l’area dei Carpazi, inclusiva di quelle forse più note tradizioni presenti rispettivamente in Romania, Bulgaria, Ungheria, Moldavia, Polonia e Slovacchia.
“Tra i numerosi strumenti ucraini conosciuti vengono qui ricordati solo i più importanti: la ‘kobza’, una possibile variante della ‘bandura’, che ricorda assai da vicino strumenti persiani o afgani; presenta un lungo manico munito di tasti, collegato ad una cassa ovale, sulla quale sono tese tre/quattro corde. La ‘bandura’ propriamente detta si presenta come un singolare incrocio fra un salterio ed un liuto, dal manico corto e tozzo, sprovvisto di tasti e, salvo che in alcuni casi di esecuzioni virtuosistiche, le numerose corde dette ‘prystrunky’, varianti nel numero di 50/60, sono fissate attraverso la cassa e vengono suonate ‘vuote’, cioè senza accorciarle schiacciandole con le dita. Un altro strumento molto in uso in tutta l’area è il ‘violino’ localmente denominato ‘skrypka’ sostanzialmente identico al violino europeo ma più rozzo, la cui costruzione è affidata a liutai di villaggio. Una connotazione a parte va data al ‘gusli’ in uso nelle zone appartenenti al gruppo linguistico slavo e sta a indicare una gran varietà di strumenti a corda quali: ‘husty’ e ‘hudity’, che significano semplicemente ‘suonare’. Sembra che originariamente il ‘gusli’ sia stato qualcosa di simile a un’arpa, tuttavia di difficile attribuzione territoriale.
La ‘duda’ è una cornamusa formata da un otre di pelle da cui si dipartono tre tubi di legno: il ‘sysak’, cioè l’imboccatura attraverso la quale il musicista la mantiene gonfia d’aria; l’’huk’ che fa da bordone basso, solitamente composto da tre pezzi di legno innestati l’uno nell’altro, nel cui mediano è innestata la lamina vibrante che produce il suono. La melodia è ricavata dalle due canne parallele con finale ad ancia con sei o sette fori che servono a modificare il suono. Fanno da accompagnamento diversi modelli di flauto, fra i quali il più diffuso è forse la ‘sopilka’, un flauto a becco con cinque o sei fori. Non in ultimo, troviamo il ‘flauto di Pan’, che può avere da due a sette canne. In una nota di colore si dice che in caso lo strumento difetti di una o più note che impediscono al suonatore di eseguire la melodia desiderata, questi intoni con la voce le note mancanti. (5)”
Ma che cosa avviene quando alla formazione di una data cultura ha contribuito più di un popolo e più di una singola tradizione che verosimilmente ne ha forgiato l’anima multiforme? E di conseguenza: quale impronta musicale, più o meno originale che sia, comunque tipica del territorio preso in considerazione, risulta accresciuta nella sua dimensione socio-antropologica? L’interrogativo è mio, ma stavolta e guarda caso, la risposta ce l’ho bella e pronta, offerta a scatola chiusa, niente meno che da Charles Darwin, il quale, nel suo “L’origine dell’uomo” (6) scrive: “Giacché né il piacere legato alla produzione di note musicali, né la capacità (di produrle) sono facoltà che abbiano il benché minimo utile diretto per l’uomo (...) devono essere collocate fra le più misteriose di cui egli è dotato”. La prima risposta è inclusiva nella domanda stessa, lì dove si determina un contributo comunitario e/o in qualche modo è possibile incontrare sul nostro cammino di ricercatori, taluni accorti studiosi che usano le rispettive tradizioni per imporre e sostenere un certo ordine di costumi, all’interno delle gerarchie socio-culturali e religiose, di riferimento etnico. Ciò che dà luogo però a un sminuzzamento della cultura, una certa particolarità non influente nella formazione della cultura stessa.
In Etnomusicologia la comparazione è importante perché accomunare le similitudini, le sinonimie e, per contrasto tiene conto delle divergenze, in modo da ricondurre gli effetti entro un comune "accordo" specifico di fondo. La seconda risposta prende avvio nello studio specifico del territorio oggetto di ricerca e ne valuta la tipicità, basandosi sulla morfologia e l'economia del medesimo, alfine di rintracciare quegli elementi materiali presenti in natura che hanno permesso all'umano antropologico di sviluppare il suo utilizzo musicale e la propria creatività, per quanto primitiva essa possa risultare. A fronte di quanto affermato, va inoltre detto che l’immagine di un mondo costituito soltanto dalle culture ufficiali e dalle confessioni riconosciute, per la maggior parte, sono prive di curiosità o di particolare interesse per la nostra ricerca etnomusicologica, in quanto il nostro coinvolgimento coincide più con ciò che è involontario e accidentale, e che “viaggia” fuori delle righe della uniformità culturale ufficiale e della escatologia precostituita.
Al noto ricercatore Stefano Castelli si devono, inoltre, le numerose “note ai canti” e molto altro ancora, che accompagnano la raccolta presente nel disco citato, utilizzate in questa presentazione etnomusicologica dedicata all’Ucraina, soprattutto perché non avendo conoscenza della lingua, non potevo fare altrimenti che affidarmi alla cura sostanziale dello studioso che le ha redatte, ringraziandolo per aver aperto un varco conoscitivo a un patrimonio che altrimenti sarebbe andato perduto. Stando altresì agli ultimi accadimenti in corso di una guerra che ha disperso un numero esorbitante di artisti, fra esecutori strumentali e cantanti, detentori di molta parte di questa tradizione musicale. Non potendo presentare qui alcuna traduzione dei canti, mi limito quindi alla citazione dei nomi di alcuni di essi e alla raccolta di note ad essi riferiti, talvolta appartenenti a singole popolazioni presenti sul territorio:
“Hutsul Kolomiyka”: gli Hutsul e/o Gutsul, sono una popolazione dell’Ucraina nord occidentale che presenta caratteristiche arcaiche sia per quanto riguarda la lingua, che per quanto si riferisce ad espressioni collegate a teorie demonologiche e rituali funebri, per lo più scomparsi nella loro forma originaria dal resto del paese. Non c’è quindi da meravigliarsi per alcune arcaicità presenti in questa ‘kolomiyka’ eseguita con la ‘duda’ nonostante sia un genere musicale fiorito attorno al 16° ed il 18° secolo, periodo in cui i sistemi musicali europei incominciavano ad essere conosciuti anche fra le masse rurali e, i cui influssi provenienti dalle diverse zone limitrofe al resto d’Europa si sovrapposero alla musica locale.
Il “Kozachok” è invece una tipica forma di danza accompagnata dal canto, in cui la ‘duda’ è accordata in modo diverso dal brano precedente. Il cui testo si struttura in strofe di quattro versi di sette sillabe ciascuno con un forte accento posto sull’ultima sillaba di ogni verso. In questo particolare caso la ‘duda’ ripete il modello melodico fornito dal canto, per iniziare poi una serie di variazioni nelle quali vengono introdotte nuove note e nuove figurazioni ritmiche.
La “Hutsulka”, è una musica da danza in cui risultano estremamente evidenti le influenze dei violinisti zingari rumeni. Troviamo qui tutti gli elementi che compongono il loro tipico virtuosismo: lo svolgere parallelamente al coro la medesima melodia arricchita di trilli, acciaccature, velocissime scale e, di contro, i momenti di sospensione in cui viene ripetuto sempre un semplice gruppo di note in modo da accrescere, da consumati istrioni, l’attesa dell’uditorio. Il coro puntualizza abilmente la dimensione ritmica con grida, urla, fischi, battiti di piedi e frasi parlate, proprie della partecipazione popolare alla festa, giustificata pienamente dalla maggiore diffusione su tutto il territorio, cui la ‘Hutsulka’ ha maggiore diffusione e rivendica palesemente la propria origine etnica.
Nelle tipiche danze ucraine segnate dalla partecipazione di un folto pubblico, si stabilisce un rapporto singolare: da una parte gli archi sembrano seguire, sostenendole ritmicamente e melodicamente, le voci dei danzatori e, dall’altra, voci soliste si staccano talvolta dalla tonalità del coro per riprodurre i modi esecutivi tipici dei violinisti tzigani. E veniamo ai due ‘canti corali’ da me utilizzati per il sottotitolo a questa lunga ricerca conoscitiva: “Il vento dal campo” (che smuove solo) “Una metà dei fiori del giardino”, a significare che per quanto dell’eredità accumulata per secoli dall’eroico popolo ucraino, solo una parte di questo patrimonio culturale potrà essere cancellato, e che i ‘fiori’ strappati dal vento di un’assurda guerra (come se non bastasse la pandemia ad accumulare i morti) rinasceranno per un’altra primavera: “Così come Cristo risorgerà per una e un’altra Pasqua ancora”. Così come ricrescerà l’erba dei prati e gli alberi dei boschi, le vaste piantagioni di messi che hanno contrassegnato il lavoro di questi instancabili agricoltori che da secoli contribuiscono all’ecosistema mondiale con il mantenimento di estese ‘foreste vergini’; la loro produzione di orzo, segale, mais e frumento che nel tempo gli sono valsi la denominazione di “Granaio del mondo”.
Di tutto il materiale musicale – proseguo nel citare il ricercatore Castelli – i due brani corali sopracitati sono gli esempi maggiormente collegati ad arcaiche pratiche di canto. La polifonia è infatti uno dei caratteri anticamente dominanti in quest’area, accomunata in primis dalla pratica del lavoro di massa contadino, con i quale si accompagnavano i lavoratori e le lavoratrici durante la raccolta dei frutti della terra, (si rammentino i canti delle mondine e degli scariolanti in Italia), e non solo. Inoltre ai vicendevoli scambi fra polifonia liturgica e polifonia popolare, l’antichità del carattere polifonico è testimoniata anche dal fatto che, all’inizio del processo di inurbamento, da più parti si è sottolineata una netta differenziazione fra lo stile delle campagne e quello di matrice ‘colta’ che si andava sviluppando nelle città nonostante la diversa identità (religiosa e/o profana) fra le linee melodiche e i testi delle canzoni, nella suddivisione possibile fra “canzoni di villaggio” e “canzoni di città”. In entrambi i casi la polifonia risulta pienamente contrappuntistica; le varie linee melodiche si intrecciano e si separano allo stesso modo, non limitandosi a cantare per intervalli paralleli.
Nella tessitura composita del patrimonio rituale di una cultura – scrive ancora Stefano Castelli – le pratiche riguardanti il matrimonio occupano spesso un punto nodale, importantissimo, fondamento medesimo musicale dell’Ucraina, che possiamo dividere in canti in qualche modo corrispondenti ai momenti eclatanti del rito: le canzoni di addio e le lamentazioni dei parenti della sposa; i canti di carattere mitologico, cavalleresco o eroico cantati durante i festeggiamenti e i banchetti; le strofe a sfondo erotico eseguite nelle vicinanze della casa in cui gli sposi si preparano a trascorrere la prima notte delle nozze; infine, le canzoni di matrimonio propriamente dette, cantate durante lo svolgimento del rito. Anticamente infatti il rito durava giorni, scandendosi con precisione in un accurato sviluppo minutamente preordinato. Tralasciando il passato, rimane facile notare la pressoché completa identità di alcuni canti matrimoniali, per quanto riguarda lo stile melodico e i modi di esecuzione, con i canti agrari del raccolto. La cui funzione raccoglie intorno a sé stili diversificati relativi a funzioni diverse. Il matrimonio, quindi, vissuto come momento di mescolamento in cui è presente una molteplicità di temi paragonabili solo a più antichi riti di iniziazione che comportano sempre uno scenario di morte iniziatica.
È questo della morte un altro momento rituale assai marcato nei canti di matrimonio, specie da parte dei parenti della sposa per cui ‘sposarsi’ equivale allontanarsi dal clan di appartenenza per seguire il marito; come morire e viceversa rinascere in altro luogo. Non a caso i funerali di una ragazza assumono la forma di un matrimonio, con canti e musiche allegre. Le simbologie usate nei testi sono assai esplicite: “la sposa muore per il suo clan”, “la fanciulla sprofonda nel mare”, “il ramo è divelto dalla pianta” e così via. I canti relativi vengono eseguiti da due cori, solitamente femminili, guidati da due attendenti. Il testo descrive, in forma di contrasto, tutti i momenti del rituale: come accade per gli incantesimi, la partecipazione umana deve essere costante e l’attenzione più minuziosa deve essere posta in tale atto ‘legislativo’ in modo che nulla venga turbato e sfugga al controllo dei celebranti. Così, appare spesso che l’atto di rapimento della sposa da parte del clan del marito, deve sembrare che ella venga obbligata ad andarsene, per non offendere il clan originario.
Se è vero che la musica ha il potere di mantenere vivi certi suoi caratteri a distanza di millenni, che continua a essere suonata e intonata negli stessi luoghi dove si è formata, ciò vale altresì per la parola orale e scritta, per la letteratura come per la poesia, per i gesti rituali così come per il canto e la danza, che troviamo, pur con migliaia differenziazioni in ogni parte del mondo e presso tutte le popolazioni conosciute. Gli esempi potrebbero essere infiniti, sebbene a tutti va dedicata, da parte del ricercatore, una particolare attenzione. Soprattutto perché, ogni singolo momento nell’ambito della vita e della cultura di ogni singolo popolo, rappresenta una condizione sperimentale evolutiva, e la musica è sempre stata la più attaccabile dai bacilli delle mode e della modernità, e non sempre in maniera eccepibile. Appare chiaro, dunque, come l'eredità di questo approccio sia fondamentale per comprendere la pluralità dei codici e dei linguaggi, centrale nella teoria postmoderna, nonché sia applicabile ante litteram alla situazione contemporanea della multimedialità, dell'ipertestualità e della contaminazione «in rete», che della teoria postmoderna sono l'esito ultimo e più complesso.
Orientamento teorico e metodologico risalente, con diramazioni successive, all'opera del linguista svizzero Ferdinand de Saussure, che considera la lingua come un insieme strutturato di elementi interagenti e interdipendenti; successivamente la definizione è stata adottata anche per indicare gli indirizzi di pensiero che hanno esteso alle scienze umane i principi dello strutturalismo linguistico, per cui i fenomeni culturali sono visti come insiemi organici tra i cui componenti vigono relazioni costanti e sistematiche: l'antropologia (con Claude Lévi-Strauss), la critica letteraria (con Roland Barthes), la psicanalisi (con Jacques Lacan), l'esegesi marxista (con Louis Althusser), la filosofia della cultura (con Michel Foucault) e la neo-liguistica (con Roland Jakobson). Per una comprensione analitica del fenomeno cfr. G. Fornero e F. Restaino, Nicola Abbagnano – “Storia della Filosofia”, volume X in “La filosofia contemporanea” (7). Come scrivono E. Schultz e R. Lavenda, autori di “Antropologia Culturale” (8): “Il sapere etnografico risulta sempre mediato da sguardi orientati, da contesti storici e relazionali, da prospettive ideologiche e biografie situate. Ma si farebbe un grave errore pensare di dover depurare o cancellare questa mediazione: si perderebbe la possibilità stessa di riconoscere le fonti e le modalità del processo conoscitivo che si è attuato; verrebbe meno la possibilità di ricostruire e di dar senso alle energie e alle risorse della trasformazione avvenuta. La comprensione dell’altro culturale scrivono gli autori echeggiando posizioni vicine all’ermeneutica contemporanea, e in Italia per molti versi anticipate dall’antropologia di Ernesto de Martino – è costruita intersoggettivamente, utilizzando elementi tratti dal sistema culturale sia dell’antropologo che dell’informatore. Afferrando il significato del sé culturale dell’altro, scopriremo in parte il significato della nostra identità”.
Conoscere la storia di un territorio, la morfologia della sua natura, il clima, la flora delle sue pianure e la fauna dei suoi boschi, le condizioni di vita della sua gente, certo aiuta a comprendere la pur “semplice” vena creativa delle sue tradizioni popolari, a conoscere l’origine dei racconti di fiaba, la derivazione mitologica delle sue leggende. Così come conoscere le “sorgenti” della musica e del canto, permettono di comprendere la creatività dei virtuosi strumentisti che molto successo riscossero presso i musicisti colti nelle corti europee gli studiosi del folklore. L’etnomusicologia si è occupata poco di questa regione “narrata e vissuta” in musica dal popolo pur variegato che l’ha formalizzata dentro schemi originali irripetibili. Ciò seppure è possibile affermare che una linea musicale comune li abbracci tutti, secondo una sorta di reciprocità e interscambiabilità che conferisce ad essa una sorta di uniformità e, in qualche modo, di unicità, riscontrabile e riferibile come ad un'unica entità popolare. Fra tutti vanno qui ricordati le voci della letteratura di tradizione ucraina, la cui voce poetica più antica è rintracciabile nelle ‘byliny’, canti epici del tempo in cui, all’alba del millennio passato, Kiev lottava contro i nomadi delle steppe, ed in tutta una vasta creazione popolare rimasta anonima, tramandata oralmente per secoli, prima di essere fissata sulla carta. La parte più originale di questa tradizione dell’antica letteratura sorta in terra ucraina è costituita dalle epopee di cui il “Canto della schiera d’Igor”, rappresenta l’esempio più mirabile.
Ma è anche necessario inoltrarsi nelle abitudini di un popolo per poter scoprirne l’entità vitale e recepire al meglio le sue tradizioni. È così che visitare un paese richiede inoltre di esaminare quelli che possiamo definire gli ‘archetipi’ della sua religiosità, i caratteri essenziali della sua cultura, le espressioni tipiche della sua arte, come i manufatti, la cucina, il bere, e non solo riferiti al passato. Bensì anche la residualità di quanto si proietta nel presente, come l’accoglienza e la generosità del suo popolo. Nonché conoscere la cucina ucraina in quanto parte integrante della cultura popolare che si riflette nello stile di vita e negli usi e costumi di tutti gli ucraini. Infatti la cucina ucraina si riconosce in modo particolare per la grande varietà di sapori e la diversità di ingredienti utilizzati, per lo più carni, funghi, verdure, barbabietole, frutta e vari tipi di erbe. Alcuni piatti tipici della cucina ucraina sono tra i più semplici da preparare. I cibi si accompagnano con vini locali e non, diversi tipi di birra, vodka, o te, ed altre bevande anche molto diffuse come in particolare la ‘horilka’, un distillato chiaro ricavato dal frumento e dalla segale.
Non trascurabile, sempre che la conoscenza della lingua lo permetta, e magari cercare qualche traduzione in altro idioma, dare uno sguardo alla letteratura presente sul territorio che pure conosce una storia lenta affermatasi fin dal XV secolo. “Una letteratura propria dell'Ucraina si afferma già nel XV secolo. La letteratura ucraina raggiunge il massimo splendore con Ivan Franko (1856-1916), e soprattutto con il poeta nazionale ucraino Taras Hryhorovyč Ševčenko (1814-1861), autore di ballate e poemi epici di stampo nazionale. Nel XX secolo si afferma, tra gli altri, la figura della poetessa Lesja Ukrainka (1871-1913). Tra il XX e il XXI secolo tra gli scrittori di storie per bambini si distinse Vsevolod Nestajko. Prevale, inoltre, un tipo di scrittura di carattere sociale e nazionalpopolare. In campo filosofico, nel XVIII secolo, tra gli altri, si afferma la figura di Hryhorij Skovoroda (1722-1794), che fu anche poeta” (9). In musica, come si è visto, è possibile definire la tradizione ucraina come una ‘musica senza confini’, un intrico meraviglioso di ‘strade sonore’ diverse. Per chi non è abituato a frequentarle, sono racchiuse tra questi due estremi: Occidente e Oriente, crogiuolo di stili e assonanze diverse ove si riscontrano influenze arabe ed ebraiche, mongole e tatare, ortodosse greche e altre appartenenti alla cultura islamica. Nessuna di queste però è più definita delle altre.
Dacché l’ascolto del disco sopracitato, l’unico che ho rintracciato in questo periodo di assenza totale dal mercato, rivela contaminazioni vissute e metabolizzate che pure resiste all’occidentalizzazione, insieme ad un miscuglio talvolta finanche fastidioso all’orecchio impreparato. In altri momenti però rivelatrici del fascino misterioso orientaleggiante cui ci hanno abituati i grandi compositori russi, quali, ad esempio, i romantici Glinka e Mussorgsky, attraverso le opere dei quali ci si ritrova nel mezzo di feste popolari e pagine entrate nella grande musica classica; arabeschi e armonie di tradizioni antiche e desideri nascosti e forse sconosciuti. Ma limitarsi a ciò sarebbe voler conchiudere la tradizione ucraina entro un perimetro sonoro che non conosciamo appieno; che altresì, nel tentativo di semplificare un panorama complesso e variegato, è ‘fonte estrema’ di rinnovamento musicale integrante di una cultura orale comunque millenaria. “Tra le cantanti ucraine vanno ricordate , tra le altre, Alina Grosu e per il genere pop e Rhythm & Blues Svitlana Loboda; Ruslana Lyžyčko che con il singolo “Wild Dances” ha vinto l'Eurovision Song Contest 2004, svoltosi in Turchia. In seguito l'Ucraina vinse nuovamente con la cantante Jamala nell'edizione dell'Eurovision Song Contest 2016. Tra i cantautori spicca Volodymyr Ivasjuk e la nota cantante lirica che è stata Solomija Krušel'nyc'ka. Per la musica classica ricordiamo la pianista Valentyna Lysycja, che ha assunto rilevanza internazionale (10).
Quanto rimarrà di tutto questa ‘fonte sonora’ dopo gli ultimi eventi della guerra ancora in fase di attuazione e in attesa di accordi di pace, che tutti auspichiamo, non so dire. Che nel 2022, si faccia una guerra per la supremazia di una nazione su un’altra non ha oggi alcun senso, è comunque un’offesa alla dignità umana e alla rispettabilità di un popolo civile. Ingrata per chi la fa e per chi la subisce, perché infine chi ne trarrà la vittoria, si ritroverà comunque con una forte perdita in numero di vite umane, di distruzione totale del territorio e carenza di materie prime di cui avvalersi nel processo di sopravvivenza. Davvero non ci sono parole aggiuntive che possano scusare un misfatto simile a quello che si sta consumando in quest’area continentale con la possibile estensione alle altre nazioni limitrofe e, soprattutto, con la probabilità di scatenare altre ‘menti’ offuscate dalla sete di potere o d’imperialismo autocrate. Nessun imperatore o despota che si ricordi nella storia è mai sopravvissuto al potere esercitato dalla cultura dei popoli, all’espressione di quel ‘sapere’ che le genti hanno depositato nel serbatoio della memoria del mondo.
Testi di consultazione:
“The New Oxford History Of Music” vol.1 – Oxford Press – London - per l’Italia Garzanti-Feltrinelli – Milano 1991.
“Enciclopedia della Musica” – Garzanti, Milano 1996.
“The Larousse Encyclopedia of Music” – The Hamlyn Publishing Group – London 1978.
“The world of music”, Journal of the International Institute for Comparative Music Studies – Berlin in association with The International Music Council (UNESCO). Chairman of the Board: Alain Danielou.
Note:
(1) Oliver Sacks: “Musicofilia” - Adelphi, Milano 2009.
Medico e scrittore, vive a New York dove insegna neurologia e psichiatria alla Columbia University Artist. È autore di molti libri, fra i quali “Risvegli”, da cui è tratto il film che 1990 ebbe tre nomination agli Oscar. “Ogni storia cui l’autore dà voce illumina uno dei molti modi in cui musica, emozione, memoria e identità s’intrecciano, e si definiscono. Forse la musicofilia è una forma di biofilia, giacché noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva” (dalle note di copertina).
(2) Alain Danielou: The International Music Council, “Musical Atlas”, Note introduttive alla collana Unesco Collection by the International Institute for Comparative Music Studies (Berlin/Venice). Emi-Odeon.
(3) Marcel Mauss: "Saggio sul dono: Forma e motivo dello scambio nelle società acaiche" – Einaudi, Torino 1965. Antropologo, sociologo e storico delle religioni francese, massimo esponente della scuola di Durkheim. Collaboratore della rivista Annéè Sociologique, fondata nel 1898 da Emile Durkheim. "Saggio sul dono", nasce dalla comparazione di varie ricerche etnografiche, tra le quali lo studio del rituale potlach di Franz Boas e del Kula di Bronislaw Malinowski.
(4) Stefano Castelli, scrittore e traduttore, musicista curatore delle note bibliografiche della produzione Albatros per la Editoriale Sciascia dagli anni ’70, ha curato inoltre l’uscita del disco (LP) qui presentato dal titolo “Ucraina” nel 1979. In nota: “Si può dire che, come in tutte quelle che pretendono di possedere una validità appena un poco generalizzata in un settore così magmatico quale è quello della musica popolare, richiederebbe una dimostrazione assai lunga e complessa.”
(5) Stefano Castelli, op.cit.
(6) Charles Darwin, “L’origine dell’uomo” …
(7) Schultz / Lavenia, “Antropologia Culturale” ….
(8) Nicola Abbagnano – “Storia della Filosofia”, volume X in “La filosofia contemporanea”.
(9) Wikipedia, alla voce “Ucraina”.
(10) Ibidem
*
 - Psicologia
- Psicologia
Un perfetto ‘equilibrio confusionale’.
Un perfetto ‘equilibrio confusionale’.
Lacan e me.
Parlando davanti allo specchio del bagno, in presenza di Jacques, convengo di apportare una leggera variante alla prospettiva lacaniana su alcune certezze acquisite, affatto scontate, in una delle quali si fa riferimento allo “squilibrio confusionale” di alcuni soggetti che, pur in stato confusionale, trovano nella loro quotidianità un proprio costante ‘equilibrio’. Faccio un esempio: Margy E. vive in un appartamento spazioso in centro città, arieggiato e ben illuminato, sì da permettersi una vita agiata e accomodante, a tal punto da circondarsi di mobili e quadri d’autore di un certo prestigio, oggetti di design, collezioni di libri, dischi musicali e film, secondo una scelta del tutto personale ma che darebbero le vertigini a chiunque volesse azzardare una lista o un ipotetico inventario.
Non c’è che dire (o ridire), per carità! Si pensi tutto ciò come proiettato in un possibile ‘bazar’ orientale, stracolmo di migliaia di cianfrusaglie d’ogni genere: poggiati qua e là vecchi giornali e riviste, tappeti e cuscini colorati, sculture lignee e marionette, per non dire dei ventagli incorniciati alle pareti. Altrove: manufatti e utensili di tipo contadino, moderni elettrodomestici da cucina, alimenti ancora imbustati di un’ultima visita al supermercato e, dulcis in fundo, una tavola costantemente apparecchiata, pronta a ricevere chiunque si presenti sulla porta, come se non si stesse aspettando altro. In questo caso io che mi domando se sono approdato al Bazar di Istanbul o al Suk del Cairo, o chissà, a L’Antico e le Palme di San Benedetto del Tronto o solo al mercato di Porta Portese in quel di Roma.
Nient’affatto, mi dico appena sveglio, sono in casa della mia migliore amica e tanto basta. Margy E. è una donna amabile e solare, generosa d’affetti e prodiga di liberalità ma che, forse, o proprio per questo, vive nel disordine assoluto, perfino l’orologio appeso alla parete segna un orario a dir poco strano, quasi ad avallare il detto che “almeno due volte al giorno segna l’ora esatta”. Non so dire se sia corretto vivere in tale continua approssimazione, ma comprendetemi, appena sveglio di primo mattino, almeno al suo orologio segna le 11:00, la cosa di per sé confonde non poco le idee, almeno le mie, che non riesco neppure a trovare la porta del bagno. George fai in fretta la colazione è in tavola! – esclama Margy dall’altra stanza. Quando mai, a quest’ora, mi dico, perplesso pensando a quale ora dunque è prevedibile il pranzo.
Ovviamente non è tutto, il bagno rappresenta il ‘salone delle meraviglie’: spazzole e spazzolini, pennelli e tamponi, ciglia finte e parrucche, matite colorate da far impallidire la tavolozza di Matisse, asciugamani d’ogni dimensione appesi qua e là finanche agli sportelli della doccia, ed altri minuscoli e colorati che non saprei dirne l’uso, una mutandina (si fa per dire) di pizzo color lilla, un’altra nera, un’altra ancora rossa fuoco. Nonché alcuni reggiseno minimalisti, non suoi penso, poiché non potrebbero sostenere l’abbondanza trasbordante delle tette di Margy. Non c’è che dire, non riesco a trovare il rotolo della carta igienica. Dopo la doccia riesco a malapena a trovare il fon per i capelli allorché tutto incomincia a vorticare in aria, come per l’arrivo improvviso di un ciclone. Mi chiedo che circo è questo?
Chiamo ad alta voce: Margy mi serve il tuo aiuto! Ma George che mi combini, non hai pensato di abbassare la potenza del fon? In verità no. Sta a vedere che è mia la colpa di aver mandato ogni cosa in aria, non sua che ha spento il fon sulla tacca della bora. Ma che cosa direbbe l’amico Jacques (Lacan) a proposito di tanto scompiglio? – chiedo alla figura riflessa nello specchio (cioè io). È il sintomo della paranoia latente che abita ciascuno di noi come possibile consequenzialità della psicosi di uno “squilibrio costituzionale”. Lampante ma non chiaro, disarmante direi. Il fatto è che Margy agisce istintivamente in modo ovvio. Nel suo ‘casino’ riesce a divincolarsi dalla presa occulta delle cose, entrare e uscire con ovvietà negli scaffali e nei cassetti, negli sportelli degli armadi e degli appendiabiti ancora non disfatti di ritorno da un ultimo viaggio.
Quel che conta, sempre che gli si dia la giusta importanza, sta nel fatto che Margy, pur nella sua vaga (nessuna) concezione di ordine, trova tutto ciò che le occorre in un battibaleno e nel modo più inimmaginabile, come se tutto stesse per lei a portata di mano. Sì certo poi lascia ardere sul fuoco la casseruola del sugo giusto in tempo per non farlo bruciare del tutto, mentre sta buttando giù la pasta nell’acqua che bolle, rovescia del vino nel versarlo frettolosamente nei calici di cristallo, ma solo casualmente. Che vuoi che importi George, le tovaglie si lavano, mentre noi vogliamo brindare, non è così? Cin, cin e auguri! Vado a riordinare il letto. Ma a che serve mi chiedo, dacché ci siamo appena alzati? Per un momento ho pensato che stavamo preparandoci per uscire, ma poiché stentavo ad alzarmi da tavola, ho sentito la sua mano trascinarmi via, nell’altra stanza ovviamente.
Definire tutto ciò un plausibile ‘equilibrio confusionale’ mi dice che sono nel giusto, che le parole spese a definire la paranoia un elemento di ‘squilibrio esponenziale’ da parte di tanta letteratura scientifica, psicologica e psicoterapica, mi dispone verso la ‘illogica’ conclusione che percettivamente Margy, dentro “la somma dei suoi elementi” è assolutamente originale, in bilico se vogliamo, fra l’euforia del suo mondo surreale, e la schiacciante realtà dell’ontologia classica che pretende, costi quel che costi, il condurre una vita ordinata e conclusa in se stessa. Questa ipotesi formale (e antipatica) dice alla figura speculare dentro lo specchio che, c’è qualcosa d’altro, un di più rispetto all’immagine che rappresenta, e proprio per questo motivo essa esercita sul soggetto (l’io che mi porto dentro), un simile potere di fascinazione.
Quel qualcosa in più che sta nello sguardo speculare al nostro da cui spesso prendiamo le distanze, nel timore che ci riveli quel che siamo: “la piccola fragile immagine in uno specchio”, e non quello che vorremmo apparisse di noi, senza crepe né ombre alcune: la paranoia vagamente nascosta di un vivere a confronto con un narcisismo eclatante ...
(continua)
*
 - Filosofia
- Filosofia
Il prezzo della guerra … i guasti dell’umana terra.
Il prezzo della guerra … i guasti dell’umana terra.
Con una semplice commutazione di intenti nell’apoteosi linguistica dell’alfabeto, troviamo la lettera ‘M’ che, nei simboli numerici romani, indica Mille, cioè mille e più significazioni che vanno da: Montagna della Perfezione, alla Madre Terra, la cosiddetta Mater Matuta, alla Madonna e tantissime altre, ma, ed anche, Miseria e Morte. Quest’ultime, ben presenti nella quotidianità, rientrano in quella che definiamo negatività dell’esistenza cui non è mai stata data alcuna risposta accettabile. Essendo la tredicesima lettera dell’alfabeto, come si sa, il numero ad essa riferito è considerato infausto nei paesi del Nord e fortunato nei paesi del Mediterraneo.
Ancor più perché nella simbologia dei Tarocchi, la tredicesima carta, rappresenta l’Arcangelo Azrael, colui che governa sull’occulto e il misterioso, in quanto è Guardiano delle Anime, Custode della Vita e della Morte; colui che taglia con una falce un campo nero come la notte più nera, cosparso di teste e corpi senza riguardo alcuno: uomini e donne, giovani e vecchi, cadono dinnanzi al Quarto Cavaliere dell’Apocalisse. Al suo ‘rovescio’ vige un’interpretazione contraria, alla quale va riservata una particolare attenzione, non solo necessaria quanto raccomandata che recita di “non arrendersi ad una concezione unilaterale di cieca fatalità perché contraria allo spirito di ogni divinazione” più o meno autentica.
Infatti Morte significa anche successione senza fine “da un piccolo ‘io’ a un grande ‘noi’”, al tempo stesso rinnovamento, vita nuova, vittoria sulle avversità, un cambiamento nel flusso perpetuo di un tutto vitale che porta alla trasformazione, alla rinascenza. Ciò che non hanno ancora compreso i ‘signori della guerra’ (tutti quei despoti oppressori che avallano crimini verso l’umanità), che un ‘capovolgimento’ delle circostanze, porterebbe a un annientamento delle loro stesse forze messe in campo. ‘Mille e non mille’ non è mai stato solo un modo di dire, bensì un argomentare palese dell’insegnamento della storia: onde alla fine né vincitori né vinti sopravvivranno alla giustizia divina.
Ma il prezzo della guerra non riscatta i guasti che la stessa porta all’umanità tutta, che “lo scostarsi dalla giustizia è un decadere dalla natura umana” (Marco Aurelio); che se “al giusto nuoce chi al malvagio perdona” (Monti), allora anche in guerra “va usata umanità, discrezione e misericordia” (Machiavelli), e non sarebbe giustizia se si volesse condonare le pene ai colpevoli al dolore degli innocenti” (Manzoni). Sì che “il sangue versato serve soltanto a lavare le mani dell’ambizione criminale” (Byron). Tutto infine coincide nell’interrogativo posto dal saggio: “se noi riconosciamo che errare è dell’uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia (?) (Pirandello).
Non lo è, perché se la giustizia degli uomini è cieca, la giustizia posta in essere da Azrael non lo è affatto, in quanto gli è dato il potere di prendersi cura delle anime dei morenti, in virtù di una ‘giustizia più grande’ che le attende nell’al di là. Tuttavia se “ogni guerra di libertà dall’oppressione è sacra, ogni guerra messa in atto dall’oppressore è maledetta” (Lacordaire). Acciò, “le armi si debbono riservare in ultimo luogo, dove e quando gli altri modi non bastano”; “i popoli corrono volontari sotto l’ala di chi tratta i vinti come fratelli e non come nemici” (Machiavelli). Onde “prepararsi a rispondere a una guerra ingiusta è solo un mezzo efficace per conservare la pace” (Washington); “il segreto per vivere in pace con tutti, consiste nell’arte di comprendere ciascuno secondo la sua individualità” (Jahn)…
“All’uomo infine non rimane che una timida scelta fra la felicità dei sensi e la pace dell’anima” (Schiller). Sì che andrebbe ricordato che “la terra è ampia abbastanza, e tutti feconda, può pascerci tutti (fraternamente), può altresì seppellirci tutti” (ragionevolmente)”. (Bini). Non v’è alcun bisogno che i popoli si facciano la guerra.
Note:
Massime, pensieri e aforismi liberamente tratti da …
Paolo Santarcangeli “Hortus Litterarum” – All’Insegna del Pesce d’Oro 1965.
Palazzi, Spaventa Filippi “Il Libro dei Mille Savi” – Cisalpino Goliardica 1967.
*
 - Filosofia
- Filosofia
Ombre nel buio … poeticando su questo nostro essere infinito
Più volte, dopo essermi assopito per un breve istante, apro gli occhi e mi chiedo se non sia già l’indomani o se invece non sia il prolungamento astrologico di ieri, tanto i giorni hanno per me lo stesso colore e il medesimo incanto. Quale che sia l’ardore per la bellezza perseguita o inconsciamente suscitata, improvvisamente evapora, sostituita da ore d’incolmabile astrazione e nulla più m’importa se l’orologio al posto del tempo scandisce la luce o l’oscurità che l’attende. Giunto alla fine del giorno credo di possedere una certa cognizione per cui ad ogni sorgere dell’alba segue un voluttuoso tramonto che dopo un ultimo abbaglio di luce s’accompagna al buio di un’oscurità ignota che mi spaventa e affascina allo stesso modo.
Vedo così spalancarsi davanti ai miei occhi attoniti, lontani spazi di profondo chiarore, baluginii di un’aurora appena intravista e ancora inviolata, che nel suo profondersi dentro la notte mi restituisce all’opale chiarore d’una vaga certezza. Finché la mia ferma aderenza alla realtà recupera alla dissimulata voce del silenzio mattutino, la sua chiarezza oggettiva, la prospettiva del passato nel presente onde la vita finisce per essere intimamente avvolta nell’immensità che mi sovrasta, nella parvenza virtuale di una qualche congiunzione cosmica. E non m’importa dar seguito all'illusoria assenza del passato, né di contribuire ad affermare il presente, effimero e comunque passeggero, quanto di addentrarmi nel profondo d’una nuova identificazione con la Luna che mi viene incontro per un ultimo saluto.
Ma le parole s’affacciano labili alla mia mente e presto svaniscono sulla scia di un miraggio che pian piano si disperde negli spazi inviolati di un possibile 'altro' ch’è in me, nel costante sdoppiamento di un ‘io’ diverso che si dissolve nella polvere cosmica di un vortice astrale che mi coinvolge e stravolge. Così, in quell’andare ‘oltre’, che sempre si rivela come la mera possibilità di valicare l’invalicabile, avanza il desiderio di guardare attraverso gli uadi segreti del tempo e oltrepassare lo spazio infinito, seppure non ignori che da qualche parte dev’esserci una fine per quanto imprevedibile essa sia. L’immediato desiderio di spalancare il velo ignoto del cielo spazia nella mia mente nella ricerca vana di catturare la segreta essenza di un ‘tutto’, quasi fosse il prolungamento conscio della vita inconscia, scorgo molteplici Lune che s’affacciano e vanno a spasso nell’universo, quasi da poterle afferrare, se solo lo volessi.
Per quanto, nel timore d’infrangere la pacata immensità di quel cielo, là dove talvolta l’anima s’invola rivelando a se stessa la propria grandezza e la propria iniquità, non oso svincolare il mio pensiero dal seguire la vocazione di perdermi nella vastità cosmica che si dilata a dismisura, sì che la materia si presenta nuda davanti all’invisibile e s’apre a una lenta genesi. Onde accecato, nell’incedere nella nuova realtà vengo proiettato in una vaga sensazione di prosieguo che sfugge alla materia corporea che mi compone, nell’inconscio della mia esistenza. Sì che la mia immagine riemerge nella consapevolezza di quel silenzio infinito che porta alla solitudine estrema, al vuoto assoluto che precede il vago sentore d’una eternità obliata, come sul punto di approdare alla pura essenza del divino.
Almeno per un istante credo di assistere al precipitare epifanico della forma oggettiva dello spirito, di ciò “che non è mai ma che è per sempre”, come di un precipuo concetto di bellezza che trascende nel divenire del sogno e dell’immaginazione, ed occupare infine ogni spazio dentro e intorno a me nella vacua realtà del nulla. E mentre tutt’attorno ogni cosa si mescola impercettibile, discopro nell’intimo timore che mi coglie la luminosità di un’altra Luna lontana, immaginifica e immensa, diversa dalla vecchia e misteriosa musa dell’innamorato e del poeta. Allorché, senza neppure che me ne renda conto, vago smarrito entro quella possibile verità 'altra' che posta al di sopra di ciò che sono, porta all’intima essenza di quell’io che vaga leggero fra le stelle più lontane, partecipe silenzioso del mistero dell’universo e della sua tranquilla infinitezza.
Ma nell’impossibilità di condurre lo sguardo oltre lo scintillio del firmamento che mi compete, procedo alla ricerca di quella misura astratta che anzitempo deve aver visto l’uomo, immergersi nel movimento cosmico degli astri. Sì che d’un tratto, rimango a contemplare il fuoco di ramaglie al di sotto della grande cupola della notte, sospesa com’è nell’immutabile e umanissima certezza del creato. In verità non ho mai sottovalutato il desiderio inestinguibile di senso, lo spazio irriducibile dell’interpretazione, la parola come superamento del silenzio, come neppure ho mai pensato a una concezione del tempo che propendesse per un atteggiamento diverso nei confronti del presente o del passato. Piuttosto, che rendesse pensabile una diversa costruzione del futuro, ove il tempo non fosse semplicemente memoria di forme, o apparenza di significato, bensì incontro di realtà e immaginazione, ripetizione volontaria dell’inconscio ch’è in me, reminiscenza di quel presentimento del fantastico immaginario che si annida in ognuno di noi, abbagliato da tanta bellezza.
Come certamente occorse al grande viaggiatore Jean Potocki sul finire dell‘800 davanti a ciò che non era mai cambiato nell’astratta sensazione del vissuto, la cui sembianza figurativa del passato diventava ripetizione di ciò che siamo, anch’io mi sono posto la domanda: “quale anima è così inaccessibile all’ammirazione da potersi sempre difendere da questo esaltato sentimento che è l’immaginario?”. Ma la risposta ahimè non mi ha raggiunto se non nella matura età, in cui ho ritrovato me stesso, allorquando, riscoprendo la memoria antica, l’ho sentita farsi presente nella realtà del tempo in cui vivo, quale dimora essenziale di ciò che sono. Seppure, in virtù di ciò che prevarica il mio segreto sentire, tendo a trasportare l’impostazione conoscitiva al di sopra dell’orizzonte cosmico che mi è dato, consapevole che ogni mia azione trova una diversa ragione d’essere, in cui l’immaginario si esprime e si rappresenta secondo le tendenti aspettazioni alchemiche e metafisiche delle premesse, onde né il desiderio di scienza né l’attenzione del filologo, hanno mai smentito il manifestarsi poetico del ‘limine’, in cui ‘l’altro’ ha trovato la sua affermazione sulla ‘soglia’ di quell’infinito cui di fatto tutti noi aneliamo, fissi davanti alla solitudine dell’universo, che una guerra oggi inconcepibile porterà alla dissoluzione, di ciò che rimane …
… se mai qualcosa ne resterà di noi.
*
 - Poesia
- Poesia
’In tono minore’ Una silloge di Evaristo Seghetta Andreoli
Una silloge poetica di Evaristo Seghetta Andreoli – Passigli Editori 2020.
Talvolta accade che l’uomo, nel silenzio dell’ombra che l’accompagna penetri nell’antro numinoso di un universo sospeso, che in ‘assenza di una chiassosa visitazione del proprio ego’, il poeta che pur vive in lui, si conceda all’affannosa ricerca di un’intima emozione che lo pervada. È così che nella sua scrittura, solo apparentemente dimessa, questi apra il suo cielo cosparso di stelle al chiarore di una luna infarinata di biacca, come quella di un clown che mostra al contempo, la sua ingenua meraviglia e la sua amara inquietudine, tema portante – a mio parere – di questa silloge poetica di Evaristo Seghetta Andreoli …
“Ho accettato di stare a metà
sulla scala verso l’altopiano delle stelle.
L’altro dimora all’ombra di edere antiche,
sotto i muri del romitorio.
Varie le reazioni alla speranza:
di certo non rispondono ai dettami del cuore.
Ci lega tutti questa sola strada
che sale e scende in armonia col prato,
nell’attesa di conoscere domani
il colore del nostro fiore”.
Ma non v’è meta nel poeta che s’apre alla speranza del migliore dei mondi possibili, di quel che nella cercata solitudine dell’uomo non appaia possibile, né che la sua rimostranza di clown sia presa in considerazione da alcuno, allorché, finito lo spettacolo il pubblico va via dimentico di sé. Quel che resta è dell’uomo maturo nel suo germinare alla vita, che, all’occorrenza, riscopre se stesso nella natura ch’è propria delle stagioni: così alla nascita, nei colori in primavera e nell’oro assolato dell’estate, ora per ubriacarsi di necessaria linfa, ora di fiori e verzura inebrianti, ora di nuovo polline; così come del vento e delle nuvole quando s’avvicina l’inverno della fine …
Così che “l’uno all’altro ignoti, condividiamo la stessa solitudine.” (…) Con poco o nulla da dire, scegliamo il silenzio. / Ma, se tentiamo una frase, / l’incipit parla all’unisono. E ne ridiamo”.
Allora, come sul pentagramma d’uno spartito musicale, la cifra scrittoria dell’uomo non può che essere ‘in tono minore’, direi interstiziale, di colui che cerca nell’intervallo delle note l’assoluto del suo canto lirico, ma ch’è anche una forma di rispetto necessaria al poeta che, annichilito, s’affranca al cospetto dell’immensa armonia che lo sovrasta ...
“Sono pensieri che solcano il viso, / rughe profonde, vere, come un sorriso. / Sono crepe, sui calanchi delle stelle”.
Come fu per “Vaghe stelle dell’Orsa…” e per “Che fai tu luna in ciel? dimmi che fai” di leopardiana memoria, qui non si tratta di rimembranze, o almeno non solo. Le diverse parti che compongono questa silloge poetica s’avvalgono ora di recitativo, ora d’invocazione, nel ‘modo’ che ognuno di noi, nell’intima significanza delle parole, esprime la propria silenziosa preghiera …
“La luna già riappare / nella sua curva lama. / Cade un altro giorno vano”.
Ed è nell’economia insita nel proprio respiro, nell’intrapresa costruzione di sé, come nella vaga sembianza dell’eterno, che il silenzio si fa dialogo eloquente dell’uomo, del suo inseparabile vissuto. È nell’elaborazione dei propri costrutti, nei lasciti di un’eredità consumata, così come degli abbandoni subiti, che ripone la propria ineguagliabile sofferenza, come per una assenza ingiustificata che ha lasciato l’ombra di sé in una nuvola che passa e s’allontana. Perché? – si chiede l’uomo – senza ricevere risposta … perché?
“Qualche volta le stelle cadono.
Per il resto, resistono lassù,
appese alla parete dell’Apeiron,
pertugi di fuoco nell’involucro universale.
Ce ne accorgiamo
quando sopra il mare tracciano la scia.
Il tuffo nell’infinito è ciò che vorremmo imitare.
Sappiamo bene che in quel mare,
sospeso sopra gli sguardi,
nel suo profondo,
c’è tutto ciò che cerchiamo”.
Perché? – si domanda il poeta inseguendo i fantasmi nelle nuvole che all’improvviso sovrastano il suo cielo. Che forse domani …? Ben sa che ci sarà un domani leggendo nei grafici disegnati dei cirri una scrittura artata che forse lo riguarda, quasi dovesse egli riempire gli spazi ‘bianchi’ dell’universo cielo, giammai vuoti d’altre costellazioni, d’una moltitudine di pianeti lontanissimi …
“Noi, che proveniamo dalle nuvole. / Siamo pieni di cose, di case. / Di niente. / Immersi nel tangibile, / abbiamo smarrito ogni meraviglia. / La metamorfosi della purezza / nella concretezza.”
Ben sa che solo alla poesia è dato scandagliare nel profondo dell’abisso così come dell’immenso cielo, che tutti noi, uomini e poeti … “Abbiamo bisogno di una fine che sia fine, / conclusa in se stessa …
/ Nulla che vada oltre. / Intanto, procediamo su questo otto, / in orizzontale: una linea continua, / circolare, che non ammette soluzione. / Si torna ogni volta al punto iniziale / per un altro giro di giostra: / all’infinito”.
Mentre l’uomo pur spera in un tempo fuori dal tempo in cui …
“Eppure, torneremo liberi, / lievi, tra le braccia sfilacciate delle nuvole, / sospesi ai cirri… E, se cadremo, / sarà soltanto pioggia”.
Una pioggia benefica, salutare, di cui l’uomo sente il bisogno, che lavi via ogni presunzione d’eternità, ogni esuberanza di vanità, e ubriacarsi infine di ciò che nel poeta talvolta, in ‘presenza di una chiassosa rivisitazione del proprio ego’, sa d’essere sublime …
“Questo momento che sembra eterno
ci riporta all’archetipo, all’inizio del Tutto,
al primo alternarsi della luce tra notte e giorno.
Noi rivediamo le spiagge dei mari antichi
da cui venimmo, a cui faremo ritorno, un giorno,
dopo la nostra breve avventura”.
No, non v’è rimpianto né commiserazione nella vaga sembianza del tempo edenico perduto cui il poeta affida i suoi costrutti, o che affronti nel voler superare la barriera che lo separa dal conoscere il proprio destino umano. È quanto rivelato in “Argonauti” …
“Riuscirò a setacciare i ricordi, che filtrano lenti
attraverso il vaglio della memoria.
Ricorderò i luoghi in cui non sono mai stato.
Con rammarico ricorderò di non aver trovato
la via che conduce al vello d’oro, alla ricerca,
alla consapevolezza che la luna di luglio
assai poco ci degna, ormai, della sua attenzione.
Ricorderò nomi e cognomi per tacerli,
preservando la loro debole immunità,
il desiderio di penombra.
Affonda in noi il bisogno di superare ogni barriera,
di sapere come finirà l’assurda storia
degli Argonauti della nostra era”.
Malgrado le parole dell’uomo rivendichino un’autonomia che non gli è data, spetta ancora al poeta l’insistere prepotente sulla stessa nota …
“C’è sempre vita nei versi, tessere sparse / nel mosaico della passione, / occhi vitrei che, dai porti più remoti, / fissano la deriva della coscienza. (…) E la pioggia che scroscia improvvisa, / che si fa insistente, insolente, /trascina la mia sconfitta nel fango. / (…) / Del resto so che alla pace dell’armonia / preferisco sempre la bizzarria del caos. / (…) / Ora temo che dal cielo precipitino giù / le stelle mattutine”.
Ed ecco che al tornar delle stelle nel verso, si riaccende la speranza di un qualcosa che pure è, che sa di apocrifo e autentico allo stesso ‘modo’, di suggerito all’anima dell’uomo come all’orecchio del poeta: “Univoca direzione per noi: / tutto concorre a varcare / la porta dell’asincronia... / (…) Ci sarà, anche quando la chiglia incagliata / mi ricorderà che tutto diviene / e fermarsi è un’illusione!”
Sì – esclamano all’unisono – o forse cantano l’uomo e il poeta, nel dualismo di entrambi c’è la consapevolezza di essere, ‘ergo sum’, certi che le parole non sgorgano dal nulla …
“Scendono giù le parole,
lungo il pendio dell’acqua piovana,
mentre la luna piena di questa notte straniata
danza in un valzer di nuvole chiare.
Veloci, beffarde, le parole fuggono via.
Si fermano, forse, nelle pozze, al bordo
dei campi di fieno.
Si prendono gioco di me (di noi)”.
No – s’apprestano nel dire – o forse sì, perché le parole suggeriscono loro che l’esperienza fa della vita un unico canto, il ‘modo’ d’essere se stessi …
“Ora sappiamo
che un altro giorno è compiuto.
Ci raccogliamo in noi stessi,
dentro le stanze delle nostre rinunce.
Nemmeno tentiamo più di indagare
la direzione dei voli, il sonno dei rondoni,
né dove vanno le nostre illusioni
a morire”.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è detto nel verso 139 dell’“Inferno” dantesco che, proprio grazie alla dolcezza della poesia, riesce a non smarrirsi nei meandri bui dell’esistenza artata. Così, come nella ritrovata essenza dei suoi costrutti, il nostro poeta, Evaristo Seghetta Andreoli, s’avvale del “verso poetico” per stabilire il prosieguo del suo navigare, limpido, nel mare calmo delle rimembranze; nel suo poetare si respira l’afflato di chi – com’egli dice – ‘in tono minore’, va raccogliendo il senso di ciò che siamo.
L’autore:
Evaristo Seghetta Andreoli di Montegabbione (TR) da sempre vicino, anche per formazione classica e giuridica, al mondo letterario e artistico, ha pubblicato la sua prima raccolta nel 2013 nonostante componga versi sin da giovanissimo. Egli fa parte dell’Associazione Culturale Pianeta Poesia di Firenze, dell’Associazione Tagete di Arezzo e dell’Officina delle Scritture e dei Linguaggi di Perugia. Collabora con le riviste letterarie Testimonianze, Euterpe e L’area di Broca. Ospite di varie rassegne letterarie tra le quali “Modena Poesia Festival 2019”. Vanno qui citate alcune sue pubblicazioni che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra le quali: “I semi del poeta” – Premio Aronte – Carrara 2017 – Polistampa Editore 2013; “Inquietudine da imperfezione” – Premio Internazionale “Mario Luzi” (2016/2017) Roma - Passigli Editore 2015; “Paradigma di esse” - Premio “La Pergola Arte Firenze - Lilly Brogi” (2018); Premio Equi-Libri Cava De’Tirreni (2019) - Passigli Editore, Bagno a Ripoli, 2017.
Sitografia:
http://www.italian-poetry.org/evaristo-seghetta/
Mail: evaristo.seghetta@libero.it
Note.
Tutti i corsivi all’interno dei paragrafi appartengono al poeta Evaristo Seghetta Andreoli.
*
 - Letteratura
- Letteratura
’Misura del sonno’ - Una silloge verbovisiva di F. Federici
"Misura del sonno" … una ricercata ‘cecità’ nella luce che abbaglia.
Una silloge verbovisiva di Federico Federici – in Nuova Limina - Anterem Edizioni 2021.
“Sono chiuse le pietre,
l’invisibile impenetrabile.”
Una dicotomia ineluttabile (se mi è concessa), tra l’essenza interiore e
l’espansione dell’anima che, nel silenzio della solitudine, (per presa coscienza), avalla una remissione di colpe senza nemesi, inappellabile nell’atto di sottrarsi all’apparenza della realtà distopica, in quanto rappresentazione di una concretezza immaginaria del futuro. Una cercata forma di ‘cecità’ in cui l’autore s’abbandona, in quel mondo estremo (terra di metamorfosi) che sempre appare nel sonno di chi veglia (R.E.M.), collocato in un contesto distante nel tempo e nello spazio…
“Gli sforzi della luce / sulla forma perfetta dell’occhio / e del regolo nero del sonno. / La luce si affaccia alla gemma / e la forza ad aprirsi, a soffrire / senza molte altre qualità / una forza e un impedimento / a formarsi in un’altra maniera / secondo il tempo infinito di una foglia.”
“Si addensa il silenzio all’orecchio / del mondo che si dichiara udibile / mondo indistricabile / delle cose mai dimostrate, taciute. / Si stirano le meningi / verso la rovina del risveglio. / La neve che ti volteggia innanzi / acquieta il canto dei pensieri.”
È detto che “ogni luogo ha il suo destino” che si infiltra negli spazi interstiziali del passato, di cui però nessuno conserva né memoria né immagine, tranne lo scrittore e il poeta, avviandosi lungo la strada dei propri desideri mai enunciati, (o chissà, forse dismessi?). È qui che si perdono e si ritrovano le tracce appena lasciate, calcate con penna iconografica sul fare di una scrittura nuova quanto antica, che dai primitivi grafemi, s’inoltra fin nei sistemi ideografici e pittografici dell’odierna computazione verbovisiva (interazione simbolica) messa in atto dall’autore …
“Prendine nota: / reali il vuoto e / il vento / pulviscolare / che attira la luce / nella fessura. […] (l’insegnamento / degli ingrandimenti / riguarda anche i ciechi).”
“Vorticano astratte / miniature di astri / insetti / spiriti / e universi ventosi / agli angoli delle stanze.”
Che sia il destino ultimo della scrittura di Federico Federici non è detto. L’autore non ne fa menzione, di certo è la sua cifra scrittoria, la sua ‘misura del sonno’ è quantomeno meditativa e quindi incommensurabile (in senso verbale-visivo), e/o forse inesprimibile se non considerata aleatoria (in senso sonoro-musicale). Nell’uno e nell’altro caso, il processo di codificazione-decodificazione (da parte del lettore/fruitore) è innegabilmente qualitativo quanto quantitativo di un ‘pensiero’ idealizzato attraverso la rappresentazione grafica, senza ‘altra’ necessaria mediazione se non quella visivo-quantistica evidenziata nel seguente ‘canto’…
“CANTO CXVII
chiaro – scuro
sedia – scuro
chiaro – scuro
quando scrivo
un (…)
l’intera questione di (ecc.)
l’occhio: un punto di resistenza a (parole nel canale neurottico ecc.)
questo è rumore granuloso + 3:
L I M P I D E Z Z A LIMPIDEZZA
le parole sono materia che si stampa:
geometria dell’occhio +
geometria dell’orecchio =”
È nella natura intrinseca all’essere umano ricercare i ‘segni’ della propria esistenza, che nel voler conoscere il proprio destino (ideal fate), rivolge all’implacabile oscurità del sonno i suoi costrutti di luce, onde avvenire a una qualche verità che pur non è data, se non quella di nascere e di morire nei flussi e riflussi delle maree, d’acque torbide di sangue nel suo venire alla vita, come di lacrime cristalline versate nel suo abbandonarsi alla fine…
“…così custode è il silenzio / dei pensieri vuoti / si approssima il sonno / da lontano al cervello / sui suoi passi falsi.”
“Sbocciano / gli occhi dal sonno /gemme dopo il temporale / domande / alla soglia dello spirito / dove attecchisce il mondo.”
“Un respiro profondo. / Si tace. / Nessuno / scolpito / in questo silenzio. / Il filo del sonno / cuce cicatrici di luce.”
Sussiste una sorta di immaginaria follia descrittiva in tutto ciò, che lascia interdetto il lettore/recensore davanti alle illustrazioni (contenute nel libro), come si fosse in presenza di chi (l’autore), navigando nel sonno, a un certo punto lasci il timone spingendo la nave alla deriva. È strano come le percezioni s’accavallino nel ‘fragore silenzioso’ delle onde, nella sequenza delle pagine, nei cui spazi bianchi (al confronto coi neri degli inchiostri), irrompono le trame di racconti che, presto detto, s’inabissano e riemergono nella lotta estrema contro la solitudine interiore, come a voler riempire il ‘vuoto’ spazio del mistero…
“Ciò che non si afferra / dà corpo al vuoto
finché resta solo / movimento senza traccia…”
“Un leggero morire
accarezza la cosa pensata.”
“Non la metà
né l’intero” … (come di uno scegliere non necessario).
-Da queste lontananze ci parla Federici … Dalle distanze sorgive dell’essere. Da una profondità originaria. Dalla sua lingua anteriore. Dalle parole di cui si è figli. – (dalla presentazione di Laura Caccia).
È nella ‘misura del sonno’ che la ‘vibrazione poetica’ di Federico Federici, facendo leva sull’immaginazione creativa (di colui che osserva), nonché su quella estrema dell’ascoltatore che legge (la propria voce), sposta il limite della visualizzazione/verbalizzazione dei propri costrutti (intellettuali), portando all’evidenza una sua personale quanto ricercata ‘cecità’ nella luce che tutto abbaglia…
…i propri ‘sonni’ come i suoi improvvisi ‘risvegli’.
Note d’Autore.
La silloge è qui presentata in due lingue: italiano e tedesco a fronte, alla stregua di un vero libro d’arte con numerose riproduzioni illustrate che impreziosiscono i testi ad esse afferenti. Fanno seguito alcune note esplicative riguardo al dove e quando ogni singola composizione è venuta alla luce, la sua immanenza in quei ‘luoghi del silenzio imparziale’ che nutrono i nostri sonni, i labirinti oscuri e i paesaggi luminosi della nostra mente.
Nota del recensore:
Tutti i virgolettati sono di Federico Federici, autore inoltre di arte concettuale, scrittura e fisica. Nel tempo, ha partecipato a mostre e installazioni d’arte. Tra i suoi libri figurano “L’opera racchiusa” Premio Lorenzo Montano 2009, “Mrogn” Premio Elio Pagliarani 2017; “Profilo Minore” , a cura di Andrea Cortellessa – Aragno 2021.
*
 - Poesia
- Poesia
’I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse’
“I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse”
(...per una mitologia del presente).
‘il primo cavaliere’
«E vidi subito apparire un cavallo bianco, e colui che ci stava sopra aveva un arco, e gli fu donata una corona, e partì vincitore» … (Giovanni ‘Apocalisse’- 6 -1)
...or tu Pegaso volante
dacché portasti Orione la cui volontà
infiera contro a spalancare il cielo
col dardo infuocato in fra le nuvole
che di scaturir l’arduo furore
onde maggior senno reclami
alle rimostranze divine
deh metti sul capo la corona aurea
‘...e parti vincitore’
che di vittoria portar lo scettro
alfin non ti sia vano
nell’ora dell’ultimo traguardo.
‘il secondo cavaliere’
«Ed ecco uscì un altro cavallo, rosso e a colui che vi stava sopra fu dato il potere di togliere la pace dalla terra, e di far sì che gli uomini si sgozzassero fra di loro, e gli fu consegnata una grande spada» … (Giovanni ‘Apocalisse’- 6 -1)
...che già s’ode lo scalpitar
del tuo cavallo baio Epimeteo
irrompere sul terreno madido
del tuo sudore d’ira
violare la pavida serena mestizia
del creato
che de’ Viventi argui mozzare
il fiato
deh sentenza di morte una spada
sola nol può conseguir destino
confacente alle masse
che prima o poi disarcionar ti vedrai.
‘il terzo cavaliere’
«E vidi immediatamente apparire un cavallo nero, e colui che vi stava sopra aveva in mano una bilancia. E sentii come una voce in mezzo ai quattro Viventi, che diceva: Due libbre di frumento, per un denaro, e sei libbre d’orzo, per un denaro, ma l’olio e il vino non li toccare» … (Giovanni ‘Apocalisse’- 6 -1)
...dunque sei tu
l’eroe eponimo che riappare
quell’Icaro venuto
dal tempo fondativo che
s’interpone tra il simbolo e la forma
del Dio vivente
mediazione tra somiglianza e
dissomiglianza
difformità del finito-infinito
il presente e il passato
dualità incommensuarabile
del futuro difforme.
‘il quarto cavaliere’
«E subito vidi apparire un cavallo verdastro, e colui che vi stava sopra aveva nome la Morte e l’Inferno lo seguiva» … (Giovanni ‘Apocalisse’- 6 -1)
...or vieni Prometeo
discatenato dalla rupe di lava
cavaliere accecato
che lavar non puoi con la morte
il fato
che pur addusse il Creator
nell’ora del delirio osceno
onde la pandemica peste
l’Apocalisse stipulò nel guado
dell’inferno
orché della mente tua le fiere
della terra fecer razzia.
‘ai Viventi’ (de’ sopravvissuti).
«E fu data loro autorità su un quarto della terra, per uccidere con la spada, colla fame, colla peste e mediante le fiere della terra» … (Giovanni ‘Apocalisse’- 6 -1)
...deh Viventi orsù lambite
l’immenso cosmo immemore
di opposte opposizioni
finito-infinito, ragione-senso, mito
anti-mito, vitalità-geometria, causa
coscienza quantica
nel contesto del libero divenire
auto-trascendenza
identità degli estremi
connessione dell’umano e
del divino
che in ognun di voi
… s’altera.
*
 - Poesia
- Poesia
Ricami dalle frane - silloge poetica di Antonio Spagnuolo
“Ricami dalle frane” una silloge poetica di Antonio Spagnuolo –
Oédipus 2021.
Illusione.
“Anche gli umori più terreni hanno
un primitivo mitigare furie.
Non saprò mai chi sono adesso
lacerando il tessuto che mi imbriglia
tra i consueti angoli di mura.
Preferisco i golfi, le serpentine, il tocco fragili
quando le labbra squarciano le ombre,
nell’infinito adagio delle notti.
Il vello d’oro offriva le vertigini
accendendo il fantasma dell’inconscio
ove l’ombra tratteggia figure lontane
e svanisce l’illusione quotidiana…”
Accade che la ‘poesia’, come del resto in ‘musica’, ritrovi nell’incarnato delle sue possibilità l’aspetto del residuale, o come si vuole, della resilienza, cioè quell’adattamento al cambiamento che, inesorabile, abbatte le mode del linguaggio e le speculazioni filosofiche, spesso ostentate sul nulla. Siamo qui di fronte a una sorta di concretezza affabulatrice ricolma di esperienze culturali e poetiche di indubbio spessore letterario che, nondimeno di un investimento di benevolenza, conduce il poeta all’interno del proprio labirinto personale, per quanto sembri senza soluzione di continuità…
Identità.
“Ho perso la mia identità nel fremito ininterrotto dei fantasmi per altre dimensioni, le armonie di un solfeggio che incastra le memorie e mi coinvolge nei ritmi indecisi. Ho giocato al travestimento della memoria! Prima che il giorno si chiuda nel buio si miscela il vortice delle emozioni che sospendono incanti. L’inganno ancora è folgorazione in questo urgente intrigo di contrapposizioni, naufragio che sfuma a fendere il silenzio.”
Un po’ come se nell’esprimersi – scrive Eugenio Montale – “…manca ancora il silenzio nella mia vita”; quel riflesso inorganico e transitorio che restituisce l’esatta misura dell’incesto mentale, del vuoto edonistico filtrato attraverso il concetto d’una assenza iperrealista applicata a una trama che, altresì, si evince nel tessuto narrativo d’insieme…
Schianto.
“Laddove una volta c’erano le foglie ancora verdi io poggio il dito / e strappo le spine accompagnato al ritmo del carillon che gira inesorabile. / La vita stessa è un rito sempre eguale che insegue petali senza una cadenza, / nell’incanto della gioventù sfumata in un momento e nell’illusione che tutto sia infinito.” […]
Sì che gli occhi del poeta stentano nel buio dei giorni a venire, a ritrovarsi nel meditare sulle proprie ceneri, e/o come in questo caso, ‘sulle frane’ di un’esistenza avita, benché intensamente vissuta, per certi versi incredulo e frastornato dagli eventi, nel rimpianto di un ‘paradiso perduto’ a causa dell’intensità del proprio vivere mutato, nell’illusione di una promessa di eternità che non gli era data. Così come delle possibili prospettive e la profondità degli intenti portati a conclusione, le cui vedute hanno certamente aggiunto valore alle personali esperienze dell’autore, aprendogli le porte ad una lucida sensibilità emozionale …
[…] “Null’altro che illusioni aggrappate ad un sogno / rimasto indiscreto. / Lo spazio che le dita riuscivano a comporre / sgualciva l’orlo dei quaderni segreti. / […] Ecco i miei sogni radunati alla sera / pronti a sconvolgere il vuoto / […] pronti a rigare i margini del cielo / con le vocali di fuoco che disgregano il senso.”
Una prima porta è certamente quella della condivisione tranquilla e silenziosa con gli altri, cui Antonio Spagnuolo rivolge questa sua silloge, fino a questo momento inedita. Un’altra è quella che solleva il velo dell’intimità, la sola capace di modificare il senso del tempo, così come lo spazio neutro dell’ascolto, che s’inoltra per le strade inusitate dell’inconscio, solitamente non pensate, e che trovano nell’ ‘amore’ la sola ragione d’essere presente e partecipe del suo essere…
[…] “Torno a correre e ripenso a quella frase che incidesti nel tronco / quale promessa di un luogo solo nostro. / Essa salva e conserva le memorie nella estrema luce di un riflesso / che non sarà previsto cambiare tra le ombre della malinconia. / Nascondo allora l’essenza di un profumo che tagliava la pelle / e ti rendeva immortale.”
Benché qui ci si occupi della sua più recente pubblicazione, nulla toglie di cogliere certe sfumature di ritorno della sua essenza poetica, cioè di quelle “cose che non sono mai, ma che pure fanno parte del substrato d’ognuno”; di quel rincorrersi fra le parole, sia dei ‘segni’ come delle ‘allocuzioni’ nel linguaggio scrittorio; sia dei ‘gesti’ come delle ‘espressioni’ insite nei segreti del suo lessico verbale, qui raccolti nella
chiusa significativa dal titolo “Ultimo Registro”: quasi una ‘summa’ per un’opera carente di prologo e/o di un plausibile epilogo, sostituiti da partiture che pure rendono possibile la compenetrazione d’insieme…
“Anche l’oblio è stralcio di memoria / altro versante che cancella colori, / solitudini e canti misteriosi, tra forme vaghe e luminose…”
Non è a caso – scrive l’amico Flavio Ermini – che dall’erranza di costrutti intuitivi, che solo il lettore attento in qualche caso può riuscire a cogliere, non si giunga in poesia a compenetrare l’essenza delle cose: “… errante è la parola poetica che si cala nell’abisso dei colori, cercando la via più breve che porta all’uno.”…
“Ho lacerato la carne stringendo fra le labbra il non senso della mia illusione. / Quel voler procedere a memoria aspettando i riflessi sanguinanti avvolti nel canto / inesauribile dei colori, del vero vuoto che vuole divenire verso.” []
[…] “Ora un salto mi allontana dall’incendio / di speranze disconnesse: / tra le fragili dita disegno forme nuove del dissidio.”
[…] “Gli occhi al cielo distratto, quasi per lontananze / ha il pensiero di ghiacci e nell’azzurro / compone il sussurro di abbandoni. / Ora il mio urlo lo raggiunge e inganna / l’attesa di un racconto nuovo.”
Ciò che accade nei ‘ricami’ poetici di Antonio Spagnuolo, in quanto riflessioni che lo hanno portato dalla rimembranza delle ‘frane’ alla rinascenza dei suoi ultimi ‘florilegi’ lirico-poetici, con la creazione di spazi esclusivi riservati alla poesia e alla saggistica di ‘prospettive’ e ‘rassegne’ dedicate: sia con la produzione di riviste letterarie ad ampio spettro; sia in campo pittorico con opere destinate alla ‘poesia visiva’, delle quali l’autore vanta numerosi riconoscimenti e premi.
Note.
Tutti i corsivi sono di Antonio Spagnuolo, tratti dalle ‘poesie’ edite nel volume “Ricami dalle frane” – Oédipus 2021.
La citazione afferente ad Eugenio Montale è tratta da “Prose e racconti” – Mondadori 1984.
La citazione afferente a Flavio Ermini è tratta da Margherita Orsino “La traversata infinita” – Anterem Edizioni 2019.
L’Autore.
Antonio Spagnuolo (Napoli, 1931), poeta e saggista, redattore di periodici e riviste letterarie, fondatore e direttore del mensile “Prospettive culturali”. Presente in mostre di ‘poesia’ e ‘poesia visiva’ è attualmente inserito in antologie nazionali e internazionali. Alcune delle sue opere sono state tradotte in diverse lingue: francese, inglese, greco, spagnolo, arabo e turco, inoltre ad aver ricevuti numerosi riconoscimenti. Tra le recenti pubblicazioni: “Non ritorni” (Robin 2016); “Sospensioni” (Eureka 2016); “Svestire le memorie” (Fondi 2018), “Polveri nell’ombra” (Oédipus 2019).
*
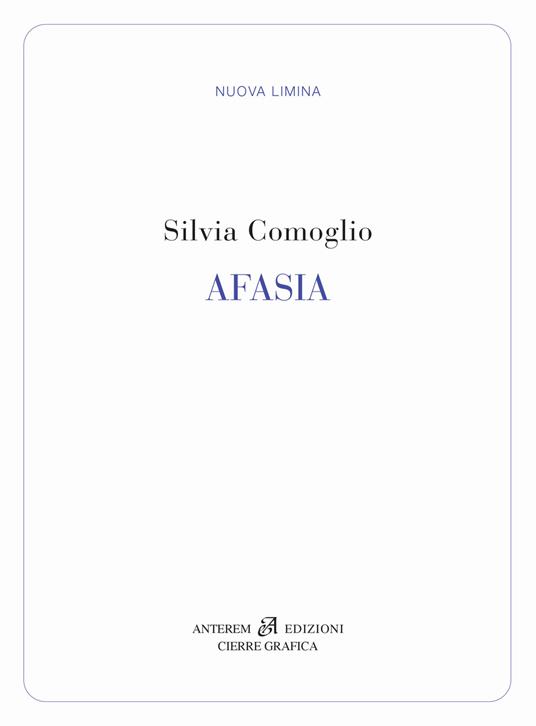 - Poesia
- Poesia
Silvia Comoglio … o l’apoteosi dell’ozio creativo
Silvia Comoglio … o l’apoteosi dell’ozio creativo.
“Afasia” una silloge poetica, Nuova Limina / Anterem Edizioni 2021
L’apparente ossimoro del titolo consiste nell’accostamento di due concetti volutamente contrapposti: ozio e creatività. Ben sappiamo che lì dove esiste una contrapposizione spesso si ha un immediato confronto dialettico con ciò che è logico razionale, sia con l’illogico irrazionale, in entrambi i casi, fonti primarie d’ispirazione poetica che solo formalmente coincidono con la dialettica letteraria …
*
L’illusione, sapete, è sempre così sapiente,
ordine di scie archetipe di mondi a-
vidi di mondi
*
L’albero-lanterna è l’ultimo segreto,
il sonante, e eterno, strisciare delle ali
Di fatto, in questo crogiuolo di creatività che è “Afasia”, Silvia Comoglio esprime mediante la scrittura, un’incoerenza di tratto (parlato e/o grafico) che la pone nell’immediato sconvolgimento del linguaggio pensato …
*
Amotanto la luna frantumata nel tempo di parola,
tersa piccola vedetta di amorose notti tra-sudate a labbra
Scrive Jean-Paul Sartre in “La nausea” (*): “La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno. Tenere un diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli” – mettendo in risalto la possibilità di pensare senza l’uso delle parole e/o, viceversa, di classificarle separatamente, come fossero pensieri tenuti a mente di un diario del quotidiano che dietro ogni parola vuole ci sia un pensiero, qui riversato in una sorta di presupposto implicito del linguaggio mnemonico …
*
múrami la bocca di lumi liquidi di cielo,
incontrati di notte per ventura
*
taci, e non guardarmi
mentre scendo – sulla strada: è nella casa,
tutta bianca! che di torba scende a iato
quel regno degli avanzi nudi di –
memoria
*
… a risalita! nel mondo, appena nato
sul palmo della mano, a cu-
spide di sguardo único di amore
È quanto meno sembra funzionare al primo impatto con la poetica dell’autrice, sia sul piano logico, sia su quello illogico, seppure, per meglio esplicitare questo presupposto, vale chiedersi se c’è un qualche nesso fra pensiero e linguaggio …
*
[Dite se questa nube sciolta –
è il viaggio che trabocca,
tempo che si inclina quando –
mondo aggiunge giorno
al corpo rimasto sul confine
O, quale idea si comprime nel linguaggio olistico del poetare (?) …
*
[amore di impotente chiaroveggenza l’occhio divorato
Sempre dal suo mondo: chiglia rovesciata in nugoli di voci
Tacite a frontiera, a profonda terra misconosciuta
[…]
a giusto solo peso di un mondo senza mondo,
come se orma cresciuta inconcepita,
al limite di sponde nude di stupore –
Non in ultimo, qual è la dimensione pragmatica del linguaggio usato dall’autrice, per quanto questo possa apparire consapevolmente e/o inconsciamente artato …
*
[udii sogni che fecero degl’occhi –
alte - e strane case: specchi in cui ti guardi,
e che riempiono di terra le nostre –
scárcerate ombre
A queste e ad altre analoghe domande non v’è risposta alcuna che ci si possa aspettare. Rimane che l’autrice, Silvia Comoglio, si avvale in “Afasia” di una passione reiterata per la scrittura, così come, ragionevolmente, quella di una sorta d’illusione di felicità, la cui ricerca ossessiva, sappiamo, è da annoverarsi tra le cause maggiori di infelicità …
*
Un giorno avrò un sogno che uscirà dal bosco –
prezioso ordine a saperci identici contrari, specchiati,
a mondo di traverso, dentro il suo chiarore –
di cuspide di sguardo único d’amore
*
nello stagno gridano a fior di loto
venne, venne il pesciolino d’oro,
senza lisca e senza spine –
e senza nulla, nulla, tenere al mondo
Ci si potrebbe chiedere inoltre chi decide cosa, la ragione o la passione, nelle controversie della vita (?); l’andare in cerca della felicità e/o concedere all’illusione il miraggio della felicità (?); e perché no: in che consiste il voluto accostamento di due concetti volutamente contrapposti di un ossimoro (?) …
*
… è l’eco, a primo soffio, tenuto in fede di parola,
come se puro solo bacio rimasto sulle dita a car-
dine stellato –
Nel caso specifico, in “Afasia” l’autrice risponde con il paradigma dell’ozio in quanto apologia di creatività, o, se vogliamo, imprime all’ozio un proprio determinato stile di vita, quello stesso che, come diceva Oscar Wilde: “…non far niente è il lavoro più duro di tutti”, in quanto bisogna volutamente imporsi e/o esporsi alle ragioni del mondo …
*
[è tutta, tutta morta! la luna che si sente –
tanto, stanca-stanca! nel tempo di paura
Dacché è apparente che Silvia Comoglio ha scelto di sovvertire le parole a una rivendicazione di individualità e di indipendenza con una scrittura personalissima, impetuosa quanto appassionata, più che mai viva, cui va riconosciuto un diritto di libertà che noi tutti dovremmo riaffermare: poeti e filosofi, scrittori e giornalisti, censori e recensori, per quanto oziosi e al tempo stesso creativi, costruttori di altre fantastiche verità …
*
Amotanto la luna frantumata nel tempo di parola,
tersa piccola vedetta di amorose notti tra-sudate a labbra
“Io non ho bisogno di fare delle frasi – ci rammenta Jean-Paul Sartre. Scrivo per mettere alla luce certe circostanze. […] Bisogna scrivere tutto come viene alla penna, senza cercare le parole … ho bisogno di ripulirmi con pensieri astratti, trasparenti come l’acqua. […] Piuttosto è il modo con cui gli istanti si concatenano. Ecco come credo che avvenga: d’un tratto si sente che il tempo scorre, che ogni istante porta con sé un altro istante, questo un altro e così di seguito; che ogni istante si annulla, che non vale la pena di tentare di trattenerlo.” (*)
È questa la cifra scrittoria di Silvia Comoglio? Forse! risponde l’autrice nella chiusa che segue: prima di qualsiasi giudizio avventato, permettetemi un’ultima parola …
*
“l’antimondo! è il solo punto
In cui l’alba si sorride: il forte
bacio di chi bacia noi che siamo
tutti – i paradisi”
L’autrice:
Silvia Comoglio, filosofa e scrittrice, autrice di numerose sillogi poetiche, è presente in molte pubblicazioni antologiche presso i più affermati editori del genere. Vanno qui ricordati “Cati onirici” – L’arcolaio 2009; “Via Crucis” – Puntoacapo 2014; “Sottile, a microchiarore!” – Joker 2018. Da alcuni anni fa parte del Comitato di Lettura di Anterem Edizioni – Premio di poesia e prosa Lorenzo Montano.
Note:
(*) Jean-Paul Sartre, “La nausea”, Einaudi 2014
Nota del recensore:
Mi scuso personalmente con l’autrice per non aver mantenuta l’ortografia dei testi stampati, in ragione di una carenza effettiva del mezzo di trascrizione.
*
 - Poesia
- Poesia
’La dimora del ritorno’ una silloge poetica di S. D. Rosati
La dimora del ritorno - una silloge poetica di Sofia Demetrula Rosati – Nuova Limina / Anterem Edizioni 2021
“Tremila anni … ecco dove accadde. Lei è stata qui. Questi leoni di pietra, ora senza testa, l’hanno fissata. Questa fortezza (Micene), una volta inespugnabile - cumulo di pietre ora - fu l’ultima cosa che vide … Vicine, oggi come ieri, le mura ciclopiche che orientano il cammino: verso la porta dal cui fondo non fiotta più sangue. Nelle tenebre. Nel macello. E sola.” (*)
Sola, come la Dea Misterica di cui l’autrice porta il nome, Demetra dea della natura, colei che dà amore incondizionato, portatrice delle stagioni e patrona della giovinezza, “il cui non esserci (oggi) era (è) solo un voltare di spalle, un cambio di maschera, una posa drammaturgica.” Ma ciò che può sembrare un gioco effimero che sfocia nel tragico teatrale, non è che luce riflessa, un ripensamento sul ‘mito’ di cui, col passare del tempo (millenni), si è perso il filo, smarrito nell’attraversare il labirinto del vissuto, definitivamente …
“Tremila anni … così il verdetto del dio si mostrò duraturo: nessuno le avrebbe creduto” (*) – mai, per l’eternità.
Nessuno, sebbene un fantasma si aggiri ancora, come nel passato, sui guasti d’ogni guerra: Troia come Micene, Varsavia come Beirut, Hanoi come Rangoon, Beirut come … quante altre? – contro un nemico da tempo dimenticato e i secoli inesorabili che l’hanno spianate. Il sole, la pioggia, il vento, tutto è cambiato invano. Immutato è rimasto il cielo, un blocco d’azzurro intenso, alto, distante …
“Ogni cosa cosmica / aveva possibilità di sguardo / su ciò che era stabilito.”
Così, come nelle macchinazioni teatrali non tutto però è dato per scontato, in ciò l’autrice restituisce alla scrittura poetica ciò che va oltre il testo sponsorizzato dal ‘mito’, condividendo il suo ruolo precipuo con quello del lettore/spettatore, formalizzando una possibile trama che riversa in-presenza, quella che era l’attualità misterica, assente ai nostri giorni; da cui il titolo “La dimora del ritorno”, per un appagante ‘incontro’ con il presente …
“…certi passi silenti e lo sguardo distratto di chi sta per partire e non ha più a cuore ciò che resta, qualche appunto qua e là sparso in casa, su fogli strappati male, perché male fa, dover lasciare parole prive di storia, sconnesse all’attenzione e tenute insieme da un collante … nei radi giorni di senso … con la dolorante consapevolezza (d’essere null’altro che) un grafema, scaldano solo se brucio le pagine su cui scrivo, nutrono solo se diventano mercanzia.”
Per quanto ciò possa sembrare vuoto di senso, è nella presenza del ‘mito’ che si consuma il nostro e l’altrui destino, di “assenza nella presenza” che si rinnova: dimensione e misura di un incesto edenico mai venuto meno …
“…e non somigliavamo a nulla, ci coglieva lo stupore quando potevamo sfiorarci, emettevamo leggeri suoni bluastri, dall’indistinto sapore di felci, il verde non era ancora stato codificato, vagavamo tra il giallo denso e il blu liquido.”
Ancorché non bruciate le pagine scritte, leggiamo:
“…esistevamo, nell’evanescenza del divino femminile, ne eravamo certi, perché i nostri colli lunghi, si sollevavano verso il cielo, le retine cominciavano a guizzare, emanando segnali striduli e imprecisi, spazi di mnemonizzazione … quando i suoni divennero parole, conoscemmo la memoria e la dimenticanza.”
Non c’è dimenticanza conscia nell’immutabile ‘segreto delle cose’ se non la labile, inconscia “…adesione alla sapienza sacrificale dominata dall’incertezza, che pesa sulle coscienze oscuramente, come esigenza inespressa” (**), presente nei segni del ciclo annuale di morte e rinascita inerenti al ‘mito’, archetipo che possiamo contemplare solo unendo gli estremi di una qualche entità/identità astratta, profetica, veggente. Ebbene, è questa la cifra incatenata che Sofia Demetrula Rosati pone davanti allo specchio del tempo, come riflesso rifratto in sequenza fino a raggiungere l’evaporazione.
È forse questa “l’evanescenza del divino femminile” cui sottintende l’autrice nel suo excursus poetico attorno al ‘mito’?
Per quanto è dato sapere, è rivelato nelle pagine di questa silloge, che nulla esclude alla verità sulla condizione della donna di ieri come di quella d’oggi, entrambe “rinchiuse in una singolare normalità – benché avverte – si definiscono abusate” e, per antonomasia, senza riscatto dal ‘peccato originale’ che, in ragione di una presunta colpevolezza, si autoesclude dall’essere stato commesso, che pure è ancor oggi presente, sopravvissuto finanche all’espiazione di un Dio misericordioso …
“…le figlie della narrazione … non conoscono la storia delle proprie antenate, madri nonne perse nei tempi, ormai ossa consunte, alcune diventate tossicodipendenti, altre malate a volte psicotiche … sebbene l’imperfezione creata, prende la forma dal ventre ripetutamente abusato, di sagoma dalla memoria abortiva, figlia che osserva il mondo con lo sguardo di una Gorgone costernata e afflitta, da uno stupore cupo.”
Per giungere poi alla bellissima supplica ‘madre’:
“…non mi lasciare sola
in questo vuoto che non è assenza
ma compressione di colpa
domani la possibilità di poter credere che
se torno a muovermi
la materia nella quale sono immersa
mi riconoscerà e saprà farsi involucro
affinché anche per me
questo universo in moto esprima
il suo senso relativo e l’essere l’esserci
abbandoni la posizione di quesito
per spostarsi in un luogo temporaneamente
attratto dalla ripetizione.”
Come anche dice nella sua filiale invocazione:
“…madre, sfiora il mio corpo
districa i capelli e usali
per la tessitura
ungimi con unguenti
da te preparati
fammi sorridere cullami.”
Così di seguito, sul farsi della preghiera, la figura materna della Dea Partenogenica è umanizzata nel ‘mito’ che l’accoglie: “…rinasci dal mio ventre di figlia, onde ella nacque divorando il suo destino.” E benché separata da un’umanizzazione che la distoglie dall’eternità cui pure è relegata, si fa oracolo; la cui “parola (di veggente) non conosce simbolo o metafora … (e dalla quale), si è sempre attesa la narrazione … ma la cui gola non narra e non conduce a nutrimento.”
Fino alla conclusiva ammissione di colpa (un’altra) imperitura:
“…madre
Non fu con le parole
Che distruggemmo
I tuoi altari?”
“Nessuno la credette allora, nessuno le avrebbe creduto …” (*) – è quanto intessuto nella tela dei millenni. È qui che l’autrice si richiama al ‘prologo’, posto in apertura d’ogni canto in indice, per condurre il lettore/lettrice alla fonte della sua creazione poetica, si direbbe in extremis, all’ ‘epilogo’ mitologico del suo narrare le assennatezze della dea …
“…i suoni di flauti e danze la riportarono con lo sguardo verso il mare e la sua Salerno dove trascorse una vita lunga e feconda, dispensò cure e bellezza fino all’ultimo dei suoi giorni, mai più volse le spalle a levante … con la consapevolezza che non esiste sapienza tanto grande da non poter essere offuscata da un solo unico errore. E allora chi può realmente possederla?”
Allo stesso modo s’interroga il poeta-lettore/lettrice-protagonista, l’essere per il quale il dubbio è l’unica certezza …
“…se la parola scritta fosse l’unica sapienza … e la poesia restasse l’ordine ultimo al quale poter accedere? L’unico senso, la conoscenza di ciò che … fra punto di partenza e divenire … non può avere significato”.
È allora che il ‘mito’ qui contemplato, s’accende di poetico afflato, impercettibile ai sensi, ineludibile la verità dell'essere che siamo: mitici eroi di una galassia ormai spenta, coscienti che un giorno non lontano gli antichi dèi torneranno.
L’autrice Sofia Demetrula Rosati, scrittrice e traduttrice di testi poetici dal greco moderno apparsi in diverse raccolte antologiche per le più importanti riviste e collane editoriali, vincitrice inoltre di alcuni premi importanti del settore tra cui “Premio Donna e Poesia” 2012. Appassionata di tecniche calligrafiche orientali e occidentali, produce lavori di visual poetry, asemic writing e asemic calligraphy. Sue sono le significative illustrazioni grafiche interne al libro.
Note:
(*) Christa Wolf, “Cassandra”, E/O 1983
(**) Italo Calvino, “Palomar”, Mondadori 1983
*
 - Musica
- Musica
Musica en la Obra De Cervantes
(...rileggendo Don Chisciotte de la Mancha nel 404° anniversario della morte Aprile 1616).
“Los tiempos mudan las cosas y perficionan las artes …”
Il Romance Spagnolo tra Letteratura e Musicologia.
Prima di entrare nel vivo dell’investigazione, necessita qui trattare, seppur brevemente, quello che era il contesto letterario medioevale di rilevanza musicologica, che verso la fine del XIII secolo salutò in Spagna il sorgere di forme culturali autonome come la “prosa epica” e la “poesia lirica”, corrispettivi di un sostrato “etnico” preesistente – forse retaggio di più antichi aedi – formatosi sulla scia dei “cantare de gesta” e sfociato poi nel Romance epico-cavalleresco, giunto a noi esclusivamente in forma letteraria, ma che un tempo era fondamento della tradizione orale …
“Ya represento mil cosas / no en relaciòn como antes, / sino en hecho, y asì es fuerza / que haya de myudar lugares”.
Si tratta in breve di una sorta di narrazione che, fluita attraverso i cuentos (racconti, novelle, fiabe), le coplas (canzoni, versi, ballate), subì notevoli mutazioni prima di definirsi nella forma del Romance che noi conosciamo e che, una volta oltrepassati i confini nazionali, arrivò nelle Corti dell’Europa medievale, al seguito di venditori ambulanti, viaggiatori e pellegrini, guitti e trovatori, subendo modifiche di aggiustamento secondo la lingua e la cultura ospitante, onde per cui una stessa “ballata”, magari d’origine inglese o francese, italiana o spagnola, all’occorrenza rimaneggiata, raggiungeva e diventava popolare in altre parti del mondo all’ora conosciuto, nei territori tedeschi e olandesi, o attraversati i mari, addirittura in quelli scandinavi e oltre.
Caratteristica dell’epoca era la riduzione, da parte di narratori e cantori che li avevano appresi dalla tradizione orale, di Romance più o meno anonimi che venivano rappresentati nei teatri improvvisati all’interno delle corti medievali, alla presenza di nobili e prelati altolocati, nonché di signorotti arricchiti, e da cui, verosimilmente, prese forma quello che sarà la grande tradizione del Teatro spagnolo passando per Garcilaso de La Vega, Lope de Vega, fino a Calderon de la Barca. Quello stesso che, ad uso e consumo della catechesi dilagante, trascinerà sui sagrati delle chiese, dando sfogo all’attività processionale nella chiusa dei Sacramentales, recitativi di derivazione religiosa, conosciuti anche come Sacre Rappresentazioni.
Allo stesso modo che, seppure in forma assai ridotta, entrava nei Retablo degli spettacoli di piazza, tenuti in occasione di fiere e mercati, o durante le festività ad uso e consumo del popolino, sempliciotto e credulone, ma non per questo sciocco e sprovveduto, che cercava nel Romance un certo acume vivace e spesso salace, in cui si rispecchiavano le debolezze umane, le passioni e gli intrighi dei nobili o delle Corti. Spettacoli questi molto popolari che, con l’avanzare d’una maggiore conoscenza della lingua e della scrittura, acquistarono man mano un certo gusto espressivo e se vogliamo finanche pittoresco che ritroveremo più tardi nella zarzuela, l’operetta tipica del teatro spagnolo, che fornì ai “Romanceros”, sorta di divulgatori d’una primitiva forma di comunicazione sub-mediale, forme linguistiche e letterarie originali profuse di latino, giudaico-cristiano, moresco, e alcuni dialetti volgari che, in buona misura, ritroviamo nelle canciónes liriche e in alcuni Romance famosi, come questo “Romance del Quintado” (*), nella sua forma più tradizionale, trascritto da Joaquin Diaz:
“Ciento y un quintado llevan, todos van para la guerra. / Unos ríen y otros cantan; otros bailan y otros juegan. / Si no es aquel buen soldato, que tan largas son sus penas, / que el día que la casaron, sus bodas fueron sin fiestas. / Ya se acerca el capitán, le dice de esta manera: / ¿Qué tiene mi buen soldado; qué tiene que non se alegra? / Que el día que me casé me llevaron a la guerra / y he dejado a mi mujer, ni casada ni soltera. / Coge mi caballo blanco y vete en busca de ella, que con un soldado menos, también se acaba la guerra”.
"Cento ed un reclutato partono, tutti vanno per la guerra. / Alcuni ridono ed altri cantano; altri ballano ed altri giocano. / Se non quel buon soldato che tanto lunghe sono le sue pene, / che il giorno che si sposarono, le sue nozze furono senza feste. / Si avvicina già il capitano, gli dice di questa maniera: / Che cosa ha il mio buon soldato; che cosa ha che non si rallegra? / Che il giorno che mi sposai mi portarono alla guerra / e ho lasciato mia moglie, né sposata né nubile. / Prendi il mio cavallo bianco e vatti alla ricerca di lei che con un soldato in meno, finisce anche la guerra."
Riguardo alla composizione dei testi, molti erano gli autori che usavano stilare i loro versi sullo stile del virelai (*) provenzale, una delle tre forme impiegate nella poesia e nella musica medioevale, le altre sono la ballata italiana e il rondeau francese che rimandano a quel patrimonio musicale comune di una vasta area che dalla penisola Iberica raggiungeva l’Occitana fino alla Lombardia. Non di meno la musica strumentale era altresì ricca di straordinari esecutori per vihuela, chitarra saracena, cornamusa, ribeca, che si servivano per l’accompagnamento di tintinnambulum, flauti diversi, crotali, tamburi e tamburini, e timpani per segnare il “passo” nelle processioni.
Nel tempo, vanno citati i francesi Jehannot de l'Escurel, Guillaume de Machaut e Guillaume Dufay che ci hanno lasciato composizioni ballate e mottetti, e alcuni complainte, molto eleganti nella forma; gli italiani Francesco Landini, compositore, organista, poeta, cantore, organaro e inventore di strumenti musicali, uno dei più famosi compositori della seconda metà del XIV secolo; e il più acclamato del suo tempo non solo in Italia, Jacopo da Bologna, compositore che si inserisce nella corrente musicale dell’Ars Nova, noto soprattutto per i suoi madrigali, e le sue numerose “cacce”. In Spagna, Alonso Mudarra, Luis de Milàn, Diego Ortiz e altri, i quali composero brani preminentemente strumentali utilizzando generi diversi, come: la “gagliarda”, “fantasia”, “ballade”, “pavana” e le così dette “recercar” e “folias”.
Vanno ricordati inoltre, quei Troubadour (così si chiamavano nell’Europa medievale) che, oltre a suonare strumenti di vario tipo, come: lira, arpa, organetto, piffero e Fidel, intonavano la “voce” su versi di loro stessa composizione, improvvisando nei diversi “dialetti” regionali, canzoni e musiche a ballo in occasione di feste, matrimoni e banchetti, nelle nascenti Corti e presso i Signori dell’epoca. Tra i molti rimasti anonimi spiccano i nomi di Peire Vidal, Bernart de Ventadorn, Rambaut de Vaqueiras, La Comtessa de Dia, Marcabrun, Jaufre Rudel che scrissero madrigales cortesanos, romance e villancicos amorosos, danzas e bailes para cantar y taner (per cantare e suonare). In quel tempo, la maggior parte della poesia lirica e i poemi cavallereschi, le cronache storiche, i Romance e le opere filosofiche, erano per lo più scritte (o trascritte) in castigliano antico, che accoglieva in sé molte espressioni popolari, e che, una volta adeguatamente affinate o del tutto rimosse, diedero forma alla lingua spagnola così come è conosciuta ai giorni nostri.
È in quest’ambito cortigiano e popolare che, nel XIII secolo Alfonso X di Castiglia, ‘el Sabio’, dispose la raccolta delle “Cantigas de Santa Maria” (*), quattrocentoventisette composizioni in onore della Vergine Maria e dei suoi miracoli, in cui è fatto uso del volgare desunto dal latino, dovuto a copisti non sufficientemente esperti della lingua, che lo intervallarono con espressioni d’uso quotidiano a loro forse più naturali. Conservate in parte a Madrid e altre a Firenze, in quattro manoscritti contenenti inoltre raffigurazioni pittoriche di strumenti e suonatori, le Cantigas, ricche come sono di suggestioni musicali improvvise e di apporti letterari diversi, rappresentano una forma “commemorativa” di notevole pregio, sia nell’uso della “cantata”, sia per la struttura musicale utilizzata, che ben presto confluirono nella cultura delle austere corti d’Aragona e di Castiglia, d’Aquitania e di León, al pari del teatro e della danza annoverate tra gli svaghi preferiti dagli aristocratici del tempo.
Ad Alfonso X ‘el Sabio’, si deve inoltre l’aver incrementato con le sue opere, la letteratura del tempo e le discipline storiografiche e giuridiche, in aggiunta alla sua già copiosa biblioteca, indubbiamente una delle più ricche e conosciute dell’epoca, costituita da un numero impressionante di manoscritti redatti da intellettuali latini e arabi, ebrei e islamici, iberico cristiani e provenzali che formavano l’importante scuola da lui fondata detta dei Traduttori di Toledo, il cui apporto letterario e scientifico andò sviluppandosi nei secoli successivi. A lui si devono alcune fra le Cantigas più belle:
Dalla “Cantigas 7”: (stralcio senza traduzione)
“Esta é de como Santa Maria pareceu en Toledo a Sant Alifonsso, et deu-ll’huia alua que trouxe de Parayso, con que dissesse missa”.
“Muito dovemos, varóes, / loar a Santa Maria, / que sas graças et seus dòes / dá a quen por ela fia. / Sen muita de bòa manna / que deu a un seu prelado, / que primado foi de España / et Affons’ era chamado; / deu-ll’húa tal vestidura / que trouxe de Para’yso, / ben fe’yta a ssa mesura, / porque metera seu siso / en a loar no’yf’e dia. / Ben enpregou él seus ditos, / com’achamos en uerdade, / et os seus bòos escritos /que fez da Virigihndade / d’aquesta Sennor mui santa; / per que sa loor tornada / fai en España de quanta / a end’auian de’ytada / jvdeus et a eregìa. / Porén deuemos etc.”...
È indubbio che all’origine di tanta ricchezza di brani sia strumentali sia cantati che compongono il “Cancionero de Palacio”, si noti la molteplice coesistenza di diverse forme musicali, quelle stesse che hanno accompagnato la grande evoluzione culturale che si andò conformando nella Spagna dei secoli XIII e XIV, e che videro l’evolversi, accanto agli inni processionali, ai canti dei pellegrini e le preghiere ispirate, altre forme musicali popolari, accostate a canciones amorose e profane, melodie per vihuela e arie di danza e d’occasione, impiegate come brevi “intermezzi musicali” durante la lettura dei primi Romance viejos d’argomento religioso che segnarono un’autentica evoluzione del genere.
Uno dei più noti, è senz’altro la “Historia de los enamorados Flores y Blancflor” di anonimo medievale, il primo esempio di romance esposto in forma letteraria, conosciuto in tutta l’Europa già nel XIII secolo, in cui si narra di due innamorati, modello di fermezza e di costanza, la cui lealtà superò ogni pena che la vita inflisse loro per separarli, e di come, infine, riuscirono a coronare il loro sogno d’amore: “… essendo Flores d’origine mora e Blancaflor cristiana”:
“Señora mia: De la pena vuestra duele al ànima mia, que, de la vida mia, yo tengo por bien empleada, porque, cuando yo de espana partì, fice cuenta de perder la vida por vos. Pues Dios me ha enderezado asì, creo que me sacarà a mì y a vos de todo este peligro. Màs una sola cosa, señora, vos demando merced, si a vos placerà: que demos complimiento a nuestros amores”.
“Signora mia: Della vostra pena duole all’anima che, della mia vita io ho ben impiegata, perché, quando io partii di Spagna, feci conto di perdere la vita a causa vostra. Perché Dio mi ha indirizzato così, credo che tirerò fuori voi e me da tutto questo pericolo. Ma una sola cosa, Signora, voglio chiedere grazia, se a voi piacerà: che si dia compimento ai nostri amori”.
La trasformazione da poema lirico in Romance è di carattere popolare e avrà un lungo seguito, per cui tutti i poemi più o meno attendibili, nati come brevi evocazioni di leggende o ascrivibili a cronache realistiche, divennero veri e propri romance lunghi, paragonabili a sequel di più puntate, tra questi: “Romance del Rey Don Rodrigo y la perdida de España”, “Bernardo del Carpio”, “Romance de los siete Infantes de Lara”, ed altri, di cui rimangono solo alcuni episodi, come nel caso del: “Romance de Don Bueso”, del “Romance de Abenámar y el rey Don Juan”, o del “Romance del Prisonero” .
Tra questi ricordiamo Gil Vicente, drammaturgo e poeta portoghese autore di un “Amadis de Gaula” tratto dall’omonimo romanzo in cui si alternano vicende d’amore, di gelosia e pentimento, di grande eleganza letteraria. Nonché Bernardo Tasso (italiano) padre di Torquato, il quale, rimasto affascinato dalla trama, rielaborò la materia del poema e ne proseguì la historia, in un poema in ottave “Amadigi”, formato di 100 canti. E l’altro, quel “Romance del cautiverio de Guarinos” di anonimo pubblicato in pliegos sueltos, cioè in fascicoli sciolti, all’inizio del XIV secolo, in seguito ricordato da Miguel Cervantes nella sua opera più famosa “El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha”(*), nel passo in cui, Don Quijote andando a trovare Dulcinea, lo ascoltò cantare da un agricoltore del Toboso, il cui incipit è pressoché indimenticabile:
“!Mala la hubistes, franceses, / la caza de Roncesvalles ...”
“! Cattiva la subiste, francesi, / la caccia(ta) da Roncisvalle...”
L’opera letteraria più importante dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes de Saavedra, giustamente ritenuta una delle più rappresentative della letteratura mondiale, è anche un eccellente compendio di musica del suo tempo, infatti fa dire al burlone scudiero Sancio Panza:
“Señora, donde hay mùsica no puede haber cosa mala.
La mùsica siempre es indicio de regocijo y fiestas”.
"Signora, dove c'è musica non può esserci cosa cattiva.
La musica è sempre indizio di gioia e festa"…
È questa la più alta testimonianza della popolarità del Romance in terra di Spagna, che ci permette di dar credito a quella che è una prima informazione musicale (ne troveremo delle altre) che forse stavamo cercando fin dall’inizio e che fa da autentica cornice all’epica tardo-rinascimentale e quindi barocca, in cui sfocerà il Romance successivo. L’attendibilità di questo discorso, ci fornisce la chiave di lettura dell’intero romanzo, che è racchiusa nella frase che Cervantes fa dire proprio al protagonista indiscusso della sua opera, quel “Don Chisciotte della Mancia” audace cavaliere errante:
“Todos o los mas Caballeros andantes de la edad pasada,
fueron grandes trovadores y grande musicos”.
“Tutti o forse i più dei Cavalieri erranti dell'età passata,
furono grandi trovatori e grandi musicisti”.
Con ciò, s’introduce qui la figura del “Romamceros”, ovvero dello scrittore di romance, da non confondere con la raccolta di Romance cosiddetta cancioneros, quei narratori medievali, trovatori e menestrelli (vecchi e nuovi) che ancora all’inizio del XIV secolo, giravano per i borghi e nei contadi portando oltre alle cantate popolari e le canciones, quei componimenti poetici di carattere epico-lirico espressi in doppi ottonari assonanti con o senza estribillo (ritornello) fra l’una e l’altra strofa, simile alla ballata trovadorica e, come questa, lineare e monotona, gravata da una pena inarrivabile e dolente, tipica delle lamentaciones religiose. Dire che i Romanceros, narratori di storie leggendarie e avvenimenti di cronaca spesso rimaneggiati, obbedivano in certo qual modo, a quel codice dell’amor cortese, modello di virtù e moralità, nel quale la società cortigiana del tempo piaceva rispecchiarsi, è più che superfluo, nessuno di loro sfugge a quelle che sono le linee (o le mode) “letterarie” dell’epoca in cui si trovavano ad esercitare uno dei mestieri più antichi del mondo: l’affabulazione.
È però nella forma del “Romance nuevo” che i Romanceros mettevano insieme sentimenti diversi anche contrastanti quali: amore e odio, vendetta, magia, esotismo, fantasia (che più tardi saranno detti romantici), e che oggi ancora abbagliano l’improvvisato ascoltatore e l’acculturato lettore per le tematiche riferite a eroi lontani e vicini (nel tempo o nella realtà), e che piuttosto desidera burlarsi di loro, piuttosto che ammirarli per quelli che sono o che rappresentano. Non si sa bene se fin dall’inizio, ma comunque e sempre più spesso, i Romanceros rendevano una trasposizione fortemente emotiva, inframmezzata di pause e silenzi più o meno prolungati che accrescevano nell’ascoltatore una certa suspense nella narrazione. Così come, sul tipo della canciones epica, usavano accompagnarsi al suono di una chitarra, o una viella, alternando la narrazione con brevi parti cantate, o “villancicos” che, oltre ad alleggerire il racconto, permettevano, in ragione dell’orecchiabilità della musica, una maggiore memorizzazione del fatto narrato, per cui non sorprenda che il risultato artistico possa vantare una storia fra le più lunghe e continue, dal medioevo a oggi.
Obras cantadas:
“Al villano se la dan
la ventura con el pan.
Ano bueno, Rey, tuvimos
porque sembrando en el suelo
y ayudàndonos el cielo,
mucho pan al fin cogimos;
mas, si Dios quiere y vivimos,
si después nos lo comemos,
màs contentos quedaremos
que comiendo de un faysàn.
Al villano se la dan
la ventura con el pan”.
“Donde estàs, senora mia,
que no te duele mi mal?
O no lo sabes, senora,
O eres falsa y desleal.
...
Mi dolor, que es muy sobrado
me hace desatinar.
Tù no sabes de mi mal
Ni de mi angustia mortal;
...
Esposa mia y senora!
no cures de me esperar;
hasta el dia de juicio
no nos podemos juntar”.
Molti sono gli autori spagnoli di Romances vecchi e nuovi, che solo un elenco sarebbe qui impossibile quanto inutile azzardare, pertanto mi limito a citarne uno, il primo e senza dubbio il più grande, colui che, in qualche modo, ha contrassegnato la sua epoca, il XIV secolo: Juan Ruiz, più noto come Arcipreste de Hita, nato presumibilmente ad Alcalá de Henares (la stessa patria di Cervantes) nel c.1280, anche famoso per essere l’autore del “Libro de buen amor” considerato uno dei capolavori della poesia medievale spagnola. Un poema di 7 mila versi assortiti divisi in 1728 strofe, con forme che rimandano alla poesia devota, alla lirica, all'allegoria, alla satira, e personaggi molto realistici (come la mezzana Trotaconventos, e doña Endrina). Nel prologo si allude a una prigionia che una didascalia di un amanuense dice ordinata dal cardinale Gil Albornoz, dove il "buen amor" del titolo, cioè l'amore divino, si contrappone al "loco amor", l'amore folle e terreno.
Senz’altro uno dei libri più singolari e significativi delle origini della produzione in castigliano, scritto in "cuadernavía", un verso in sedici sillabe, usato soprattutto nella parte narrativa, ma sono presenti anche altri tipi di versi. Con la pretesa/pretesto di svelare i sottili inganni dell'amore mondano, attraverso una concreta varietà di ‘exempla’, “Libro de buen amor” si muove tra digressioni e divagazioni di ogni genere, presentando una serie di esperienze galanti e sensuali in cui la seduzione si conclude sempre con uno scacco, tranne in una sola eccezione. Alla costruzione del poema pseudo autobiografico confluiscono dati e toni disparati: avventure immaginarie e esperienze reali, schemi dottrinali e atteggiamenti goliardici e giullareschi, l'invettiva e il tradizionalismo, fonti classico-latine e cristiane, mentre influenze francesi e orientali sono inserite nel flusso della vita quotidiana. Quest'ultima è deformata in modo caricaturale da un irrefrenabile umorismo fantastico e un vitalismo che si mescola con pressanti preoccupazioni didascaliche, e tuttavia di edificazione etico- religiosa.
Dal “Libro del buen amor” leggiamo:
“El hombre debe alegrar su corazón, pues las muchas tristezas pueden nublar su entendimiento. Son palabras de Catón el sabio, que yo hago mías ahora. Mas nadie puede reírse de cosas serias, por eso yo pienso introducir en este libro algunos chistes con objeto de que aquéllos que los lean puedan divertirse y alegrar su ánimo. Pero te ruego, lector, que entiendas bien lo que digo y no tomes el rábano por las hojas. Medita bien la esencia de mis palabras. No me pase contigo lo que sucedió al doctor de Grecia con su rival romano, un hombre ognorante y de pocas luces. He acquí el cuento: ...”.
"L'uomo deve rallegrare il suo cuore, perché le molte tristezze possono offuscare il suo intendimento. Sono parole di Catone il saggio che io faccio ora mie. Ma nessuno può ridere di cose serie, per qual motivo io penso di introdurre in questo libro alcune storielle che quelli che li leggono possano divertirsi e rallegrare il proprio animo. Ma ti prego, lettore, capisci bene quello che dico e non prendere il ravanello per le foglie. Medita bene l'essenza delle mie parole. Non mi passi con te quello che succedette al dottore della Grecia col suo rivale romano, un uomo ignorante e di poche luci. C'è qui il racconto: ... ".
Pervenuti per lo più in manoscritti tardivi, in rielaborazioni di seconda e terza mano, talvolta decurtati di alcune parti, quando non ridotti a poco più di semplici testi sovrapposti uno sull’altro, i romance costituiscono il retaggio di un “fare teatro” che li riscatta dall’etichetta narrativa nel loro insieme, per restituirli integri nella loro originalità, al teatro drammatico vero e proprio, tipico della finzione scenica che trascende la contingenza di luogo e di tempo, per acquisire significato universale, un artifizio questo di molto teatro popolare. Il genere si commenta da solo, a poco – come si è visto – è servito in questa sede, un’analisi sistematica dei testi, coniugare il soggetto coi personaggi o con la metrica del verso.
Le forme musicali più frequenti sono, come si è detto, il villancico somigliante alla frottola italiana, e lo zejel arabo. Il fraseggio compositivo delle canzoni non è unificato e varia dalla semplice monodia: dall’espressione vocale formata da tre-voci nel discanto, lasciato al tenore e al controtenore, alla forma polifonica vera e propria a sei-voci del XVI secolo. Altra forma presente, sebbene in numero minore, è ancora il romance, letteralmente "portato” nelle corti e foderato con perfezioni e squisitezze colte, diverso nella metrica che risulta irregolare, fiorita per bocca di buffoni e narratori che l’adattarono ai canoni dell’epoca. Trascritto più tardi in versi di otto sillabe (ottonari) in forma strofica che, vale qui la pena ricordarlo, il romance sempre inizia con un verso introduttivo (estribillo), continua con una strofa originale (copla), e termina con la (vuelta), cioè il ritorno all’inizio.
Forme queste, che ritroviamo anche nella musica popolare, basata su una struttura armonica molto semplice, che man mano si andò arricchendo di nuove espressioni strumentali con inserimenti corali, e una più sensibile espressione del testo, al pari di quella “spiritualità” cortese di stampo religioso conosciuta come musica sacra. In ognuna delle molte canciones o villancicos il canto popolare sempre si mostra come il fiore della vita culturale spagnola, destinato, per il tramite d’una risorta autocoscienza, fortificata dal fatto dell’avvento di un nuovo spirito nazionale che attraverso il contatto con le altri nazioni europee, che caratterizzò in profondità lo stile musicale del romance – “accompagnato da brevi e monotone note” , come ha commentato l'eminente Menéndez Pidal, che lo ha ben esposto nel suo "Romancero Ispanico" (*):
“..quello que sin ningun orden, regla ni cuento, facen estos romances e cantares de que las gentes de baxa e servil condicion se allegra, forman un solo cuerpo tradicional”.
"…quello che senza nessun ordine, riga né conto, fa di questi romanzi cavallereschi e dei canti che le genti di bassa e servile condizione rallegra, forma un solo corpo tradizionale".
Non in ultimo, va riscontrata un'indubbia tendenza del romance verso il verismo, che però non deve confondersi con un realismo troppo dettagliato, il che lo porterebbe a eliminare la sua potenza archetipica e i suoi misteriosi suggerimenti. La realtà che i “romance cavallereschi” ci mostrano è di per sé una realtà in certa misura trasfigurata nell’aspetto, più o meno veridico della cosa ideale o idealizzata, connessa con chiavi ed echi di magica trascendenza; le cui caratteristiche possono apprezzarsi, in certo qual modo, più per la stringente spontaneità, che per rilevanza storica o realistica. Come si può riscontrare in “L'apparizione” (*), di anonimo, che qui leggiamo un breve stralcio nella versione di Campaspero di Valladolid:
"Se ha asustado mi caballo / yo tambien me sorprendì. / No te asustes, caballero / no te asustes tù de mì, / que yo soy la tu querida / la que llaman Beatriz. / Còmo siendo mi querida / no me hablas tù a mi?/ Boca con que yo te amaba / ya no la traigo yo aquì, / que me la pidiò la tierra / y a la tierra se la dì. / Ojos con que te miraba / tampoco les traigo acquì, / que me les pidiò la tierra / y a la tierra se les dì. / Brazos con que te abrazava, / tampoco les traigo aquì, / que me les pidiò la tierra / y a la tierra se les dì. / Yo venderé mi caballo / para misas para tì, / y me venderé a mì mismo / porque no pases allì. / No vendas a tu caballo / ni te pongas a servir; / cuantas màs misas me digas / màs tormentos para mì".
“Si è spaventato il mio cavallo / che anch’io mi sorpresi. / Non ti spaventare, cavaliere / non ti spaventare di me, / che io sono la tua amante / quella che chiamano Beatrice. / Come mai, pur essendo la mia amante / non parli tu a me? / Bocca con che io ti amavo / non la porto oramai io qui, / che io la chiesi alla terra / ed alla terra io la diedi. / E gli occhi con cui io ti guardavo / neanche quelli porto io qui, / che io li chiesi alla terra / ed alla terra essi li ho dati. / E queste braccia con che tu abbracciavi, / neanche loro porto qui, / che io essi chiesi alla terra / ed alla terra essi ho dato. / Io venderò il mio cavallo / per dire messe per te, / e venderò me stesso / perché non passi lì. / No, non vendere il tuo cavallo / né mettiti a servire; / quante più messe tu mi dica / più aumentano i tormenti per me".
Come è possibile comprendere dal testo che abbiamo appena letto, l’atmosfera dell’amor cortese, fa ancora da sfondo a quella culturale del periodo entro il quale il Romance fiorì e si sviluppò, e che, ritessuta nelle forma più erudita del genere novelesco, trovò una sua evoluzione più tardi, in epoca Barocca e per certi versi nel corso dei secoli XVI e XVII in cui assistiamo a una ripresa assai suggestiva, da parte di musicisti e letterati illustri che ne fecero un genere raffinato, utilizzato poi nella successiva forma polifonica. Ne sono esempi illustri: Luis de Góngora, teso al recupero dell’aspetto primario ricco d’immaginazione e fantasia; Francisco de Quevedo, che nel Romance evidenziò l’aspetto satirico e menzognero; Lope de Vega il cui ideale cortese consisteva in un colto casticismo che sovrapponeva la tradizione del Romancero, all’eleganza e alla dolcezza della metrica italiana. Per arrivare alla nostra epoca con Blas de Otero, che trasformò la figura del “poeta” in un “profeta” che segnala gli errori del presente per riuscire a superarli ed accedere a un futuro migliore. In entrambi i casi, questi autori, con fare di moderni musicologi, si adoperarono nel recupero delle antiche melodie tradizionali e poemi anonimi e popolari di molti autori del passato, e altri ne composero, interpretando con notevole compiacenza, i sogni e gli ideali della Spagna feudale.
Facciamo anche noi un passo indietro nell’affrontare un aspetto finora trascurato in questa ricerca che a fatica s’inoltra nel mare magnum della letteratura spagnola riferita al Romance, e recuperare, lì dove ci siano state carenze, alcuni testi di rilevante importanza. Ovviamente il semplice elencare testi non comporterà una loro assunzione nella ricerca qui avviata che certo non valica il muro della conoscenza archeologica, ma si vuole essere di stimolo per riscoprire quanto di essi ha contribuito alla nostra formazione letteraria e non solo. Soprattutto di quanto oggigiorno viene utilizzato da molti autori che crediamo originali, creatori di fumetti e romanzi, giochi elettronici e cinema fantasy, e che invece, sicuramente, dobbiamo a quanti: filologi e ricercatori, etnomusicologi e musicisti, letterati e semplici ricercatori appassionati, che si sono prodigati nel recupero di tanta letteratura e che ci permettono di rivisitare quell’epopea portentosa del passato, non senza scaturire in noi, attuali fruitori senz’anima, una pur vaga emozione che testimonia una creatività esemplare, mai venuta meno.
La tradizione del Romance dunque, si presenta a noi di una tale ricchezza che definirei quasi miracolosa, e che invito qui a riscoprire, per l’essere sorprendentemente ricca di spunti poetici e non solo. A partire da un autore che in assoluto si leva su tutti (almeno per noi ricercatori), testimone della popolarità che ebbero il Romance e i Romanceros nella tradizione spagnola: Miguel de Cervantes de Saavedra. Il quale, nel suo “Don Quijcote de la Mancia” (*), che di fatto possiamo definire quasi un lungo “romance nel romance”, elenca circa quaranta strumenti musicali in accordo con la loro funzione e colore timbrico perfettamente allogati e aggettivati secondo la lingua popolare. Nonché venti danze e balli tra quelli menzionati; altrettanto dicasi delle canzoni che corrono di bocca in bocca e che l’autore fa cantare ai suoi personaggi; mentre sono almeno una dozzina i romance citati. Un esempio di quella che è la sua sterminata conoscenza enciclopedica, lo troviamo in apertura del capitolo XXXXIII, in cui il Romance è annunciato dal canto “in sulla prima ora dell’alba”, l’ora propizia per il canto amoroso in letteratura:
“Marinero soy de amor / y en su piélago profundo / navego sin esperanza / de llegar a puerto alguno … ”.
“Marinaio son d’amore / e nel suo pelago profondo / navigo senza speranza / di arrivare in porto alcuno …”.
Il romance popolare spagnolo si rivela comunque in tutta la sua ricchezza di contenuto, quale mezzo espressivo di sentimenti che vorremmo fossero nostri, nel ritrovare quella compostezza, quella integrità nazionalistica di un popolo che già allora si distingueva per il temperamento virile dei suoi personaggi, per l’ardire di un torneo o di una corrida, per i ritmi sfrenati dei suoi bailes, l’andamento malinconico del cante, la nostalgica cadenza della vihuela, l’insolenza della chitarra flamenca o morisca, la voce alta dei suoi poeti. Una voce altamente sonora, con la quale ogni poeta d’oggi che si misura nel romance, diventa subito autentica e popolare, nell’accezione della parola stessa di narrazione, che prende forma dal popolo e nel suo essere popolare trova la sua continuità e la sua massima affermazione creativa, secondo il metodo che restituisce al popolo la sua storia, e di cui diviene – in senso assoluto – protagonista:
“..col tagliare e aggiungere versi, col sopprimere o variare le parole, col modificare lo svolgimento o alterare capricciosamente gli avvenimenti e le azioni dei personaggi, o meglio, col riscrivere la storia secondo un singolare punto di vista, secondo una propria logica dei fatti …”.
Non poca importanza va quindi attribuita al Cervantes musicologo, conoscitore ed estimatore della musica del suo tempo, tanto più va sottolineata la sua funzione di ricercatore e trasmettitore dell’antica tradizione, sebbene, egli ne abbia fatto, per così dire, un uso speculativo all’interno del suo romanzo (e che romanzo), col voler dare ai suoi personaggi una parvenza di realtà e di lucida follia. E che bene interpretò il noto compositore contemporaneo Manuel de Falla, il quale, nella messa in musica di “El retablo de Maese Pedro” (*), improntato sulla storia di “Gaiferos e Melisenda” (*), d’appartenenza al Romance epico, in cui il “retablo”, cioé il teatrino dei burattini, fa da sfondo alla rappresentazione che si svolge davanti a Don Quijote, l’ultimo e certamente il più nobile dei cavalieri erranti che siano mai esistiti.
Nel suo romanzo Miguel de Cervantes, l’antico romance vijeos assume una posizione di grande rilievo, rendendogli quell’attualità che in parte esso aveva perduta nel tempo, ottenendo così un duplice effetto: integrativo della rappresentazione che si svolge sulla scena, alla vita dello spettatore e viceversa e, al tempo stesso, permette a Don Quijote di entrare nel vivo della rappresentazione. Una scena che ritroviamo nella finzione del “teatro nel teatro” e ancor più nel cinema: da “Hellzapopping” di Henry C. Potter, a “La Rosa purpurea del Cairo” di Woody Hallen , dove la “finzione sostituisce la realtà che sostituisce la finzione”, in quanto elemento caratterizzante di un accadimento, attraverso il quale l’autore colto, il musicista galante, il narratore forbito, con l’assegnare ai personaggi certe emozioni, li consegna alla vita reale o inventata che sia, restituendo al lettore prima, all’ascoltatore poi, così come al cineamatore meravigliato, una diversa condizione esistenziale, attraverso la quale è sollecitato il sogno, la fantasia, l’istinto, la follia, l’ignoto:
“Giace qui l’hidalgo forte
Il cui valore arrivò
A tal punto che ebbe in sorte
Che la morte non trionfò
Della vita con la morte.
Poco il mondo calcolò.
Se ebbe d’orco la figura,
un’insolita mistura
la ventura in lui provò:
visse pazzo e morì savio.”
È ancora Cervantes che ci fa dono di questo sonetto, se pure va ricordato che sono passati secoli da che Miguel de Cervantes scrisse il suo famoso romanzo e altrettanti da che l’eco di quella che fu la poesia epica spagnola fosse ripresa dai suoi poeti più insigni: “che è poi il segreto spirito del romance che torna a forgiare noi moderni”, come affermato da Léon Felipe, uno dei grandi poeti spagnoli del novecento che ha dato nuova voce al romance epico e cavalleresco, quello stesso spirito che releghiamo all’antica voce della terra e che trascende la contingenza di luogo e tempo, per acquisire quei significati universali che sono propri della grande poesia. Quand’ecco:
“Per la pianura della Mancha / torna a vedersi la figura /
di Don Chisciotte passar”.
El Romance de Calaynos.
“Ya cavalga Calaynos
a la sombra de una verde oliva,
sin poner pie en el estribo
cavalga de gallardìa.
...
Mirando estaba a Sanduena
al arrabal con la villa
por ver si verìa algùn moro
a quien preguntar podrìa.
...
Por Alà te ruego moro
asì te alargue la vida
que me muestres los palacios
donde mi vida vivìa”.
NOTE:
Bibliografia di consultazione:
Miguel Cervantes de Saavedra “Don Chisciotte della Mancia” – Einaudi 1972.
Dionisio Preciado - “Folklore Espanol: musica, danza y ballet” - Studium Ed. Madrid 1969.
G. Di Stefano - “El Romancero: estudio, notas y comentarios de texto” - Narcea de Ed. - Madrid 1985.
Javier Villalibre - “Selection de Romances” - Editorial Everest - Leòn 1983.
Cesare Acutis, a cura di, "Romancero: Canti Epici del Medioevo Spagnolo" – Einaudi 1983
C. Samonà – A. Varvaro “La Letteratura Spagnola: dal Cid ai Re Cattolici” – Sansoni – Milano 1972.
Ramon Menéndez Pidal - in “Flor nueva de romances viejos” - Espasa-Calpe - Madrid 1985.
“L’apparizione” di anonimo del XIV secolo - in Wikipedia Libera Enc.
Manuel de Falla - “El retablo de Maese Pedro” - (vedi discografia)
“Gaiferos e Melisenda”, ballata judeo-españolas in “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes op. cit.
CINEMA:
Esistono diversi adattamenti cinematografici dell’opera, alcuni dei quali molto celebri come:
“Don Quixote” 1933 diretto da Georg Wilhelm Pabst.
“Monsignor Quixote” 1991 con Alec Guinness nel ruolo di Don Chisciotte.
“Don Chisciotte di Orson Welles” - ovvero il capolavoro perduto. Film del 1955 presentato Fuori Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica del 1992.
“Don Chisciotte e Sancho Panza”, film commedia del 1968 diretto dal regista Giovanni Grimaldi. Franco Franchi interpreta Sancio Panza mentre Ciccio Ingrassia don Chisciotte. In origine il film doveva intitolarsi “Don Cicciotto e Franco Panza”. Franchi e Ingrassia non sono stati l’unico duo comico a vestire i panni dei due celebri personaggi; infatti i protagonisti del film muto “Don Quixote” (1927, regia di Lau Lauritzen Sr.) sono i due comici Pat e Patachon (Carl Schenstrøm e Harald Madsen).
“Man of La Mancha” di Arthur Hiller film musicale del 1972 a sua volta tratto dal musical di grande successo. La trama del film è la messa in scena di “Don Chisciotte della Mancia” a opera del suo stesso autore. Cervantes è interpretato da Peter O’Toole (che veste anche i panni di Don Chisciotte); Sophia Loren interpreta Duclinea/Aldonza e James Coco Sancho Panza/servo di Cervantes.
“Lost in La Mancha” di Keith Fulton e Louis Pepe - overo la mancata realizzazione di ‘Don Qixote’ 2001.
“Donkey Xote” di Josè Pozo, commedia d’animazione del 2007 di produzione Lumiq Studios Filmax International, scritta da Angel Pariente e diretta da José Pozo in cui la storia è raccontata dal punto di vista dell’asino Rucio, che interrompe la narrazione di Cervantes per esporre il suo punto di vista sulle avventure di Don Chisciotte.
“Quijote” di Mimmo Paladino 2006, film surreale, dal taglio teatrale a opera dell’artista Mimmo Paladino. La maggioranza delle scene è girata nell’atelier di Paladino e la scenografia si avvale di alcune delle sue opere. Nel cast del film compaiono Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza.
“The Man Who Killed Don Quixote” di Terry Gilliam che dopo anni di controversie esce nel 2018.
MUSICA:
(*) “Canciones y Danzas de Espana: en el tiempo de Cervantes” – Hespèrion XX – EMI 1989.
(*) “Musica en la Obra de Cervantes” – Pro Muica AntiquA – Monumentos Historicos de la Musica Espanola 1982.
(*) “El Cancionero de Palacio” 1474.1516, Hespèrion XX, Jordi Savall – Astrée 1991
(*) “Cantigas de Santa Maria” Alfonso el Sabio 1223 -1284 - Monumentos Historicos de la Musica Espanola 1990.
(*) “Cantigas de Santa Maria” Alfonso el Sabio 1223 -1284 – Clemencic Consort – René Clemencic – Harmonia Mundi 1995.
*
.jpg) - Poesia
- Poesia
Anna Chiara Peduzzi... l’adeguata finitezza delle parole.
“Figure semplici” una silloge poetica di Anna Chiara Peduzzi – Anterem Edizioni 2021 – con una riflessione critica di Giorgio Bonacini.
C’è un’adeguata finitezza delle parole che dell’essenza varca il limine del dire, spuria finanche della grafia che la distingue e/o del suono che ne ottempera l’afflato. Nel suo divenire, pur nel vuoto subliminale che l’accoglie, se tratte dalla profondità simbiotica del linguaggio, ecco aspirano a un primario connubio verbale, onde risalire dal profondo i negati meandri del senso. Come di riflesso transitorio, in/organico e residuale, di materia gassosa e/o secrezione liquida evaporata nell’incesto mentale che le ha concepite, e che, per effetto transitorio di adattamento al cambiamento, assumono significato di ‘assenza nella presenza’…
Non dette non esistono le cose
o esistono di meno
restano inoffensive ad aspettare
sgretolate dal dubbio che le erode
mezze realtà di incerto statuto
di malavoglia ogni tanto visitate …
Inevitabile pensare alla presenza di una certa finitezza che investe il ‘profondo esistenziale’ dell’autrice; a un’anamnesi personale transiente e resiliente dalla resa iperrealistica: fisiologica e patologica della realtà, onde costruire e/o ricostruire, seppure a livello inconscio, l’illusione organica dei propri trascorsi. Quel dialogo ‘secretum’ che Anna Chiara Peduzzi pur rivela, non senza qualche esitazione, nella sua silloge poetica “Figure Semplici”, recentemente pubblicato da Anterem Edizioni. Si è messi qui di fronte a una forma del ‘dire’: limite e/o soglia di quell’addivenire che, in senso figurato, ognuno raramente espone al giudizio altrui …
Parla compitando la voce che s’affonda
senza accento di luogo
e si alloggia nel dialogo dei vivi …
Più che di ‘figure semplici’ si è qui proiettati nel mezzo di ‘forme composite’ di un dialogare presente, la cui materia biologica è strutturale, di collegamento e sostegno alla finitezza umana, corporea ed epidermica, emozionale e sensibile, sostenuta dall’afflato umorale percettivo, conoscitivo e/o intuitivo, che elabora le
possibili varianti apprensive: ansietà, preoccupazione, sofferenza, inquietudine; ma anche sentimento, passione, e quella finitezza d’amore che ciascuna parola porta con sé, vissuta o da vivere fino allo spasimo, fino alla fine dei giorni, come … in altro luogo la nutrice / che sazia questa fame.
Dov’è come si forma
la cosa che di noi non ha bisogno
per apparire e imprimersi …
L’imprinting alla finitezza d’amore è qui di seguito dato dalla sequenza a-ballo dei sistri suonati dal vento, dalla sabbia (o forse la polvere) sollevata dai piedi scalzi delle parole sussurrate, udite (?), in una notte d’estate, e volate via nei versi di una canzone che, se non direttamente, riguarda la presenza di (noi) protagonisti, fantasmi di noi stessi …
All’improvviso accampata intorno al fuoco
di inaudite parole scintillanti
aggredisce il silenzio e fa irruzione
come un vento caldo che spalanca
le rime doppie il suono dei metalli
così della fiamma iniziale
non resta che l’assenza
nell’incavo dei versi rifiutati
l’eccidio dei pronomi personali.
Allora cos’è che manca al compimento di un sentimento che pure dimostra tutta la sua finitezza: è forse il tenace istinto che lo trattiene, l’incompiutezza della perfezione o l’illimitatezza dell’infinità, che dietro la varianza rivela / l’incessante lavoro di diairesi? No, nessuna, o forse tutti i distinguo possibili, insiti dietro un’emozione che da sola enumera il multiplo e l’immenso, /… / contro l’idea che si sdoppia / che sempre è ed era …
Una parola sola occupa la mente
liquida come un fiume che al passaggio
tutto travolge e filtra in ogni anfratto
lasciando oggetti sparsi campi invasi
mulinello che ingurgita il presente
nel disordine nuovo delle stanze
dove il pensiero fluttua impotente
finché nel tempo saturo
tutto poi tace …
Come di frattali tendenti all’infinito che elaborano similitudini di se stessi, sfrangiati schemi d’infiorescenze pandemiche, ogni punto in esatta rispondenza, […] non mentono un’eternità promessa / saranno pulviscolo molecolare / informi scarti / nella generale dispersione …
Dov’è come si forma / la cosa che di noi non ha bisogno / per apparire e imprimersi (?) … si chiede ancora l’autrice/protagonista del libello, nel ricercare la ragione del suo sentire, la finitezza di senso impressa sulla carta, come a voler imprimere sulla sabbia il proprio estemporaneo ‘io’, ben sapendo che il vento e il tempo cancelleranno ogni residuale esistenza delle parole …
Dicono il tempo fattore d’incostanza
aberrazione dal piano intelligente
come deriva dei gravi verso oriente
che ci trascina ignari tra stagioni
ma nessun argomento mostra o spiega
quella freccia che manca il suo bersaglio
le fermate ai bordi della strada
non è il carattere che guida il nostro passo
ma agitazione di cellule e membrane
e inesaudito resta allora il voto
che in terra imprima un’orma disuguale.
“Figure semplici” di Anna Chiara Peduzzi
è il XXXIV° volume della collezione La Ricerca Letteraria diretta da Ranieri Teti, vincitrice della sezione storica del Premio Lorenzo Montano - Anterem Edizioni 2021. L’autrice laureata in Filosofia a Milano e in lingue straniere e traduzione a Parigi, lavora e collabora a riviste italiane e francesi, come traduttrice per organismi pubblici francesi e internazionali. Interviene in seminari di traduzione specialistica presso università e istituti di formazione dell’Unione Europea.
*
 - Poesia
- Poesia
Il pensiero magico di Bianca Battilocchi in Herbarium magic
...in “Herbarium Magicum” – Collana Nuova Limina / Anterem Edizioni 2021.
“…
penetra in abisso
sprofonda nel sonno vigile
dell’anima mundi
…
e traduci in idioma nuovo”
Volta a riportare alla luce la vera sapienza, “affinché dalla vista si sollevi alla percezione” (*), l’autrice di questo florilegio poetico lancia l’invito apologetico-celebrativo ad entrare nel labirinto magico-ermetico, stratificato nel complesso sistema esoterico di una certa produzione filosofico-letteraria medievale che, sopravvissuta nel substrato intellettuale moderno, si spinge nel sottobosco impenetrabile, perché misconosciuto, o forse perché abbandonato in Illo-tempore e che riconosceva all’Anima Mundi un primato rilevante nella conduzione dell’esistenza umana.
L’analisi semantica, di assegnazione di significato al testo, trova qui le difficoltà proprie del fare poetico, che esula dal dare un senso a una struttura sintattica corretta e, di conseguenza, di penetrazione dell’espressione linguistica autorale. Di conseguenza il pensiero magico-ermetico dell’autrice disvela il “…consegnarsi a una lingua interiore (labirintica) che dà voce al vedere (simbolico-immaginario) e, nello stesso tempo se ne sottrae, per ritirarsi nel mistero di un idioma nuovo”. (**)
“… risillabare / vocalizzare … per effetto di un incantamento, questo?”
Forse sì, o meglio per effetto di stasi, entro cui trova esito lo straniamento poetico, nei “…passaggi intricati e dondolati / da litanie … che si fondono d’io”. E che talvolta ritornano (prima di) “… svanire / e riassorbire in sublime / l’aurum potabile / lasciarsi pervadere dal calore / della pura ispirazione”; quell’aurum (oro liquido) che nella fusione ermetica si rapporta con mitico-oracolare, assume nella semantica poetica significato di purezza, valore e lealtà, che è all’origine molto più antica della divinazione mistica cristiana insieme all’incenso e alla mirra …
“quando non è più lo sfondo a coprirsi dorato
ma di oggetti in oro il trittico si fa vanto
…
di versi pressappoco illeggibili
in sospensione riversati
ombre sagoma
profumo ipnotico
di lingua edenica
…
sotto il segno di un magico botanico”
Annota Bianca Battilocchi in ‘Marginalia’: “Jung ravvisò nell’alchimia la volontà di trasformare quel fondo sotterraneo o inconscio, per portarlo a esprimere il ‘suo oro’, ovvero il suo significato occulto”. (***)
Altro elemento costitutivo questo “Herbarium Magicum” appartiene a quel sistema simbolico elaborato fin dagli albori storici dall’immaginario collettivo, che attribuisce alla materia vegetale, così come del resto a quella minerale, proprietà salutari benefiche e propizie o, all’occorrenza malefiche, messaggere di sortilegi e incantesimi …
“…avvicinarsi all’hortus
rosa dopo rosa
…
una rosa, solo una rosa, in pieno inverno
che folle richiesta”
…
rosa croce
croce rosa
…
le tavole si sovrapponevano
in un’arte scompaginata
in una danza schizofrenica
della memoria
…
in grumo
…
un viale stretto e polveroso
costeggiato gravido
giallo e verde
i limoneti fitti e grondanti
d’estate
…
l’approdo
non segnalato
da raggiungere
mettere alla prova
…
ma v’era l’ombra lontana
d’un luminoso fiore”
Note
(*) Cristina Campo, ‘Gli Imperdonabili’, Adelphi 1987.
(**) Giorgio Bonacini, dalle note di copertina.
(***) Carl Gustav Jung, ‘Psicologia e alchimia’, Bollati Boringhieri 1994.
L’autrice
Bianca Battilocchi, scrittrice e ricercatrice collabora con diverse riviste letterarie. La sua raccolta poetica Herbarium magicum è arrivata finalista al Premio Montano 2020 e una seconda La fonte di Isadora, ha vinto il Premio speciale del presidente di giuria a Bologna in Lettere 2021.
*
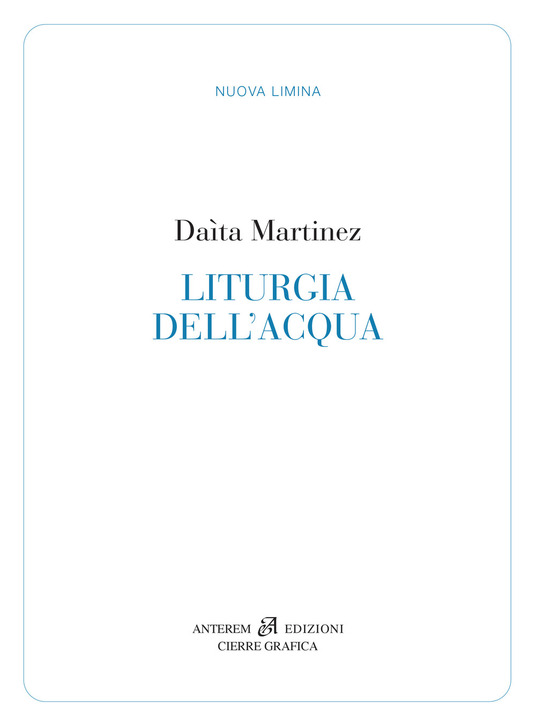 - Poesia
- Poesia
Daìta Martinez … la voce lirica del discanto.
S’increspa al respiro del vento, prima d’incedere dagli interstizi dei suoi silenzi marini, la liricità grave di Daìta Martinez, che riporta in superficie scompagini di un linguaggio primario, agli albori di una fonesi onomatopeica il cui alitare nudo, scaturisce, per effetto di discontinuità, dalla “precisa irrealtà di una distanza”.
È questo il tempo residuale di un passato che è solo della memoria, onde il verso poetico consegue dilagante al ‘discanto’ gergale e sacro rigenerato sul filo di una “liturgia dell’acqua”, da un ‘qui ed ora’ veritiero e inquietante, che “ruba parola alle parole … sospingendo destini”.
Eppure non traspare afflizione, dispiacere o tormento del verso, se non l’accettazione di una ‘assenza nella presenza’, ascendente alla volontà determinante dell’essere, di quel ‘sé’ che l’accompagna nel discanto, così nei ‘pianissimo’ come nei ‘fortissimo’ della sua voce, agra nella fusione gergale, tuttavia così mediterranea.
Non è certo necessario a Daìta Martinez stabilire l’ineguagliabile e profondo legame con la sua terra, “una riserva di limoni … la fioritura del ciliegio / l’incantesimo di una cantilena, / nella danza di una trottola”, nonostante la materia della lingua parlata, è negli elementi annotati, nel ‘riportarli alla luce’, che la rivelazione del suo ‘spirito lirico’ s’avvale, e che conosciamo dalle sue labbra “ammucciate sutta sta finestra di sciroccu”.
L’insensatezza della solitudine, la propaggine dei silenzi nei giorni senza vento, il pronunciare discontinuo delle parole avite, l’antitesi dell’ossimoro nell’ingranaggio dell’esistenza che porta a nuovi costrutti della mente, la soglia, il limite estremo dei desideri che non si realizzano, il “nodo nudo … mentri talìa como sciddica ciatu”.
Leggiamo qui, in questo modo di dire siciliano, com’è detto di persona indifferente ad ogni avversità, l’anima bella dell’autrice “chiarissima d’insistenza”, il suo respiro, aperta alla resilienza, al distacco dalla ‘realtà nella realtà’: “margine di un margine di vento … vuoto il grembo nel grembo agli / occhi sorge e discende l’obliquo / suo farsi dal mio fondo crociato”.
Intrecci di parole che spetta al poetare disciogliere nel “chiarissimo buio” che le circonda, con indulgenza nel “l’immobile acqua che sospende l’impronta calma … di seta sorta vuota tonda sul finire”, quasi a indurle a ritrarsi in se stesse, per un riscatto salvifico dalla condanna ciclica di un paradiso mancato: “Per disobbedienza cerco un riquadro inverso / al senso di una grazia unita e segreta all’ode del perdono”.
L’effetto ultimo può risultare infimo oppure grandioso, dipende dallo spirito con cui si affronta l’intero costrutto della “liturgia” annunciata, dal pronunciarsi ‘vivo’ delle parole: “il prato di latta ha margherite colorate nei sogni dei bambini … / dopo la questua la preghiera e quel finire / a mano il ricordo più lento odoroso vento / con occhi della piccola grazia ribelle alle / stelle pi n’anticchia di beni attummuliatu rina rina dintra ‘a vucca ca scunta e nenti cunta di lu scantu”.
Non c’è bisogno di conoscere il dialetto per comprendere ciò che la lingua evocata aggiunge al suono dell’afflato d’amore: “per imperfezione o / per credenza rubata agli angeli nudi / come impercettibile ora del passero / questa sua ritrosia sulla biancheria / bianca di bianchissimo cuore tutto / l’ardore dell’odore accolto per cura / sola primizia di una lacrima matura”.
Siamo allo stremo del poetare, in cui l’esistenza stanca di lottare perennemente di fronte al destino, s’avvoltola in se stessa, nel silenzio di un sentimento d’amore o, forse, di melanconia affettiva, di quella osservanza che il poetare sovverte in “isolata perla, la luna, il cielo altro non promette solitario”.
Dacché scrive (dal profondo dell’abisso):
“… anche le lacrime hanno lo loro melodia
e veglia l’aurora retrostante il ticchettio
nudo del mezzadro di fianco stanco per
inconoscibile protesta la sua lattescente
finitezza che là tra bocca impensata per
maldestra sua attesa la misura del bene
seppur senza mai tracciarlo un riservato
ti voglio bene nascosto dentro al profilo
della stanza venuta all’acqua profumata
la guancia rosata del sole un breve oltre
allo sguardo del mare …”
“Il mondo che ne emerge è favoloso – scrive Maria Grazia Calandrone nella sua intensa ‘prefazione’ – Daìta Martinez racconta un’infanzia e un presente cresciuto fino all’amore adulto, dove tutto è mescolato a tutto e ogni elemento contribuisce a formare il suono di fondo che riconosciamo come il ronzio del ‘reale’, oltre la così detta realtà. […] Perché Martinez sta parlando a qualcuno, sta raccontando il colmo, il mediterraneo traboccare in colori e sapori della vita, per qualcuno che ascolta. O ascolterà, leggendo questo nascondersi in bella vista della parola, questo smettere anche la punteggiatura e lasciare che ognuno sia quel che è, veda quel che vede. Canti il suo canto”.
Daìta Martinez è poetessa palermitana autrice di numerose sillogi poetiche è finalista nel 2020 della 34° edizione del Premio Lorenzo Montano. La presente silloge è edita da Nuova Limina per i tipi di Anterem Edizioni 2021.
*
 - Libri
- Libri
Leggere / Ascoltare Idee e Suggerimenti per tenersi occupati
Leggere / Ascoltare
Idee e Suggerimenti per tenersi occupatidurante il loockdown.
PSALM - di Paul Celan
“Salmo” nella traduzione di ……
Nessuno ci impasta di nuovo da terra e fango,
nessuno rianima la nostra polvere.
Nessuno.
Che tu sia lodato, Nessuno.
Per amore tuo vogliamo
fiorire.
Incontro a
te.
Un Nulla
fummo, siamo, reste-
remo, noi, in fiore:
la rosa di Nulla, di
Nessuno.
Con
il pistillo chiaro-anima,
lo stame deserto-cielo,
la corolla rossa
per la parola porpora, che cantammo
al di sopra, oh al di sopra
della spina.
È detto: “Con salmi e inni e cantici spirituali” (San Paolo ‘Lettera ai Colossesi’).
Dapprima inclusi nel rito liturgico, alfine di trasfigurare e di elevare l’umanità al di sopra delle vicende terrene, il canto dei “Salmi” (*) ha illuminato da sempre il successivo cammino della preghiera verso nuovi e più alti ideali, offrendo alla religione un linguaggio altamente spirituale, le cui ampiezza espressiva ha ancora tutt’oggi un effetto trainante sulle masse che nei secoli ha rappresentato la sublimazione del rito liturgico cristiano.
Dall’iniziale canto Gregoriano, all'Exsultandi et Lautandi del canto-fratto, alle odierne “Prayers" (*) del compositore georgiano Giya Kancheli, sono passati qualcosa di più di 1000 anni, acciò il senso caratterizzante la ‘preghiera’ non è mai venuto meno. Dell’uso di fare musica e di elevare canti durante le cerimonie liturgiche, rituali della diffusione del culto cristiano, del quale è fatta menzione nell’Antico Testamento con riferimento alle lodi solenni composte sulle parole sacre inizialmente recitate, che dovevano essere intonate ‘con gaudio ed esultanza’, non si è persa oggi memoria.
O almeno così sembra, seppure in parte, stando alle testimonianze raccolte nell’area slava, successivamente unificata nel canto rituale della Chiesa russo-ortodossa, il cui rigore imposto alla forma ne delimita immancabilmente la portata strumentale d’ogni pretesa d’arte, per farsi linguaggio collettivo, sia di recitazione che strumentale che fosse eseguibile e recipita dalle masse raccolte in preghiera. In ciò Giya Kancheli sembra aver raccolta ogni forma preesistente, antica e antichissima, nella sua odierna creazione musicale, ricreando a sua volta un nuovo stile, unico e inconfondibile.
Il cui andamento ‘piano e grave’ ondeggia come di un mare solo apparentemente calmo, che all’improvviso scaturisce dal profondo, come per una tempesta rigeneratrice di spume, ad esprimere l’imtima natura del proprio sentimento religioso. Così in “Caris Mere” (*), quasi l’estensione di una preghiera che implode con notevoli assonanze col Gregoriano, sia di forma che di stile, sia nell’uso dell’organo che degli strumenti esibiti, quali: voce soprano, clarinetto, viola, e l’inserimento del sax soprano e orchestra d’archi. Un mix che si rivela testimonianza di una medesima derivazione liturgica, per quanto sarebbe improprio asserire un origine diversa dall’una dall’altra forma, ma più verosimilmente ritenere entrambe confluite da un comune patrimonio, tramandato dalle culture più antiche alla cultura cristiana.
Concepita in forma di ‘preghiera’ l’opera di Giya Kancheli prende spunto dal ‘Salmo 23’ cui è detto “Il Signore è il mio pastore…”, incluso nel CD “Exil” (*), per poi includere ogni altro significato voluto, spaziando da testi di Paul Celan, ad Hans Sahl. Mentre in “Abii ne Viderem” (*) l’utilizzo della Stuttgarter Kammerorchester diretta da Dennis Russel Davies; con le voci e il flauto del The Hilliard Ensemble, e Kim Kashkashian impegnato alla viola. L’opera completa “Prayers” si sviluppa in quattro parti formando essa stessa ‘un ciclo e così suddivisa: “Morning Prayers”, “Midday Prayers”, “Evening Prayers”, “Night Prayers”. Volendo essere ‘up-to-date’ l’ensemble Kronos Quartet (*) ha elaborato quest’ultima in un Cd dedicato all’autore georgiano, cui va riconosciuto, insieme all’estone Arvo Pӓrt, l’eccellenza musicale della grande tradizione liturgica.
Che la ‘liturgia musicale’ si sia occupata in particolare all’antica innodica cristiana, noi sappiamo che in letteratura, invece, in via alternativa ci si è occupati, attraverso linguaggi e immagini, al simbolismo fenomenologico delle diverse forma dell’immaginazione. Pertanto, inseguire un schema speculativo nel campo della filologia linguistica che fin dai primi enunciamenti potrebbe risultare infruttuoso, è per me cosa ardua da affrontare, in questo contesto. Soprattutto se a proporlo è uno stimato filosofo francese di tendenza teologico-cristiana qual è Stanislas Breton, che ha dedicato un eccellente saggio “Simbolo, schema, immaginazione” (*) alla ‘riflessione sul simbolo’ della poetessa e scrittrice Rubina Giorgi.
Scrive Breton: «Simbolo è ciò che, senza concetto, al di là o al di qua del concetto, fa dunque comunicare gli uomini tra loro e le cose tra loro. […] Molti indizi, oggi ci persuadono della necessità di tralasciare sia l’ontologia tradizionale sia la semiotica generale che l’ha rimpiazzata. Tra le opere che testimoniano questa insoddisfazione e che delineano, in modo fermo, lo schema di questo superamento, ce n’è una che abbiamo scelto perché ci sembra essere il punto d’incontro di diverse tendenze e di molteplici discipline: […] cioè la scienza filosofica dell’essere, afferente alla “metafisica platonico-aristotelica”.» […] Da cui l’affermazione: «La fine della metafisica, potrebbe essere l’inizio della simbologia.»
Ne consegue l’individuazione, nell’ambito della ‘speculazione filosofica’, di uno ‘schema’ necessario nello studio della ricognizione scientifica, antecedente alla formulazione dell’ ‘ontologia formale’. Un metodo di apprendimento rivolto alla comprensione del ‘sistema significante’ che, come è anche detto nell’introduzione del saggio, rivolge la sua utilità allo studioso/lettore, nell’addentrarsi, seppure con non poca difficoltà, nella ‘materia significante’ ed accettarne i concetti e/o a condividerne le tesi.
Una proposta di lettura questa che, stando almeno nelle intenzioni dell’autore, guarda all’insieme del pensiero in ambito linguistico a lui contemporaneo. Breton, infatti, rivolge una speciale considerazione alla simbologia di Rubina Giorgi, che ha svolto un’importante excursus, quanto più addentro all’ ‘ontologia formale’, attraverso l’aspetto delle forme e ai significati intellegibili, rivolto, soprattutto, alla funzione che il ‘simbolo’ riveste nel nostro mondo odierno.
Nella specifica del ‘simbolo’ che Breton rende in modo quantomeno suggestivo oltre che rigoroso, si hanno in breve: due poli entrambi ricettivi, divisi da un intervallo vuoto e/o nullo (nihil) reso fruibile nell’immaginale (vedi Cobin, Hillman e altri). In primis va qui chiarito che il sussistere dell’ “approccio immaginale” nei confronti del ‘simbolo’, non esula da ciò che è fondativo nel “pensiero immaginale” riferito al ‘simbolico’. In breve, lì dove Breton cita Rubina Giorgi: «..il simbolico, come funzione di negazione e di distanza, non è vuoto perché è auto-riflettente, ma è auto-riflettente perché è vuoto.
Il movimento dell’autoriflessione conferma questo vuoto.»
[…] «Per ristabilire l’equilibrio tra il causale ed il semantico, è necessario che lo schema elevi alla dignità di nuovi significati delle accezioni preliminari e convenzionali, che non sono del resto da concepire mai come cause propriamente dette, e le inserisca in una totalità originale dove esse prendano una valenza nuova.»
Soprattutto quando questa è applicata all’intenzionalità dell’arte cui l’impersonalità dell’artista diventa abnegazione del soggetto nei confronti dell’oggetto. Un’esigenza speculativa messa al servizio della creatività, per cui – come scrive Carlo Di Legge: «l’abnegazione del me provoca (spesso) le rappresentazioni più raffinate dei molteplici recessi della soggettività.» Ma il passo poetico non si ferma qui, infatti Breton aggiunge che «..l’oggetto e il soggetto non sono fissati una volta per tutte. Bisogna assimilarli non a degli elementi invariabili ma a delle polarità reversibili. […] Nel suo movimento, il simbolo è soggettività in modo che specularmente (moto proprio del riflessivo), rimanda di continuo il soggetto all’oggetto e viceversa.» In ciò non v’è nulla di misterioso quanto invece c’è di speculare, in ogni singola istanza c’è sempre all’origine un’intenzionalità ricettivo-creativa propria dell’essere pensante (animale, vegetale, umano), afferente a una sorta di ‘energia’:
Difatti il ‘simbolo’ re-interpretato secondo Breton sulla scia delle avances di Rubina Giorgi equivale a un principio d’identificazione, l’affermazione stessa dell’individualità dell’essere antropico: «Ed anche questa energia è sospesa ad un irraggiamento originario che, aldilà dell’essere e della forma, si presenta come pura indeterminazione “per eccesso” di cui le figure sensibili e le forme intellegibili, come pure lo stesso movimento formativo, spiegano, in una lingua cosmica, l’inesauribile generosità.»
Veniamo quindi messi di fronte a un problema logistico che si vorrebbe risolvere, ma di certo – scrive Carlo Di Legge nella sua eccellente introduzione: «Non (con) la logica formale classica dunque, ma (con) una logica che, tuttavia, consente di districarci, orientandoci nella selva delle somiglianze, e che paradossalmente presiede alla comunicazione e all’interpretazione, se interpretazione è sempre legata alla comunicazione: quello simbolico è, per quanto non possieda chiarezza né evidenza, il luogo che offre certezze, pur nella variabile molteplicità delle forme»:
«Il suo carattere polimorfo non gli impedisce (al simbolo) di assicurare la comunicazione tra gli uomini. Non più del resto di quanto la sua ambiguità non lo condanni all’incomprensibile. Ad ogni modo questa comprensibilità si accontenta benissimo dell’equivoco e della pluralità dei sensi.»
Pertanto giungiamo a un’altra affermazione: «L’essere è la forma, attiva o passiva, che sfida ogni nostro gioco linguistico.» (Breton) Come è anche detto nell’introduzione, che «lo si riconosca o meno, questa è propriamente la nostra vita. […] Ci parla del nostro universo, dicendo che in esso ogni ente è in simpatia con ogni altro; ma non è questa, la dimensione della logica scientifica: non stupisce chegli scienziati non la ammettano, se non i più illuminati.» (Carlo Di Legge)
Volendo a questo punto rientrare nello schema formulato inizialmente, dei: “due poli entrambi ricettivi, divisi da un intervallo vuoto e/o nullo (nihil) reso fruibile nell’immaginale”, approdiamo con più facilità a individuare i rapporti che intercorrono tra ‘simbolo, schema, immaginazione’ definiti nel titolo del libro:
«Oggi si sarebbe tentati di riservare lo studio a questo insieme di discipline abbastanza privo di rigore che si chiama “semiotica”, perché si occupa di segni, di qualsiasi natura essi siano, sia pure privilegiando lingua e linguaggio e con il primato e la guida della linguistica, che induce talvolta a subordinare l’antico ‘semeion’, nella plasticità delle sue accezioni, alla chiarezza e alla distinzione della parola scritta o parlata.»
Tuttavia ciò non basta a seguire uno ‘schema’ di per sé farraginoso che induce alla antinomia delle trattazioni, allorché si avvale della speculazione filosofica per affermare alcuni principi solo apparentemente indissolubili afferenti ad altre discipline e altri autori come Heidegger, Levinas, Lacan, Frigo ed altri che, non in ultimo, trovano in Jacques Derrida, “l’epistemologo del pensiero postmetafisico”, la resilienza di una specificità indelebile con testi importanti anche per questa trattazione:
«Ma è chiaro che il dilatarsi e l’esplicitarsi, messo in opera dallo schema e dall’immagine (rappresentati nel testo), suggeriscono una linea di sviluppo all’infinito che non copre tuttavia la perfetta omogeneità del tempo postulato. Il tempo dell’immaginario, come quello della storia che lo nutre, è al tempo stesso racconto che spiega e memoria che raccoglie. Tempo ciclico e tempo lineare si fissano quindi in un tempo più profondo, […] che la densità dell’essere, la pienezza che si insinua, in certi momenti che miracolosamente sospendono l’uniformità della successione che affiora nell’Opera, quando essa è veramente Opera […] che restituisce all’uomo , contro la minaccia di dispersione e l’inerzia della natura, la poesia di un’espressione autentica.»
Va citato inoltre un libro di Jacques Derrida: “Pensare al non vedere - Scritti sulle arti del visibile” (*), in cui si tratta delle arti come problematicità: “che si rifrange ogni volta in una molteplicità lontanissima dall'essere omogenea. Per quanto ciò che concerne il visibile, infatti, si tratta sempre, anche se in modalità differenti nelle arti e rispetto alla scrittura, della traccia, del tratto, di spettri, e dunque di un “vedere senza vedere niente … punto di condensazione di una realtà possibile”.»
“Vedere senza vedere”, si è detto, e anche “pensare al non vedere”, ciò che più si abbina alla tematica di “Vocali”(*), introdotta da Arthur Rimbaud in cui il ‘poeta maledetto’ avverte precise sinestesie tra colori e vocali, tra elementi naturali e grafici …
Vocali
“A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali,
io dirò un giorno i vostri ascosi nascimenti:
A, nero vello al corpo delle mosche lucenti
che ronzano al di sopra dei crudeli fetori,
golfi d’ombra; E, candori di vapori e di tende,
lance di ghiaccio, bianchi re, brividi di umbelle;
I, porpore, rigurgito di sangue, labbra belle
Che ridono di collera, di ebbrezze penitenti;
U, cicli, vibrazioni sacre dei mari verdi,
quiete di bestie ai campi, e quiete di ampie rughe
che l’alchimia imprime alle fronti studiose.
O, la suprema Tromba piena di stridi strani,
silenzi attraversati dagli Angeli e dai Mondi:
– O, l’Omega, ed il raggio violetto dei Suoi Occhi!”
C’è però anche chi invece avverte un’istintiva identificazione con essi, ad esempio nei colori della natura nelle diverse stagioni, e perché no nei colori dei sogni che sfolgorano all’interno del “… punto di condensazione di una realtà possibile”. E chi abbina i colori all’effimero contemplativo della musica, e allora è il mare, il cielo, la terra o i prati a dettare la sua tavolozza; e perché non pensare ai sentimenti cui siamo invero profondamente legati, che ci ispirano il colore dei giorni, o anche il profondo buio delle notti. Quei colori che ci invitano al canto che, come nei ricordi dell’infanzia ci avvertono che non tutto è perduto, che il germinare della terra riporterà l’antica origine edenica del mondo, che inseme agli antichi dèi torneranno le speranze messianiche di una redenzione possibile.
Quegli stessi colori che il canto di una voce o il suono di uno strumento può darci la dimensione di quel che siamo, l’identità di esseri umani, intelligenti, capaci di creatività, di sostegno, di concepire un disegno di vita unitario, di poter affrontare le sfide e affidarci all’avventura di un viaggio. Come ad esempio in musica, di misurarci in un ‘ensamble’, di comunicare con gli altri elementi di un’orchesta, operare affinché le note si colorino di accordi, di assonanze armoniche, di linee melodiche sempre nuove, che ci restituiscano, infine, quella ‘gioia di vivere’ che oggi sembra perduta nelle strette maglie della sofferenza che ci attanaglia.
Nasce così “The colour identity” (*) un CD interamente strumentale con alcuni straordinari inserimenti vocali di Marta Loddo e Rosie Wiederkehr, presentato dal Mauro Sigura Quartet, formato da Mauro Sigura, cui si deve la ‘coloratura’ virtuosistica della melodia e le ‘variazioni’ all’interno dei brani, come di componente costitutiva essenziale. A determinarla è l’assoluto cui egli approda con l’Oud, uno strumento solista per eccellenza, che in questo caso fornisce al Quartet l’alchimia d’insieme necessaria a coniugare memorie di un passato lontano con il moderno presente, la cui ‘chiave’ definisce la ‘linea sonora’ costituente la New-Jazz World Music.
Se si volesse accostare un colore al suono dell’Oud, potremmo definirlo ‘contenuto nell’emozione che suscita’, corrispondente in pittura all’arancio tendente al rosso, o forse al viola tenue, i colori propri del melos antico, ovvero dell’odierna melancolia che suscita l’autunno nei dipinti ‘crepuscolari’; il colore stesso di un sentimento come l’amore, per pienezza sonora ed espressiva, paragonabile a un certo tipo di poesia e, in certo qual modo, ‘chiave sonora’ dei brani nell’album pressoché acustico. Brani in cui s’intercalano voci diverse, offrono all’ascoltatore attento l’opportunità di sentire/vedere i ‘colori’ che verosimilmente li hanno ispirati: il ‘bruno’ dell’accorato richiamo che fuoriesce dal profondo della terra in “Il canto di Maddalena” e “Madri di Damasco”; il ‘verde-blu’ di “Terramare” e “Instabile”; la lontananza ‘azzurro-cielo’ di “A ovest di me” e “Seven chitzaz”; la desolata contrada bruciata dal ‘giallo-oro’ del sole di “Allagamenti” e il successivo “Bruja”; fino all’ ‘argenteo’ “Mbour” che sa di pioggia che scende leggera sui campi, portatrice d’ebbrezza e di sperato piacere. Bravissimi tutti i componenti The Quartet, autori e coautori dei brani e degli arrangiamenti: Mauro Sigura, Gianfranco Fedele, Alessandro Cau, Tancredi Emmi, ai quali va il plauso per aver mantenuta, senza mai strafare, l’eccezionale ‘misura del tempo’ spesso ricercata dei componimenti; e il mio personale omaggio per leleganza raffinata del suono dei loro strumenti.
L’eco della ‘poesia’ di cui fin qui si è spesso parlato trova riscontro in “Edeniche” - Configurazioni del principio (*), una raccolta poetica di Flavio Ermini - Moretti & Vitali Edit. 2019, che propongo all’attenzione di quanti mi leggono.
"Prolegomeni alla ricerca del ‘mito’ perduto".
Nella concezione poetica di Flavio Ermini, autore di ‘Edeniche’, difficilmente si arriverebbe a una ‘dismissione del mito’ così come è giunto a noi contemporanei, per quanto gli effetti della sua ‘caduta’ si dimostrino oggi irreversibili, privata com’è della tesi che l’ha sostenuta fin dall’origine. Tesi che, dapprima Kant poi Jung e Kerényi hanno posto in evidenza, in quanto rappresentazione dell’inconscio collettivo primordiale, come “creazione mitica del pensiero umano”, d’appartenenza specifica alla sfera della psiche. Una ‘dismissione’ dubbia che pure c’è stata, e di cui oggi si tende a sminuire l’importanza, malgrado volenti e/o nolenti, non riusciamo ancora a fare a meno della ‘prestanza creatrice del mito’ che, come già Hegel a sua volta ha dimostrato, si palesa come essenza di “pura disciplina fenomenologica dello spirito”:
«Non ha fondamento né gravità l’antro dei cieli / discosto com’è dal fuoco al pari del mondo abitato / che dalle acque creaturali viene circoscritto / per quanto non si tratti che di assecondare la caduta / consentendo così alle residue forze relittuali / di protendersi una volta ancora verso il principio / […] desituandoci dalle nostre abitudini cognitive / per esporci all’assoluto contrasto che si afferma / nel secondo principio di ascensione al cielo / […] nel varcare con reticenza il limite che ci separa / dalla superficie celeste dell’ultima terra / con la segreta illusione di rivelarne la natura».
Non mi è dato conoscere quanto consapevolmente ogni singolo autore citato, e lo stesso Flavio Ermini, “nel fondare il mondo sulla ragione”, abbiano visto negli effetti della ‘caduta edenica’, la perdita delle forme archetipe della psiche, attraverso le quali lo spirito umano pure s’innalza verso il sapere assoluto. Di fatto, con la compiuta ‘dismissione’ della pregressa mitologia senza uno scopo definito, seppure sostituita per ciò che riguarda l’attualità da nuovi ‘déi ed eroi’ di recente conio e piuttosto avulsi da virtù etiche ed estetiche “quale testimonianza dell’oscurità che si cela / nell’impreciso vuoto del presente”, si è creato un ‘nulla prepositivo’ nella conoscenza collettiva di non facile riempimento psicologico, che sta portando a uno sconvolgimento profondo di tipo esperienziale, pari quasi al trauma ‘immemore’ del Diluvio che in illo tempore sconvolse la terra:
«..a causa dell’ostinato levarsi delle tenebre / se non proprio dell’annientamento cui porta l’apparire / sempre di nuovo si ripete l’ascensione al cielo / in omaggio al divenire che in terra si distende / sullo sfondo originario cui l’umano si sottrae / mettendo a soqquadro anche il sacro recinto / […] dove opera ogni notte un rivolgimento natale / l’incerta creatura da poco tempo generata / per la cui sacralità viene un mortale a garantire / in virtù della pietra e di un impossibile assentire».
Grandiosa l’immagine del ‘sacro recinto’ edenico, e della causa che ha portato alla dismissione dell’umana creatura da esso, in cui: «‘la terrena sostanza del giardino’ porta all’incompiutezza il graduale sottrarsi alle stagioni / che improntano senza posa il nostro incerto cammino / attraverso i gradini del tempo fino all’atemporalità / che diventa ostile alla terrena sostanza del giardino / rendendo inadeguato il consacrarsi al cielo della luce / così come il situarsi ai lati di una penosa dissoluzione / che (di fatto) mortifica l’essere umano per la vita che gli resta».
Nondimeno, nelle diverse sezioni autonome che distinguono questa silloge poetica al pari di un ‘unico lungo poema’, ritroviamo più o meno definiti tutti quei valori che il poetare si concede di trasformare in verso descrittivo, in cui si ravvisa una trama che non stento a definire ‘tragica’, se non ipotizzando una sorta di riabilitazione ‘al momento non formulabile’, che arresti il tempo della ‘caduta edenica’, in una sospensione a noi necessaria per ovviare quella ‘dismissione mitologica’ che pure fin qui ci ha accompagnati, «..se non ipotizzando l’aiuto delle ali», di nuove ali che ci permettano di tornare a volare:
«..non l’interezza è all’origine del nostro apparire / ma un grido che ai viventi l’indiviso sottrae / quando è su loro impresso il marchio dell’obbedienza / anche se altro non fanno che sfuggire all’esilio / votati come sono all’illusoria condivisione della verità […] in collisione con l’orizzonte che lontano si configura / e con dolore fa pensare a molti uomini in catene […] nella relazione che i differenti mantiene separati / per un tempo che potrebbe anche essere indefinito / … il cui ‘paradiso perduto’ / rappresenta l’ultima luce per i mortali / spinti come sono verso la prima essenzialità / che nell’antiterra riconosce … / l’insopprimibile incedere di forze discordanti».
Per quanto il sottotitolo avverta trattarsi di ‘configurazioni del principio’, «nel carattere albale di vaghe sembianze», si ravvisa, almeno nelle intenzioni, un plausibile riferimento alla perdita delle ali da parte degli angeli caduti che ritroviamo sparpagliate un po’ dovunque. In ogni luogo dove, in contrasto con gli spostamenti tumultuosi che la ‘caduta’ dei corpi, al pari di meteore impazzite, di per sé conduce, si è ceduto a quella ‘pietas’ umana e divina insieme, atta a conservarne le spoglie e la memoria. È in questo senso che in “Edeniche” ogni locuzione va letta e ponderata a fronte di una forma poetizzante della trasformazione ‘divina’ dell’umano sentire:
‘la forma perfetta dei cieli’
nel carattere albale di vaghe sembianze
proprie dello spirito che bagna la terra
dove soffre ogni pena l’umano che appare
è nota da tempo la compostezza dei morti
pur se occultata sulla linea di faglia
del moto affannoso di chi ancora vive
ignaro della forma perfetta dei cieli
Ma noi non possiamo dismettere l’idea di una possibile intesa tra gli umani, propensi come siamo all’affrancamento della pena giustamente/ingiustamente inflitta, semplicemente perché non ci è concesso dalla violenza delle necessità cui siamo sottoposti, onde per cui ‘il cantiere dell’uomo’ “nell’atto di sottrarsi all’apparenza”, rimane attivo “per bandire il vuoto dal giardino”:
‘il cantiere dell’uomo’
ha voci ovunque il cantiere dell’uomo
nel richiamare alla mente la casa natale
che spinge l’esule a uno stato di sconforto
in quanto elemento destinato alla fine
mentre più inerte si va facendo il preumano
per l’estendersi del male tra le forze discordanti
la cui violenza impedisce al giusto di tornare
privo di ali com’è alla volta del regno.
In fine ècco due libri di recentissima produzione letteraria: 'La scatola di latta' (*) il fantasmatico volumetto scritto e illustrato da Paolo Donini che ha messo a punto una sorta di gioco prezioso, utilizzando 'l’alchimia di una fiaba moderna' capace di affabulare il lettore. È così che rapito nella lettura mi sono ritrovato …
'Nello sperduto paesino di Ics, fra morbide colline ondulate come le pagine di un libro...' Così come ha fatto l’autore di questo ‘delizioso’ piccolo libro (nel formato), ma grande per contenuto che è “La scatola di latta”, enome, immensa quanto l'universo. Tuttavia più che raccontarvi la ‘fiaba’ adatta a grandi e piccini, ho scelto di parlare delle ‘tavole sinottiche’ (i disegni) che Paolo Donini ha incluso nel suo libro a incominciare dalla copertina … la storia narrata verrà poi da se e/o potrete sempre leggerla direttamente, ma non senza esporvi a un qualche ripensamento sull’evoluzione della vostra crescita, sulla maturità acquisita, sul rapporto con gli altri e col mondo che ci sta attorno.'Siete pronti? Allora andiamo a incominciare!':
Tutto ha inizio con un punto, anzi da 'il punto' (((.]]] Certo così incorniciato può sembrare di stare a parlare di un’opera d’arte. Ma è così, forse non avete considerato che ‘lui’ è all’inizio di tutte le cose, il ‘punto’ focale di ogni dimensione: in algebra, in geometria, in architettura, nell’arte più in generale, ma anche nel linguaggio scritto e/o in qualche modo sottinteso, allo stesso modo del linguaggio parlato, di cui 'il punto' sta al centro dell’Universo. Si pensi per un istante a come Michelangelo Buonarroti ha suddiviso in riquadri, vele e rombi la Cappella Sistina, se non fosse partito da un punto 'iniziale' del suo capolavoro (?), c’è da rimanere sbalorditi.
Il pregio di Donini sta nell’aver individuato una ‘formula grafica’ che coglie l’occhio e ci dice che siamo approdati in territorio alieno: analogico, semiotico, ermeneutico, sembolico, filosofico, immaginale. Non c'è niente di più significativo dell’anima cosmica cui il ‘punto’ appartiene, nel suo insieme ordinato che si esplica nel significante, pur restando nei limiti dell’interpretazione linguistica e della scrittura grafica. Un 'significare' le cui coordinate si dipartono '..frementi di virtualità, suscettibili di prendere forma' (*) nell’ordine del linguaggio che compongono, dando luogo a una sequenza e a una dipendenza ritmica: mettere/levare – pieno/vuoto – presenza/assenza: quale oggetto e/o soggetto di un sostantivo che apre a nuove prospettive simboliche, e che rimandano '..come suggeriva la definizione classica, ad una facoltà del conoscere'. (*) Dacché ‘il punto’ prima ancora d’essere un segno grafico ha un potere figurativo da cui nascono le figurazioni costruttive della nostra creatività.
'Quella sera il piccolo poeta cenò prima del solito, si infilò a letto e si addormentò ...'
È qui che l’immaginale creativo riflette della genesi polimorfa dei segni/simboli che appaiono oggi sulla nostra tastiera visiva, fuoriusciti dall’ 'ermeneutica formale' con cui abbiamo riempito il ‘vuoto’ (solo apparente) della nostra 'scatola di latta'. Ma torniamo per un momento al ‘gioco’ iniziale: cioè all’interpretazione del ‘punto’ nell’immanenza del senso, e concepirlo come qualcosa che va oltre il significare di ogni contenuto concreto. Proviamo dunque a leggere la ‘tavola sinottica’ di copertina, incrociandone e traducendone i simboli contenuti, pertanto:
'Quando @ incrocia sulla sua strada asterisco * gli sovviene qualche dubbio …. che fin da subito si trasforma in domanda? V vuoi vedere che dalle parentesi ( ) sono fuggite le doppie virgolette' 'cui fa seguito, in percentuale %, che @ si preoccupa non poco di dove siano andate. V vuoi vedere che certi loro compagni & un poco birichini, veduta la bella giornata di sole hanno boicottato la Scuola per andare a giocare sui prati delle colline di Ics? Ò, che qui sta per ‘ops’, e si vuole che sia proprio così. E mentre di notte c'è un Poeta che s'ispira all'amata luna, di giorno c'è un grillo che canta senza posa. Così, fra una nuvoletta bianca che vaga nel cielo, c'è un certo Vento che arriva a scombinar le fila delle Parole, e volendo, compare un aquilone Д (intravisto di profilo) che zigzagando innalza i loro cuori e rende festosa l’allegra & compagnia'. ©
Potete anche non crederci ma 'Ics' (non X), la bella ‘favola di latta’ di Paolo Donini esiste davvero, ma non cercatela in nessuna cartina geografica, perché non la troverete. Cercatela nella soffitta dei ricordi, allorché sfogliando le pagine, forse solo un poco impolverate, v’accorgerete di non aver mai smesso di scrivere di voi, dei vostri sogni, delle illusioni, delle sconfitte e delle risalite, e che infine converrete con me, che il confronto con le brutte favole di oggi, vale una rilettura critica, per quanto benevola su ‘chi siamo?’ e ‘dove stiamo andando?’ in questo nostro mondo altero.
(*) I corsivi nel testo sono di Paolo Donini.
Paolo Donini, scritore, saggista e critico d'arte e letteraria si occupa di curatela di mostre e di spazi espositivi, è inoltre autore dei disegni presenti nel volume che bene si incastrano con la grafica, il formato, nonché la cura editoriale di questa pubblicaszione. Sue sono tre raccolte di poesia 'Incipitaria' (Genesi Edit. 2005); 'L’ablazione' (La vita felice 2010); 'Mise en abîme' (Anterem Edizioni 2016). È vincitore inoltre del del Premio Lorenzo Montano ‘Opera Edita’ 2011.
'Enne'… le mille + una volte del quotidiano essere.
Un libro di Valentina Durante – Voland 2020
Mio Caro Enne …
ovvero costruzione e decostruzione di un personaggio apparente, necessario nello scrivere in italiano a coprire la carenza grammaticale del tempo neutro in cui si apre la scena di questo libro solleticante (quanto appetibile) le velleità del lettore curioso.
Eh sì, perché Enne è qui utilizzato come fattore scrittorio che potrebbe non esistere nella realtà e che, anzi, non esiste in nessun’altra concretezza attoriale dall’autrice, che lo adopera per dire ‘enne persona’, ‘enne volte’, presente in una ‘enne-sima’ situazione in cui si rende necessario il suo impiego.
Mi avvalgo qui dell'accezione che l'autrice fa nel definire ‘impiego’ l’attività svolta dal personaggio che si va man mano delineando all’interno di una sciarada di situazioni fittizie (a non voler dire superficiali quanto metodiche del quotidiano), che pure prendono corpo nel corso della costruzione oggettiva del libro, frutto di una scrittura creativa verosimilmente istantanea, a voler rimarcare la maniacale intermittenza fotografica (in 'Enne-due'), lì dove l’operato del fotografante e del fotografato si vuole coincidano … 'per avere una restituzione reale di noi stessi'.
È qui (in questo passaggio minimale), che l'autrice coglie in pieno l’annosa e mai risolta prolissità della filosofia odierna, intenta com'è a decifrare i gesti del quotidiano e trasformarli in concetti che esulano dalla sua missione originaria. Ed è ancora qui che ha inizio la costruzione del personagio ‘Enne’ e, al tempo stesso, la sua de-costruzione, in ciò che molto probabilmente serve da supporto al 'narratore'. Ma siamo ancora al congetturale, ben presto si scoprirà che ‘Enne’ è ciò che non vuole essere e/o ciò che l’autrice presume di voler essere (che lei è in segreto), ovvero una 'Oblomov' (*) al femminile.
Chissà che tutto questo non corrisponda poi a quanto affermato dalla stessa Valentina Durante… 'Eppure, per il modo in cui ho scelto di vivere, non avrei potuto desiderare di meglio'. Il che coincide con quanto intercorre tra ‘nominalismo’ e ‘realismo’ nei 'Tipi psicologici' (*) di Jung; e tra ‘finzione’ e ‘realtà’ nella costruzione cosciente de “Il sé viene alla mente' (*) di Damasio, integrati da nuove e più complesse sequenze …
«..quella sull’incidenza delle emozioni e dei sentimenti come ponti connettivi tra il proto-sé e il Sé; quella sul discrimine tra percezione e rappresentazione degli eventi interni ed esterni al nostro corpo come base biologica, unitamente alla memoria, nella costruzione dell’identità individuale.» (Damasio)
Per quanto, il dualismo ‘apollineo-dionisiaco’ non sia mai venuto meno, la scelta di ‘Enne’ riflette, suo malgrado, dell’individualità specifica del quotidiano a cui tutti facciamo ricorso, cioè una fuga dall’essere e da quella 'società liquida' (Bauman) che ci costringe a vivere dipendenti dall’ambiente e dai '..limiti delle nostre strutture cognitive'. Dacché, avverte ancora l’autrice: 'Non sono i nostri comportamenti ad adattarsi alla realtà, non siamo noi a concepire idee compatibili con l’ambiente che ci circonda; è piuttosto la realtà che, per limitatezza del possibile, elimina tutto ciò che non è vitale'.
Un 'Fuggire da sé' (*) impresso «..nella tentazione contemporanea di imprimere un'affermazione permanente per una continua reinvenzione della vita.» Siamo certi che sia così?
Il dubbio si pone nella formulazione di una domanda condivisa, si tratta di '..una sopravvivenza migliore o peggiore' di un qualcosa che affligge il quotidiano, quella dettata dalla '..selezione ‘Enne’ che non agisce mai in senso positivo preservando le idee e i comportamenti più idonei, bensì in negativo' (?); i cui ..comportamenti e le idee che non resistono alla prova di vita, che poi è una prova di verità attraverso l’efficacia, periscono', oppure (?)...
L'altro relativo dubbio viene dal seguente brano (in Enne-tre): 'Ma non c’è sempre qualcosa di torbido, di malevolo, in tutti i nostri comportamenti? […] Ebbene, sono di fronte a una delle scelte più difficili che esistano: quella fra due azioni che rappresentano un rimedio, e per lo stesso motivo un danno'. Per quanto a questa domanda non vi sia risposta che tenga, il dubbio rimane sincretizzato nel Sé apparente del personaggio, nel dualismo reale/irreale della sua essenza: se figlio spurio di una creazione letteraria (a tavolino); oppure rivelazione oggettiva (meditata) di un Sé antropomorfo.
E ancora: se nel ‘tempo storico’ della sua affermazione 'Enne' dia forma al contenuto di un diario tout court, (sebbene l’impostazione voglia farlo sembrare); oppure di un vademecum rivestito di filosofia (?), pur tralasciando ‘la percezione visiva come attività conoscitiva’ (Arnheim), che dal quotidiano vivere si spinge alla ricerca delle ragioni intrinseche del ‘profondo’ derridiano dei 'Luoghi dell’indecidibile' (*), così come dello spazio storico e simbolico della verità ...
«..La verità (intesa) come luogo in cui il soggetto si chiama ad una sovranità e ad una responsabilità irrevocabili e incolmabili; l’indecidibile come ciò che è all’opera nel senso, che fa del dire, della lingua, della scrittura, qualcosa di più ampio di quello che la presenza, l’intenzione o la semplice percezione potrebbero esprimere.» (Derrida)
È quanto affermato con tenacia in questo libro da Valentina Durante che, pur entrando di straforo nel meccanismo contorto della riflessione filosofica, affida all’intuizione del lettore più attento, con un linguaggio scorrevolissimo dall’impatto cordiale, come per uno scambio epistolare, in cui con 'Mio caro Enne…' pure apre a un colloquiare ‘intimistico’ ricco di sottigliezze espressive, di aggettivazioni simboliche, di gesti abitudiniali e consuetudini maniacali che finiscono per procurare la vertigine nel lettore.
Quelle stesse che nella semplice espressione prosaica (non di meno poetica), raggiungono nella narrazione quella piacevolezza in cui il silenzio si sostituisce alla parola '..il modo migliore per capire chi siamo, la maniera per avere una restituzione reale di noi stessi'.
Non per questo 'Enne' può dirsi un libro consolatorio malgrado le sue ‘mille+una’ sfaccettature, quanto poetico-illusorio, allorché il/la protagonista (in ‘Enne-tre’) rivolgendo lo sguardo dal finestrino del treno immerso nel buio: '..avvolgerà i campi, le case, le fabbriche, le chiome degli alberi, le automobili e le persone, nascoderà tutto, interrotto solo da punti luminosi: arancioni e bianchi, verdi e rossi, le finestre delle case, l’illuminazione delle aree industriali, qualche semaforo'.
Un buio lucido che nell’essere rivelazione lessicale del gesto (il guardare avvolgente), s’apre in pensosa assenza nel secretum della coscienza individuale, illuminando quei comportamenti di natura morale che, diversamente, porterebbero alla verità dell‘indecidibile’ derridiano, di quella «..verità come luogo in cui il soggetto si chiama ad una sovranità e ad una responsabilità irrevocabili e incolmabili; l'indecidibile come ciò che è all'opera nel senso, che fa del dire, della lingua, della scrittura qualcosa di più ampio di quello che la presenza, l'intenzione o la semplice percezione potrebbero esprimere.»
È così che 'Enne' pur essendo tendenzialmente un/una ‘oblomovista’ si riscatta da un atteggiamento ozioso e sterile, vivendo per così dire, o se vogliamo, sopravvivendo, affetto da patologia filosofico-letteraria propria dell’inguaribile idealista, senza paure e senza aspettative, nella pienezza della libertà acquisita, o forse solo ritrovata (?), pur nella consapevolezza che non esiste un mondo migliore. Ma il gioco verbale continua, riprende da dove è iniziata la sua costruzione, avvenendo subito dopo (in Enne-quattro) alla sua de-costruzione.
Cambia la scena, il buio rimane, il lucido iniziale si screzia di pioggia, la visibilità nell’abitacolo dell’auto scema: 'Noi crediamo di vedere, […] noi soprattutto sentiamo'. Per quanto sentire è la forma primaria dell’immaginale individuale e collettivo, concepimento del fantasticare dei sentimenti, del desiderio talvolta recluso che si porta in superficie malgrado una qualche volontà contraria lo sospinga sul fondo; e che, più spesso, porta allo sdoppiamento della personalità, in cui il Sé ricompone il proprio dualismo originario 'l‘io e l’altro', le due faccie della stessa medaglia, e finisce per incorporare in sé 'Il dottor Jekyll e Mr. Hyde' (*), nel suo sostenere che l’essere umano è diviso a metà tra il bene e il male.
'Enne', in quanto personaggio, non sta nei panni dell’uno né dell’altro '..l’unica conoscenza possibile è quella simbolica, che procede per somiglianze e immagini'. – Questo l’autrice lo sa bene, che - 'Non esistono realmente cause o effetti, come non esistono cose che possiedano proprietà intrinseche. Possiamo però considerare i fenomeni (che le regolano) ‘come se’ producessero effetti, e le cose ‘come se’ avessero proprietà, in modo identico, cioè, alla loro rappresentazione'.
Ma quella che forse è solo l'istanza dettata da una inderogabile necessità, fa di 'Enne' l’equivalente di un sognatore/trice ad occhi aperti: '..la confortevole illusione di un mondo provvisto di senso' che nella realtà non esiste: 'Lo so benissimo – scrive Valentina Durante e possiamo dedurre che sia vero – che quel viaggio in treno (e qualunque viaggio sia di seguito narrato) per come l’ho immaginato, non è avvenuto e non avverrà mai. Eppure la mia supposizione – il 'come se' – resta formalmente valida. Considerala, se più ti piace (Caro Enne lettore), un punto di vista soggettivo dal quale leggere i comportamenti umani'.
Dacché, come commentatore, trovo il mio punto d’arresto, tutto quanto potrei aggiungere in seguito sarebbe comunque basato sul susseguirsi di una supposizione dietro l’altra, di eventi intrappolati nel 'tempo ipotetico' della narrazione. Nel prosieguo l’autrice mi ha preso per mano conducendomi 'ab aeterno ad infinitum' dove ha voluto, formulando domande su domande sulle quali tante volte anch'io mi ero soffermato, tuttavia senza trovare risposte adeguate. Ma non potevo trovarle, perché ero cieco, non vedevo più in là della mia immagine. Infatti scrive ancora l'autrice...
'Solo ora mi accorgo che sono gli occhi. Sì la differenza rispetto a tutti gli altri autoscatti archiviati nel mio computer, nessuno eccettuato, sta certamente negli occhi, (chiusi nel silenzio della sua scatola), e quando ...
Mi avvicino allo schermo.
La sua luce azzurrata mi sfarfalla in faccia.
Mi avvicino ancora.
Poi ancora.
E finalmente lo vedo nei miei occhi, stasera, c’era uno sguardo bellissimo'.
È il mio. ‘Enne’?
Quindi dove sono le risposte? Si chiederà perso il lettore attento. Sono contenute nelle pagine del libro che Valentina Durante ha scritto per il piacere di tutti. Sì, per quei molti lettori che increduli, forse, in fine, usciranno convinti che le risposte erano già verosimilmente in noi.
L’autrice Valentina Durante, è copywriter e consulente di comunicazione freelance, ha lavorato come ricercatrice di tendenze coordinando per la Camera di Commercio di Treviso un gruppo di stilisti, designer, artisti, progettisti e fotografi. Il suo primo romanzo “La proibizione” è uscito nel 2019 per l’editore Laurana. Suoi racconti sono stati pubblicati su varie riviste letterarie e non, tra cui 'Leggendaria', 'Altri Animali' e nella raccolta 'Polittico'. Dal 2019 collabora con la Bottega di narrazione di Giulio Mozzi. 'Enne' è pubblicato da Voland 2020.
Buona lettura e buon ascolto a tutti voi con l’augurio di un più sereno 2021.
*
 - Musica
- Musica
New World-Jazz-Music con Mauro Sigura Quartet
Con Mauro Sigura (oud, bouzouki), Gianfranco Fedele (piano, dronin, elettronica), Alessandro Cau (batteria, percussioni), Tancredi Emmi (contrabasso, basso elettrico), featuring Luca Aquino (tromba.
Che il Jazz sia il compendio estremo del suono, capace di una perfetta esternazione focale dell’intima passione degli strumentisti per la musica (di tutta la musica), è di per sé assodato, in quanto non solo contiene l’insieme dei suoni ma li ricrea, liberandoli così dalla cornice del tempo che li vuole etichettati in questo o quel genere, trascurando a volte, tutto quanto è all’origine stessa del suono che produce, la capacità umana di catturarne l’energia creativa e trasferirla in immagini oniriche. È quanto si concretizza in questo secondo album discografico dell’ensamble Mauro Sigura Quartet dal titolo programmatico “TerraVetro”, d’ispirazione World-Jazz strumentale che dalle sponde del Mediterraneo s’inoltra nel cuore dei Balkani, alla ricerca ‘empatica’ della migrazione dei suoni, trasferendo l’idea iniziale del 'viaggio attraverso', nella metafora dell’ 'incontro con', dell’abbraccio virtuale con i popoli e le culture che incontra, per una performance energica e vitale…
Nascono così le atmosfere di ‘Mistral’ dedicato al vento di Nord Ovest (Maestrale), che spazza via l’atmosfera statica, le nuvole sospese sopra il pianoro e porta il nuovo, aprendo a spazi di creatività inusitati; di ‘Carthago’, quale omaggio rivolto alla città mitica che affaccia sul Mediterraneo e al suo intimo legame con la terra in cui viviamo, quella Sardegna che tutti (compreso chi scrive) portiamo nel cuore. Così come ‘I muri di Ceuta’ (enclave europea in Africa), un brano afferente ai muri realistici come appunto è quello di Ceuta e i muri mentali e culturali che andiamo costruendo a difesa di noi stessi. E quel ‘Requiem per il Calderone’ dedicato alla memoria del ghiacciaio più a Sud d’Europa “..a cui l'inserimento della ‘tromba’, risuonando nell’immenso spazio lasciato vuoto dal nevaio ormai disciolto, richiama alla memoria ancestrale l'esistenza di un Eden perduto”. (*)
È dunque nella risonanza degli strumenti che più si evidenzia la ‘magica’ essenza della musica che si sprigiona dagli otto brani contenuti ‘in-vivo’, in cui il Quartet entra in sintonia con l’ascoltatore, e non solo quello dei fan del jazz tout cour, quanto, per essere più pertinenti, quello del popolo della World-Jazz-Music. Una precisazione necessaria per meglio cogliere l’insieme del loro ‘sound’, la cui alchimia raggiunge il suo ‘focus’ nella teoria speculativa-filosofica messa in atto dall' ‘amore’ di ognuno per la musica, la professionalità e l’impegno che più evidenzia lo scopo del loro ‘viaggio’ musicale e, non in ultimo, la compiutezza raggiunta della loro creatività artistica, com’è rivelata nei brani riflessivi sui diversi temi.
Quale, ad esempio, ‘Listen, Noodle’ scritto da Gianfranco Fedele, d'impostazione ‘poetica’ sul mistero dell'amore, fatto della stessa sostanza della vita meravigliosa e inafferrabile quanto autoreferenziale, non codificabile tramite i mezzi della logica razionale. E ‘Ad un solo passo’ con il quale il Quartet immagina le tante emozioni che si provano quando da una nave, di notte, s'intravedono le luci del vicino approdo, metafora dell'andare verso una nuova vita, che è sì la salvezza ma anche l'incertezza dello stato d’animo di chi si trova ad essere vicino alla realizzazione di un sogno o, comunque, vicino a un cambiamento importante, quel “l’attimo prima” di coglierne il senso ...
Un 'viaggio' che inevitabilmente prende avvio dalla Terra, poteva essere diversamente? E che, quindi, si avvale dell’allegoria della solidità della materia, della forza traslata nelle sonorità precipue della natura e nei 'ritmi' felicemente ricreati da Alessandro Cau (percussioni). Per poi spingersi a ricercare la fragilità del Vetro nei timbri liquidi del ‘piano’ di Gianfranco Fedele, fino a cimentarsi nel costante dueling sostenuto dal ‘contrabbasso’ di Tancredi Emmi che fa da collante dell’intero ensamble, e che le note melodiche del ‘liuto’ (al-oud, trasposizione araba dal persiano antico), di Mauro Sigura, congiunge: “..portando a consuonare tutto ciò che è capace di vibrare, o almeno di far oscillare ciò che è suscettibile di vibrare”. (*) Dacché, in fine, gli ’inserimenti' della tromba di Luca Aquino, aggiungono di misura un tocco di contemporaneità alle sonorità d’insieme dei brani, altrimenti esposti a una catalogazione dal gusto retrò, quasi “..una sorta di melancolia assopita delle note” (*), tra l’altro bella e suggestiva, cui il tono aulico dell’oud, magistralmente suonato da Mauro Sigura, inevitabilmente porta con sé dai secoli passati.
La ‘magica’ sonorità del oud ben si rivela nel brano d’apertura ‘Desir’, liberamente ispirato a "Le città invisibili" di Italo Calvino, in particolare al capitolo "Le città e il desiderio", da cui il titolo: “Ho immaginato il desiderio come un qualcosa in costante divenire che non e' mai allineato perfettamente con la realtà” - scrive Mauro Sigura nelle note di presentazione all'ambum...
Del resto la storia di questo strumento si presta per un confronto di almeno due diverse espressioni culturali in cui Oriente e Occidente, seppure con le diversità che ne conseguono, in fine s'incontrano sul piano del linguaggio universale della musica tutta. Infatti, non è un caso se lungo la traiettoria del ‘viaggio’ intrapreso dal Quartet, avveniamo sorprendentemente alla metafora del tanto auspicato ‘incontro’ che si spinge dalla Sardegna a Cartagine, dalla Grecia alla Turchia, dai Balkani alla Romania, non come recupero o contaminazione, quanto, se vogliamo, come ‘retrogusto’ di sapori autentici, la rielaborazione di un profumo conosciuto da sempre, fosse anche quello del “pane tagliato e condiviso”.
Una metafora, forse, di quel incanto/disincanto in cui la musica si conduce e che ogni volta che l’ascoltiamo impone il suo effetto trascinante da uno stato di incredulità o di smarrimento, a quello della 'gioia di vivere' al cospetto di una verità più grande, suggestiva quanto indefinibile. Come è detto “in principio erat verbum” (*), lo stesso che tuttavia a noi moderni ancora sfugge: il cielo della World-Jazz-Music come modello culturale del mondo in cui viviamo. Un mondo alquanto instabile, in cui la 'solidità’ della Terra sotto i piedi, offre l'opportunità per restare, mentre lo spirito d'avventura e/o di cambiamento suggerisce di voler andare. Una crinatura che lascia spazio alla fragilità del Vetro di cui s'avvale la nostra più intima 'realtà’, assai diversa dalla 'realtà' di chi attraversa il mare in cerca di un porto cui attraccare i propri sogni, nell'incertezza di una ragione per cui valga la pena di partire, di lasciare tutto per ‘migrare’ altrove.
Ma ogni sogno, come ogni viaggio, presenta anche un lato fragile, incerto, contro cui spesso naufragano le speranze. È questo il tema alla base di ‘The Secret Conflict Of Pireo’ dedicato agli esuli greco-turchi che dopo la guerra tra Grecia e Turchia (1919-1922), a seguito dello scambio di popolazioni furono trasferite nei campi profughi e proibito loro di suonare le musiche delle loro tradizioni e quindi: "Dedicato ai musicisti di quelle comunità che pure hanno continuato a suonare clandestinamente le loro musiche, le antiche ‘arie’ del Pireo, ai quali tutti noi abbiamo voluto fare un sentito omaggio sonoro" (*). A seguire ‘Dromo’ (corrispettivo nella musica greca del makam arabo-ottomano) in cui è utilizzato uno strumento a corda suonato con l’archetto, l'assai raro ‘dronin’, nella virtuosa esecuzione di Gianfranco Fedele, con il quale si è voluta ricreare l’atmosfera "instabile e disordinata, inquieta quanto riflessiva", in cui versa il migrante, così come il profugo e l'esule da ogni dove, qui ripresa come tema di fondo di una realtà sociale che si ripropone costante all'attenzione dolente dell'umanità intera.
Un ascolto emozionale dunque, quello qui proposto dai componenti il Mauro Sigura Quartet che non mancherà di sorprendervi. Non resta che augurarvi Buon 'viaggio' nel mondo globale della World-Jazz-Music.
Mauro Sigura Quartet ha già prodotto un primo disco “The color identity” (S’ARDMUSIC-EGEA) presentato in-concerto nei diversi paesi dove si sono esibiti: Italia, Tunisia, Norvegia, Giappone, Germania, Serbia, Romania ecc.., ben accolto dagli estimatori e dal pubblico di diversa estrazione culturale dedito all’ascolto della musica, e se vogliamo, ‘di tutta la musica’ estemporanea che va sotto l’egida della World-Jazz-Music.
Note:
(*) Le note a capo dei brani di “TERRAVETRO”, S’ARDMUSIC-EGEA 2020, sono di Mauro Sigura.
(*) Marius Schneider, “Il significato della musica”, Rusconi 1970.
(*) Giorgio Mancinelli, “Musica Zingara. Testimonianze etniche della cultura europea”, MEF - Firenze Atheneum 2006.
(*) Profeta Ezechiele, Bibbia di Liegi.
Contatti:
Personal e-mail: thecolouridentity@gmail.com
https://www.maurosigura.it/contatti-2/
*
 - Scienza
- Scienza
Coscienza Quantica - il nuovo libro di Alberto Lori
COSCIENZA QUANTICA
Un percorso quantistico di sviluppo evolutivo.
Alberto Lori ci offre un grande dono: ci fa comprendere la bellezza della Scienza e della Coscienza unite.
Non possono esserci due cose separate: la scienza da una parte e la coscienza dall’altra.
“Tutto è uno”, ci ricorda Alberto, attraverso le dimostrazioni matematiche della fisica contemporanea e la saggezza dell’antica spiritualità che affronta questi temi con il coraggio, la determinazione e la lungimiranza di un altro grandissimo genio: Carl Gustav Jung.
C.G.Jung aveva compreso molto bene la fisica dei quanti, anche grazie alla sua amicizia con Wolfgang Pauli, premio Nobel nel 1945 per la meccanica quantistica.
Indice
Prefazione a cura di Giovanni Vota.
Capitolo 1 - Tutto cominciò per una lampadina: il nuovo paradigma della fisica
• Il contributo di Planck e Kirchhoff
• L’ausilio degli oscillatori
• Boltzmann, De Broglie, Feynmann e Bohr
• La scuola di Copenaghen
• L’importanza dell’osservatore
Capitolo 2 - Viviamo di paradossi: l’indeterminismo degli esperimenti “su campo”
• Il curioso gatto di Schrödinger
• Wheeler e la doppia fenditura
• Località e non località, “questo il problema”
• “L’assist” dei testi sacri
• Il potere che ti appartiene
• L’apporto di Giuseppe Genovesi, istoni e DNA
• Intenzione come Causa mundi
Capitolo 3 - In rotta di collisione o nella direzione di un auspicabile sincretismo?
• Visioni opposte o complementari?
• Computer cerebrale
• Il dilemma sulla coscienza e il cervello olografico
• Penrose, Hameroff e Haramein
Capitolo 4 - La Coscienza non locale
• Coscienza: a che punto siamo? Un po’ di dietrologia
• L’uovo, la gallina e il primato della nascita
• Amit Goswami e la fisica delle possibilità
• La connessione biunivoca tra cuore e cervello
• Huygens e gli orologi a pendolo
• Conclusioni
Capitolo 5 - La struttura del Vuoto
• Vacuum, non solo un latinismo
• I capricci dell’elettrone
• Meccanica quantistica versus Relatività generale
• Olofrattalità dell’universo
• Geometria sacra, sezione aurea e PHI
• Dalla sfera al toroide
Postfazione a cura di Carmen Di Muro
Alberto Lori
speaker del giornale radio RAI, poi conduttore del Tg2 RAI; in seguito redattore del telegiornale Contatto di Maurizio Costanzo alla PIN della Rizzoli; collaboratore de’ Il Giornale dei Misteri di Giulio Brunner e di Mondo Archeologico di Mirella Rostaing Casini; ha diretto Immagine Italia, rivista trimestrale di carattere turistico; il settimanale ASI, Agenzia Sanitaria Italiana; Quasar, il primo mensile italiano di scienza alternativa.
Coordinatore di Dimensione Uomo, gruppo d’informazione, divulgazione e ricerca scientifica, è giornalista freelance e voce di documentari e rubriche TV di successo come: Mixer, Ultimo Minuto, SuperQuark, Sfide, La Storia siamo noi.
È stato autore e conduttore dei programmi su RadioRadio Sempre di domenica e Attenti al lupo. Diplomato Practitioner e Master advanced in PNL all’ISI-CNV di Marco Paret e in Sviluppo delle Risorse Umane all’HRD Academy di Roberto Re, si è specializzato in PNL seguendo i corsi di Anthony Robbins, di Richard Bandler, e in psicologia quantistica con lo psicologo Ilio Torre. È stato docente di dizione e pronuncia italiana nell’ambito del Corso di Giornalismo della Luiss. Ha curato la comunicazione dei dirigenti, comandanti e istruttori del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei giornalisti dell’Ansa, dei piloti Alitalia.
È autore di numerose pubblicazioni di psicoquantistica e comunicazione.
*
 - Filosofia/Scienza
- Filosofia/Scienza
Stanislas Breton ’Simbolo, schema, immaginazione’
STANISLAS BRETON
“SIMBOLO, SCHEMA, IMMAGINAZIONE” - Saggio sull’opera di Rubina Giorgi.
Edizioni Ripostes 2020.
Introduzione di Carlo Di Legge
Traduzione dal francese di Salvatore Violante.
Dall’Introduzione.
«Le scarpe consumate di Van Gogh, che Heidegger commenta, rievocano la comunione dell’uomo con la natura, la sua fatica e il suo riposo, la sua aspettativa dalla terra e dal cielo, la sua speranza nella visita degli dèi.»
S. Breton
Inseguire un schema speculativo nel campo della filologia linguistica che fin dai primi enunciamenti potrebbe risultare infruttuoso, è di per sé cosa ardua da affrontare, soprattutto se a proporlo è uno stimato filosofo francese di tendenza teologico-cristiana qual è Stanislas Breton, che l’ha dedicato alla ‘riflessione sul simbolo’ della poetessa e scrittrice Rubina Giorgi, alla quale, come enunciato nel titolo, ha rivolto questo suo saggio.
Con ciò, per quanto qui ci si avvalga dell’accurata traduzione dal francese di Salvatore Violante poeta e critico letterario e, della saggia introduzione di Carlo Di Legge che ne specifica, passo-passo, i diversi capitoli proposti, fin da subito si giunge a confrontarci col pensiero analitico afferente alla ‘psicologia del profondo’ evoluta di C. G. Jung, una delle principali figure intellettuali del pensiero psicologico e psicoanalitico, tutt’ora oggetto di apprendimento.
Una proposta di lettura e/o di rilettura questa che, stando almeno nelle intenzioni dell’autore, guarda all’insieme del pensiero in ambito linguistico a lui contemporaneo. Breton, infatti, rivolge una speciale considerazione alla simbologia di Rubina Giorgi, la nostra conterranea che ha svolto un’importante excursus, quanto più addentro all’ ‘ontologia formale’, attraverso l’aspetto delle forme e ai significati intellegibili, rivolto, soprattutto, alla funzione che il ‘simbolo’ riveste nel nostro mondo odierno:
Scrive Breton: «Simbolo è ciò che, senza concetto, al di là o al di qua del concetto, fa dunque comunicare gli uomini tra loro e le cose tra loro. […] Molti indizi, oggi ci persuadono della necessità di tralasciare sia l’ontologia tradizionale sia la semiotica generale che l’ha rimpiazzata. Tra le opere che testimoniano questa insoddisfazione e che delineano, in modo fermo, lo schema di questo superamento, ce n’è una che abbiamo scelto perché ci sembra essere il punto d’incontro di diverse tendenze e di molteplici discipline: […] cioè la scienza filosofica dell’essere, afferente alla “metafisica platonico-aristotelica”.» […] Da cui l’affermazione: «La fine della metafisica, potrebbe essere l’inizio della simbologia.»
Ne consegue l’individuazione, nell’ambito della ‘speculazione filosofica’, di uno ‘schema’ necessario nello studio della ricognizione scientifica, antecedente alla formulazione dell’ ‘ontologia formale’. Un metodo di apprendimento rivolto alla comprensione del ‘sistema significante’ che, come è anche detto nell’introduzione, rivolge la sua utilità allo studioso/lettore, nell’addentrarsi, seppure con non poca difficoltà, nella ‘materia significante’ ed accettarne i concetti e/o a condividerne le tesi:
«Si può, in diverse guise, seguirne l’evoluzione nella storia del pensiero, ma occorre premettere che un’aura di non detto e non pensato sempre accompagna ciò che del simbolo si esprime. […] Si può immaginare il simbolo come un oggetto spezzato in due frammenti, tra cui dunque s’apre un intervallo, uno spazio attraversato, percorso da una tensione ordinatrice, con sue leggi o quasi-leggi; esso viene rappresentato come “operatore di interposizione” che quindi, in quanto tale, “presuppone polarità e, tra gli estremi, un intervallo”. […] Si accetterà a rigore che tale disciplina era una “ontologia vuota”, o ancora una “logica dell’essere equivoco come oggetto d’interpretazione”. Ma dobbiamo subito aggiungere che tale essere equivoco deve la sua equivocità al fatto che il simbolo si muove nella qualità dei poli, nell’intervallo e nella condizione mediana del termine medio».(Breton)
Nella specifica del ‘simbolo’ che Breton rende in modo quantomeno suggestivo oltre che rigoroso, si hanno in breve: due poli entrambi ricettivi, divisi da un intervallo vuoto e/o nullo (nihil) reso fruibile nell’immaginale (vedi Cobin, Hillman e altri). In primis va qui chiarito che il sussistere dell’ “approccio immaginale” nei confronti del ‘simbolo’, non esula da ciò che è fondativo nel “pensiero immaginale” riferito al ‘simbolico’. In breve, lì dove Breton cita Rubina Giorgi: «..il simbolico, come funzione di negazione e di distanza, non è vuoto perché è auto-riflettente, ma è auto-riflettente perché è vuoto. Il movimento dell’autoriflessione conferma questo vuoto.»
«Se autoriflessiva è la soggettività, e il vuoto è autoriflessivo, allora il vuoto sarà l’indizio della soggettività, del soggetto, sebbene non si tratti di soggetto – e del suo correlativo, l’oggetto – come si è abituati a pensarli […] secondo il concetto avanzato dalla fenomenologia husserliana la cui evidenza appare oggi problematica.[…] Per ristabilire l’equilibrio tra il causale ed il semantico, è necessario che lo schema elevi alla dignità di nuovi significati delle accezioni preliminari e convenzionali, che non sono del resto da concepire mai come cause propriamente dette, e le inserisca in una totalità originale dove esse prendano una valenza nuova.»
Soprattutto quando questa è applicata all’intenzionalità dell’arte cui l’impersonalità dell’artista diventa abnegazione del soggetto nei confronti dell’oggetto. Un’esigenza speculativa messa al servizio della creatività, per cui – come scrive Carlo Di Legge: «l’abnegazione del me provoca (spesso) le rappresentazioni più raffinate dei molteplici recessi della soggettività.» Ed è ancora Breton che citando Rubina Giorgi nel suo ruolo di poetessa, ci avverte che «..una certa letteratura contemporanea potrebbe illustrare questa nota. Al momento in cui l’autore sembra scomparire nella tela anonima che si tesse tutta da sé, immaginiamo dietro le quinte il demiurgo che non è da nessuna parte perché è ovunque presente. Difficile sfuggire alla sua ombra.»
Onde per cui – aggiunge Breton – «L’opera d’arte dialoga, combina, assume e subordina quello che riceve inserendolo in una atmosfera misteriosa che gli assegna un senso di trascendenza. Lo schema come funzione d’intermediario, si precisa così: operazione schematizzante che seleziona e ritaglia su un preliminare gli elementi che esso ordina in una figura inedita; valore, nel senso linguistico del termine, che istituisce nel gioco dell’arbitrario, ma di un arbitrario regolato e regolatore, un sistema di differenze e di relazioni; simbolo, che non-realizza il reale radicandolo in un immaginario, di cui produce le forme ma per riaccompagnarle subito alla loro sorgente e per conferire loro, attraverso questa riduzione, una mobilità di pura fantasia.»
Ma il passo poetico non si ferma qui, infatti Breton aggiunge che «..l’oggetto e il soggetto non sono fissati una volta per tutte. Bisogna assimilarli non a degli elementi invariabili ma a delle polarità reversibili. […] Nel suo movimento, il simbolo è soggettività in modo che specularmente (moto proprio del riflessivo), rimanda di continuo il soggetto all’oggetto e viceversa.» In ciò non v’è nulla di misterioso quanto invece c’è di speculare, in ogni singola istanza c’è sempre all’origine un’intenzionalità ricettivo-creativa propria dell’essere pensante (animale, vegetale, umano), afferente a una sorta di ‘energia’:
Energia «..di un singolare tipo che, non appena sembra acquietarsi in una forma, subito muove alla ricerca d’essere altro, per “un processo indefinito di proliferazione”. […] Questa proliferazione indefinita non è un accidente dovuto a una patologia dell’immaginazione. Non funziona come un cattivo infinito ma come una necessità essenziale. Ciò che Brouwer diceva del continuo numerico vale qui a fortiori: il simbolo si muove in un contesto di libero divenire […] per il suo potere sempre nuovo di auto-trascendenza.[…] Questa alterità fa parte della sua natura di ‘funzione simbolica’ nella quale si esplicita e s’interpreta.» (Breton)
Difatti il ‘simbolo’ re-interpretato secondo Breton sulla scia delle avances di Rubina Giorgi equivale a un principio d’identificazione, l’affermazione stessa dell’individualità dell’essere antropico: «Ed anche questa energia è sospesa ad un irraggiamento originario che, aldilà dell’essere e della forma, si presenta come pura indeterminazione “per eccesso” di cui le figure sensibili e le forme intellegibili, come pure lo stesso movimento formativo, spiegano, in una lingua cosmica, l’inesauribile generosità.»
Pertanto siamo messi di fronte a un problema logistico che si vorrebbe risolvere, ma di certo: «Non (con) la logica formale classica dunque, ma (con) una logica che, tuttavia, consente di districarci, orientandoci nella selva delle somiglianze, e che paradossalmente presiede alla comunicazione e all’interpretazione, se interpretazione è sempre legata alla comunicazione: quello simbolico è, per quanto non possieda chiarezza né evidenza, il luogo che offre certezze, pur nella variabile molteplicità delle forme»: (Carlo Di Legge)
«Il suo carattere polimorfo non gli impedisce (al simbolo) di assicurare la comunicazione tra gli uomini; non più del resto di quanto la sua ambiguità non lo condanni all’incomprensibile. Ad ogni modo questa comprensibilità si accontenta benissimo dell’equivoco e della pluralità dei sensi.» Pertanto giungiamo ad un’altra affermazione: «L’essere è la forma, attiva o passiva, che sfida ogni nostro gioco linguistico.» (Breton)
Come è anche detto nell’Introduzione, che «lo si riconosca o meno, questa è propriamente la nostra vita. […] Ci parla del nostro universo, dicendo che in esso ogni ente è in simpatia con ogni altro; ma non è questa, la dimensione della logica scientifica: non stupisce chegli scienziati non la ammettano, se non i più illuminati.» (Carlo Di Legge)
Tuttavia l’equivoco menzionato è, secondo me, la conseguenza della ‘pluralità dei sensi’ che qui si vuole mistificare dentro il contesto simbolico univoco della ‘forma/immagine’ come punto di arrivo inconfondibile, contravvenendo alla tesi junghiana della sincronicità degli eventi che rendono la doppia polarità del segno inter-connettiva, dinamica stessa del linguaggio comunicativo di ‘reversibilità assoluta’, per cui vale la formula:
«Ciò che non ha forma prende forma, ma ciò che ha preso forma, a sua volta, può cambiarla.» (Breton)
Volendo a questo punto rientrare nello schema formulato inizialmente, dei: “due poli entrambi ricettivi, divisi da un intervallo vuoto e/o nullo (nihil) reso fruibile nell’immaginale”, approdiamo con più facilità a individuare i rapporti che intercorrono tra ‘simbolo, schema, immaginazione’ definiti nel titolo del libro:
«Oggi si sarebbe tentati di riservare lo studio a questo insieme di discipline abbastanza privo di rigore che si chiama “semiotica”, perché si occupa di segni, di qualsiasi natura essi siano, sia pure privilegiando lingua e linguaggio e con il primato e la guida della linguistica, che induce talvolta a subordinare l’antico ‘semeion’, nella plasticità delle sue accezioni, alla chiarezza e alla distinzione della parola scritta o parlata.»
Tuttavia ciò non basta a seguire uno ‘schema’ di per sé farraginoso che induce alla antinomia delle trattazioni, allorché si avvale della speculazione filosofica per affermare alcuni principi solo apparentemente indissolubili che, per contrasto, trovano in altre discipline (e altri autori: Heidegger, Levinas, Lacan, Frigo ecc.) la resilienza di una specificità indelebile. Inoltre ai già citati Jung, Corbin e Hillman si prenda, ad esempio, l’epistemologo del pensiero ‘postmetafisico’ Jacques Derrida tra le cui opere figurano almeno due testi importanti anche per questa trattazione:
“Margini della filosofia” (1997) in cui l’autore si concentra sul problema dei limiti della speculazione filosofica, problema da sempre "interno" alla filosofia, che si è costantemente interrogata sulla sua portata e ragion d'essere. E l’altro, “Pensare al non vedere - Scritti sulle arti del visibile” (2016) in cui tratta delle arti come problematicità: “che si rifrange ogni volta in una molteplicità lontanissima dall'essere omogenea. Per quanto ciò che concerne il visibile, infatti, si tratta sempre, anche se in modalità differenti nelle arti e rispetto alla scrittura, della traccia, del tratto, di spettri, e dunque di un "vedere senza vedere niente".
Per quanto, ciò che apprendiamo dal saggio di Stanislas Breton sull’opera di Rubina Giorgi assume valenza nella specifica dei sottocapitoli trattati: I: Simbolo, schema, immaginazione / II: Simbolo e Mediazione / III: Il problema dell’intervallo / IV: Immaginazione e Schema / V: Simbolo e Realtà. Nonché al rinvio a motivi di teologia a cui la riflessione simbologica si è ispirata. «Riferendosi a espressioni di Rubina Giorgi, Breton può evocare la parola ‘spirito’ in toni di “esistenzialismo religioso”» (C. Di Legge), forse più inerenti alla materia dogmatica per mezzo degli ‘schemi’ offerti alla speculazione intellettiva:
«Questa legge d’atmosfera che cinge di un’aureola il simbolo o piuttosto della qualesi cinge esso stesso, sarebbe come l’indicativo di trascendenza. Questa chiamata segreta a un “altrove” che ci lascia disorientati, questa continua trasgressione che ci impone un ascetismo dell’abbandono, non sarebbe , in ultima analisi, l’impronta del simbolico sull’essenza stessa dello spirito, se vogliamo ben ravvisare, sotto questo termine logoro, il respiro e la fiamma, di cui non si sa né da dove viene né dove va, ma che ci porta e ci condanna a non essere nessuna parte in tutti i luoghi che attraversiamo?»
La domanda, così concepita, richiede una certa dose di riflessione prima di trovare una risposta adeguata, sempre che la si trovi. Nel tempo molti sono stati i pensatori di tutte le discipline che si sono spesi nella ricerca, e i più addentro hanno trovato una o più ragioni ‘speculative’ per arrivarci e che, nel loro mettere insieme formule filosofiche e alchimie linguistiche, infine ci hanno offerto motivo di credere in quel ‘mondo estremo’ e forse ‘unico nella sua unicità’, comprensiva della temporalità originaria di natura simbolica che ci troviamo ad affrontare, di un’era evolutiva che ci vede protagonisti inconsci di una mitica realtà che forse non ci appartiene:
«Ma è chiaro che il dilatarsi e l’esplicitarsi, messo in opera dallo schema e dall’immagine (rappresentati nel testo), suggeriscono una linea di sviluppo all’infinito che non copre tuttavia la perfetta omogeneità del tempo postulato. Il tempo dell’immaginario, come quello della storia che lo nutre, è al tempo stesso racconto che spiega e memoria che raccoglie. Tempo ciclico e tempo lineare si fissano quindi in un tempo più profondo, […] che la densità dell’essere, la pienezza che si insinua, in certi momenti che miracolosamente sospendono l’uniformità della successione che affiora nell’Opera, quando essa è veramente Opera […] che restituisce all’uomo , contro la minaccia di dispersione e l’inerzia della natura, la poesia di un’espressione autentica» …
“..il punto di condensazione di una realtà possibile”.»
L’autore.
Stanislas Breton (Gradignan 1912-2005) fu teologo e filosofo francese. Entrato nell’ordine dei Passionisti, dopo l’insegnamento all’Università Pontificia di Roma negli anni Cinquanta, divenne professore di Filosofia all’Università di Lione e poi all’Università Cattolica di Parigi. Nel 1970 fu Maestro Conferenziere alla Ecolo Normale Supérieure: nominato da Louis Althusser, il primo filosofo cattolico a ottenere l’incarico. Stimato studioso del pensiero occidentale , con particolare riferimento ai testi della filosofia antica, e del pensiero contemporaneo attraverso l’esame dei testi e delle correnti più significative.
Suoi testi in italiano: inoltrre a quello qui presentato, figura “Filosofia e Mistica – Esistenza e Super-esistenza” – Libreria Editrice Vaticana 2001.
*
 - Musica
- Musica
Vietri sul Mare e in Scena
Mercoledì 8 luglio, alle ore 11,00 presso la Sala giunta di Vietri sul Mare si è tenuta la presentazione della quinta edizione di "Vietri in scena", la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel Comune costiero, alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, dell'assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo e del direttore artistico della manifestazione, il maestro Luigi Avallone.
"Vietri in Scena segna l'inizio del ritorno della nostra bella cittadina alla vita culturale ed artistica nel senso più alto del suo significato. Inauguriamo l'estate vietrese nella Villa comunale per regalare ai nostri concittadini e a tutti gli ospiti che vorranno trascorrere delle serate all'insegna della buona musica, sei concerti gratuiti che ci daranno la gioia di riprendere la vita sociale e culturale dopo mesi di isolamento. E' un traguardo importante per la nostra comunità, soprattutto se si tiene conto del fatto che solo un mese fa sembrava impossibile programmare eventi sul territorio. Alla fine, fortunatamente, grazie anche all’esperienza del sindaco Giovanni De Simone e alla professionalità del maestro Luigi Avallone, siamo riusciti a mettere su una rassegna estiva di grande qualità, che certamente incontrerà il favore dei vietresi e di tutti i turisti che ci faranno l’onore di venire a Vietri sul Mare a trascorrere le proprie vacanze".
Il maestro Avallone ha annunciato che "In qualità di direttore artistico della manifestazione mi sento in dovere di dedicare questa edizione di Vietri in Scena alla memoria del grande Ennio Morricone, un genio della musica che è appena scomparso e che merita un segno di riconoscenza per le musiche che ci ha regalato: spero di inserire in queste serate almeno un brano a lui dedicato". La manifestazione a carattere musicale è stata realizzata in compartecipazione con il Conservatorio di musica di Salerno "Giuseppe Martucci". Sei gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, che si terranno nella bellissima e panoramica Villa comunale di Vietri sul Mare, nel pieno rispetto delle misure anti covid-19 prescritte. I posti disponibili per consentire le distanze di sicurezza sono 130. La manifestazione "Vietri in scena", condotta come ogni anno da Nunzia Schiavone, inizierà venerdì 10 luglio, per concludersi giovedì 30 luglio. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00.
IL PROGRAMMA
Venerdì 10 luglio - Dirty Six;
Daniele Scannapieco - sax
Tommaso Scannapieco - contrabbasso;
Lorenzo Tucci - batteria
Claudio Filippini - pianoforte
Gianfranco Campagnuolo - tromba
Roberto Schiano - trombone
Martedì 14 luglio -The Caponi Brothers - "Swing & Soda";
Domenico Tammaro - voce
Giuseppe Di Capua - piano
Gianfranco Campagnoli - tromba/flicorno
Tommaso Scannapieco - contrabbasso
Vincenzo Bernardo - batteria
Giovedì 16 luglio - Quintetto Martucci
Gaetano Falzarano - clarinetto
Tommaso Troisi - violino
Olena Vesna - violino
Francesca Senatore - viola
Francesca Taviani - violoncello
programma:
G. Salieri,F.Danzi, W. A. Mozart
Martedì 21 luglio - Trio di Salerno
Sandro Deidda - sax
Guglielmo Gugliemi - pianoforte
Aldo Vigorito - contrabbasso
Martedì 28 luglio - Duo
Francesco Buzzurro - chitarra
Giuseppe Milici - armonica
Giovedì 30 luglio - Duo
Daniela Del Monaco - canto
Antonio Grande - chitarra
canzoni classiche napoletane
addetto stampa Claudia Bonasi - 339 7099353 - claudia@puracultura.it
*
 - Poesia
- Poesia
Tirrenide - silloge poetica di Maria Grazia Insinga
"TIRRENIDE" ... nei ‘soliloqui poetici’ di Maria Grazia Insinga - Anterem Edizioni – Cierre Grafica 2020.
Un asterisco (*) a suddividere i ‘passi’ di soliloqui che avallano il silenzio a ‘forma’ compiuta e/o incompiuta di un dialogare estremo, definitivo, senza appello. Un passo dietro l’altro conforme a un prima e un dopo sospesi nella ricerca di un fil-rouge che investighi sul senso… “..era in era è e siamo l’intero”.
Orme di piedi scalzi che sfiorano appena l’arenile e continuano sull’acqua nell’attraversamento del mare dell’esperienza, da una sponda all’altra incerte, eppur ferme, sì da lasciare il segno del proprio passaggio, quasi di involo predestinato, inappellabile…
“..e del dopo e sul dopo diremo tanto / e tanto diremo è tutto dopo / ora e non saremo e mai”.
Lo si direbbe un voluto richiamo a note marginali, all’omissione di un concetto che sfugge all’indagine, o forse di un pensiero immaginale, indicibile, che subentra e invade lo spazio di un gesto incontrollato, un segno grafico in sostituzione d’una parola mancante…
“..la parola è qui cosa è presenza non quella / giusta né la soluzione né l’idea di luce perché qui / tutto è nuovo nulla ripete e nulla è in vita”.
Un ‘verso’ evocativo di edenica rimembranza, di cui Maria Grazia Insinga si serve nel richiamo alla ‘Tirrenide’ in illo-tempore scomparsa, e che pur riaffiora in ogni etnia del Mediterraneo Mare, come memoria mitica ancestrale, seppur disgiunta dall’odierna realtà virtuale…
“..e dall’infinito areale un corteo di posidonia sbuca / mostruose evoluzioni di unicorni e sirene in miriadi / di ippocampi la cui polvere è cura e linea di flusso e luce / tra opera viva e opera morta pinne dorsali disseccate / rapidissime farfalle cavalcatura e guida dei mostri”.
Per una realtà che sfugge all’estensione del ‘tempo’ e che s’avvia, per conseguenza, verso ‘la quarta dimensione’ della conoscenza, o se vogliamo della luce, in cui tutto risplende e sfoca nell’impercettibile, allorché il Sé viene alla mente estatica per non appartenere più a sé…
“..su in strada per Tirrenide il viaggio è già / compiuto e alza lo scirocco e / il pianeta è perfetto sto per morire”. Quale fonema di sicura ampiezza ‘il vento la macchia mediterranea un’imperfezione da correggere’ sulla linea di fuoco onde s’adempie il ‘sublime’.
Sussiste che il coniato asteriscolum latino non delimiti un luogo, un terreno confinante, uno spazio abitativo, bensì un alone luminoso dell’anima silente che avalla e/o sconfessa l’esperienza oggettiva dell’enunciato, ponendo il sigillo idiomatico all’ ‘indecidibile’…
“ora è troppo leggibile / la parola che c’è / e in quella che manca / il vuoto mille inizi / uguale mille non possibilità … / dove sono le cose / quando non ci sono?”.
“il tempo primo non sufficiente,
e secondo a nessuno e lo spazio
non sufficiente e prima di tutto
il nostro raccolto non sufficiente
non sento da un orecchio quello
musicale è vuoto e avverte la fine
dalla fine …”.
“che al nulla porti il nulla è già qualcosa
e la smettano di non dire il non dicibile
anche se lo ammetto è già qualcosa …
al diavolo un cenno sarà sufficiente
un nonnulla del capo al limite in limine
faremo unaltro cenno del capo”.
Entrati nel labirinto ricreato dall’autrice “..tutto è solo nel possibile niente”, nel mitico tutto delle parole “..l’estremo esercizio delle rapide contro / dammi il mio arco quotidiano”; dove il dardo incendiario penetra nel liquido discorsivo per incendiare il mare, ove Poseidone regna su Tirrenide “..sulla fiumana ingrossata”, “..l’arco contro la piena, contro vuoti e pieni, e la forma sigillo”; “..in un cerchio, un ciclo due anzi un triciclo o l’uroboro”, preso a simbolo archetipo della condizione esoterica dei cerchi nell’acqua, dell’indistinta sovrapposizione dei cerchi di luce che obliterano la vista...
“la forma nello spazio è pur sempre distanza e pure,
luogo e lì si toccano e c’è nell’intero di chi è solo
una misura di prosa che qui non c’è non c’è racconto
non dirsi ma essere che va verso un altro intero
per contraddirsi dirsi contro e dunque forma dimmi”.
«Io non scorgo che una successione di splendori crudeli il cui movimento stesso esige che io muoia.» – scriverà Georges Bataille (*) nel definire la morte la consumazione ‘sfavillante’ di tutto ciò che era. È qui che ‘Tirrenide’ riassume in sé ‘ciò che non può essere deciso’, il numero finito di ‘passi’, la parola ‘mancante’ nel dialogo costante che l’autrice propone, insito nella scelta del ‘verso’, o se vogliamo, nella ‘forma’ che l'autrice stessa ha dato al suo componimento poetico…
“..in cui la fame la resuscita al canto
del gallo in eccesso di corsivi
e a proposito il corsivo è suo”
“sul farsi del nulla sul farsi del verso
incepparsi in questa vita e nelle parallele
e in altri nulla nulla nulla e bastava uno”.
Poetica che la vede immersa in quel ‘soliloquio’ indefinito e pur nobile che le suggerisce l’anima, onde per cui alcun algoritmo può sostituirsi al ‘senso’ infine trovato, e che Jacques Derrida afferma «..non restare più in contatto con sé, non appartenere più a sé: sta in questo l’essenza della cenere, la sua stessa cenere.» (*)
Una ‘asterisco’ dunque che infine brilla come una stella nello spazio bianco della pagina, come di un cielo spolverato di un ‘biancore diffuso’, di quella ‘iancura’ (*) dove, per una ragione insperata, soggiunta imprevista, “..il nulla accadeva in forma di varco di nulla … la non perfezione della perfezione”.
L’autrice:
Maria Grazia Insinga, siciliana, letterata, musicista professionale, ideatrice di premi di poesia importanti per i giovani “La Balena di Ghiaccio”, “Premio Lighea”, è inoltre autrice superpremiata di libri di poesia e saggistica letteraria. Nel 2015 vince il concorso 'Opera prima', iniziativa editoriale diretta da Flavio Ermini, con la raccolta 'Persica' (coedita da Anterem e Cierre grafica). Nel 2016 con la raccolta 'Ophrys' è finalista alla XXX edizione del Premio Lorenzo Montano, uscito in volume nella collezione 'Limina' di Anterem Edizioni con la postfazione di Giorgio Bonacini. Il presente volume 'Tirrenide' partecipa alla XXXIII edizione del Premio Montano è oggi incluso nella Collezione “La Ricerca Letteraria” (Anterem 2020), a cura di Ranieri Teti.
Note:
(*) Georges Bataille, “Il Labirinto” – SE Editore 1970
(*) Jacques Derrida, “Ciò che resta del fuoco” – SE Editore 2000
(*) ‘iancura’ in “Tropismi” : iancura, biancore omerico, quiete marina – nella intervista a Paolo Casuscelli.
*
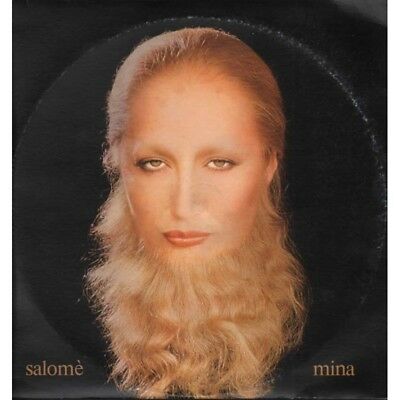 - Musica
- Musica
Mina Vagante - Auguri Vivissimi.
MINA VAGANTE
"Sei grande, grande, grande e come te sei grande solamente tu".
Con quanti nomi si può appellare un’artista ‘assoluta’ che sa catturare l’audience di milioni di fans senza apparire sulla scena da almeno 40 anni? Facendo due conti strampalati, a 40 anni aveva già pubblicato quaranta album di canzoni, e che canzoni (!); che ha doppiato nei suoi secondi 40anni pubblicando almeno un album all’anno e che, sommati, fanno 80 LP/CD di successi, e che successi (!), lasciatemelo dire, da capogiro. Per non dire degli innumerevoli ‘capolavori’ centrati dalla sua voce eclettica e straordinaria che ancora oggi, a dispetto dei suoi 80anni Mina per tutti noi che l’abbiamo vissuta e amata è considerata un’idea, e come a suo tempo ebbe a scrivere Ivano Fossati “Non può morire un idea”.
Ciò che invece possiamo dire, è che ci sono in circolazione almeno 80milioni e forse più di ‘Mina/e’ vaganti, pari al numero dei suoi album venduti. Sicuramente più di quante ne sono esplose durante le ultime guerre in giro per il mondo. Ma almeno queste non recano danno alcuno, anzi sono ‘bigné’ alla crema, di cui lei stessa è golosa. Non so quanto tutto questo sia vero, se non altro perché di danni le sue canzoni ne hanno combinati non pochi, se non altro perché hanno smosso i sentimenti di altrettanti milioni di cuori infranti che, nel bene e nel male, hanno trovato e distrutto corrispondenze affettive.
Né, d’altronde, si può prendersela con gli autori delle sue canzoni senza esimersi dal constatare l’affinità tematicamente forte di adesione lirico-musicale in cui si raccontano storie ostacolate o di abbandoni sentimentali. In esse è fondante l’effetto insito nel suo modo di cantare e l’uso della voce tecnicamente invasiva, che si sprigiona dalle proprie corde emozionali e proiezioni ‘espressive’ di sicura presa sull’immaginario del pubblico al quale si rivolgono, e d’altro aspetto con i mutamenti delle forme e delle modalità del consumo discografico. Come è dimostrato dal “mina.live” registrato a “Bussoladomani” secondo una moda di quegli anni e che ha visto l’abbandono dalle scene dell’artista.
È lecito chiedersi perché Mina eserciti un così grande carisma nell’ambito canzonettistico italiano e non solo? O anche come e soprattutto perché così numerose schiere di ‘iniziati’ si siano convertite al culto della sua stravaganza? A voler dire alla sua personalità, professionalmente rigorosa, la cui voce riesce a imporre un tale fascino e una sensualità così imperante da autentica ‘regina’ di un popolo di alieni abitanti di una indubbia galassia di estimatori. Indubbiamente una risposta c’è, anzi più d’una, diverse e contrastanti. Che lo crediate o no, nell’intenzione di configurare il prototipo Mina mi sono rivolto alla schiera esorbitante dei suoi ‘consumatori’, i quali hanno dato più o meno una identica risposta:
«Praticamente perché è ‘una voce per tutte le stagioni’», «..perché dall’età di 10 a 100 anni ci si rivolge a Lei per fare regali a se stessi», «..perché dice ciò non si ha il coraggio di dire», «..affinché ci si lasci trascinare in una qualche storia impossibile da vivere sulla propria pelle».
Ma altre risposte provengono dalle parole di quanti si farebbero straziare il cuore, per vivere una così ‘grande, grande, grande’ emozione e almeno un’altra domanda: «Quale uomo o donna non vorrebbe lasciarsi coinvolgere in una ‘passione’ così profonda, e ‘ancora, ancora, ancora’ donarsi per l’eternità dei propri giorni?» Per cui si noti come i riferimenti non siano propriamente casuali, e che quasi sembra di sentire sulla propria pelle che stiamo parlando di una ‘love-affair’, non è forse così? Ma non provate neppure a dare altre risposte perché suonerebbero false. In realtà ogni animo sensibile trova nella voce accattivante di Mina la propria sensibilità nascosta e/o palese che sia, il proprio modello di mondanità. Vuoi per aver consumato ‘scandali’ procurati senza volerlo, e per certe sue esibizioni ‘eclatanti’ addirittura censurate, che l’hanno vista tirarsi fuori dalle convenzioni di una società che fin dai suoi inizi gli andava stretta. Tali che si può ben dire di aver contrassegnato un’epoca in cui la ‘libertà femminile’ reclamava il proprio diritto di esistere come ente a sé stante, e di essere considerata dall’altro sesso, quello maschile, capace di una sensibilità emozionale forte, forse più forte di come fino allora esposta.
È vero, in certi casi l’abbiamo vista esporsi quale feticcio da ‘baraccone’ cui sono seguite infinite brutte imitazioni, non senza però una punta d’invidia da parte di chi, in qualche modo, desiderava sostituirsi a lei. Per non dire delle molteplici quanto orrende parodie dei suoi modi di esprimersi nel cantare: dall’uso delle mani e del corpo, fino ai ‘vezzi’ delle sue labbra mentre canta; anche e, soprattutto, senza avere né la sua estensione vocale, né la sua capacità interpretativa, e neppure le sue qualità oltremodo sensuali e spiritosamente gay. “E se domani…” canta Mina ancora dopo 40 anni, ma nessuna delle sue imitatrici nel frattempo ha oscurato il suo ‘domani’.
Notevolmente sofisticata in certe apparizioni televisive di show che hanno fatto epoca, Mina è comunque una ‘diva senza esserlo’, ritraendosi piuttosto che apparire promotrice di una certa mondanità, la cui assenza dalla scena non ha fatto altro che accrescere la sua popolarità e, immancabilmente i pettegolezzi sul suo conto. Sì che viceversa una ‘diva’ di celluloide di solito sollecita, e in qualche modo sostiene, tutto ciò che rende ‘glamour’ la propria esistenza. Lei no, la sua personalità malgrado la sua timidezza, s’impone visivamente all’occhio del pubblico attraverso le copertine decisamente ‘artistiche’ dei suoi album.
È così che abbiamo appreso ad apprezzarla nell’insolita quanto originale veste grafica creata dal suo ‘personal designer’ Luciano Tallarini che negli anni ’80 ha sorprendentemente magnetizzato la sua figura d’interprete, presentandola ogni volta diversa ma pur sempre all’altezza della situazione: si pensi al doppio album “Salomé” in cui Mina appare con la barba, la cui veste grafica accresce il suo prestigio artistico, creando un aspettativa ulteriore nei fans che ogni volta l’accoglievano con effetto ‘sorpresa’. Fu quello uno dei tanti appuntamenti ‘di classe’ a cui Mina ci ha abituati, per la felicità di noi estimatori, con la sua voce eclettica, la cui estensione supera di gran lunga la scala musicale.
Per una ‘Salomè’ con la barba Erode avrebbe fatto decapitare (con rispetto parlando) cento Giovanni Battista, e che si può definire la migliore trovata pubblicitaria di quell’anno 1981. Ma a un altro artista, questa volta un affermato visagist, che va attribuito il plauso delle molteplici trasformazioni, ‘vere e proprie metamorfosi’, in cui l’abbiamo spesso ammirata: Stefano Anselmi, già curatore sul set di Federico Fellini ed di altri importanti registi del cinema che re-inventa il suo ‘look’ rendendola di volta in volta inedita e soprendente.
Quella stessa Mina apprezzata interprete di brani del reportorio italiano e internazionale, quai ad esempio: “Walk on by” di Burt Bacharach e “Tu sarai la mia voce” versione italiana “Put the weight on my shoulders” di Gino Vannelli. E ancora più entusiasticamente “Verde Luna”, “Tres palabras” ed “Esperame en el cielo” prese dal repertorio sudamericano, come farà anche in seguito interpretando canzoni in brasiliano di Cicho Buarque e di altri. Inoltre ai nuovi brani contenuti in questo straordinario doppio-album, appositamente scritti per lei da Andrea Lo Vecchio, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Edoardo De Angelis ed altre arrangiate dal figlio Massimiliano Pani.
Per quanto non si è ancora qui parlato di un altro album “Attila”, la cui ironia sottile della copertina, in cui ‘Lei’ appare completamente ‘calva’, che ci permette di pregustare, quasi a livello epidermico, l’interessante quanto stravolgente contenuto di una Mina-disco-music. 18 brani più o meno classici e tuttavia mai apparsi prima, calibrati sulle sue qualità ed estensione vocale da compositori e poeti quali: Bardotti, Shapiro, F. Monti Arduini, Malgioglio, Cantarelli che portano nella canzone italiana una ventata di fresco e di attualità con i tempi.
Brani quali: “Street Angel”, “Anche tu”, “Ma ci pensi”, e quella “Anche un uomo” che furono la colonna sonora dell’anno 1980, interpretate da Mina volta a superare il clichè canoro tradizionale con matura intelligenza interpretativa. Si pensi che “Attila” già a poche settimane dalla sua uscita, realizzò l’esaurirsi delle scorte, sì che la casa discografica PDU, fu costretta a rivolgersi ad altri per la stampa dei dischi, ammettendo di non farcela ad esaudire la richiesta del mercato. Ma era quella una Mina vestita a nuovo che malgrado le sue rare apparizioni sugli schermi televisivi, ancora una volta centrava l’obiettivo del successo, e che tutte le Radio, cresciute a dismisura, proponevano a tutto spiano per il piacere di un pubblico fedele al suo mito che le dimostrava così il suo affetto incontrastato.
Nel frattempo ‘Lei’ la cantante per eccellenza, conosciuta oltreoceano quasi senza mai muoversi da casa, conquistava paesi e continenti, tanto da essere considerata all’altezza, se non più grande, di tante star internazionali. E questo solo perché non ha mai voluto prendere un aereo; non ha mai smesso di cucinarsi le ‘frittelle’ con le quali soddisfa la sua inconsueta golosità; così come di catturare i suoi uomini e/o scegliere i suoi compagni di viaggio nelle sue performance televisive. Scusate se è poco, potendo lo ha fatto, tenendo fede alla sua interdipendenza che ancora oggi non le permette di sottomettersi alle astruse volontà degli altri: creatori di eventi, imprenditori ed esercenti di media; e non solo perché ha accumulato una fortuna di cui non tiene neppure conto, ma perché infine è rimasta se stessa, semplicemente Mina, con la sua preponderante personalità che riesce ancora, e sempre, a creare con la sua voce un’atmosfera autentica e ‘paradisiaca’ che riesce a dare a tutti i suoi risvolti. Paradisiaca come il titolo del suo album del 2018 intitolato “Paradiso – Lucio Battisti Songbook”, contenente le versioni più sofisticate dell’autore, e interpretate da Mina con la solita voce esaustiva incredibile e inarrivabile come solo lei riesce a fare.
Un discorso a parte va qui fatto riguardo alle molte interpretazioni di vecchi e nuovi brani del panorama canoro italiano: dai successi sanremesi da Lei reinterpretati con intelligente maestria vocale, ai successivi “Mina in studio”, “Mina canto o Brasil”, “Sorelle Lumiere” e “Veleno” con lo strepitoso “Succhiando l’uva” di Zucchero e altri brani di autori come Bruno Lauzi “Certe cose si fanno”, Daniele Silvestri “La seconda a sinistra”, Renato Zero “Che fatica”, Samuele Bersani “In percentuale” e Ivano Fossati “Notturno delle tre”.
Quant’altro ci sarebbe da dire a riguardo dei molti cantautori che hanno duettato con Lei, a incominciare dallo strepitoso Adriano Centano che recentemente con “Le migliori” tanto ci ha divertito e strabiliato; per parlare poi dell’incommensurabile Enzo Jannacci; delle re-interpretazioni di brani di Domenico Modugno, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Pino Donaggio, Roberto Vecchioni, De André, Renato Zero, Cristiano Malgioglio, Zucchero Fornaciari, e dell’ultimissimo album in ordine di uscita in duo “Mina Fossati” da cui “L’infinito di stelle”, “Luna diamante” e "Meraviglioso, tutto qui” entrati a far parte della colonna sonora del film di Ferzan Ozpetec “La dea fortuna”.
Così come non vanno assolutamente i due album dedicati alla canzone napoletana dei quali nessuno in questi giorni di grande afflato amoroso da parte dei fans per il suo ‘compleanno’ ha lasciato trapelare almeno la conoscenza. E dire che appena agli inizi, nell'ormai lontano passato, Mina aveva dedicato alla canzone partenopea almene due o tre album indimenticabili.
Mi riferisco in particolare allo speciale ‘Mina - ieri & oggi’, andato in onda su Rete4, condotto dal pur capace e bravissimo Mauro Coruzzi (in arte Platinette), co-fondatore del Mina Fan Club, che insieme a Paolo Piccioli ci hanno regalato uno splendido spaccato di una Mina per certi versi ‘inedita’. Tuttavia ritengo non si possa restare indifferenti nell’ascolto dei due album dedicati a “Napoli” e “Napoli secondo estratto”, nei quali Mina interpreta in modo straordinario vecchie e nuove canzoni del repertorio napoletano: “Amaro è ‘o bene” di Sergio Bruni, insieme a “Napule è” e “Je sto vicino a te” di Pino Daniele e la struggente “Indifferentemente” di Martucci-Mazzocco, e tanti altri reinterpretati per l'occasione come: Bovio, Di Giacomo, Russo, Di Capua, E.A.Mario, fino a “O cuntrario è l’ammore” tratto da “Crisantemi” di Giacomo Puccini. Per quanto va assolutamente ricordata l’accorata “Lacreme Napulitane” inserita nel già citato album “Mina. Live”. Ma voglio qui ricordare un album passato un po’ sottotono come “Dalla Terra” in cui Mina si cimenta con 'brani sacri’ alcuni in napoletano ed altri cantati in latino: “Voi ch’amate lo criatore” tratto dal “Laudario di Cortona” del XIII secolo, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea e “Quanno nascette Ninno” di Sant’Alfonso de’ Liguori, insieme a brani di Pergolesi, Chiaravalle, Monteverdi, e Gounod nella chiarissima “Ave Maria”.
Un particolare apprezzamento va fatto per “Volevo scriverti nonostante tutto” di Pulli-Ferrara contenuto nell’album “Maeba Mina” del 2018, inoltre al duetto “A Minestrina” di e con Paolo Conte, nonché quello con Davide Dileo in “Un soffio”. Mentre tra gli autori è impossibile non notare la presenza di Paolo Limiti che ha firmato “Il mio amore disperato”, e nel tempo altri grandi successi interpretati magistralmente da Mina. Inserite in questo album troviamo inoltre “Last Christmas” dei Wham e “Heartbreak Hotel” cavallo di battaglia del mai compianto sufficientemente Elvis Presley.
Per quanto splendidamente concepito nell’ultimissimo “Mina Fossati” i due sembrano fare a gara nel voler riproporre un ‘melò’ musicale patinato che ricalca l’avventura biografica e individuale, riconoscibile nell’ombra stilistica e romantica dell’autore Ivano Fossati. Si può tentare di definire un tale ‘valore emotivo’? Certamente sì. Anche se non mi sembra il caso di ripercorrere qui le tappe di questo cantautore apprezzato ma in qualche modo anche contrastato, ‘perché difficile’, del panorama musicale italiano. Per quanto, va detto, la voce imprevedibilmente ‘chiara’ (a questa età) di Mina fa rifulgere anche i testi più artificiosi, benché carichi di tensione emotiva.
Anzitutto va fatta luce su un punto essenziale ancora non espresso del rapporto fra Mina e il pubblico, non esclusivamente quello dei suoi ammiratori quali siamo, riguardo alla sua capacità di distribuire ‘piacere’ a chiunque si metta in ascolto; di riempire la ditanza che c’è fra la sua ‘voce’ e l’intera ‘auidiece’, rendendoci partecipi di una realtà vissuta in maniera autentica per quanto virtuale, del suo e del nostro esserci. Ciascuno di noi ascoltandola cantare è infatti un po’ meno solo, come dire prende a carico la sua voce come esperienza di sé e della propria necessitudine di vivere.
Grazie Mina, e tantissimi affettuosi auguri: “Sei grande, grande, grande, e come te sei grande solamente tu”.
Un tuo fan da sempre perso nei meandri della tua voce intensa.
*
 - Politica
- Politica
Bla, bla, bla … ’al gran ballo degli ingrati’.
Dal libretto “Ballo delle Ingrate” di Ottavio Rinuccini , membro della Accademia Fiorentina degli Alterati, musicato da Claudio Monteverdi in forma di madrigale per strumenti antichi, quali: viole da braccio, chitarrone, arpa doppia, clavicembalo.
“De l’implabil Dio
Eccone giunt’al regno:
seconda, o bella madre, il pregar mio.
Non tacerà mia voce
Dolci lusinghe e prieghi,
fin che l’alma feroce …”
La scena s’apre tra i fumi e le fiamme dell’inferno ove in alterco si rivendica amore: “Amor non sai / che dal carcer profondo / calle non è che ne rimeni al mondo”. Non sembra anche a voi di risentir balzare di bocca in bocca, ora dall’una ora dall’altra fazione politica del nostro parlamento, una sentenza oscura che infine è comunque quanto ci tocca? Non altro perché dai loro scranni gli ‘ingrati’ pensano di convincere, e ci riescono, coi loro falsi affanni ciò che: ‘la gente vuole’, ‘ce lo chiedono gli italiani’, ‘è per il bene del paese’ ecc. ecc.
Sfido chiunque di voi che leggete di dirmi con chi dei tanti parlamentari che ruotano intorno scambiandosi i vessilli, avete parlato o fatto richieste alcune che siano mai state ascoltate? Che non siano state disattese con alterigia di chi non sa cosa rispondere e per questo rispondere talvolta con la prosopopea del ‘politichese’, quando ancor più con l’arroganza di chi sta facendo solo i propri interessi. E dire che ne hanno avuta fin ora di fiducia che chiedevano a gran voce, se non di più, e che noi gli abbiamo data.
Sbagliato! È stato proprio quel ‘di più’ a farli sentire ‘padreterni’, tali da non far loro provar vergogna alcuna, allorché infilano la scheda nell’urna parlamentare e avvenire a un ‘voto palese’. Nò, devono farlo nel modo più ambiguo che ci sia, di nascosto, senza rivelarsi davanti a Voi/Noi che li abbiamo messi lì, anche se in verità non sappiamo bene perché. Sta di fatto che una volta arrivati a occupare gli scranni, non li cedono più e non c’è ragione che valga, neanche quando sono stati colti in flagrante con le dita nella marmellata.
La finzione della scena parlamentare li fa sentire avulsi da qualsiasi colpa o rivendicazione alcuna, in quanto possono sempre dire, come del resto fanno: ‘l’abbiamo fatto per voi’, ‘è per il bene del paese’. Su cui confezionano altre promesse, propositi aggiuntivi, incanti che si rivelano fasulli il giorno dopo, perché gli ‘ingrati’ sono così: rigorosamente falsi, bugiardi a prescindere. Ché, dopo le malefatte: “dolgonsi invan ché non ben saggi furon”; finché arsi di nuova fiamma invocano, anzi pretendono pure d’aver ragione: “Ma qual cieca ragion vol che si nieghi quel che malgrado al fin vi tolgon gli anni?”.
Gli anni sì, fino a precludere il quotidiano vivere con stenti e vicissitudini, che contentar dobbiamo, i loro sprechi e i loro laggi, che vivere essi devono nel benessere ad ostentar fatiche che non fanno. Meschini noi che abbiam creduto ‘agli ideali loro’ e ancor crediamo che di cambiar le cose siano ancor capaci, quando dal loro canto strenua ‘avidità’ avanzar vediamo senza plausibile riscontro, la cui voracità è pari a quella del Diavolo in persona.
Di certo “frutto non è da riserbarsi al fine”, Orsù dunque coraggio Sardine, date fede al mio dire, ben sarebbe, per chiunque s’affacci prossimamente alla politica di metterci la faccia e il culo. Udite udite! Ben sarebbe altresì, ancor prima di recarvi alle urne conviene “..aprir le tenebrose porte de la prigion caliginosa e nera e de l’anime ingrate traete qui la condannata schiera!”, che d’altro più non meritano:
“Udite, udite oh de l’infernal corte feri ministri udite!
…
Aprite deh
le tenebrose porte …
al fumo, a’ gridi, a’ pianti
a sempiterno affanno …
tornate al negro chiostro
anime sventurate
tornate ove vi sforza il fallir vostro!”
Ma se la par-condicio reclama in giusta misura, le colpe e le pene, è giusto lasciar a loro raggiungere le vette che reclamano a gran voce? Non v’assale il dubbio che facciano ancor meglio di quei ladruncoli da quattro soldi detti ‘furbetti del cartellino’, che accusano di rubare allo stato, mentre loro si accaparrano i migliori posti, occupando tutti i ruoli costituzionali? E che, per quanto noi sappiamo, riservano alle loro amanti il plauso per quello che fanno senza ritegno alcuno? Vogliamo dire neppure loro sono da meno ché l’avidità delle regalie che ne ricavano è fuor di misura, quindi gettiamo pur le meschine alle fiamme:
“Udite, Donne, udite i saggi detti
che di celeste parlar nel cor serbate:
chi, nemica d’amor, ne’ crudi affetti
armerà il cor nella fiorita etade …
Donne che di beltade e di valore
togliete alle più degne il nome altero …
che di cotanto rigor sen vanno armate
mal si sprezza d’amor la falce e’l cielo”.
Deh voi ingrate quanto loro, che declamate in terra populistiche veglie e scaramantiche effusioni, volgete lo sguardo altero verso la superna giustizia che di diritto a vivere per ognun reclama. Che infine anche voi donne di ‘ineguagliabile bellezza’ patire dovete lo scorno, e che a lungo andare, ne perdete di grazia il plauso, per rincasar meschine nottetempo degli affannosi anni dell’età che vi consuma.
Siete or voi certe che tutto quel pretendere posizioni e potere in questa società non abbia poi indirizzo in quel che perdereste d’onestà? Che d’uguagliar quegli uomini (si fa per dire), non abbiate già perduto di femminilità il consenso? Davver convinte siete che non sia nella rivalsa maturata in seno agli uomini il vanto di un possesso che li piega a un futuro voler vostro che li fa diventar violenti e ancor più assassini?
Cercare un equilibrio conviene, una giustizia giusta che non consenta soprusi di genere, ché ritrovar il senno di poi a questa umana prole non è ancor dato.
*
 - Sociologia
- Sociologia
Bla, bla, bla … Australia lo sterminio dimenticato.
Bla, Bla, Bla … Australia lo sterminio dimenticato.
Incendi, la soluzione aborigena. (*)
“In Australia si cercano nuove soluzioni per contrastare il fuoco, c'è chi propone e attua tecniche che vengono dal lontano passato. I recenti temporali tanto attesi hanno provocato chiusure stradali e inondazioni improvvise in parte della costa orientale , mentre il paese sta ancora combattendo contro un centinaio di incendi boschivi. A questo si aggiunge anche l'allarme lanciato dal WWF, relativo alle centinaia di tonnellate di cenere e detriti che avranno un impatto importante sull'ambiente e sulla salute delle persone. Di fronte a questo scenario, si cercano nuove soluzioni ad un problema, quello degli incendi, che si ripete ogni anno, anche se mai con questa intensità. Per oltre 50'000 anni, gli aborigeni australiani si sono presi cura della terra in modo olistico e per loro il fuoco non è un nemico da combattere, ma un amico da capire per ripristinare la terra ed aumentare la biodiversità. Le tecniche aborigene liberano la terra dal combustibile, come detriti e boscaglia, con fuochi controllati e a bassa intensità, che riducono il carico di carburante e diminuiscono il rischio di incendi. Si tratta di una pratica poco conosciuta dai vigili del fuoco, come affermato dal pompiere John Olle, che ha capito che questa tecnica - quelle degli incendi controllati - non ha a che fare solo con il fuoco, ma si tratta di connettersi con la natura”.
È bastato alzare il tiro di questa affermazione per dar luogo a una montagna di polemiche, e a ragione secondo me, pur tuttavia non riportate sui social, né argomentate dai giornalisti in alcun servizio visto alla TV né sulla carta stampata, se non in brevi accenni, tanto per tenerci al corrente che l’Australia stava bruciando, con fiere immagini di salvataggio di alcune specie animali che, guarda caso, rischiavano l’estinzione. Di contro nulla è stato detto, tantomeno fatto vedere, degli esseri umani che, sempre guarda caso, malgrado le esigue concessioni governative, sopravvivono sul territorio sembra solo da 50.000 anni, segregati in aree delimitate, in stato di povertà assoluta, succubi di uno ‘sterminio silenzioso’ quanto coatto, che punta all’estinzione degli Aborigeni e per lo più ‘volutamente’ ignorato dal resto del mondo, quanto caparbiamente inflitto.
Voglio far qui presente che, guarda caso, non si tratta solo di esseri umani oggi ascesi a una condizione di merce di scambio, besì di una ‘cultura’ che potrebbe essere la più remota nell’evoluzione dell’uomo ancora oggi esistente sulla terra, comprensibilmente evolutasi su altri ‘piani di intelletto’ e in perfetta simbiosi con la natura che li accoglie. Ma forse sarbbe più idoneo qui dire ‘che li accoglieva’, poiché espropiati in toto da quell’ancestrale connessione che gli Aborigeni (vocabolo orrendo coniato all’inizio dell’800 dai Colonizzatori, altro vocabolo questo di una caparbietà devastante), detenevano con il territorio che li ospitava. A tal punto da saper come domare gli eventi naturali che oggi incutono preoccupazione, come appunto: gli incendi boschivi, le alluvioni e le esondazioni delle acque, con una gestione proficua e nella costante salvaguardia della natura circostante.
Davanti a un tale disastro ecologico come quello che abbiamo vissuto in diretta, mi chiedo se non sarebbe il caso di porsi qualche interrogativo sulle condizioni di vita delle popolazioni aborigene dell’Australia, oppure vogliamo immaginare che le fiamme dei roghi, il fumo e la cenere che hanno invaso tutto il continente non abbiano affatto scalfito la loro pelle, i loro occhi, i loro sensi. Quasi fossero degli ‘avatar’ un tempo umani ascesi alla declinazione divina e oggi reincarnatisi sulla terra, e per questo avulsi dalla fine che fanno tutti gli esseri mortali in preda ad eventi così distruttivi (?). Vogliamo pensare al voler mettere fine, cioè per concludere un genocidio iniziato da almeno un millennio, si sia intenzionalmente dato fuoco a un intera area geografica, rischiando alcune casette di legno scelte a bella posta da dare in pasto ai media, con tanto di successivo e/o preventivo risarcimento statale? No, non lo pensiamo, anche se …
Vogliamo pensare che gli Aborigeni stufi di tanta acredine nei loro confronti, in quanto succubi del razzismo che da sempre li perseguita e li ha visti spesso ridotti in schiavitù, nonché contro lo sfruttamento apocritico (*) della società odierna, e la malversazione (*) nei confronti della loro cultura e delle loro tradizioni, abbiano appiccato, per una tensione masochista, gli incendi, al fine di estinguersi nelle fiamme per poi rinasceri dalle proprie ceneri come la Fenicie di mitologica memoria (?). Beh, pensiamolo pure, anche se qualche dubbio ci viene alla mente …
Oppure siamo di fronte a un altro genere di sterminio, quello faunistico che vede il governo australiano impegnato ad affrontare il prolificarsi di spacie animali come i canguri e i koala che tanto danno (leggi fastidio) creano alle popolazioni e alle coltivazioni, sia in fatto di spesa economica, sia in fatto di ingiusta distribuzione (sperequazione) fra animali ed esseri umani, onde la determinata riduzione sostanziale del loro numero. Ma guai aprire una sorta di caccia al canguro (che pure esiste), o ai koala che farebbe insorgere gli animalisti di tutto il mondo e che, sempre guarda caso, butterebbe una cattiva luce sul governatorato e farebbero scrivere intere pagine, con tanto di immagini illustrative, sulla mancanza di umanità del popolo australiano. Non sia mai …
Allora è meglio fare di tutto quanto un unico falò, dicono i malpensanti governativi, anche perché in questo modo il ‘governo di Ponzio Pilato’ si lava le mani di problematiche fastidiose e in un modo o nell’altro irrisolvibili. O almeno, vista la cosa sotto una certa luce, non si espone a critiche e responsabilità socio-economiche che altrimenti arriverebbero a far pensare, guarda ancora il caso, a una qualche corresponsabilità e/o a collusioni lobbistiche e opportunità politiche che, chissà, magari non poi così accettabili dall’opinione pubblica. Ma noi che scriviamo non siamo così perfidi di pensare possibili certe cose, anche se smentiti dai fatti che, volenti o nolenti, ci confermano di non essere degli ‘avatar’, o almeno, fino a prova contraria, ancora non conclamati …
Per quanto il tutto possa sembrare riduttivo d’una realtà conclamata, i roghi australiani non scoppiano per caso o per noncuranza ma per un’incapacità di gestione sia individualistica sia collettiva che, dimentica di un fare rispettoso dell’ambiente, mette oggi a repentaglio l’intera comunità colonizzatrice, gettando ombre anacronistiche sulla condizione degli Aborigeni e sulla loro ancestrale cultura. Comunque non è il caso di attribuire colpe imbarazzanti a tradizioni arcaiche che pure serpeggiano nel sottobosco australiano ma che hanno perso ogni legame con la superstizione popolare, o almeno una tradizione orale che non appartiene più alle masse, semmai è l frutto d’una contaminazione razzista tornata in auge con la globalizzazione politica estremista.
I danni dovuti alla globalizzazione sono irreparabili per l’avvenuto abbattimento delle barriere contenutistiche, la cui de-costruzione, dopo aver depauperato le culture autoctone, ha continuato a imporre ad esse sollecitazioni di carattere politico-comunitarie di insiemi solo apparentemente affini, mescolando e mistificando, le realtà culturali un tempo aggregative, maturate a volte in secoli di storia. Ma la storia non ha mai camminato di pari passo con gli avvenimenti di un’epoca, ancor meno con gli espedienti messi in campo di governi. Più spesso ha visto aggiungere pagine scritte col sangue e/o col carbone più nero, prima di prenderne atto e capitolarle con noni altisonanti come ‘occupazione’, ‘invasione’, ‘schiavitù’, ‘rivoluzione’, tutti apocrifi di ‘apocalisse’.
Cosa che pur sembrando lontanissima nel tempo e quasi cancellata dall’elenco delle probabilità, se non mettiamo particolare attenzione nella salvaguardia del pianeta, siamo vicini a dover affrontare. Allora sì che ci troveremo spiazzati, causa l’incapacità ‘culturale’ di affrontare l’accadimento. Ma che non si dica che non eravamo stati avvisati. Decostruire una cultura ancestrale, senza possibilità di ritornare a una germinazione della stessa, e soprattutto senza averne compresa la portata elettiva che la rende estrema nella pur breve rotazione generazionale cui l’umanità assolve, rende pienamente il senso della ‘stupidità’ che tutti ci attanaglia.
Note:
(*) Articolo a cura della redazione di RSI-News - 18 gennaio 2020.
(*) apocritico, nell’accezione di ciò che risulta superfluo e ridondante e qindi eplulso dalla società di cui non riconosce l’appartenenza.
(*)malversazione è quando un soggetto riceve un finanziamenti per un determinato scopo o attività di qualche interesse, e non li utilizza per tale scopo.
*
 - Cinema
- Cinema
Tutto il Cinema che vuoi ... Cineuropa News
De Rome à Paris: 10 opere italiane inedite in Francia
di Fabien Lemercier
10/12/2019 - Dal 13 al 17 dicembre si svolgerà la 12ma edizione di un evento che mette in mostra film italiani inediti in Francia.
Venerdì 13 dicembre, Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti aprirà a Parigi i 12mi Incontri del cinema italiano, alla presenza del regista e della sua attrice protagonista Valeria Bruni Tedeschi (che nel film recita al fianco di Marcello Fonte), alla quale il festival consegnerà un premio per il suo contributo agli scambi culturali tra Francia e Italia.
Battezzato "De Rome à Paris" e organizzato al cinema L'Arlequin dall’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali) con il sostegno del MiBACT (ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo) e in collaborazione con ICE-AGENZIA (Istituto nazionale per il commercio estero), l'Ambasciata italiana, l’Istituto Luce Cinecittà e l'UNFAE (Unione Nazionale Esportatori Film e Audiovisivi), l'evento proporrà fino al 17 dicembre dieci lungometraggi italiani ancora inediti in Francia che saranno proiettati alla presenza delle squadre dei film.
In programma spiccano i concorrenti a Venezia 'Il sindaco del rione Sanità' di Mario Martone e 'La mafia non è più quella di una volta' di Franco Maresco. Altri tre film scoperti alla Mostra sono in menù con 'Vivere' di Francesca Archibugi, che era stato presentato fuori concorso al Lido, e due titoli passati per la sezione Sconfini: Effetto domino di Alessandro Rossetto e il film che mischia documentario, finzione e materiale d’archivio 'Il varco' del duo Federico Ferrone - Michele Manzolini.
Sono in programma inoltre 'Bangla' di Phaim Bhuiyan (un’opera prima passata per il concorso Big Screen di Rotterdam), 'Dafne' di Federico Bondi (apprezzato al Panorama della Berlinale e recente premio del pubblico all’Arras Film Festival), il documentario 'Bellissime' di Elisa Amoruso (scoperto alla recente Festa di Roma, nella sezione Alice nella Città, e proiettato anche all’IDFA) e 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi nel cast) che chiuderà questa edizione 2019 degli Incontri del cinema italiano - De Rome à Paris.
Si ricorda che l'evento sarà preceduto da incontri professionali con un Work In Progress, un mercato di coproduzione e una tavola rotonda.
GOLDEN GLOBES 2020
Un tocco europeo nelle nomination ai Golden Globes
di David González
09/12/2019 - Dolor y gloria, Les Misérables e Ritratto della ragazza in fiamme tra i film candidati, insieme alle coproduzioni britannico-americane I due papi, 1917 e Rocketman
Proving the experts' predictions correct, a clutch of European titles have been invited to the upcoming party at the 77th Golden Globe Awards, handed out by the Hollywood Foreign Press Association. The ceremony, which will mark one of the most important milestones of the US awards season, will take place on 5 January in Los Angeles.
This year, the nominated films hailing from the Continent are mainly in English, but are also in Spanish and French. Manchegan maestro Pedro Almodóvar is continuing his successful run through the season with 'Pain and Glory' (recently awarded Best Foreign-language Film by Los Angeles’ film critics, among other accolades), and the work of its lead actor, Antonio Banderas (honoured at Cannes, and more recently, by New York’s film critics and the European Film Awards), has also been acknowledged by the Golden Globes.
Locking horns with Almodóvar for the Golden Globe for Best Foreign Language Film are two of the most highly acclaimed European productions across the pond this year, Ladj Ly’s Oscar submission 'Les Misérables' and Céline Sciamma’s 'Portrait of a Lady on Fire', both coming from France and also awarded at Cannes.
But English-language films, mainly co-productions between the UK and the USA, are leading the European contingent. The Netflix title 'The Two Popes', a co-production between the USA, the UK, Italy and Argentina, has received four nominations, including Best Motion Picture – Drama. The film, revolving around the meeting between Pope Benedict XVI and Pope Francis, stars UK-born thesps Anthony Hopkins and Jonathan Pryce, both nominated too, and was directed by Brazil’s Fernando Meirelles.
Following closely behind with three nominations, '1917', the World War I - film by British filmmaker Sam Mendes, is also nominated for Best Motion Picture – Drama, alongside the work of the director himself, and 'Rocketman', the Elton John biopic directed by the UK's Dexter Fletcher, is the European hopeful in the Best Motion Picture – Musical or Comedy category.
Lastly, a number of other European works cn also be found on the list of nominees led by Noah Baumbach’s Marriage Story, including 'Rupert Goold’s 'Judy' (through Renée Zellweger’s performance), and the TV series Fleabag, The Crown and Chernobyl.
Here is the full list of nominees:
Film
Best Motion Picture – Drama
1917 – Sam Mendes (UK/USA)
The Irishman – Martin Scorsese
Joker – Todd Phillips
Marriage Story – Noah Baumbach
The Two Popes – Fernando Meirelles (USA/UK/Italy/Argentina)
Best Motion Picture – Musical or Comedy
Dolemite Is My Name – Craig Brewer
Jojo Rabbit – Taika Waititi (USA/New Zealand/Czech Republic)
Knives Out – Rian Johnson
Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino
Rocketman – Dexter Fletcher (UK/USA)
Best Director
Bong Joon Ho - Parasite (South Korea)
Sam Mendes - 1917
Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood
Martin Scorsese - The Irishman
Todd Phillips - Joker
Best Actor – Drama
Christian Bale - Ford v. Ferrari
Antonio Banderas - Pain and Glory (Spain)
Adam Driver - Marriage Story
Joaquin Phoenix - Joker
Jonathan Pryce - The Two Popes
Best Actress – Drama
Cynthia Erivo - Harriet
Scarlett Johansson - Marriage Story
Soarise Ronan - Little Women
Charlize Theron - Bombshell
Renee Zellweger - Judy (UK/US)
Best Actor – Musical or Comedy
Daniel Craig - Knives Out
Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit
Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood
Taron Egerton - Rocketman
Eddie Murphy - Dolemite Is My Name
Best Actress – Musical or Comedy
Awkwafina - The Farewell
Ana de Armas - Knives Out
Beanie Feldstein - Booksmart
Emma Thompson - Late Night
Cate Blanchett - Where’d You Go Bernadette
Best Supporting Actor
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
Al Pacino - The Irishman
Joe Pesci - The Irishman
Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood
Anthony Hopkins - The Two Popes
Best Supporting Actress
Annette Benning - The Report
Margot Robbie - Bombshell
Jennifer Lopez - Hustlers
Kathy Bates - Richard Jewell
Laura Dern - Marriage Story
Best Screenplay
Noah Baumbach - Marriage Story
Bong Joon-ho - Parasite
Anthony McCarten - The Two Popes
Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood
Steven Zaillian - The Irishman
Best Original Score
Daniel Pemberton - Motherless Brooklyn
Alexandre Desplat - Little Women
Hildur Guðnadóttir - Joker
Thomas Newman - 1917
Randy Newman - Marriage Story
Best Original Song
“Beautiful Ghosts”, Cats (UK/US)
“I’m Gonna Love Me Again”, Rocketman
“Into the Unknown”, Frozen II
“Spirit”, The Lion King
“Stand Up”, Harriet
Best Animated Feature
Frozen II - Chris Buck, Jennifer Lee
The Lion King – Jon Favreau
Missing Link – Chris Butler
Toy Story 4 – Josh Cooley
How to Train Your Dragon: The Hidden World - Dean DeBlois
Best Foreign-Language Film
The Farewell – Lulu Wang
Les Misérables – Ladj Ly (France)
Pain and Glory – Pedro Almodóvar
Parasite – Bong Joon-ho
Portrait of a Lady on Fire – Céline Sciamma (France)
TV
Best TV Series - Drama
Big Little Lies
The Crown (UK)
Killing Eve (UK/USA)
The Morning Show
Succession
Best TV Series - Comedy
Barry
Fleabag (UK)
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
The Politician
Miniseries or TV Film
Catch-22
Chernobyl (UK/USA)
Fosse/Verdon
The Loudest Voice
Unbelievable
Best Actor TV Series – Drama
Brian Cox - Succession
Kit Harington - Game of Thrones
Rami Malek - Mr. Robot
Tobias Menzies - The Crown
Billy Porter - Pose
Best Actress TV Series – Drama
Jennifer Aniston - The Morning Show
Jodi Comer - Killing Eve
Nicole Kidman - Big Little Lies
Reese Witherspoon - The Morning Show
Olivia Colman - The Crown
Best Actor TV Series – Comedy
Ben Platt - The Politician
Paul Rudd - Living With Yourself
Rami Yousef - Rami
Bill Hader - Barry
Michael Douglas - The Kominsky Method
Best Actress TV Series – Comedy
Christina Applegate - Dead to Me
Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
Natasha Lyonne - Russian Doll
Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida
Rachel Brosnahan - Marvelous Mrs. Maisel
Best Actor Miniseries or TV Film
Chris Abbott - Catch 22
Sacha Baron Cohen - The Spy
Russell Crowe - The Loudest Voice
Jared Harris - Chernobyl
Sam Rockwell - Fosse/Verdon
Best Actress Miniseries or TV Film
Michelle Williams - Fosse/Verdon
Helen Mirren - Catherine the Great (UK)
Merritt Wever - Unbelievable
Kaitlyn Dever - Unbelievable
Joey King - The Act
Best Supporting Actor – Series, Miniseries or TV Film
Alan Arkin - Kominsky Method
Kieran Culkin - Succession
Andrew Scott - Fleabag
Stellan Skarsgård - Chernobyl
Henry Winkler - Barry
Best Supporting Actress – Series, Miniseries or TV Film
Meryl Streep - Big Little Lies
Helena Bonham Carter - The Crown
Emily Watson - Chernobyl
Patricia Arquette - The Act
Toni Collette - Unbelievable
Festival / Premi
9587 notizie (festival / premi) disponibili in totale a partire dal 24/05/2002. Ultimo aggiornamento il 10/12/2019. 483 notizie (festival / premi) inserite negli ultimi 12 mesi.
FESTIVAL / PREMI Italia
Assegnati i premi Meno di Trenta, dedicati ai giovani attori
di Cineuropa
09/12/2019 - Giulio Pranno, Ludovica Martino, Carlotta Antonelli e Giacomo Ferrara sono i vincitori della prima edizione del premio riservato agli interpreti italiani di cinema e televisione sotto i 30 anni.
Sono Giulio Pranno, Ludovica Martino, Carlotta Antonelli e Giacomo Ferrara i vincitori della prima edizione di Meno di Trenta, il nuovo premio riservato agli interpreti italiani di cinema e televisione sotto i 30 anni, ideato da Silvia Saitta con la direzione artistica di Stefano Amadio e Silvia Saitta, prodotto dal Nuovo Cinema Aquila di Roma con il patrocinio del Mibact.
La giuria stampa, composta da Vittoria Scarpa (Cineuropa), Luca Ottocento (Fabrique Du Cinéma), Elena Balestri (Funweek.it), Valentina Ariete/Margherita Bordino/Eva Carducci/Gabriella Gilberti/Sonia Serafini (The Giornaliste) e Alessandra De Tommasi (Airquotes.it), ha eletto i vincitori delle quattro categorie principali, partendo dalle cinquine proposte dalla direzione artistica che ha preso in considerazione le uscite dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 7 dicembre a Roma, al Nuovo Cinema Aquila.
Il premio Miglior Attore - Cinema è stato assegnato a Giulio Pranno per il film 'Tutto il mio folle amore' di Gabriele Salvatores, perché “dona al personaggio di Vincent una leggerezza e un’empatia perfetta e speciale. Con questo ruolo ha emozionato tutti e scoperto il suo immenso talento”. Pranno ha avuto la meglio su Giampiero De Concilio (Un giorno all'improvviso), Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini), Francesco Gheghi (Mio fratello rincorre i dinosauri) e Guglielmo Poggi (Bentornato Presidente).
Il premio Migliore Attrice - Cinema è andato invece a Ludovica Martino per il film 'Il campione' di Leonardo D'Agostini, “per aver dato al personaggio di Alessia la giusta dose di genuinità e dolcezza” e per la sua “presenza luminosa e schietta che lascia il segno ogni volta che compare sullo schermo”.
Le altre candidate erano Anastasiya Bogach (Fiore gemello), Ginevra Francesconi (The Nest - Il Nido), Angela Fontana (Lucania - Terra Sangue e Magia) e la coppia Blu Yoshimi - Denise Tantucci (Likemeback).
Passando alle categorie dedicate alla serialità televisiva, la Migliore Attrice - Fiction è risultata Carlotta Antonelli per il suo ruolo nella serie originale Netflix Suburra - la serie 2, “per la capacità di rappresentare con intensità, in primis attraverso un convincente lavoro sugli sguardi e sulla gestualità, la forte determinazione del personaggio di Angelica”. Antonelli era finalista con Antonia Fotaras (Mentre ero via), Benedetta Gargari (Skam Italia 3), Fotinì Peluso (La compagnia del cigno) e Valentina Romani (La Porta Rossa 2).
Sempre per Suburra - la serie 2 si è aggiudicato il premio come Miglior Attore - Fiction Giacomo Ferrara, che “a Spadino ha dato il meglio del suo talento, alternando sguardi di fuoco e sorrisi spiazzanti. E anche qualche passo di danza”. Ferrara era in gara con Giancarlo Commare (Skam Italia 3), Emanuele Misuraca (La compagnia del cigno), Eduardo Valdarnini (Suburra - la serie 2) e Lorenzo Zurzolo (Baby 2).
Consegnato inoltre il Premio speciale Under 30 New Generation al regista 22enne Phaim Bhuiyan per il film Bangla [+], riconoscimento assegnato dalla direzione artistica del progetto e proposto per valorizzare tematiche contemporanee e universali come l'integrazione e il rispetto reciproco.
Infine, è la 19enne Jenny De Nucci la vincitrice del Premio speciale Under 30 New Media, riconoscimento proiettato nel futuro delle professioni legate all'arte e alla comunicazione, e assegnato da una giuria di studenti delle scuole superiori.
I premi:
Miglior Attore – Cinema
Giulio Pranno - Tutto il mio folle amore
Migliore Attrice – Cinema
Ludovica Martino - Il campione
Migliore Attrice – Fiction
Carlotta Antonelli - Suburra - la serie 2
Miglior Attore – Fiction
Giacomo Ferrara - Suburra - la serie 2
Premio speciale Under 30 New Generation
Phaim Bhuiyan - Bangla
Premio speciale Under 30 New Media
Jenny De Nucci
EUROPEAN FILM AWARDS 2019
La favorita trionfa a una cerimonia degli European Film Awards impegnata politicamente
di Elena Lazic
09/12/2019 - Il film di Yorgos Lanthimos ha fatto la parte del leone lasciando poco altro agli altri nominati, con poche eccezioni come Antonio Banderas, Céline Sciamma e Les Misérables.
Forse c’era da aspettarselo di vedere il film "più" europeo in competizione ai 32mi European Film Awards tornarsene a casa con così tanti premi. 'La favorita', diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, una coproduzione irlandese-britannico-americana con protagonista un cast in gran parte inglese, ha vinto un totale di 8 premi durante la cerimonia, che si è svolta presso l'Haus der Berliner Festspiele a Berlino sabato 7 dicembre. Dopo aver dominato le categorie tecniche con quattro premi (Fotografia, Montaggio, Costumi, Trucco e acconciature), il film ha visto il produttore Ed Guiney salire sul palco per conto di Lanthimos due volte (per il Regista europeo e la Commedia europea), e introdurre un messaggio registrato di ringraziamento da parte di Olivia Colman per la sua vittoria come Attrice europea.
Il film ha lasciato poco spazio agli altri candidati, ma le sorprese non sono mancate. Uno dei momenti più toccanti di una cerimonia altrimenti irriverente (per fortuna), introdotto con grande entusiasmo da Anna Brüggemann e Aistė Diržiūtė, è stata la vittoria come Attore europeo di Antonio Banderas per la sua interpretazione in 'Dolor y gloria' di Pedro Almodóvar. Impossibilitato a partecipare, l'attore, visibilmente commosso, si è unito alla cerimonia via Skype e ha ringraziato il regista.
Un'altra grande e piuttosto inaspettata vittoria per la Spagna è stata nella categoria Film d'animazione europeo, in cui 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' di Salvador Simó ha battuto i contendenti di Cannes 'J'ai perdu mon corps' e 'Les Hirondelles de Kaboul', così come il nominato di Annecy Marona’s 'Fantastic Tale'.'Les Misérables' di Ladj Ly, che ha vinto il premio Scoperta europea - FIPRESCI.
La Germania, paese ospitante, ha avuto la sua quota di vincitori. Oltre alla già annunciata vittoria di John Gürtler per la Colonna sonora originale europea per 'System Crasher', il paese è stato celebrato anche ottenendo il nuovo premio Serie fiction europea, andato a Babylon Berlin, che ha visto molti del cast e della troupe dello show salire sul palco. Ma la celebrazione più lunga e sontuosa è stata per Werner Herzog, a cui è stata dedicata una performance esilarante sulla sua vita e carriera in suono e immagini prima che il presidente della European Film Academy Wim Wenders gli cantasse una breve interpretazione di "Nothing Compares 2U" e gli consegnasse il Premio alla carriera. Herzog ha ringraziato il suo produttore Lucki Stipetić e ha incoraggiato tutti a celebrare e difendere l'Unione europea per aver concesso ai film di piccoli paesi una visibilità maggiore di quella che avrebbero avuto da soli. Ha anche elogiato l'Unione europea come il miglior progetto di pace nel mondo, opponendolo a "sciocchi tentativi di creare la pace mettendo fiori nei fucili".
L'idea che l'Europa sia un agente attivo e funzionante per la pace è stata vibrante per tutta la serata, specialmente quando Mike Downey, neoeletto presidente della European Film Academy, ha invitato sul palco il regista ucraino Oleg Sentsov, recentemente rilasciato dal carcere in Russia dopo oltre cinque anni. Downey ha colto l'occasione per annunciare la creazione da parte della European Film Academy, insieme a IDFA e IFFR, dell'International Coalition for Filmmakers at Risk, un'organizzazione volta a sostenere i cineasti che affrontano persecuzioni politiche per il loro lavoro. Fortunatamente, l'annuncio è arrivato lontano da qualsiasi menzione a Roman Polanski, nominato in diverse categorie per 'L’ufficiale e la spia'; menzioni che hanno ricevuto timidi applausi dal pubblico e sono state precedute da una spiegazione di Downey a inizio serata, secondo cui, alla luce delle recenti accuse contro il regista, l'Accademia stava cercando di "rivedere le sue misure disciplinari".
Mix riuscito di impegno e irriverenza, la cerimonia ha visto anche il regista polacco Paweł Pawlikowski ricevere il People's Choice Award per 'Cold War', accompaganto da un'umoristica osservazione su come la gente sia stata recentemente incline a fare scelte terribili. Edward Watts, regista con Waad Al Khateab del Documentario europeo vincitore 'For Sama', ha dichiarato che la squadra britannica del film è stata particolarmente felice di vincere un premio europeo mentre il paese è nel bel mezzo dei negoziati sulla Brexit. La produttrice croata Ankica Jurić Tilić, vincitrice dell'Eurimages Co-Production Award, ha elogiato allo stesso modo lo spirito europeo di collaborazione e tolleranza, che sperimenta ogni giorno nel suo lavoro di produttrice e coproduttrice.
La lista completa dei vincitori:
Film europeo
La favorita – Yorgos Lanthimos (Irlanda/Regno Unito/Stati Uniti)
Documentario europeo
For Sama – Waad Al Khateab, Edward Watts (Regno Unito/Stati Uniti)
Commedia europea
La favorita – Yorgos Lanthimos
Regista europeo
Yorgos Lanthimos – La favorita
Attrice europea
Olivia Colman – La favorita
Attore europeo
Antonio Banderas – Dolor y gloria (Spagna)
Sceneggiatura europea
Céline Sciamma – Ritratto della ragazza in fiamme (Francia)
Scoperta europea - Premio FIPRESCI
Les Misérables – Ladj Ly (Francia)
Film d'animazione europeo
Buñuel en el laberinto de las tortugas [+] - Salvador Simó (Spagna/Paesi Bassi)
Cortometraggio europeo
The Christmas Gift - Bogdan Mureşanu (Romania/Spagna)
People's Choice Award
Cold War - Paweł Pawlikowski (Polonia/Regno Unito/Franciia.
Direttore della fotografia europeo
Robbie Ryan – La favorita
Montatore europeo
Yorgos Mavropsaridis – La favorita
Scenografo europeo
Antxon Gómez – Dolor y gloria
Costumista europeo
Sandy Powell – La favorita
Acconciatore e truccatore europeo
Nadia Stacey – La favorita
Compositore europeo
John Gürtler – System Crasher (Germania)
Sound designer europeo
Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova e Laurent Chassaigne – Una notte di dodici anni (Uruguay/Spagna/Argentina/Francia/Germania)
Effetti visivi europei
Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen e Torgeir Busch – About Endlessness(Svezia/Germania/Norvegia.
Eurimages Co-Production Award
Ankica Jurić Tilić
Serie Fiction Europea
Babylon Berlin
*
 - Musica
- Musica
Novara Jazz - per concludere l’anno in bellezza
Novara Jazz - Tutti insieme per concludere l'anno in bellezza.
Una serie di concerti in location insolite, come la chiesa di San Giovanni Decollato proponendo le mille sfaccettature del jazz.
Nuova serie di appuntamenti nella splendida cornice della chiesa di San Giovanni decollato a Novara. Si comincia mercoledì 11 dicembre, alle 19, con il solo di sassofono di Luca Specchio. Brani originali che creeranno un'atmosfera davvero speciale. Si prosegue il 18 dicembre, ore 19, con la tromba di Vito Emanuele Galante e le sue composizioni di grande respiro.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.
Tasteofjazz @ Opificio - Cucina e Bottega
Non mancano i concerti dell'appuntamento settimanale Taste of Jazz a Opificio - Cucina e Bottega, ogni giovedì sera. Sul palco dell'area Boccascena saranno tanti gli artisti che si esibiranno.
Il 5 dicembre a esibirsi il duo Davide Rinella e Simone Quatrana, un progetto che vede psichedelia, jazz, funk, groove, ritmi meccanici, ironia e introspezione, semplicità e caos come protagonisti.
Domenica 8 Dicembre - Aldo Mella e Lorenzo Cominoli (nella foto) - Aperitivo in... Jazz che hanno creato questo progetto dedicato a Charlie Christian, Padre della chitarra elettrica nel Jazz (e non solo…). Chitarre semiacustiche e classiche si uniscono alla sonorità di contrabbasso e basso elettrico oltre all’impiego di effettistica e loops dando vita a sonorità calde e melodiche oltre che ipnotiche ed etniche a tratti.
Giovedì 12 dicembre sul palco Carlo Nicita e Simone Mauri Quartet che dialogano improvvisando per creare paesaggi variopinti, attraverso composizioni originali e standard jazz in continua evoluzione e una costante ricerca creativa basata su ascolto e interplay. Carlo Nicita flauto, Simone Mauri clarinetto basso, Tito Mangialajo Rantzer contrabbasso, Massimo Pintori batteria.
Il 19 dicembre a suonare il Paolo Fabbri Jazz Ensemble con il loro standard jazz. Il repertorio comprende brani di Duke Ellington, Telonius Monk, Oliver Nelson, Charlie Parker, Wayne Shorter e di molti altri artisti che hanno fatto la storia di questa musica afro americana. Paolo Fabbri sax tenore, sax baritono, flauto, Gianni Belletti flicorno, Tommaso Uncini sax alto, Alessandro Manni Villa pianoforte, Massimo Erbetta contrabbasso, Davide Stranieri batteria.
Tutti i concerti inizieranno alle ore 20:30
La serata musicale Taste of Jazz può essere accompagnata dai vini e cocktails e dalle specialità gastronomiche proposte da Opificio. Per informazioni e prenotazioni 03211640587.
Aperitivo in... jazz @ Piccolo Coccia
Per l'ottava stagione consecutiva, NovaraJazz firma il programma degli Aperitivi in... Jazz del Teatro Coccia. Sette domeniche mattina, alle 11:30 al Piccolo Teatro Coccia, durante le quali si degusteranno prima del concerto alle 11 nel foyer del Teatro Coccia specialità della produzione enogastronomica del territorio.
Calendario NovaraJazz
Dicembre 2019
Giovedì 5 dicembre 2019, ore 20:30 – Opificio - Cucina e Bottega
Davide Rinella e Simone Quatrana - tasteofjazz
Domenica 8 dicembre 2019, ore 21:10 - Piccolo Coccia
Aldo Mella e Lorenzo Cominoli - Aperitivo in... Jazz
Aldo Mella contrabbasso, basso elettrico a 6 corde, loops e effetti; Lorenzo Cominoli chitarre, loops e effetti
Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 19:00 – Chiesa di San Giovanni Decollato
Luca Specchio
Giovedì 12 dicembre 2019, ore 20:30 – Opificio Cucina e Bottega
Carlo Nicita e Simone Mauri Quartet - tasteofjazz
Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 19:00 – Chiesa di San Giovanni Decollato
Vito Emanuele Galante
Giovedì 19 dicembre 2019, ore 20:30 – Opificio Cucina e Bottega
Paolo Fabbri Jazz Ensemble - tasteofjazz
*
 - Poesia
- Poesia
M. Grazia Galatà ... o l’incognita moltitudine delle parole.
Raccolta poetica - Marco Saya Edizioni - 2018
“. . oltre il muro dell’innocenza […] taci o brivido / all’acuirsi del sonno / retto appena nel nudo silenzio”
“. . c’è solo il tempo del distacco […] quel quarto lato della coscienza / l’attimo / oltre / je m’appelle”
“. . sarà (?), la migranza dei nostri sogni / o l’affaticamento / di un silenzio ambrato all’ora giunta / di un improbabile ritorno forse”
«L’inconcio si esprime per immagini», usava dire Carl Gustav Jung, quelle stesse immagini che la memoria smuove allo sguardo retrospettivo dell’autrice di “Quintessenze”, nel consegnare le parole alla superficie della pagina, volendo restituire una qualche finitezza all’apparire.
Per quanto ciò che appare ben presto svanisce, ancor più dell’assenza violata delle parole, prima che le immagini trovino sulla pagina le risposte più adatte alle tante domande che l’autrice si pone in finitezza d’inganno, in assenza di ciò che riversa in esse la voce nel declamarle all’inconscio.
“. . che il silenzio rimanga / tra la porta della quinta / essenza o un tramite / dell’incandescente / la mira delle speranze / nella ripetizione di / un singolo respiro”
Tant’è che le parole ancor non dette necessitano di leggersi con enfasi, non d’essere tradotte, perché sono esse stesse immagini, catturate nel momento della rêverie, in cui la memoria s’apre all’inconscio, a quell’ “ignota moltitudine di nulla” (Pessoa) che noi siamo in assenza di voce.
Sì che ci si può perdere negli spazi bianchi fra le righe andando alla ricerca della parola mancante, nell’intuizione delle domande che non chiedono risposta alcuna, e che quasi, viene da chiedersi se mancando davvero esiste, o se mai giungerà alla sua epifania, nell’approsimarsi del tempo che si concede.
“. . è nei piani del tempo
quell’avvicinarsi ambiguo
all’innocenza
o dell’amore leso
nella solita impervia salita
che appena appena tocca”
“Quintessenza” come essenza del fluire della parola nuda nell’ “aspetto liquido” (Bauman) della realtà delle cose, metafora della estraneità afferente ai fatti della vita, in quanto delatori di edenica memoria, della fiducia tradita, rimasta sospesa senza alcuna possibilità di riscatto.
C’è tutto l’estraneo che siamo a noi stessi nell’inconscio junghiano della frase iniziale che Maria Grazia Galatà esprime con le parole contaminate d’ignoto ancor più delle immagini che il suo fare poesia evoca, e che, invece di avvicinarsi s’allontanano nello specchio convesso della sua onirica visione.
“. . niente aveva ragione di esistere / oltre questo tempo stanco o il / battito accelerato dopo essersi / giustificati del perché si vive / e si perde […] oppure sono fumo queste memorie di attesa”
“. . forse l’apparente è un apostrofo invisibile / una riga di memoria nel lato buio / o l’addio rovescio del sale […] le attese delle guance erano terra erano / aria e tempo di mille spose / leggendo tra voci basse al petto / quando i coralli hanno abisso / / ed ebbero a dire nel sonno inquieto”
Qualcosa di indicibile, di non detto, che sa di fugace prossimità, come di verità smentita dalla realtà o forse tradita ancor prima di conoscerne l’entità, la forza nascosta di un sentimento provato che cerca una smentita, per non essere accolto fino in fondo del soffrire, di cui pure non si è perduta l’emozione.
“. . l’imbrunire delle nostre solitudini
non è che ballo ambiguo di
corrispondenze e maginazione
fascinata da questo segreto improvviso
nei pasti nudi intatti di forse
prendi piano le mie emozioni
delle prime luci quando il doppio
sarà altro o alta estasi
nella follia riflessa moltiplicata
spazio scenico o immerso nulla
sospensione di una vita spazzata”
“Quintessenza” di cui sentiamo il bisogno, affinché la parola mancante renda alla possibilità dell’istante, seppure violato, di assolvere al dovere di renderci quella felicità che volevamo, per cui sentire nella vita che pulsa, ancora il brivido fremente dell’amore, ancor prima che ci colga nell’apparire estremo, il perdurare della presenza nell’assenza.
“. . negli inverni di notti violate
da mille solitudini
mi fanno già male gli anni che
non avrò partendo da un informe
giaciglio giacendo inadatta
tale è là
frequenza di immagini
sovrapposte e
lunga è la mano che poggia
l’attimo nel tempio dei miracoli
quando tutto sembra perfetto”
Ma quale e quanta solitudine disconosce la felicità “. . di quando il ricordo era più forte” (?), si domanda, o forse si risponde Maria Grazia Galatà, nell’incedere dei passi che la vedono attenta “. . nelle ore del silenzio – quando – le fragole sono dolci – che – nemmeno le vedi”.
Una sospensione di tempo che lascia sperare nella produzione di ‘senso’, quasi da illudersi/ci che la filosofia infine salverà la poesia dall’amara esperienza, dalla caducità dell’anima assorta; sicché “. . la pioggia cade sempre forte / nei solchi delle guance quando / giunge il tempo dei nodi quelli / che ti chiudono nelle ore del / silenzio”.
È allora che ho sentito: “. . dal cielo cade(re) una rosa […] misera misericordia”, ed ancora “. . ho sentito fermarsi il respiro / in questo tempo malato e la / forma non ha spazio ma cadute […] piove – non senti i lamenti dei vuoti lasciati?”. C’è ancora una qualche verità in questo “. . luogo delle ombre / di vana fertile coscienza / la traccia silenziosa / di una città sospesa”.
No, si risponde l’autrice: “. . lì dove non è vento nelle mille costellazioni / tra le rughe del giorno si aprono le porte / del tempo che dilata gli anni / non c’è niente ch’io possa vedere più della / luce riflessa senza passare per le voglie / di carta (ricordi?) / le arance fiere l’odore / di bruciato – bisognerebbe sentire il profumo / dell’erba – la nebbia – fino allo stordimento / assecondando la solitudine di questo lungo / istante sfocato”.
Ma noi che leggiamo, sentiamo quell’aroma che sa di bruciato nelle parole del poeta, e mai abbiamo pensato che sia possibile evitarlo, solo ubriacarsi di esso, assaporare fino in fondo il gusto del miele affumicato, forse, ma pur sempre con quel retrogusto dolce che porta a illuderci, con Maria Grazia Galatà, ancorché “. . dalla mia (sua) più nuda / realtà / ne gli attimi di tempo […] mentre tutto s’ovatta – i suoi occhi – hanno visto la nebbia / salire fino al cielo” della speranza . . .
“. . c’è un silenzio assordante e tacito / per tutte le volte che ho sognato il mare.”
L’autrice.
Maria Grazia Galatà nativa di Paermo risiede da tempo a Mestre Venzia, ha all’attivo numerose pubblicazioni e rilevanti premi nel panorama della poesia e non solo. È presente in diversi siti web e cataloghi d’arte internazionali e fotografa di professione (è infatti sua l‘originale foto di copertina, e inoltre si dedica da diversi anni nell’ambito della ricerca.
Va qui ricordata la sua partecipazione alla Biennale di Venezia 2009; “Altrove” un ‘reading con videoproiezione 2010; la Mostra fotografica personale “Simmetria di un’apparenza” – presso la Galleria d’Arte dell’Istituto Romeno di Venezia; nonché la partecpazione alla 2° edizione di “Congiunzioni Festival Internazionale di Poesia 2017”.
Sitografia: www.mariagraziagalata.it
Il libro “Quintessenze” è edito da Marco Saya Editore – info@marcosayaedizioni.com
*
 - Filosofia
- Filosofia
A Tolentino - la 30a Biumor / Popsophia
A TOLENTINO – 30a BIUMOR / POPSOPHIA
Si celebra quest’anno la Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte.
“Un'opportunità di intrattenimento intelligente, spettacolare e popolare per ragionare sui temi del mondo contemporaneo”.
Tema dell’avvenimento è: “L’ODIO”
Io conosco la gente, cambia in un giorno.Elargisce con la stessa generosità il suo odio e il suo amore.Voltaire Gli artisti della XXX Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte si interrogano su una parola d’ordine politicamente dirompente e culturalmente dominante: “l’odio”. Proprio questo sarà il tema delle quattro giornate di Biumor, il festival dell’umorismo di Popsophia. Dall’origine antropologica alla sua metamorfosi digitale, dai fatti di cronaca alle creazioni dell’immaginario, dai social network alle opere cinematografiche: il festival sarà un’indagine senza sconti dei linguaggi dell’odio contemporaneo con la lente d’ingrandimento della filosofia. Un tema di stringente attualità che merita di essere affrontato senza facili moralismi. L’odio che dilaga sul web, oltre a essere l’inestirpabile retaggio di un passato che non passa, è un’intossicazione pericolosa di cui siamo al contempo colpevoli e vittime. In un clima saturo di passioni biliose, proprio la cultura e la filosofia, amiche del dubbio e nemiche del fanatismo, possono rappresentare una scialuppa di salvataggio contro l’odio settario e beota degli haters. Lucrezia Ercoli Direttrice Artistica Popsophia
La Trentesima edizione della Biennale caratterizza il novembre tolentinate e torna nel centro storico per realizzare un evento culturale inedito in una città che si è sempre distinta per innovazione artistica e promozione turistica. Un’occasione importante per contribuire alla ripresa del territorio dopo gli eventi sismici, che rilancia il dibattito culturale intorno ai temi legati alla nostra Biennale dell’Umorismo, un’eccellenza della città di Tolentino. Giuseppe Pezzanesi, Sindaco di TolentinoLe giornate della Biennale di fine novembre nel centro storico di Tolentino sono un'opportunità di intrattenimento intelligente, spettacolare e popolare per ragionare sui temi del mondo contemporaneo. Per Tolentino è un'ottima occasione per aumentare il richiamo turistico dello splendido museo dell'umorismo e di tutto il territorio comunale.Silvia Luconi, Vicesindaco e Assessore al Turismo La Biennale dell’Umorismo nell’Arte si conferma dopo ben trenta edizioni come grande evento internazionale, capace di rappresentare la cultura della creatività artistica utilizzando gli strumenti della satira e del sorriso. Un’eccellenza che contribuisce a rendere Tolentino una città moderna che ha la capacità di entrare nella battaglia delle idee oltre i confini regionali. Biumor si conferma un progetto di respiro nazionale che valorizza le eccellenze del nostro territorio e contribuisce a rilanciare dopo i danni degli eventi sismici il valore turistico del centro storico. Silvia Tatò, Assessore alla Cultura.
MOLTI INGRESSI GRATUITI.
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1329 7 settembre 2018) e di credito formativo per gli studenti.
LE MOSTRE:
La 30a edizione a Palazzo Sangallo : LA MOSTRA E IL MUSEO 21 novembre 2019 / 26 gennaio 2020.
Il 2019 mobilita l’arte umoristica nazionale e internazionale per celebrare la 30a edizione del concorso della Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte con grandissime novità.La mostra delle opere in concorso ripropone con forza una eccellenza internazionale che contraddistingue il nostro territorio. Il trentesimo anniversario del concorso si svolge in un contesto prezioso, il Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte – Miumor. Unica nel suo genere in Italia, la collezione di Palazzo Sangallo custodisce disegni, illustrazioni, caricature, sculture e dipinti di artisti di calibro nazionale e internazionale. La mostra delle opere sul tema dell’odio vi aspetta per scoprire un altro lato dell’arte, quella che, nonostante venga considerata un’arte minore, è capace, più di ogni altra forma dell’espressione artistica, di parlare direttamente e chiaramente a tutti.
LE MOSTRE: NORBERTO BOBBIO E L’ELOGIO DELLA TOLLERANZA NELL’ARTE DI MAURIZIO GALIMBERTI:
La figura di Norberto Bobbio è al centro di uno dei lavori più affascinanti di Maurizio Galimberti. Il raffinato fotografo, maestro indiscusso nell’uso della Polaroid in particolarissimi “mosaici fotografici”, è già stato ospite d’onore del festival Popsophia. Galimberti, infatti, ha sempre raccontato mediante l’occhio delle istantanee soggetti dall’identità unica, dai protagonisti della cultura pop internazionale (da Lady Gaga a Johnny Depp) fino alle grandi personalità della cultura italiana. E quello con Norberto Bobbio è stato uno degli incontri più significativi per il maestro del ritratto. A Biumor 2019, a 110 anni dalla sua nascita, lo ricordiamo come un intellettuale che ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale del nostro Paese, un invito al dialogo come antidoto al linguaggio dell’odio. Gli scatti, prezioso ricordo di un incontro, confluiranno in una mostra, resa possibile grazie alla collezione del dottor Alberto Marcelletti, mecenate con attento occhio artistico.
LE MOSTRE : FEDERICO FELLINIE LA BIENNALE
Il 2020 sarà l’anno di Federico Fellini. Tolentino si unisce agli eventi che ne celebreranno il mito con il significativo tributo della Biennale. Nel 1991, infatti, Fellini raggiunse la città per inaugurarne l’edizione numero XVI del concorso. L’ambizione è di iniziare da questo indelebile ricordo, rivivendolo con immagini, video e protagonisti dell’epoca, per arrivare a una selezione di disegni umoristici dedicati al grande maestro che provengono dal museo di Tolentino Miumor. Un’ulteriore occasione per ribadire il genio di Fellini disegnatore: la mostra affronterà aspetti inediti e reconditi della figura del grande maestro e del legameche ebbe con l’umorismo.
O R E 17. 3 0AUDITORIUM ASSM VIA ROMA 36Eroismi giovanilinuovi linguaggi e nuove generazionicontributi video degli studentidell’I.I.S. Francesco Filelfoindirizzo Liceo Classicocorso Comunicazione e Nuovi MediaintervengonoSilvia TatòAssessore alla CulturaDonato RomanoDirigente dell’I.I.S. Francesco FilelfoClaudia CanestriniCoordinatrice Liceo ClassicoRiccardo Minnucci Videomaker Popsophia
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE / biumor young
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1329 7 settembre 2018) e di credito formativo per gli studenti.
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
ORE 17.00 PALAZZO SANGALLO, SALA MARIMUSEO DELL’UMORISMO inaugurazione mostra: La 30a Biennale “L’odio”
ORE 18.00 POLITEAMA inaugurazione Mostre Surreale, poetico e visionario Federico Fellini e la Biennale a cura di Giancarlo Cegna Maura Gallenzi Giorgio Leggi Agnese Paoloni Elogio della tolleranza ritratto di Norberto Bobbio di Maurizio Galimberti
ORE 18.30 Filosofia dell’odio la lezione dell’immagine lectio inauguralis con Massimo Donàe Maurizio Galimberti
ORE 19.30 La pausa buffet a cura dell’Alberghiero “Varnelli”di Cingoli
ORE 21.30 POLITEAMA Concorsopremiazione dei vincitori della 30a edizione della Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte Umorismo 2.0 premio Accademia teatro Degrado Postmezzadrile interviene Piero Massimo Macchini premio Accademia social Lercio.it premio Accademia videoTerzo Segreto di Satira premio alla carriera Iginio Straffi Presidente del Gruppo Rainbow.
VENERDÌ 22 NOVEMBRE
ORE 18.00 POLITEAMA Un ‘silenzioso’ sguardo nello humour con Paolo Della Bella Pietro Frenquellucci
ORE 18.45 Odiare ti costa con Andrea Colamedicie Maura Gancitano (Tlon)
TEATRO VACCA J. ORE 21.15 LECTIO POPHate Speech, con Massimo Arcangeli.
ORE 21.30 PHILOSHOWAll That Jazz il Musical e l’elogio della leggerezza spettacolo filosofico-musicale ideato e diretto da Lucrezia Ercoli interviene Saverio Marconi ensemble musicale Factory voce recitante Rebecca Liberati.
PRENOTAZIONE:
telefonando a Teatro Vaccaj 0733 960059 da lunedì a venerdì orario 10-13/15-18 oppure scrivendo ainfo@teatrovaccaj.it
ORE 18.00 POLITEAMA Joker dalla parte dell’odio con Riccardo Dal Ferro
ORE 18.45 I duellanti dalla novella di Joseph Conrad al film di Ridley Scott con Maurizio Blasi letture Rebecca Liberati.
SABATO 23 NOVEMBRE
TEATRO VACCA J. ORE 21.15 LECTIO POPHate Speech con Angela Azzaro e Piero Sansonetti.
ORE 21.30 PHILOSHOW All You Need is Love I Beatles e l’elogio della leggerezza spettacolo filosofico-musicale ideato e diretto da Lucrezia Ercoli Interviene Carlo Massarini ensemble musicale Factory voce recitante Rebecca Liberati.
PRENOTAZIONE telefonando a Teatro Vaccaj0733 960059da lunedì a venerdì orario 10-13/15-18 oppure scrivendo ainfo@teatrovaccaj.it
Con gli interventi prestigiosi di:
MASSIMO ARCANGELI Professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Cagliari. Dal 2010 è docente di teoria e tecnica del linguaggio giornalistico presso l’Università LUISS – Guido Carli. Numerose le collaborazioni con testate nazionali. Tra le sue ultime pubblicazioni “All’alba di un nuovo medioevo. La comunicazione al tempo di internet” (2016); “Faccia da social. La comunicazione su Facebook” (con Valentino Selis, 2017).
ANGELA AZZAROGiornalista, già caporedattrice de “Il dubbio”, giornale promosso dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana del Consiglio Nazionale. Dal mese di ottobre 2019 è vicedirettrice e caporedattore della nuova edizione del quotidiano “Il Riformista”. Prima a “Liberazione” (ne curava anche l’inserto culturale della domenica) e vicedirettore de “Gli Altri”.
MAURIZIO BLASI Giornalista, di origine fermana, entrato in Rai nel 1978 attraverso i concorsi pubblici che diedero il via alla Terza Rete Tv. Dal 1988 è in forza alla redazione delle Marche, e per 12 anni ha condotto il Tg itinerante, che ha conseguito importanti risultati di ascolto. Dal 2014 è caporedattore della redazione marchigiana della Rai.
RICCARDO DAL FERROFilosofo, scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione. Direttore delle riviste di filosofia contemporanea Endoxa e Filosofarsogood, porta avanti il suo progetto di divulgazione culturale attraverso il suo canale Youtube “Rick DuFer”. Performer ed autore teatrale, insegna scrittura creativa presso la scuola da lui fondata a Schio (VI) “Accademia Orwell”. Nel 2014 esce il suo romanzo “I Pianeti Impossibili”. Nel 2018 esce il saggio “Elogio dell’idiozia” e nel 2019 “Spinoza e popcorn”.
PAOLO DELLA BELLA Artista fiesolano, Medaglia d’Oro al Salone Internazionale dei Comic di Lucca nel 1967. Nel 1967 ha fondato, insieme a Graziano Braschi e Berlinghiero Buonarroti, il Gruppo Stanza, impegnato nella diffusione e nella divulgazione dell’umorismo grafico d’autore. È autore del libro “Uno Sguardo profondo. Viaggio nello Humour e nella Satira” in collaborazione con Claudia Paterna e Laura Monaldi, con la prefazione di Stefano Salis, in cui sono raccontati gli incontri con i grandi maestri dell’umorismo.
MASSIMO DONÀ Musicista e filosofo, è professore ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Ha all’attivo ben 7 CD musicali incisi con i suoi gruppi. Tra le sue ultime pubblicazioni filosofiche: “La filosofia di Miles Davis. Inno all’irrisolutezza” (2015); “Tutto per nulla. La filosofia di William Shakespeare” (2016); “La filosofia dei Beatles” (2018).
LUCREZIA ERCOLIDottore di ricerca in filosofia presso l’Università Roma Tre. Docente di “Storia dello spettacolo e filosofia del teatro” presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e di “Storia della televisione” e “Filosofia dell’arte” presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. È direttrice artistica di Popsophia dal 2011. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Filosofia della crudeltà. Etica ed estetica di un enigma” (2015); “Filosofia dell’Umorismo” (2016); “Che la forza sia con te! Esercizi di popsophia dei mass media” (2017).
SAVERIO MARCONI Attore di cinema, teatro, radio e tv, e regista teatrale. Firma la regia di innumerevoli opere teatrali, opere liriche, musical che gli fanno ottenere prestigiosi riconoscimenti, da ultimo l’Oscar Italiano del Musical nel 2015. Fa nascere a Tolentino la Scuola di Recitazione di cui è ancora oggi direttore artistico e nel 1983 la Compagnia della Rancia. Tra le sue ultime produzioni, nel 2018 il musical “Big Fish” a Tolentino per la riapertura del Teatro Vaccaj. Dal 2019 è Presidente Onorario della BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna.
CARLO MASSARINI Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Dal 1981 al 1984 è conduttore e autore della famosa trasmissione di Rai1 “Mister Fantasy” dedicata alla videoarte e al videoclip e dal 1995 al 2002 conduce MediaMente per Rai Educational. Dal 2014 conduce su Virgin Radio la seguitissima trasmissione “Absolute Beginners”. Tra le sue numerose pubblicazioni legate alla critica musicale, Dear Mister Fantasy (2009).
PIERO SANSONETTIGiornalista di politica italiana e di esteri. Dal mese di ottobre 2019 dirige la nuova edizione del quotidiano “Il Riformista”. Inizia a l’Unità nel 1975, prima come cronista, poi come notista politico, caporedattore, vicedirettore e codirettore. Corrispondente fino al 1996 dagli Stati Uniti. Dirige poi Liberazione e collabora con Il Riformista. Nel 2010 conduce Calabria Ora. Lavora alla nascita del quotidiano Gli Altri e di Cronache del Garantista. Fino al 2019 è stato direttore del Il Dubbio.
TLON Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori del progetto Tlon (Scuola di Filosofia, Casa Editrice e Libreria Teatro). Insieme hanno scritto Lezioni di Meraviglia (2017), La società della performance (2018), e Liberati della brava bambina (2019). Hanno realizzato per Amazon Audible i podcast “Scuola di Filosofie”. Sono promotori, insieme all’avvocata Cathy La Torre, dell’iniziativa “Odiare ti costa”, campagna contro l’hate speech sul web.
PATROCINI
Presidenza del Consiglio dei MinistriMinistero per i Beni e le Attività CulturaliMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della .
CONTRIBUTI
Arianna Berroni, Maria Rossella Bitti, Mauro Cicarè, Mara D’Amico, Mauro Evangelisti, Pierandrea Farroni, Rossella Ghezzi, Gianni Giuli, Giulia Lazzari, Loredana Leoni,Piero Massimo Macchini, Cinzia Maroni, Caterina Marziali, Edoardo Mattioli,Mauro Minnozzi, Laura Mocchegiani, Gisella Quaglietti, Carla Sagretti, Vando Scheggia, Sofia Tomassoni, Mirella Valentini, Viola Vanella, Massimo Zenobi
COLLABORAZIONI CULTURALI
Biblioteca Filelfica, Istituto Alberghiero Varnelli Cingoli,I.C. Don Bosco, I.C. Lucatelli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, I.I.S. Francesco Filelfo, IPSIA Renzo Frau, UniTre Tolentino.
PARTNER EDITORIALE Casa Editrice ‘Il Melangolo’
STAFF TECNICO DFL ServiceTecum Srl
*
 - Cinema
- Cinema
Ceneuropa Italian Film Reviews
Recensione: "Tutto il mio folle amore"
di Camillo De Marco
24/10/2019 - Gabriele Salvatores non teme di toccare il cuore del pubblico con il viaggio di un padre assieme al figlio autistico, con qualche cliché e una regia di alto livello.
“Io sono strano, tu sei strano. Dove andiamo?!” urla Willi (Claudio Santamaria) al figlio sedicenne Vincent (Giulio Pranno) mentre sono in fuga su un furgone in Tutto il mio folle amore - presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia 2019 - film con cui Gabriele Salvatores è tornato “on the road again”, con i suoi paesaggi visceralmente emozionali.
Cantante di matrimoni squattrinato e ad alto tasso alcolico in perenne tournée nel Nord Est (lo chiamano il “Modugno dei Balcani”) Willi ha tagliato la corda prima che Vincent nascesse e mostrasse i primi segni di autismo. La mamma Elena (Valeria Golino, che ha interpretato nel 1988 il film più famoso sull’autismo, Rain Man di Barry Levinson) lo ha allevato, con tutte le difficoltà del caso, in una gabbia dorata fatta di una casa di lusso nei dintorni di Trieste e ippoterapia, aiutata dal compagno Mario (Diego Abatantuono), facoltoso editore di romanzi e poesie. Folgorato sulla strada della celebre ballad “Vincent” di Don Mc Lean, Willi irrompe in casa di Elena per sapere del figlio. Quando riparte, si accorge che l’inarrestabile Vincent si è nascosto nel suo pick up. Il musicista si è impegnato in una serie di date in Croazia e inizia così un viaggio fisico e sentimentale, di avvicinamento padre-figlio, di riscoperta di se stessi e dell’altro. Un viaggio attraverso territori deserti e spesso colorati dell’ex Jugoslavia, punteggiato da episodi bizzarri e spassosi, conditi con alcol e sesso iniziatico. Il bravo Santamaria duetta in perfetta sintonia con l’esordiente dalla faccia d’angelo Giulio Pranno, impegnato in una performance straordinaria fatta di stranezze ed eccessi, mentre la famiglia naturale parte alla ricerca del ragazzo “rapito”.
Scritto da Umberto Contarello e Sara Mosetti con il regista, il film è una trasposizione libera del romanzo di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non aver paura”, racconto autobiografico di una padre che dopo aver inseguito terapie tradizionali, sperimentali e spirituali, parte con il figlio autistico per un viaggio in moto, attraversando l’America e perdendosi nelle foreste del Guatemala. Tutto il mio folle amore sarebbe facilmente attaccabile per come è trattato superficialmente il disturbo dello spettro autistico. Anche se all’inizio del film si intuisce il disagio familiare con una scena piuttosto esplicita, si può obiettare che il dramma vissuto dai genitori di giovani affetti da questo disturbo e le difficoltà che incontrano nella società non sono raccontate. Ma Salvatores sembra aver scelto piuttosto il lato solare di questo adolescente diverso, per esprimere la relazione tra “follia” e purezza, autenticità e creatività (non a caso, la canzone “Vincent” di Mc Lean è stata ispirata dal tormento di Van Gogh). Il film mette in scena la gioia di vivere nonostante tutto, senza timore di toccare il cuore del pubblico con qualche cliché ma con una confezione visiva di altissimo livello (la fotografia è di Italo Petriccione).
Tutto il mio folle amore è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema ed EDI Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, in associazione con Unipol Banca S.p.A. Le vendite internazionali sono affidate a RaiCom. Il film sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre con 01.
Recensione: "Tornare"
di Vittoria Scarpa
28/10/2019 - Cristina Comencini ritrova Giovanna Mezzogiorno, quattordici anni dopo La bestia nel cuore, in questo thriller dell’inconscio che ha chiuso la 14ma Festa del Cinema di Roma
E’ un ritorno doppio, sia fisico che mentale, quello che compie il personaggio principale del nuovo lungometraggio di Cristina Comencini, Tornare. Ma il film, proiettato in chiusura della 14ma Festa del Cinema di Roma, segna anche il ritorno di Giovanna Mezzogiorno, quattordici anni dopo il film candidato all’Oscar La bestia nel cuore, su un set diretto dalla regista romana figlia del grande Luigi, e ai temi dell’inconscio e dei traumi rimossi. Un racconto, sotto forma di thriller, in cui passato e presente convivono, e il tempo lineare non esiste, è solo un modo per misurare il cambiamento.
La protagonista del film, Alice, si fa letteralmente in tre ed è interpretata 40enne da Mezzogiorno, adolescente dalla rivelazione Beatrice Grannò e bambina da Clelia Rossi Marcelli. Siamo nella Napoli degli anni Novanta e le tre dialogano fra loro metaforicamente (e non solo) nella vecchia casa di famiglia sul mare, disabitata, dove Alice adulta torna dopo molti anni di lontananza, in occasione della morte del padre. Lì ritrova anche sua sorella Virginia (Barbara Ronchi), con la quale decide di vendere la casa e di svuotarla quindi di tutti i loro ricordi, e un uomo misterioso, Marc (Vincenzo Amato) che negli ultimi tempi si era preso cura del padre malato.
Sarà proprio quest’uomo, di cui inizialmente Alice sembra non ricordare nulla, ad aiutarla a rimettere insieme i pezzi di un evento drammatico e determinante della sua vita. Alla fine degli anni Sessanta, la donna era un’adolescente bella e ribelle, che respirava l’aria di emancipazione del tempo, avida di libertà e divertimento. Il suo atteggiamento, la sua voglia di godersi la vita e di flirtare con tutti, era facilmente scambiato per leggerezza, in una società dell’epoca repressiva, essendo lei oltretutto figlia di un militare della marina americana. Questa sua “diversità” avrà delle conseguenze che il film ci svela gradualmente, durante un viaggio nella memoria molto doloroso.
Nel presente, Alice è una donna molto diversa da quella che fu, e sembra nutrire un senso di colpa per essere stata un tempo così spensierata e audace. Mezzogiorno incarna una donna sofferente, remissiva (anche troppo), “punita”, praticamente irriconoscibile rispetto alla ragazza degli anni Sessanta che ballava il sirtaki in costume da bagno. Da sottolineare invece la straordinaria somiglianza fisica tra le attrici che impersonano le tre diverse età della protagonista (il casting è di Laura Muccino e Sara Casani), così come l’assoluta credibilità dei tre Marc, da ragazzo interpretato da Marco Valerio Montesano e all’età di 10 anni da Alessandro Acampora.
Il tema del film è universale, è difficile perciò che non lasci un segno nello spettatore. Sarebbe bello poter rincontrare noi stessi da adolescenti e da bambini con la consapevolezza degli adulti che siamo oggi, e magari tenersi per mano. Ispirato alla storia di una sua amica, Comencini ha confessato che questo è il suo “film più libero” che scava “in un mondo interiore dove il tempo non esiste”, e nel finale, questo assunto ingarbuglia un po’ troppo le cose. Il tutto è calato in una Napoli inquietante e bellissima, lontana dai cliché, con i suoi luoghi insolitamente spopolati e le grotte sotterranee. Un film forse non facile, ma ammaliante.
Tornare è prodotto da Lumière & Co. con Rai Cinema. La distribuzione è affidata a Vision Distribution.
*
 - Libri
- Libri
La stella sibillina - un libro di Mario Nicolao
Nonostante lo scorrere del tempo, “ho desiderato il paradiso, mi sono accontetato dell’inferno”, sembra dirci ‘volando alto’ l’autore di questo prezioso cammeo che ripercorre le strade del Mito ctonio dell’Oscurità orfica, ripreso dal leggendario viaggio del poeta Orfeo nell’Ade alla ricerca di Euridice, che Mario Nicolao rintraccia, nelle tappe rilevanti della sapienza greca (del periodo arcaico VIII – VI sec. a.C.), attestandone il valore creativo, o meglio ‘la sua forza evocativa’, nell’ambito della scrittura poetica del Novecento.
Viene da chiedersi con quali occhi noi guardiamo oggi a quei cieli così gravidi di un passato senza avallo, concepito in amplessi furtivi per un misero aborto d’idee appassite, ancor prima d’esser rifiorita in noi la speranza di un futuro sagace? Con quale purezza crediamo di poter accedere alla sublimità di quell’empireo scomparso che pure ci è dato contemplare di qua dall’orizzonte, se in ultimo, ciò che alla vita compete è solo di scendere nell’immensa voragine del profondo, nell’incerto oscuro mondo che ci accoglierà furtivi?
Con quale sentire ci avvicineremo al riscatto mitico di Orfeo se l’insegnamento dei ‘grandi’ del passato sfugge alle nostre orecchie frastornate dal chiasso che fanno le dispute eccessive, i ferri battuti, gli scismi e gli squarci abbacinati delle guerre, cui pure siamo sopravvissuti e/o ancorché scomparsi, andiamo alla ricerca del carattere ‘orfico’ della liricità poetica, della bellezza onirica dell’arte, della purificazione iniziatica dell’anima, non meno del Mito che lo contempla? Ciò, per quanto l’autore non sembri in cerca di risposte ma di affermazioni, richiama alla nostra attenzione la necessaria discesa agli inferi che dobbiamo intraprendere per il suo raggiungimento.
Possiamo noi, in quanto neofiti, affermare con Mario Nicolao di essere seguaci, nonché oscuramente sibillini, di quel movimento poetico afferente all’Oscurità orfica che fin dall’antichità impone la sua presenza in molta produzione letteraria contemporanea, in cui annaspiamo al pari di clandestini in cerca di un approdo che non ci è dato? Siamo davanti alla mutazione dell’orfismo della parola, caratterizzata dalla dottrina della metempsicosi e da riti per la purificazione dell’anima riservati non più solo agli iniziati che nell’antica Grecia sceglievano (e/o erano scelti) nell’orphne la via da seguire; bensì alla copiosa ‘Oscurità orfica’ dei nostri giorni.
Numerosi sono gli esempi di riferimento ‘colto’ che l’autore raccoglie nelle pagine del libro, nei quali Thanatos (potenza ctonia degli inferi) interferisce fra vita e immortalità, come sempre sarà «..nel rapporto prima positivo poi negativo con l’amore … a causa della morte.» Ciò, per quanto l’amore, come la morte, ha molte sfaccettature diverse, si riveste di molteplici maschere, è soggetta a numerose interpretazioni che, pur tuttavia non dissimula, non occulta la fine che incombe, di cui è ‘oscura’ portatrice.
Quale fosse l’oscuro ‘sibillino’ sentire di Stéphane Mallarmé, o di Marcel Proust, di Marina Cvetaeva o di Mario Richter e Tommaso Landolfi, tutti autori ‘interpreti’ di questo libro, le cui opere Mario Nicolao scandaglia fin nel profondo nell’intento di svelarne il segreto fluire poetico, sotto l’egida landolfiana: «Nulla significare, nulla dire», permette a noi lettori di inoltrarci in quel ‘mondo profondo’ che attraversa tutta la letteratura del Novecento e che giunge fino ai nostri giorni. Tant’è che
viene da chiedersi perché non Boudelaire e tutti i ‘poeti maledetti’; perché non Bulgakov e Pirandello e/o Leopardi, perché non tanti altri … (?)
Ma questo non vuole essere un compendio di nomi da includere in una lista, bene ha fatto l’autore a limitare il campo di ricerca all’interno di un progetto letterario la cui intenzione precipua è quella di: “..avvicinarci al senso dell'Orfismo e di svelare la presenza dell’Oscurità orfica nella scrittura poetica del Novecento”; «Su cosa davvero cercavano i Greci (e dopo di loro gli altri popoli che vi hanno fatto riferimento per secoli)»; o del perché noi ancora oggi torniamo soventi al mito di Orfeo, non è dato sapere. Di certo facendo ad esso rirferimento, s'apre davanti a noi un futuro aspro che fin sulla soglia denota un oscuro sopito silenzio di morte.
Di quali accordi – mi chiedo – noi (scrittori e poeti) instancabili cercatori d'oro e di perle, di muse e d'eroi, di meraviglie già viste, consumate fino allo stremo, che abbiamo ighiottito finanche le parole, fermate sul liminare del tempo, andiamo alla ricerca? Mario Nicolao ci rammenta, in esergo, che «Il mito è ciò che non è mai avvenuto ma è sempre», a cui aggiunge a mo’ di postilla: «Orfeo , il cantore privilegiato e solitario, (è) il vero e proprio archetipo della poesia lirica occidentale»,
e che noi, in limine, siamo i suoi sudditi.
L'autore:
Mario Nicolao, nato a Pesaro, ha vissuto tra Milano, Parigi e Genova. Oltre a due libri di poesie, Carte perse e Falso Haiku, ha scritto con Vincenzo Consolo Il viaggio di Odisseo e con Aldo Buzzi Lettere sulbrodo. Ha pubblicato saggi su Tommaso Landolfi, Richard Burns, Stéphane Mallarmé, Marcel Proust e soprattutto sul poeta siriano Adonis di cui ha curato diversi libri narrativi.
*
 - Poesia
- Poesia
’Edeniche’ - raccolta poetica di Flavio Ermini
"Prolegomeni alla ricerca del ‘mito’ perduto", Introduzione critica di Giorgio Mancinelli.
Nella concezione poetica di Flavio Ermini, autore di ‘Edeniche’, difficilmente si arriverebbe a una ‘dismissione del mito’ così come è giunto a noi contemporanei, per quanto gli effetti della sua ‘caduta’ si dimostrino oggi irreversibili, privata com’è della tesi che l’ha sostenuta fin dall’origine. Tesi che, dapprima Kant poi Jung e Kerényi hanno posto in evidenza, in quanto rappresentazione dell’inconscio collettivo primordiale, come “creazione mitica del pensiero umano”, d’appartenenza specifica alla sfera della psiche. Una ‘dismissione’ dubbia che pure c’è stata, e di cui oggi si tende a sminuire l’importanza, malgrado volenti e/o nolenti, non riusciamo ancora a fare a meno della ‘prestanza creatrice del mito’ che, come già Hegel a sua volta ha dimostrato, si palesa come essenza di “pura disciplina fenomenologica dello spirito”:
«non ha fondamento né gravità l’antro dei cieli / discosto com’è dal fuoco al pari del mondo abitato / che dalle acque creaturali viene circoscritto / per quanto non si tratti che di assecondare la caduta / consentendo così alle residue forze relittuali / di protendersi una volta ancora verso il principio / […] desituandoci dalle nostre abitudini cognitive / per esporci all’assoluto contrasto che si afferma / nel secondo principio di ascensione al cielo / […] nel varcare con reticenza il limite che ci separa / dalla superficie celeste dell’ultima terra / con la segreta illusione di rivelarne la natura».
Non mi è dato conoscere quanto consapevolmente ogni singolo autore citato, e lo stesso Flavio Ermini, “nel fondare il mondo sulla ragione”, abbiano visto negli effetti della ‘caduta edenica’, la perdita delle forme archetipe della psiche, attraverso le quali lo spirito umano pure s’innalza verso il sapere assoluto. Di fatto, con la compiuta ‘dismissione’ della pregressa mitologia senza uno scopo definito, seppure sostituita per ciò che riguarda l’attualità da nuovi ‘déi ed eroi’ di recente conio e piuttosto avulsi da virtù etiche ed estetiche “quale testimonianza dell’oscurità che si cela / nell’impreciso vuoto del presente”, si è creato un ‘nulla prepositivo’ nella conoscenza collettiva di non facile riempimento psicologico, che sta portando a uno sconvolgimento profondo di tipo esperienziale, pari quasi al trauma ‘immemore’ del Diluvio che in illo tempore sconvolse la terra:
«a causa dell’ostinato levarsi delle tenebre / se non proprio dell’annientamento cui porta l’apparire / sempre di nuovo si ripete l’ascensione al cielo / in omaggio al divenire che in terra si distende / sullo sfondo originario cui l’umano si sottrae / mettendo a soqquadro anche il sacro recinto / […] dove opera ogni notte un rivolgimento natale / l’incerta creatura da poco tempo generata / per la cui sacralità viene un mortale a garantire / in virtù della pietra e di un impossibile assentire».
Grandiosa l’immagine del ‘sacro recinto’ edenico, e della causa che ha portato alla dismissione dell’umana creatura da esso, in cui: «‘la terrena sostanza del giardino’ porta all’incompiutezza il graduale sottrarsi alle stagioni / che improntano senza posa il nostro incerto cammino / attraverso i gradini del tempo fino all’atemporalità / che diventa ostile alla terrena sostanza del giardino / rendendo inadeguato il consacrarsi al cielo della luce / così come il situarsi ai lati di una penosa dissoluzione / che (di fatto) mortifica l’essere umano per la vita che gli resta».
Nondimeno, nelle diverse sezioni autonome che distinguono questa silloge poetica al pari di un ‘unico lungo poema’, ritroviamo più o meno definiti tutti quei valori che il poetare si concede di trasformare in verso descrittivo, in cui si ravvisa una trama che non stento a definire ‘tragica’, se non ipotizzando una sorta di riabilitazione ‘al momento non formulabile’, che arresti il tempo della ‘caduta edenica’, in una sospensione a noi necessaria per ovviare quella ‘dismissione mitologica’ che pure fin qui ci ha accompagnati, «..se non ipotizzando l’aiuto delle ali», di nuove ali che ci permettano di tornare a volare:
«non l’interezza è all’origine del nostro apparire / ma un grido che ai viventi l’indiviso sottrae / quando è su loro impresso il marchio dell’obbedienza / anche se altro non fanno che sfuggire all’esilio / votati come sono all’illusoria condivisione della verità […] in collisione con l’orizzonte che lontano si configura / e con dolore fa pensare a molti uomini in catene […] nella relazione che i differenti mantiene separati / per un tempo che potrebbe anche essere indefinito / … il cui ‘paradiso perduto’ / rappresenta l’ultima luce per i mortali / spinti come sono verso la prima essenzialità / che nell’antiterra riconosce … / l’insopprimibile incedere di forze discordanti».
Per quanto il sottotitolo avverta trattarsi di ‘configurazioni del principio’, «nel carattere albale di vaghe sembianze», si ravvisa, almeno nelle intenzioni, un plausibile riferimento alla perdita delle ali da parte degli angeli caduti che ritroviamo sparpagliate un po’ dovunque. In ogni luogo dove, in contrasto con gli spostamenti tumultuosi che la ‘caduta’ dei corpi, al pari di meteore impazzite, di per sé conduce, si è ceduto a quella ‘pietas’ umana e divina insieme, atta a conservarne le spoglie e la memoria. È in questo senso che in “Edeniche” ogni locuzione va letta e ponderata a fronte di una forma poetizzante della trasformazione ‘divina’ dell’umano sentire:
‘la forma perfetta dei cieli’ (*)
nel carattere albale di vaghe sembianze
proprie dello spirito che bagna la terra
dove soffre ogni pena l’umano che appare
è nota da tempo la compostezza dei morti
pur se occultata sulla linea di faglia
del moto affannoso di chi ancora vive
ignaro della forma perfetta dei cieli
Ma noi non possiamo dismettere l’idea di una possibile intesa tra gli umani, propensi come siamo all’affrancamento della pena giustamente/ingiustamente inflitta, semplicemente perché non ci è concesso dalla violenza delle necessità cui siamo sottoposti, onde per cui ‘il cantiere dell’uomo’ “nell’atto di sottrarsi all’apparenza”, rimane attivo “per bandire il vuoto dal giardino”:
‘il cantiere dell’uomo’ (*)
ha voci ovunque il cantiere dell’uomo
nel richiamare alla mente la casa natale
che spinge l’esule a uno stato di sconforto
in quanto elemento destinato alla fine
mentre più inerte si va facendo il preumano
per l’estendersi del male tra le forze discordanti
la cui violenza impedisce al giusto di tornare
privo di ali com’è alla volta del regno
Il presupposto di un ‘giardino indiviso’ appositamente creato da Flavio Ermini per questa silloge, riflette di una sorta di sovrapposizione architettonica tipica della costruzione spaziale della torre di Babele, di cui narra la Bibbia nel libro della Genesi, in cui l’uomo, nel tentativo di recuperare l’Eden perduto: “..volendo costituirsi quale superamento dell’illusoria preminenza sul mondo che lo circonda”, smarrisce definitivamente la propria dimensione (umana), per entrare «..nell’imperfetta sua aderenza al pietroso crinale / per un altissimo grado di estraneità alle tenebre»:
‘la parte indivisa del giardino’ (*)
nel crepuscolo cui guardiamo con molta apprensione
perdono vigore i corpi cadendo su rovi inospitali
e su se stessi si piegano e con l’uomo ancora cadono
perché la luce è così fioca da spegnersi d’un tratto
legata com’è alla parte indivisa del giardino
Scrive Kerényi (*): «Non si tratta qui di ‘spiegare’ il mito con un aspetto più o meno patologico della vita psichica di un individuo, ma di constatare come un tema mitologico altro non sia che l’espressione concreta di una struttura intemporale dell’inconscio umano». In altri termini, a differenza dell’intendimento della scuola psicoanalitica classica, «..la psicologia non è impegnata a ‘ridurre’ il mito a espressione di uno stato psicopatologico riccorente nell’uomo antico e moderno, ma tenta di mostrare come nella natura puramente formale dell’inconscio, si possano reperire le matrici universali dei temi mitologici che per la vastità e l’intensità del loro ricorrere debbono a ragione essere chiamati universali».
«L’autentica mitologia – scrive ancora Kerényi – ci è diventata talmente estranea che noi, prima di gustarla, vogliamo fermarci a riflettere [...]. Noi abbiamo perduto l’accesso immediato alle grandi realtà del mondo spirituale – ed a queste appartiene tutto ciò che vi è di autenticamente mitologico –, l’abbiamo perduto anche a causa del nostro spirito scientifico fin troppo pronto ad aiutarci e fin troppo ricco in mezzi ausiliari. Esso ci aveva spiegato la bevanda nel calice, in modo che noi, meglio dei bravi bevitori antichi, sapevamo già che cosa c’era dentro».
‘il giardino conteso’ (*)
su questa terra palmo a palmo depredata
implacabilmente il tempo ci aggredisce
in un devastante potere di annientamento
tumulandoci sotto strati spessi di macerie
che l’epoca sottrae alle aule del cielo
nel far sì che l’umano essere sia sostituito
da un susseguirsi ininterrotto di simulazioni
[…]
da ‘la tomba guerriera’ (*)
come accade alle rose sulla tomba guerriera
nel fare spazio a figure d’indefinibili forme
al cospetto di un chiaro verdetto di condanna
«Per Jung (*), l’immagine archetipica (il mito) non è l’archetipo, ma il prodotto del suo incessante operare. Spetta allo psicologo individuare la struttura formale che genera le infinite immagini che sorgono dall’inconscio, tentando di separare “ciò che compete all’operare della forma e ciò che compete al materiale investito da tale forza strutturatrice (percezioni, ricordi, contenuti mnestici sepolti e persino concrezioni complessuali)”. […] D’altra parte, il fatto che i motivi mitologici fino ad oggi venivano trattati abitualmente in campi di studio diversi e separati, come la filologia, l’etnologia, la storia culturale e la storia comparata delle religioni, non ha favorito molto il riconoscimento della loro universalità».
Scrive D. Verard(*):
«A guidare i due studiosi Jung e Kerényi è la medesima convinzione: secondo la quale lo spirito scientifico moderno ha privato l’uomo delle sue reali capacità di comprendere pienamente la realtà. D’altronde, come Jung ha modo di precisare in numerosi luoghi della sua opera scientifica, è la separazione tra esperienza interiore ed osservazione scientifica, frutto della nascita dello spirito scientifico moderno, ad aver prodotto quella dicotomia tra mondo interiore e mondo esteriore che, per lo psicologo, equivale alla “perdita dell’anima”».
«Noi preferiamo le vie tortuose per arrivare alla verità» – scrive Nietzsche (*) – una frase che Flavio Ermini sembra aver fatto propria, se non fosse per quel sottotitolo più che mai ponderato, che avverte il lettore: trattasi di ‘configurazioni’, cioè, morfologie di forme archetipe intrinseche nella natura, nonchè da rappresentazioni di figure umane, entrambe recuperate dalla memoria collettiva. Una tortuosità visualizzata in immagini ‘di non facile lettura’, (e non poteva essere altrimenti), e che s’avvale di una simbologia dotta tutta da scoprire, che “..non rinuncia al desiderio di tornare / agli stadi periferici dell’esperienza / […] all’insipienza della vita terrena / quando la spada del divino s’impone / con il flusso vorticoso del tempo / all’inerte cammino che porta alla fine”.
“Un altissimo grado di estraneità alle tenebre”, scrive ancora Flavio Ermini in un passo elucubrativo, in cui “prelude al pianissimo di un lamento il dolore”, così intenso da rasentare il silenzio “che non ama farsi udire così come in terra / non s’odono i morti incedere sul selciato / tanto che la verità può rendersi manifesta / solo in quanto simulacro del primissimo inizio”.
Ma non c’è dato sapere dove tutto ha avuto inizio: “vano fin dal principio è l’uso delle ali / nelle cavità malamente scavate dai fratelli / e impone di assentire alla crudeltà della vita / nell’incessante perpetuarsi di un destino di morte / giorno per giorno testimoniato dall’uomo in catene / che affida agli immemori la custodia della terra”…
Impetuoso l’oceano sconfinato che circonda la rupe all’estremità del mondo, dove Prometeo in catene s’abbandona al moto silenzioso delle stelle, per un viaggio interiore dei primordi che richiama la memoria volontaria degli spiriti ancestrali a dar luogo alla condizione esistenziale umana sulla terra: “significazione temporale che ci separa da una minaccia o una promessa nella rara elargizione di follia cosciente” (*) che riscontriamo in noi nell’incedere alla vita, nella lotta costante del progresso e della libertà che ci è cara, quale archetipo/metafora del pensiero umano … “che danza nel silenzio e nel mistero”.
‘le terre delle pietre d’onda’ (*)
dà senso e forma al nostro esserci questo errare
sulle terre via via emerse tra le pietre d’onda
alla ricerca di un rifugio contro le illusioni
cui l’umana avventura induce nell’oscillazione
tra presenza e assenza in una sorta di estinzione
che appare incessante davanti alla dimora
della quale riconosciamo il vero fondamento
unicamente negli strati periferici del vuoto.
L’autore:
Flavio Ermini, poeta, narratore e saggista, dirige la rivista di poesia e critica letteraria “Anterem” dal 1976, dopo aver ricoperto importanti ruoli editoriali presso Mondadori, è oggi consulente di varie case editrici. Collaborazioni e partecipazioni a seminari e convegni in molte istituzioni accademiche italiane e straniere ne fanno una eccellenza nel settore dell’editoria, al quale si deve l’annuale “Premio Lorenzo Montano” e numerose collane nell’ambito della ‘poesia’ e la ‘saggistica’, tra le quali “Narrazioni della conoscenza” per i titoli della Moretti&Vitali.
Collabora, inoltre, all’attività culturale degli “Amici della Scala” di Milano.
Tra le sue pubblicazioni: ‘Poema n. 10. Tra pensiero e poesia’, (poesia 2001; edito in Francia nel 2007 da Champ Social), ‘Il compito terreno dei mortali’ (poesia, 2010; edito in Francia nel 2012 da Lucie Éditions), ‘Il matrimonio del cielo con la terra’ (saggio e poesia, 2010), ‘Il secondo bene’ (saggio, 2012), ‘Essere il nemico’ (pamphlet, 2013), ‘Rilke e la natura dell’oscurità’ (saggio, 2015), ‘Il giardino conteso’ (*) (saggio di poesia, 2016), ‘Della fine’ (*) (prosa poetica, 2016).
(*) titoli recensiti da Giorgio Mancinelli sul sito www.larecherche.it
Sitografia:
ANTEREM – Rivista di Ricerca Letteraria: www.anteremedizioni.it
Premio Lorenzo Montano: premio.montano@antermedizioni.it
Note:
Tutti i corsivi inclusi e le citazioni poetiche sono di Flavio Ermini, tratte da “Edeniche – Configurazioni del principio” – Moretti & Vitali Editori 2019.
Per gli altri autori di riferimento:
(*) Kàroly Kérenyi, “Nel Labirinto”, Bollati-Boringhieri 1983
(*) Carl Gustav Jung, Kàroly Kérenyi, “Prolegomeni Allo Studio Scientifico Della Mitologia” - Bollati-Boringhieri 1999.
(*) Verard D. in “L’albero filosofico. C.G. Jung e il simbolismo alchemico rinascimentale”, Psychofenia, 21, 2009. (cit. “Prolegomeni Allo Studio Scientifico Della Mitologia”).
(*) Friedrich Nietzsche – “Ecce Homo”, Adelphi 1991.
(*) Vittorino Andreoli ,”Il potere del silenzio”, Ediz. Corriere della Sera 2019.
*
 - Cinema
- Cinema
CinEuropa News - prossimamente al cinema.
Ferzan Ozpetek sul set per 'La Dea Fortuna'
Articolo di Camillo De Marco.
24/06/2019 - Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca sono i protagonisti del nuovo film che il regista sta girando tra Roma e Palermo. Producono R&C, Faros e Warner
Nella foto la squadra di La Dea Fortuna sul set.
Ferzan Ozpetek è attualmente su set per le riprese del suo nuovo film dal titolo La Dea Fortuna, per il quale il regista turco naturalizzato italiano ha voluto ancora Stefano Accorsi - protagonista de Le fate ignoranti nel 2001 e Saturno contro nel 2007 - affiancato questa volta da Edoardo Leo e Jasmine Trinca.
Nel cast anche Filippo Nigro e la fedele Serra Yilmaz. Iniziate il 15 maggio, le riprese con la fotografia di Gianfilippo Corticelli si concluderanno a metà luglio e si svolgeranno tra Roma e Palermo. Nei giorni scorsi Ozpetek ha condiviso un post su Instagram con un selfie di tutto il cast.
Scritto dal regista con Silvia Ranfagni e Gianni Romoli (quest'ultimo collaboratore di Ozpetek dai tempi de Le fate ignoranti), La Dea Fortuna racconta di Alessandro e Arturo, coppia legata da più di 15 anni ma ormai in crisi. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciati in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. "Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia", si legge nelle note di produzione.
La scenografia del film è di Giulia Busnengo, i costumi di Monica Gaetani e Alessandro Lai. Le musiche saranno firmate ancora da Pasquale Catalano mentre il montaggio sarà realizzato da Pietro Morana. Producono come sempre di Tilde Corsi e Gianni Romoli per R&C Produzioni con Faros Film e Warner Bros. Ent. Italia. Il film uscirà in Italia il prossimo novembre con Warner Bros. Pictures ed è venduto da True Colours, che lo ha proposto nel proprio listino già al Marché du Film di Cannes a maggio (leggi la news).
Il 'Martin Eden' di Pietro Marcello è in post-produzione
Articolo di Camillo De Marco.
27/06/2019 - La libera trasposizione del romanzo di Jack London è una coproduzione Avventurosa, IBC Movie, Match Factory, Shellac Sud. La data di uscita film conferma la presenza del film alla Mostra di Venezia.
Molto attesa l'opera seconda di Pietro Marcello, Martin Eden, attualmente in post-produzione, che molto probabilmente sarà presente nella selezione della Mostra di Venezia 2019. Con i suoi documentari prima (soprattutto La bocca del lupo [+], vincitore del Torino Film Festival nel 2009) e poi con l'opera prima Bella e perduta [+] (premiato dalla giuria dei giovani a Locarno 2015), Marcello si è accreditato come uno dei giovani registi più dotati, indipendenti e visionari del panorama italiano attuale.
La sua seconda prova al lungometraggio di finzione suscita curiosità per il tema, una libera trasposizione del celeberrimo romanzo di Jack London, e la presenza di un attore straordinariamente versatile e talentuoso come Luca Marinelli. Il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux avrebbe voluto il film sulla Croisette: "Ho parlato molto con Pietro Marcello del suo Martin Eden, che è il mio libro preferito. Non vedo l’ora di vederlo in autunno”, aveva dichiarato a maggio in un'intervista ad un quotidiano italiano.
Ambientato in una città portuale ideale alla fine del secolo scorso, il Martin Eden di Pietro Marcello è un archetipo che viene reso e trasposto attraverso il congegno della fiaba. "Come i personaggi di Amleto e Faust, Martin Eden è un po' il fallimento dell'eroe", aveva spiegato a Cineuropa poco prima delle riprese il regista, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Maurizio Braucci (La paranza dei bambini, L'intrusa tra le sue più recenti collaborazioni). "Abbiamo trasposto il romanzo nella società contemporanea, in una storia che attraversa le epoche".
Per Pietro Marcello nel film "c'è il tradimento della classe di appartenenza", un tema che ci riporta al cinema di Ken Loach e di Jean-Pierre e Luc Dardenne, che definiscono un ordine economico odierno che punta ad un indebolimento dei diritti e spinge ad una disperata guerra tra i lavoratori stessi.
Nel cast, accanto a Marinelli appaiono Marco Leonardi, Vincenzo Nemolato, Rinat Khismatouline, Pietro Ragusa, Aniello Arena, Lana Vlady, Jessica Cressy, Carlo Cecchi. La fotografia è di Francesco di Giacomo e Alessandro Abate, il montaggio di Fabrizio Federico e Aline Hervé. Luca Servino è accreditato per la scenografia e Andrea Cavalletto per i costumi. Marco Messina e Sacha Ricci curano le musiche del film.
Martin Eden è una coproduzione Italia/Germania/Francia tra Avventurosa, la società del regista, IBC Movie, Match Factory Productions, Shellac Sud e Rai Cinema, con il contributo del MiBAC. The Match Factory cura le vendite internazionali. 01 Distribution ha già diffuso il giorno di uscita in Italia, il 4 settembre, una data che conferma la presenza del film a Venezia.
Fine riprese per 'Si muore solo da vivi'
Articolo di Vittoria Scarpa
25/06/2019 - Il lungometraggio d’esordio di Alberto Rizzi ha come sfondo il terremoto in Emilia del 2012, con protagonisti Alessandro Roja e Alessandra Mastronardi. Produce K+
Si sono concluse a Gualtieri (Reggio Emilia) le riprese di Si muore solo da vivi, primo lungometraggio di Alberto Rizzi, già drammaturgo, regista teatrale e autore di cortometraggi. Scritto dal regista con Marco Pettenello (Io sono Li, Zoran, il mio nipote scemo, Finché c’è prosecco c’è speranza), il film si preannuncia una commedia romantica piena di colori e sentimenti, sullo sfondo del terremoto in Emilia del 2012, con protagonisti Alessandro Roja (visto di recente al cinema in Ma cosa ci dice il cervello e in tv ne La compagnia del cigno) e Alessandra Mastronardi (tra i suoi ultimi lavori, L’agenzia dei bugiardi [+] e la serie tv I Medici - Lorenzo il Magnifico).
'Si muore solo da vivi' ruota attorno a Orlando, che ha tutta l'aria del perdente: a quarant'anni vive alla giornata sulle sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 2012 non lo costringerà a rimettersi in gioco, tra nipoti a cui badare, una band da rimettere in piedi e soprattutto un grande amore, Chiara, che si riaffaccia dal passato.
“Partendo da un evento drammatico come il sisma che ha colpito l’Emilia”, spiega il regista, “ho voluto realizzare, con profondità e leggerezza, un omaggio alla forza di questa terra e della sua gente: una commedia sulle seconde occasioni, ambientata in un mondo di musicisti di provincia, pescatori e balere color zafferano”.
Nel cast, tra gli altri, anche Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai e Amanda Lear.
'Si muore solo da vivi' è prodotto da Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella per K+ (già dietro Finché c’è prosecco c’è speranza), con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission e Mantova Film Commission.
Alessandro Rossetto torna con 'Effetto domino'
Articolo di Camillo De Marco
21/06/2019 - Il business della terza età è al centro dell'opera seconda di fiction del documentarista veneto Alessandro Rossetto, che si era rivelato con Piccola Patria nel 2014
Dopo l'ottimo esordio al lungometraggio di finzione nel 2014 con Piccola Patria [+], presentato in Orizzonti alla Mostra di Venezia, il documentarista Alessandro Rossetto è tornato dietro alla macchina da presa per la sua opera seconda 'Effetto domino'.
Attualmente in postproduzione con il montaggio affidato a Jacopo Quadri, il film è tratto dal romanzo omonimo dello scrittore padovano Romolo Bugaro, che racconta di un gruppo di persone coinvolte in un enorme investimento edilizio, nel bel mezzo del Nord Est italiano. Una banca decide di bloccare quel progetto ormai avviato e di conseguenza imprese edili, consulenti, fornitori, semplici camionisti si arrendono e crollano, uno dopo l’altro con l'effetto domino del titolo, per aver confidato ognuno nel proprio committente. Nel libro si trattava della costruzione di una “new town”, nel film si punta sul "business della terza età", trasformando 20 enormi alberghi abbandonati (che si trovano realmente tra Abano, Montegrotto e Galzignano) in residenze per anziani ricchi, per vivere gli ultimi anni in un contesto esclusivo e tecnologico.
"Il romanzo mi aveva colpito anche per la sua struttura, che ha ispirato la sceneggiatura scritta in capitoli con Caterina Serra", ha spiegato il regista. "Era il racconto ideale per rischiare e sperimentare forme narrative nuove da quelle di Piccola patria anche se c’è una continuità tra i due film. I personaggi hanno la medesima provenienza: è come se si fossero evoluti per diventare i protagonisti di questa nuova storia". Rossetto si è affidato nuovamente a molti degli attori scelti per la sua opera prima: Diego Ribon e Mirko Artuso nei panni del costruttore e del geometra del progetto edilizio, Maria Roveran e Roberta Da Soller nel ruolo delle figlie dell'imprenditore edilizio e Nicoletta Maragno in quello della moglie. Lucia Mascino sarà il personaggio-chiave del dirigente bancario (nel libro di Bugaro era un uomo).
Prodotto da Francesco Bonsembiante per Jolefilm con Rai Cinema e con il sostegno di IDM Südtirol – Alto Adige Film Fund & Commission, Effetto domino potrebbe puntare alla selezione in un festival internazionale come Venezia.
Globi d’Oro: Il traditore eletto miglior film
Articolo di Vittoria Scarpa.
20/06/2019 - Assegnati i 59mi premi della stampa straniera in Italia. Jasmine Trinca e Alessandro Borghi migliori interpreti, Bangla è la miglior opera prima
È Il traditore [+] di Marco Bellocchio il miglior film dell’anno secondo la stampa straniera in Italia. La pellicola con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni del mafioso poi collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, si è aggiudicata il Globo d’Oro più importante, ieri sera alla cerimonia di premiazione ospitata a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico. “Incentrato su un personaggio altamente drammatico”, è la motivazione dei giornalisti dell’Associazione della stampa estera in Italia che assegnano il premio, “il film ne ricostruisce dall'interno, in modo coinvolgente e seduttivo la tormentata psicologia”, grazie alla capacità del regista di passare “magistralmente dalla cronaca minuziosa dei fatti e dei delitti di mafia visti nella loro cruda realtà, alla teatralità del maxi processo, alla dimensione onirica del protagonista senza mai rinunciare alla sua visione etica del mondo”. A Il traditore va anche il Globo per la miglior musica, firmata da Nicola Piovani.
Come miglior opera prima è stata eletta la pellicola di e con Phaim Bhuiyan, Bangla [+], “un'opera che aiuta l'integrazione reciproca di un Paese che oramai è sempre più multiculturale”, mentre i Globi dei migliori interpreti sono stati assegnati a Jasmine Trinca, per la sua interpretazione in Croce e delizia [+] di Simone Godano, dove l’attrice “conferma la sua bravura, rivelando di avere anche i tempi comici”, e ad Alessandro Borghi per la sua drammatica performance in Sulla mia pelle [+] che lo rende, secondo i giornalisti stranieri, “un attore che ha tutte le carte per una svolta internazionale”. Il film sulla tragica vicenda di Stefano Cucchi è stato premiato anche per la miglior sceneggiatura, scritta da Alessandro Cremonini e Lisa Nur Sultan.
Si segnala inoltre la miglior fotografia, opera di Daria D'Antonio, riconosciuta a Ricordi? di Valerio Mieli, il nuovo Globo per la miglior serie tv attribuito a Il nome della rosa guidata da Giacomo Battiato, e il Globo per il miglior documentario aggiudicato a Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Olmo di Davide Calvaresi è il miglior corto.
Infine, come già preannunciato, sono stati consegnati il Premio giovane promessa a Ludovica Nasti, giovane e talentuosa protagonista della serie tv L'amica geniale, e il Premio alla carriera a Franco Nero e Vanessa Redgrave.
I vincitori dei Globi d’oro 2019:
Miglior film
Il traditore - Marco Bellocchio (Italia/Francia/Germania/Brasile)
Miglior opera prima
Bangla - Phaim Bhuiyan
Miglior attrice
Jasmine Trinca - Croce e delizia
Miglior attore
Alessandro Borghi - Sulla mia pelle
Miglior fotografia
Ricordi? - Daria D'Antonio (Italia/Francia)
Miglior serie tv
Il nome della rosa - Giacomo Battiato
Miglior musica
Nicola Piovani - Il traditore
Miglior sceneggiatura
Sulla mia pelle - Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan
Miglior documentario
Butterfly - Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman
Miglior corto
Olmo - Davide Calvaresi
Premio giovane promessa
Ludovica Nasti - L'amica geniale
Premio alla carriera
Franco Nero
Vanessa Redgrave
*
 - Filosofia
- Filosofia
Popsophia - Filosofia del Contemporaneo
POPSOPHIA 2019
Filosofia del Contemporaneo
"É GIÀ IERI"
ON-LINE IL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE DI PESARO 2019
“Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta,
dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte,
e non ci sarà in essa mai niente di nuovo”
F. Nietzsche
“E’ già ieri” è il tema di Popsophia a Pesaro dal 4 al 6 luglio 2019: l’eterno ritorno del sempre uguale. I fenomeni della cultura di massa contemporanea riproducono costantemente cose già viste e già sentite. L’immaginario pop – dai revival musicali ai remake cinematografici, dalle politiche reazionarie alle mode retrò – ci traghetta in un paradossale futuro-passato.
Nel corso della tre giorni, il festival rifletterà con due Philoshow, spettacoli filosofico musicali e prodotti distintivi della rassegna, incentrati sull'eterno ritorno dei Beatles e sul cosa è rimasto di Woodstock, a cinquant'anni dal concerto che stravolse il rock. Ma in programma ci sarà pure un tributo ai novanta di Sergio Leone e alla sconvolgente contemporaneità della serie televisiva già cult “Black Mirror”, con il pubblico che sarà tutt'altro che spettatore silente.
Il nostro ragionare prende forma giovedì 4 luglio, alle 18, al cortile di Palazzo Mosca, dove inaugureremo “E' già ieri” con i saluti di apertura. Alle 18.30 c'è una doppia lectio pop. La prima conUmberto Curi che riflette su “Il circolo del tempo” e il suo eterno ritorno alla Nietzsche. Poi Nicla Vassallo interviene sull'eterno ritorno dell'ignoranza, fantasma che si profila con insistenza sul mondo contemporaneo. Al termine condivideremo un calice di vino con la Cantina Colonnara e Pisaurum. Alle 21.30, per POPism, il caporedattore del TGR Rai Maurizio Blasi racconta l'esperienza del giornalismo della nostra regione, tra luoghi e storie delle Marche.
Alle 22 c'è una meditazione a partire da Black Mirror, con Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon) e la loro conferenza interattiva. Che verrà orientata dal pubblico presente e online.
Venerdì 5 luglio ripartiamo dal cortile di Palazzo Mosca alle 18.30 con Fabio Camilletti e “Il ritorno degli spettri”, figure di una simbologia che non è stata mai elaborata. Alle 19 parliamo di felicità con Ilaria Gaspari, che vede nelle scuole filosofiche antiche ricette utili per il presente. Concludiamo il pomeriggio con un brindisi (che rinnoveremo alle 23.30) per darci appuntamento poi alle 21 con i saluti di apertura in Piazza del Popolo e con Simone Regazzoni, alle 21.10. A lui il compito di introdurci al Philoshow delle 21.30 su “Yesterday - Ieri è arrivato improvvisamente. L'eterno ritorno dei Beatles”, spettacolo ideato e diretto da Lucrezia Ercoli, con l'intervento di Massimo Donà e l'ensemble musicale Factory. Alle 23 torniamo al cortile di Palazzo Mosca con i Tiratardi, dove Riccardo Dal Ferro fa un passaggio nei mitici anni Novanta.
Sabato 6 luglio l'apertura del cortile alle 18.30 è affidata a Cesare Catà, sul tempo e la perdita da Virginia Woolf e il film “A Star is Born”.
Alle 19 Andrea Minuz celebra Sergio Leone a novant'anni dalla nascita, salutandoci con un calice alle 19.30 (brinderemo anche alle 23.30). Alle 21.10, in Piazza del Popolo, Salvatore Patriarca introduce con il mito dell'eterna giovinezza il Philoshow delle 21.30, che si intitola “Paradise Lost - A cinquant'anni da Woodstock”. Con ospite Alessandro Alfieri. Un requiem di un mondo perduto. L'ultimo Tiratardi al cortile è alle 23 con Tommaso Ariemma e un viaggio nella filosofia degli anni Ottanta. Tutti gli ingressi sono gratuiti e la frequenza ha valore di aggiornamento per docenti (prenotazioni a info@popsophia.it).
“E' già ieri” è promosso dal Comune di Pesaro con la Regione Marche, organizzato dall'associazione culturale Popsophia con l'ideazione e la direzione artistica di Lucrezia Ercoli.www.popsophia.it
POPSOPHIA - Che cos'è la Pop Filosofia?
10.059 visualizzazioni 7 anni fa
Cosa si intende per "Popsophia"? Che significato hanno le serie tv, la pubblicità, la musica e i fumetti all'interno della società di massa contemporanea? Popsophia ha un unico obiettivo, quello di avvicinare il pensiero filosofico ai fenomeni di massa, costringendo la Filosofia ad indagare il Pop, e il Pop a raccontare la Filosofia. Montaggio a cura di Riccardo Minnucci e Lucrezia Ercoli.
Il video del primo appuntamento di Popsound "Il secondo sesso, la donna tra opera lirica e musica pop" al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta.
Il video finale del secondo appuntamento di Popsound, "Abbey Road, la filosofia dei Beatles e dei Rolling Stones", al Teatro Annibal Caro di Civitanova alta.
Popsound 2019 - "Rock Revolution, a cinquant'anni da Woodstock"
Il video dell'ultimo appuntamento di Popsound, "Rock Revolution, a cinquant'anni da Woodstock", che ha infiammato il Teatro Annibale Caro di Civitanova Alta, in compagnia del filosofo Alessandro Alfieri e delle performance musicali della band Factory.
*
 - Musica
- Musica
Rita Marcotulli insignita dell’onoreficienza per la musica.
È una delle artiste italiane più illustri, e per i suoi innumerevoli meriti in ambito musicale il Presidente Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: è Rita Marcotulli, pianista e compositrice di grande talento ed eleganza. Prima donna ad aver vinto un David di Donatello per la miglior colonna sonora (nel 2011, per “Basilicata coast to coast”), annovera tra gli altri suoi riconoscimenti il Ciak d’oro, il Nastro d’Argento e le due vittorie al Top Jazz della rivista Musica Jazz prima come miglior talento emergente e poi come miglior talento italiano.
Già ufficializzata, la prestigiosa nomina di Ufficiale della Repubblica Italiana sarà ulteriormente suggellata il 1 giugno al Quirinale con la sua partecipazione al ricevimento per la Festa della Repubblica.
Nel corso della sua carriera Rita Marcotulli è riuscita ad affermare il suo stile raffinato in numerosi progetti e generi musicali che l’hanno portata ad esibirsi in tutto il mondo con grandi artisti e nelle location più importanti a livello internazionale.
Memorabili i suoi concerti con Pino Daniele (è suo il pianoforte e alcuni arrangiamenti dell’album “Non calpestare i fiori nel deserto” vincitore di 8 dischi di platino e della Targa Tenco), Ambrogio Sparagna, la sua esibizione al Festival di Sanremo 1996 con Pat Metheny, il tour mondiale come membro del gruppo del celebre batterista statunitense Billy Cobham, la sua sapiente rilettura dei Pink Floyd con un grande ensemble tra cui Raiz e Fausto Mesolella, il live multimediale dedicato a Caravaggio presentato nel 2018 al Festival Umbria Jazz.
Nel 2013, è stata chiamata come membro della Giuria di qualità per la 63esima edizione del Festival di Sanremo.
In ambito jazz spiccano i progetti e le performance con Enrico Rava, Michel Portal, Javier Girotto, Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Kenny Wheeler, Norma Winston, Luciano Biondini, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Sal Nistico, Maria Pia De Vito. Per oltre 15 anni è stata membro del gruppo del sassofonista statunitense Dewey Redman - padre del noto sassofonista Joshua Redman - suonando in tutta Europa e in Sud America.
Tra le sue recenti collaborazioni troviamo Max Gazzè, Gino Paoli, Peppe Servillo, Noa, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni e John De Leo. In ambito teatrale e cinematografico: Lella Costa, Chiara Caselli, Stefano Benni, Rocco Papaleo (per cui ha scritto le colonne sonore di “Basilicata coast to coast” e “Una piccola impresa meridionale”), Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco, Gabriele Lavia, Paolo Briguglia, Daniele Formica, Michele Placido.
Nella sua discografia, oltre 25 album tra cui “Woman Next Door - Omaggio Truffaut”, che nel 1998 il magazine inglese The Guardian ha nominato miglior disco dell’anno, e l’ultimo di Giorgio Gaber “Io non mi sento italiano”.
L’ultimo, appena uscito, è il live “Yin e Yang” (ed. Cam Jazz) in duo con il batterista e vocalist messicano Israel Varela, che a sua volta annovera collaborazioni con Pat Metheny, Charlie Haden, Bireli lagrene, Diego Amador, Bob Mintzer, Mike Stern, Yo Yo Ma, Jorge Pardo. Per questo nuovo progetto, Rita Marcotulli sarà impegnata nei prossimi mesi in tour con un eccellente quartetto europeo formato dal noto bassista Michel Benita, il sassofonista britannico Andy Sheppard (vincitore di numerosi British Jazz Awards) e lo stesso Varela.
CONTATTI
Ufficio Stampa: Fiorenza Gherardi De Candei
tel. 328.1743236 email info@fiorenzagherardi.com
*
 - Società
- Società
Bla, bla, bla … Vincitori e vincitori, nessun perdente.
(Speciale elezioni 2019)
Vincitori e vincitori, chi più o chi meno, tutti hanno vinto, nel senso che chi ha stravinto è perché ha preso più voti; chi ha semplicemente vinto, non è perché ha preso meno voti, bensì perché ha sperperato i voti che erano suoi, facendo promesse in campagna elettorare che sapeva di non poter mantenere.
C’è poi chi non ha vinto, ma che non ha neppure perso (vaglielo a dire non lo ammetterà mai), poiché nessuno di quei Signori che occupano le poltrone del Parlamento perdono davvero qualcosa, semmai pensassero alla loro ‘reputazione’, ma di quella non gliene può fregare di meno.
Chi invece può dire veramente di aver perso Tempo e Denaro, siamo tutti noi che ce li abbiamo messi, ma come loro mai e poi mai lo ammetteremmo a noi stessi; e non certo per la loro stessa ragione, ma perché noi conosciamo la ‘vergogna’. Infatti siamo capaci di cambiare casacca (leggi partito) subito dopo le elezioni, allorché il nostro referente non rientri tra quelli vincenti o che hanno stravinto.
È quanto mai vero che all’occorrenza , siamo subito prenderci le nostre responsabilità (quando mai?), e facciamo esattamente come fece Pinocchietto, ve lo ricordate? Come no! È una storiella / conta in uso dei bambini, quando si voleva mettere alla berlina qualche compagno un poco ‘farfallone’ (per dire bugiardello).
Beh, se proprio non la conoscete, allora ve la racconto io:
“Pinocchietto alla stazione prende il treno e se ne va, prende l’ultimo vagone per non farsi canzonar”. Ovviamente ogni riferimento è puramente casuale (mica tanto). Tuttavia il problema resta, così come resta (nel senso di rimane) ognuno di quelli che se ne dovrebbero andare. Non certo perché hanno perso, anzi perché pur avendo preso meno voti, hanno vinto lo stesso.
Quelli che restano invece con un pugno di mosche in mano siamo tutti noi che dopo tante chiacchiere al vento, tante promesse impossibili affogate in un fiume di bugie, una indescrivibile arroganza puramente nazionale e tanta strafottenza internazionale, avevamo sperato che qualcosa alla fin fine cambiasse davvero. Macché, non ci rimane che sperare che almeno i nostri figli ‘emigrino’ andando in cerca di una società migliore.
E comunque, malgrado loro, saranno etichettati come ‘arroganti’, ‘imprevedibili bugiardi’, ‘insostenibili chiacchieroni’, ‘irriguardevoli improvvidi ’, ‘sconsiderevoli cialtroni’, sconvenienti pensatori di “io speriamo che me la cavo” e quant’altro.
E noi, noi mi chiedo, che restiamo a fare qui? Non ci rimane che una sola via di fuga verso quei paesi dove (sembra) ci aspettano per accoglierci a braccia aperte (ma quando mai?), e mandarli tutti quanti, senza escludere alcuno …
letteralmente a cagare.
*
 - Cinema
- Cinema
Cineuropa a Cannes
I professionisti del cinema a Cannes incoraggiano i cittadini a votare alle elezioni europee.
Le News di Cineuropa.
21/05/2019 - CANNES 2019: La Société des Réalisateurs de Films, European Film Academy, FERA e SAA uniscono le forze per lanciare un manifesto e un invito all'azione dal 23 al 26 maggio
Oggi, al 72° Festival di Cannes, i professionisti del cinema hanno partecipato alla presentazione di un manifesto per incoraggiare i cittadini a votare alle elezioni europee, che si svolgeranno tra pochi giorni, dal 23 al 26 maggio, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Redatto dalla Société des Réalisateurs de Films (SRF), organizzatrice della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, la European Film Academy (EFA), la Federation of European Film Directors (FERA) e la Society of Audiovisual Authors (SAA), il documento è un invito all’azione in quello che un momento decisivo per l’Unione europea.
La regista francese Céline Sciamma (che è anche in competizione per la Palma d'Oro di quest'anno con il suo nuovo film, Portrait de la jeune fille en feu), con il regista croata Hrvoje Hribar, alla presenza di diversi altri registi, ha letto il manifesto di fronte al Centre d'art La Malmaison, proprio accanto alle sedi principali del Festival di Cannes.
Gli 500 firmatari includono registi come Céline Sciamma, Wim Wenders, Agnieszka Holland, Miguel Gomes, Luc e Jean-Pierre Dardenne, Valeria Golino, Jacques Audiard, Susanne Bier, Pawel Pawlikowski, Julie Bertuccelli, Alan Parker, Costa-Gavras, Julie Delpy, Stephen Frears, Stellan Skarsgard, Ralph Fiennes, e molti altri.
Il manifesto:
L'Europa non è perfetta, è vero. A volte le rimproveriamo, e a ragione, di trascurare anima ed emozioni e di utilizzare una lingua che pochi di noi capiscono. Le rimproveriamo di non essere all'altezza delle crisi ecologiche, sociali e politiche che al giorno d’oggi l’attraversano, di non essere all'altezza del dramma dei rifugiati. Eppure, nonostante debolezze e fragilità, troviamo in essa anche umanità e bellezza. E ci sforziamo di descriverla con la delicatezza delle immagini e con un linguaggio più accessibile a tutte me genti che la compongono. E non dimentichiamo che l'Europa si è unita per la pace. Dai sei membri iniziali, si è allargata fino ad abbracciare 28 paesi, che formano un'unione unica e fonte di ispirazione per tutta l'umanità. Questa Unione si è fondata sul superamento delle frontiere, la libera circolazione, lo scambio, la fratellanza e la solidarietà, valori oggi minacciati da ogni parte, anche al suo interno. Ma questa è anche l'Unione della cultura, vera e propria ambizione per un'Europa in cui innovazione e creazione sono da sempre le colonne portanti. Un'Europa libera e democratica è anche un'Europa caratterizzata da libertà di pensiero e di espressione. È nostro dovere difenderla da estremismi e da mentalità retrograde, che tornano a diffondersi come la peste. Questo equilibrio così fragile, dobbiamo consolidarlo, migliorarlo, e opporci a quanti intendono indebolirlo con fratture e rinunce, cercando di sottrarvisi o di isolarsi. Alla domanda: come costruire un'Europa desiderabile, un'Europa in grado di riunire, un'Europa aperta che offra uno spazio di libertà e di pace? dobbiamo rispondere con l'impegno, guidando la lotta delle idee per evitare quella delle armi. Dal 23 al 26 maggio, in occasione delle elezioni europee, andremo a votare. È in gioco il nostro futuro comune, anzi il nostro stesso futuro.
LEGISLAZIONE Europa
I deputati europei approvano la riforma del copyright.
Articolo di Thierry Leclercq 27/03/2019 - Mettendo fine a più di due anni e mezzo di negoziati e di intensa lobbying, il Parlamento europeo ha approvato il 26 marzo a Strasburgo la direttiva che modernizza il diritto d'autore.
With 348 votes in favour of the text, 274 against and 36 abstentions, this directive is the product of an agreement reached between the European institutions at the end of their trialogue in mid-February. Its main aim is to strengthen the position of creators whose works are used by online platforms. All that remains is for the directive to be approved one last time by European ministers on 9 April – a mere formality –, after which member states will be granted two years to transpose the directive into national law.
The main change this law brings is to oblige online platforms to negotiate licensing agreements with the representatives of right holders; if the former don’t want to be held responsible for copyright infringements committed by their users, they will have to do everything in their power to prevent this scenario, either by obtaining the necessary authorisations or by withdrawing illegal content so as to prevent future breaches. For those opposed to the text, there aren’t many other options available to operators, other than installing an automatic content filter which will seriously limit freedom of expression online. The directive will, however, leave users free to share protected works in the context of quotations, criticism, opinion pieces, caricature, parody or pastiche. A further clause also allows greater flexibility for smaller platforms which are less than 3 years old, with under 5 million users per month and with a turnover below €10m.
So as to enhance the accessibility and visibility of European works on VOD platforms, the directive provides for a new negotiation mechanism which will ensure a more straightforward process for obtaining film and TV series exploitation licences. This will also apply to protected works which are no longer commercially available; institutions such as film libraries will be able to negotiate with collective rights management organisations or lay claim to copyright exceptions for uses relating to teaching, preservation or research. Under certain conditions, collective management organisations will also be permitted to conclude licencing agreements for right holders who are not members of their respective organisations.
Authors and creators will not only benefit from greater control over the online use of their content (films, music, articles...), but they will also be entitled to fair and proportionate remuneration; for their part, producers and editors will have to demonstrate transparency in their exploitation of works and allow authors and actors to receive a fair share of the proceeds. Creators should also be in a better position to (re)negotiate their contracts and to obtain redress where their rights are not respected.
According to German MEP Axel Voss (EPP, GE), who defended the initiative within the Assembly, "This deal is an important step towards correcting a situation which has allowed a few companies to earn huge sums of money without properly remunerating the thousands of creators and journalists whose work they depend on". For the Commission, "Today’s vote ensures the right balance between the interests of all players – users, creators, authors, press – while putting in place proportionate obligations on online platforms",declared commissioners Andrus Ansip and Mariya Gabriel. Creators (FERA, SAA, FSE), producers and film agencies (EFADs), meanwhile, believe the approval of this directive to be "a major victory for European authors".
LEGISLAZIONE Europa - Gli autori europei chiedono una remunerazione proporzionata nella direttiva sul diritto d'autore.
Articolo di Cineuropa 21/01/2019 - 95 registi europei hanno firmato una petizione che invita le leggi sul mercato unico digitale a rispondere in modo efficace alle loro esigenze finanziarie.
As the trilogue negotiations on the proposed Directive on Copyright in the European Union's Digital Single Market are drawing to a conclusion, European authors are making the most of their last opportunity to effectively ensure benefit from the economic success of their works. As announced by the Society of Audiovisual Authors (SAA), 95 European filmmakers have signed a petition asking for a principle of proportionate remuneration to be enshrined in the Copyright Directive.
The signatories fully support Article -14, which ensures they are to be fairly remunerated for the success of their works by establishing a fundamental principle of fair and proportionate remuneration for authors and performers in Europe. However, they have expressed their concern that it will have no positive effect in practice if the following elements are missing: an explicit reference to "proportionate" remuneration, since it is the only way for them to receive a fair reward for the success of their work by receiving a proper share of the revenues our works generate, a clear reference to the different collective mechanisms currently in place in various Member States in Art -14, i.e. collective bargaining agreements, collective management of rights and statutory remuneration mechanisms, and the need to make clear that lump-sums, while technically possible, should be the exception, given that the idea of a one-off payment contradicts the idea of proportionate remuneration and the prospect of claiming additional payment under Article 15.
Authors have expressed that as global distribution players are emerging in the EU audiovisual market, they are becoming painfully aware of the contrast of their situation with that of our US screenwriters and directors' colleagues, who are compensated for the distribution of their work worldwide. For this unlevel playing field, both within the Digital Single Market and worldwide, to come to an end, authors are calling on public support to strengthen the creative community so that they can keep on developing new creative visions at the heart of our flourishing creative industries, to grow Europe's cultural diversity in the digital era.
Signatories include well-known filmmakers such as Spain's Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín and Isabel Coixet, Italy's Marco Bellocchio, France's Stéphane Brizé, Costa-Gavras and Bertrand Tavernier, Belgium's Jean-Pierre and Luc Dardenne and Jaco Van Dormael, Poland's Agnieszka Holland and Pawel Pawlikowski, Portugal's Miguel Gomes, Romania's Cristian Mungiu, Germany's Volker Schlöndorff and Bosnia-Herzegovina's Danis Tanović.
*
 - Società
- Società
Bla, bla, bla … “Giro girotondo...
Diretta dagli scranni del Parlamento.
Bla, bla, bla … “Giro girotondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra”…
Chi pensa che gli uomini possano cambiare il proprio destino, si sbaglia di grosso. Ognuno fa ciò che può, s’inventa, s’arrabatta, si scazza, finché il suo destino non si rivela, “..allora m’è dolce naufragar in questo mare” dice il poeta pensando all’ ‘Infinito’, in cui s’annega il pensiero di libertà, di democrazia, di solidarietà, di convivenza pacifica tra i popoli. Si sa, la storia la racconta bene chi la scrive, ma come tutti sappiamo la si può scrivere in tanti modi, anche falsandola, spandendo ‘bugie’ a profusione a destra e a manca, incolpandosi reciprocamente degli scheletri nell’armadio: “l’hai messo tu”, “no ce l’ho trovato”,, “l’hanno lasciato quelli che c’erano prima!”.
O, anche, solo parlando in modo sporco dell’energia pulita, per poi essere scoperto a causa di qualche difettuccio di pronuncia rivelatore. E sono davvero in molti: c’è chi ostenta un’appartenenza del Nord rivelando poi nel parlare la sua origine del Sud; chi, al contrario, parla addirittura in dialetto grezzo (greve); chi dice ‘O’ al posto di ‘o’, chi si parla addosso arrotando la ‘r’, chi scivola sulla ‘s’ prolungata in un guazzabuglio incomprensibile, e chi azzarda la ‘z’ come in quello scioglilingua che mi ricorda tanto mio figlio quando tornava dall’asilo e mi chiedeva: “Papà, che ci fa una Zanzara a Zanzibar?”, e tutto proseguiva con una profusione di zeta del tipo di ‘zizzica’ al posto di ‘pizzica’.
Tant’è che nessuno comprende quello che dicono dagli scranni del Parlamento e hanno bisogno degli interpreti come parlassero lingue straniere. Per non dire di chi li ascolta, cioè nessuno, perché, fateci caso, (e le riprese televisive lo rivelano), stanno tutti col telefonino in mano a farsi i c…i propri. Vi risparmio la doppia ‘z’. Solo alcune frasi travalicano gli scranni da entrambe le parti governative e dell’opposizione, (che poi è la stessa cosa): “ lo richiede l’Europa”, “ce lo chiede la gente”, ma la gente dovremmo essere noi, o mi sbaglio? Io a questi signori (si fa per dire) non ho mai chiesto niente, e voi? Da povero ignorante che sono (non stupido però) sarebbe difficile per me rivolgermi a degli azzeccagarbugli, che non ne azzeccano una, o sbaglio?
Rammento che anche Pinocchio della nota favola raccontava bugie, ma almeno quello era un burattino autentico; mentre questi altri, che pure sono burattini contraffatti (leggi fasulli per non dire paraculi), raccontano bugie (leggi falsità) senza averne la cognizione di ciò che dicono. Ah, beata ignoranza! Di fatto s’ingarbugliano nelle dichiarazioni, si smentiscono l’un l’altro, baruffano e arrotano i coltelli, per poi abbandonarsi a un ‘niente di fatto’. Stando alle promesse fatte: «Avevo l’idea dell’etica come di un bivio, di un aut-aut. Qualcosa doveva essere reciso, qualcosa doveva essere deciso. Uno scatto, un movimento in avanti, un atto che mi oltrepassasse. Restava di fronte a me una biforcazione radicale: rispondo alla chiamata della mia coscienza, o mi distraggo proteggendomi nell’affaccendamento spensierato, nella dittatura anonima e impersonale del Man-(Sì), del Si parla, Si dice, Si vive, Si muore? […] Oppure occulto questa apertura, richiudo l’esposizione alla contingenza della scelta e della decisione?» (*)
Ma le promesse dei bugiardi si sa, hanno le gambe corte, e infatti si rivelano fasulle già nel dire, come quei ‘Ladri di Pisa’ che di giorno se la spassano (facendo finta di lavorare per noi) e di notte saccheggiano la buona fede della ‘gente’ (che siamo sempre noi). Di giorno dicono: “non si toccano le pensioni”, “non di aumenta l’IVA”, “non si mettono le mani nelle tasche degli italiani”, ecc. ecc.. Nel frattempo, di notte, ruspano sulle pensioni, aumentano la benzina, accrescono le detrazioni fiscali sulla sanità, sui tiket dei medicinali, ecc. ecc.; mandano in pensione, con tanto di bonus d’uscita, chi non ha mai lavorato e non ha nessuna intenzione di farlo. Il tutto alla faccia di quanti hanno versato contributi allo stato per 30/40 anni per lavori spesso mal retribuiti.
Mi fermo qui, anche se ce ne sarebbe da aggiungere, perché nel ‘girotondo’ tra i buoni e i cattivi, tra i bugiardi e i falsi, dobbiamo fare attenzione a non essere sospinti da quei “cattivi venti di propaganda” che non molto tempo addietro, ci hanno portato alla rovina. E che, seppure) da una parte contribuiscono a far girare il mondo, come i più pensano erroneamente; d’altra parte fanno girare la terra (e i coglioni) controvertendo la buona creanza degli italiani che, se ancora non se ne sono accorti, sono (siamo) già tutti col ‘culo per terra’.
Bla, bla, bla … canta il poeta: “Giro girotondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra”…
Nota: (*) Massimo Recalcati, A libro aperto”, Feltrinelli 2018.
*
 - Cinema
- Cinema
A Cannes con Cineuropa News
Nella foto: une fille facile di Rebecca Zlotowski
Quinzaine des Réalisateurs.
Nuova linfa per la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes
di Fabien Lemercier.
23/04/2019 - Sedici dei 24 cineasti selezionati saranno per la prima volta sulla Croisette. L’Europa domina un cartellone in cui brillano Lav Diaz, Bertrand Bonello, Rebecca Zlotowski e Takashi Miike
"Il ruolo della Quinzaine è quello di portare a Cannes nuovi autori e nuove proposte per il cinema, testimoniare la modernità di certe scritture, mettere in evidenza frammenti visionari". Per la sua entrata in scena, Paolo Moretti, il nuovo delegato generale della Quinzaine des Réalisateurs, la cui 51ma edizione si svolgerà dal 15 al 25 maggio nell'ambito del 72°Festival di Cannes, non nasconde il suo desiderio di dare nuova linfa alla celebre sezione parallela, come dimostra il numero impressionante di 16 registi (dei 24 in lizza con altrettanti lungometraggi selezionati nel menù principale) che faranno i loro primi passi sulla Croisette.
Presentato questo pomeriggio a Parigi, al Forum des Images, il programma è dominato da opere europee con 14 produzioni delegate. Tra loro ci sono sei registi francesi: Rebecca Zlotowski con Une fille facile, Bertrand Bonello con Zombi Child, Nicolas Pariser con Alice et le maire, Erwan Le Duc con Perdrix, Benoît Forgeard con Yves e Quentin Dupieux con Le Daim che farà l’apertura. Sei rappresentanti a cui va aggiunto il documentario 100% francese On va tout péter del cineasta americano di origini polacche Lech Kowalski.
Per il Vecchio Continente, sono presenti anche il Belgio con Ghost Tropic di Bas Devos, la Svizzera con Les Particules di Blaise Harrison, la Svezia con And Then We Danced di Levan Akin (di cui avevamo visto un estratto al Work in Progress di Les Arcs), la Finlandia con Dogs Don’t Wear Pants di Jukka-Pekka Valkeapää, la Lettonia con Oleg di Juris Kursietis e l’Austria con Lillian di Andreas Horwath. Senza dimenticare la Danimarca che ha prodotto in delegato The Orphanage della giovane afgana Shahrbanoo Sadat.
L’Asia conta tre produzioni in vetrina con le nuove opere di registi affermati come il filippino Lav Diaz (vincitore dell’Orso d’Oro e del Leone d’Oro) e il giapponese Takashi Miike, e un lungometraggio cinese (coprodotto con la Francia) del canadese Johnny Ma.
L’America del Nord è presente con tre film di cui due diretti da americani (Robert Eggers e il cineasta di origine russa Kirill Mikhanovsky) e uno dal britannico-iraniano Babak Anvari.
Anche il Sud America punta su tre rappresentanti con i lungometraggi firmati dalla peruviana Melina León (coprodotto dalla Svizzera), l’argentino Alejo Moguillansky e la brasiliana Alice Furtado (con coproduzione olandese e francese).
Infine, il Nord Africa è in cartellone con Tlamess del tunisino Ala Eddine Slim (un film coprodotto dalla Francia), che conferma l'emergere di un cinema proveniente da un'area geografica molto visibile quest'anno nelle varie selezioni di Cannes.
In totale, la selezione 2019 comprende quattro opere prime e quattro film diretti da donne, ma anche un gran numero di opere seconde. Oltre ad alcuni nomi molto noti (tra cui Diaz, Bonello e Miike), è soprattutto uno spirito di scoperta che emerge dall’insieme, che non manca di destare la curiosità e che segna anche un interessante assunzione di rischi, in quanto il programma sembra essere molto diversificato in termini di genere.
Si segnala infine che il cineasta americano di origine messicana Robert Rodriguez terrà una masterclass e che sarà presentata la sua nuova opera Red 11 in proiezione speciale, così come il mediometraggio The Staggering Girl dell’italiano Luca Guadagnino.
La lista dei titoli annunciati: Quinzaine des Réalisateurs
Lungometraggi
Le Daim - Quentin Dupieux (film di apertura)
Alice et le maire - Nicolas Pariser
And Then We Danced - Levan Akin
The Halt (Ang hupa) - Lav Diaz
Dogs Don't Wear Pants - J-P Valkeapää
Canción sin nombre - Melina León
Ghost Tropic - Bas Devos
Give Me Liberty - Kirill Mikhanovsky
First Love (Hatsukoi) - Takashi Miike
The Lighthouse - Robert Eggers
Lillian - Andreas Horwath
Oleg - Juris Kursietis
On va tout péter (Blow It to Beats) - Lech Kowalski
The Orphanage - Shahrbanoo Sadat
Les Particules - Blaise Harrison
Perdrix - Erwan Le Duc
Por el dinero - Alejo Moguillansky
Sem seu sangue (Sick Sick Sick) - Alice Furtado
Tlamess - Ala Eddine Slim
To Live to Sing (Huo zhe chang zhe) - Johnny Ma
Une fille facile - Rebecca Zlotowski
Wounds - Babak Anvari
Zombi Child - Bertrand Bonello
Yves - Benoît Forgeard (film di chiusura)
Proiezioni speciali
Red 11 - Robert Rodriguez
The Staggering Girl - Luca Guadagnino (mediometraggio)
Cortometraggi
Two Sisters Who Are Not Sisters - Beatrice Gibson
The Marvelous Misadventures of the Stone Lady - Gabriel Abrantes
Grand Bouquet - Nao Yoshigai
Je te tiens - Sergio Caballero
Movements - Dahee Jeong
Olla - Ariane Labed
Piece of Meat - Jerrold Chong & Huang Junxiang
Ghost Pleasure - Morgan Simon
Stay Awake, Be Ready - An Pham Thien
That Which Is to Come Is Just a Promise - Flatform
CANNES 2019 Semaine de la Critique
Cinque cineasti europei per la Semaine de la Critique di Cannes di Fabien Lemercier
22/04/2019 - Jérémy Clapin, Hlynur Pálmason e Lorcan Finnegan in concorso, Aude Léa Rapin e Hafsia Herzi in proiezione speciale. Spiccano anche l'America Latina e il Nord Africa
Tre cineasti europei parteciperanno al concorso della 58ma Semaine de la Critique che si svolgerà dal 15 al 23 maggio nell'ambito del 72° Festival di Cannes. Svelato oggi tramite una conferenza stampa online del delegato generale Charles Tesson (visionabile sul sito web della Semaine), il programma dell'edizione 2019 include sette titoli in concorso (di cui cinque opere prime) che verranno valutate da una giuria presieduta da Ciro Guerra.
Sarà in lizza per il Grand Prix della Semaine il francese Jérémy Clapin con il film d'animazione J’ai perdu mon corps [+], l'islandese Hlynur Pálmason con A White, White Day (suo secondo lungo dopo il tanto acclamato Winter Brothers [+]) e l'irlandese Lorcan Finnegan con Vivarium (suo secondo lungometraggio dopo Without Name [+], presentato a Toronto nel 2016).
Il concorso proporrà anche due opere prime di registi del Nord Africa (l'algerino Amin Sidi-Boumédiène con Abu Leila e il marocchino Alaa Eddine Aljem con Le Miracle du Saint Inconnu) e altri due diretti da registi dell’America Latina (l’argentino-costaricana Sofia Quiros Ubeda con Ceniza negra) e il guatemalteca Cesar Diaz con la produzione franco-belga Nos mères).
La selezione 2019 include anche quattro film fuori concorso: Litigante del colombiano Franco Lolli (rivelatosi alla Semaine del 2014 con Gente de bien [+]) che farà l’apertura, i primi lungometraggi Les Héros ne meurent jamais della francese Aude Léa Rapin, Tu mérites un amour della sua connazionale Hafsia Herzi e Dwelling in the Fushun Mountains del cinese Gu Xiaogang che farà la chiusura e che sarà l'unico rappresentante asiatico dell'edizione di questa Semaine segnata anche dalla totale assenza di produzioni nordamericane.
I film selezionati:
Concorso lungometraggi
Abou Leila - Amin Sidi-Boumédiène (Algeria/Francia)
Ceniza negra - Sofia Quiros Ubeda (Costa Rica/Argentina/Francia)
A White, White Day - Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia)
J’ai perdu mon corps [+] - Jérémy Clapin (Francia)
Nuestras madres - Cesar Diaz (Belgio/Francia)
Le Miracle du Saint Inconnu - Alaa Eddine Aljem (Marocco/Francia/Qatar/Germania/Libano)
Vivarium - Lorcan Finnegan (Irlanda/Belgio)
Proiezioni speciali lungometraggi
Litigante - Franco Lolli (Colombia/Francia) (film d’apertura)
Tu mérites un amour - Hafsia Herzi (Francia)
Les Héros ne meurent jamais - Aude Léa Rapin (Francia/Belgio/Bosnia-Erzegovina)
Dwelling in the Fushun Mountains - Gu Xiaogang (Cina) (film di chiusura)
Concorso cortometraggi
Party Day - Sofia Bost (Portogallo)
The Trap (Fakh) - Nada Riyadh (Germania)
Ikki illa meint - Andrias Høgenni (Danimarca/Isole Faroe)
Journey Through a Body - Camille Degeye (Francia)
Community Gardens (Kolektyvinai sodai) - Vytautas Katkus (Lituania)
Lucía en el limbo - Valentina Maurel (Belgio/Francia/Costa Rica)
The Manila Lover - Johanna Pyykkö (Norvegia/Filippine)
Mardi de 8 à 18 - Cecilia de Arce (Francia)
She Runs - Qiu Yang (Cina/Francia)
The Last Trip to the Seaside (Ultimul Drum Spre Mare) - Adi Voicu (Romania)
Proiezioni speciali cortometraggi
Demonic - Pia Borg (Australia)
Naptha - Moin Hussain (Regno Unito)
Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You - Brandon Cronenberg (Canada)
Invisible Hero - Cristèle Alves Meira (Portogallo/Francia)
Tenzo - Katsuya Tomita (Giappone)
La lista dei titoli annunciati per:
UN CERTAIN REGARD
Invisible Life - Karim Aïnouz (Brasile)
The Beanpole - Kantemir Balagov (Russia)
Les Hirondelles de Kaboul - Zabou Breitman, Eléa Gobé Mévellec (Francia/Svizzera/Lussemburgo)
La Femme de mon frère - Monia Chokri (Canada)
The Climb - Michael Covino (Stati Uniti)
Jeanne - Bruno Dumont (Francia)
O que arde - Óliver Laxe (Spagna/Francia/Lussemburgo)
Chambre 212 - Christophe Honoré (Francia/Belgio/Lussemburgo)
Port Authority - Danielle Lessovitz (Stati Uniti)
Papicha - Mounia Meddour (Francia/Belgio/Argelia)
Adam - Maryam Touzani (Marocco/Francia/Belgio/Qatar)
Zhuo ren mi mi - Midi Z (Taiwan)
Liberté - Albert Serra (Spagna/Francia/Portogallo)
Bull - Annie Silverstein (Stati Uniti)
Summer of Changsha - Zu Feng (Cina)
Homeward - Nariman Aliev (Ucraina)
CANNES 2019
Maestri e volti nuovi per la Palma d’Oro cannense 2019
di Fabien Lemercier
18/04/2019 - Otto cineasti per la prima volta in concorso a Cannes, affiancati da nove registi già premiati e ancora suspense per Tarantino e Kechiche
Gli osservatori avrannno potuto pensare che l'audace selezione messa a punto l'anno scorso con successo dal delegato generale di Cannes Thierry Frémaux fosse solo una questione di congiuntura, ma l’annuncio oggi a Parigi della Selezione ufficiale del 72° Festival di Cannes (14-25 maggio), in particolare la composizione della line-up della competizione, smentisce nettamente coloro che predicevano che il vento del rinnovamento sarebbe calato a favore dei cineasti “habitué“ alle più alte sfere della Croisette. Certo, ci saranno ancora grandi nomi, tra cui almeno quattro ex vincitori con il britannico Ken Loach (Palma nel 2006 e 2016 - 14a partecipazione), i belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne (Palma nel 1999 e 2005 - 8a partecipazione) e l’americano Terrence Malick (Palma d’Oro nel 2011 - 3a partecipazione), e le settimane a venire potrebbero vedersi aggiungere alla lista il francese Abdellatif Kechiche (Palma d’Oro nel 2013) e l’americano Quentin Tarantino (Palma d’Oro nel 1994) i cui film sono ancora in fase finale di montaggio.
Ma è comunque un’aria di novità molto forte quella che soffia con otto cineasti per la prima volta in concorso: le francesi Céline Sciamma e Justine Triet, il franco-maliano Ladj Ly, la franco-senegalese Mati Diop, l’austriaca Jessica Hausner, il rumeno Corneliu Porumboiu, l’americano Ira Sachs e il cinese Diao Yi’nan (Orso d’Oro a Berlino nel 2014).
A questi autori già incoronati e a questa ondata di neo partecipanti si aggiunge un gruppo di registi di talento consolidato, tra cui cinque cineasti già premiati (direttamente o tramite i loro interpreti) sul grande palcoscenico del Théâtre Lumière: l'americano Jim Jarmusch (8a partecipazione), lo spagnolo Pedro Almodóvar (6a partecipazione), i francesi Arnaud Desplechin (6a partecipazione), il palestinese Elia Suleiman (3a partecipazione) e il canadese Xavier Dolan (3a partecipazione).
Sono nuovamente in corsa per la Palma d’Oro anche l’italiano Marco Bellocchio (7a partecipazione), il sudcoreano Bong Joon-ho (2a partecipazione) e il brasiliano Kleber Mendonça Filho (2a partecipazione, che ha co-diretto stavolta con Juliano Dornelles che, dal canto suo, debutterà in competizione). Questo equilibrio generazionale della competizione (19 titoli per ora) si annuncia molto attraente ed eccitante in termini di qualità e diversità di stili e generi: Thierry Frémaux (affiancato dal presidente del Festival, Pierre Lescure) ha evocato un gusto tematico globale che ruota attorno al romanticismo e alla politica. Sul piano geo-cinematografico, l'Europa domina la line-up quest'anno con dieci titoli in gara per la Palma d'Oro: quattro francesi (Sciamma, Triet, Desplechin, Ly), uno spagnolo (Almodóvar), un italiano (Bellocchio), un inglese (Loach), il duo di fratelli belgi (i Dardenne), un rumeno (Porumboiu) e un’austriaca (Hausner). L’America del Nord punta per ora su quattro film (Malick, Jarmusch, Sachs, Dolan), mentre l’Asia schiera tre rappresentanti (Diao Yi’nan, Joon-ho e Suleiman), l’America Latina solo uno (il duo Mendonça Filho - Dornelles). L’Africa sarà presente con il primo lungo di Mati Diop, girato a Dakar. Da notare infine che quattro registe saranno in competizione quest’anno.
La Selezione ufficiale include inoltre un’interessante ramo fuori concorso con due episodi della serie Too Old To Die Young del danese Nicolas Winding Refn, Rocketman [+] dell’inglese Dexter Fletcher, il documentario Diego Maradona del suo connazionale Asif Kapadia, e i titoli francesi Les plus belles années d’une vie [+] di Claude Lelouch e La Belle époque del suo connazionale Nicolas Bedos. Senza dimenticare in proiezione speciale i film di Werner Herzog, Abel Ferrara, Alain Cavalier e Pippa Bianco, e i 15 titoli del Certain Regard (tra cui i lungometraggi di Bruno Dumont, Christophe Honoré, Olivier Laxe, ecc.
La lista dei titoli annunciati finora in Concorso:
The Dead Don't Die - Jim Jarmusch (Stati Uniti/Svezia) (Apertura)
Dolor y gloria - Pedro Almodóvar (Spagna)
Il traditore - Marco Bellocchio (Italia)
The Wild Goose Lake - Diao Yinan (Cina/Francia)
Parasite - Bong Joon-ho (Corea del Sud)
Le Jeune Ahmed - Jean-Pierre & Luc Dardenne (Belgio/Francia)
Roubaix, une lumière - Arnaud Desplechin (Francia)
Atlantique - Mati Diop (Francia/Senegal/Belgio)
Matthias et Maxime - Xavier Dolan (Canada)
Little Joe - Jessica Hausner (Austria/Regno Unito/Germania)
Sorry We Missed You - Ken Loach (Regno Unito/Francia/Belgio)
Les Misérables - Ladj Ly (Francia)
A Hidden Life - Terrence Malick (Germania/Stati Uniti)
Bacurau - Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles (Brasile/Francia)
La Gomera - Corneliu Porumboiu (Romania/Francia/Germania)
Frankie - Ira Sachs (Francia/Portogallo/Belgio/Stati Uniti)
Portrait de la jeune fille en feu - Céline Sciamma (Francia)
It Must Be Heaven - Elia Suleiman (Francia/Germania/Canada/Turchia)
Sibyl - Justine Triet (Francia/Belgio)
Fuori concorso
Les Plus belles années d'une vie - Claude Lelouch (Francia)
Rocketman - Dexter Fletcher (Regno Unito/Stati Uniti)
Too Old to Die Young - Nicolas Winding Refn (Stati Uniti) (serie TV)
Diego Maradona - Asif Kapadia (Regno Unito)
La Belle époque - Nicolas Bedos (Francia)
Proiezioni di mezzanotte
The Gangster, the Cop, the Devil - Lee Won-Tae (Corea del Sud)
Proiezioni speciali
Share - Pippa Bianco (Stati Uniti)
For Sama - Waad Al Kateab & Edward Watts (Regno Unito/Stati Uniti)
Family Romance, LLC. - Werner Herzog (Giappone/Germania)
Tommaso - Abel Ferrara (Italia)
Être vivant et le savoir - Alain Cavalier (Francia)
Que sea ley - Juan Solanas (Argentina)
*
 - Religione
- Religione
La morte che vince la morte - meditazione di don Luciano.
LA MORTE CHE VINCE LA MORTE : Quanta distanza da Gesù!
Luca 22,14—23,56
L’ascolto di questo racconto della passione ci fa prendere nuova e più profonda coscienza di quanto il Signore ci abbia amato e di quanto egli ci sta amando. Amore chiede amore; un dono così immenso chiede gratitudine; una fedeltà così estrema esige la nostra fedeltà. Ma quanta infedeltà tra Gesù e i suoi discepoli, quanta distanza tra i suoi sentimenti e i miei sentimenti. Tra me e il Signore non c’è solo distanza, c’è di più, c’è infedeltà, incoerenza e incomprensione. Il Vangelo di Luca ci invita a meditare sul contrasto profondo che divide il comportamento dei discepoli da quello del Maestro. Da parte dei discepoli c’è un’aperta resistenza a comprendere quello che Gesù sta vivendo. Già la sera della cena durante la quale Gesù ave-va spezzato e offerto il pane perché, mangiandone, si immedesimassero con tutta la sua vita, in particolare con quel gesto di donazione suprema che stava per compiere, vediamo che i discepoli sono ben lontani dal considerare i pensieri e i sentimenti del Maestro. Mentre Gesù si pre-senta come ‘colui che serve’, i discepoli vengono sorpresi in discussio-ni meschine ‘su chi di loro poteva essere considerato il più grande’.
Ma ciò che veramente commuove in questo episodio è che, nonostante la meschinità degli apostoli, Gesù non solo non li rimprovera, ma addirittura prende l’occasione per fare loro la più grande promessa che avrebbe potuto fare. Egli, infatti, prepara per loro un regno perché possano mangiare e bere alla sua mensa e sedere in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. La bontà, la gratuità di Gesù supera infinitamente la durezza e la meschinità umana. Egli non si ferma mai, nemmeno di fronte alla mia indegnità. Proprio nel momento in cui gli apostoli si mostrano estrema-mente lontani dalle categorie di pensiero del Maestro e impermeabili al suo insegnamento, Gesù, noncurante di questo, prospetta e promette loro le gioie, l’abbondanza e la gloria della vita senza fine. Gesù è come una mamma paziente con i suoi figli un po’ difficili, compatisce la debolezza, la fragilità, l’incostanza e la superficialità dei suoi amici, li prende per mano, li sostiene, ma non rinuncia ad accompagnarli fino alle altezze che ha preparato per loro.
Il Getsemani. Arrivato sul posto Gesù comincia a pregare, a provare angoscia e a sudare sangue; quest’ultimo particolare è solo di Luca. Gesù non è un eroe come lo intendiamo noi, non affronta la morte con quella spaval-deria stoica che fa la fortuna di tanti personaggi mitici della storia. Gesù è uomo vero e intero e quindi ha paura del dolore e della morte perché questa non appartiene all’umano. Gesù prova il sentimento terribile dell’angoscia. Senza addentrarci in analisi che non ci competono, il sudore di sangue è certamente il segno di una sofferenza inaudita e in-contenibile. Ma improvvisamente la scena cambia; si avvicina una folla di gente guidata da Giuda, uno dei dodici. ‘Uno dei dodici’ è l’espressione che sottolinea la costernazione dell’evangelista: proprio uno dei dodici ha consegnato l’amato Maestro ai suoi persecutori. Cosa inaudita! È la stessa costernazione di Gesù: ‘Giuda con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?’. Proprio con un bacio? Tutto questo avviene di notte. La notte è l’ora delle tenebre, della vigliaccheria, l’ora di coloro che non hanno il coraggio di compiere i loro misfatti alla luce del giorno. Pietro lo segue da lontano.
Dapprima dimostra un certo coraggio, ma poi vacilla e cade: ‘Non lo conosco!’. ‘Il Signore, voltatosi, guardò Pietro’. Il suo sguardo non è di giudizio e di condanna. ‘Pietro scoppiò a pian-gere!’. Dobbiamo imparare a sentire su di noi questo sguardo intenso e tene-rissimo di Gesù. Questo sguardo ha provocato uno sconvolgimento e un pentimento profondo nel cuore di Pietro. Un pentimento così lo vive chi guarda a lui, non chi guarda solo a se stesso. Oggi sarai con me in paradiso!Il Signore Gesù si preoccupa, fin dentro l’ultima agonia, della sal-vezza di chi gli muore a fianco e non della propria salvezza. Le sue ultime parole per gli uomini sono indirizzate ad un malfattore, ma an-che a tutti noi che rischiamo di arrenderci ad una cultura di morte. Lì, in quel malfattore, c’è tutto il mistero della persona umana. L’uomo, nel suo limite più basso, è ancora amabile, la persona è ancora sal-vabile e salvata, anche nel suo limite ultimo.Questo vuol dire che nessuno è perduto per sempre, nessuno potrà andare così lontano dalla casa del Padre, da non poter essere raggiunto.Sarai con me! Le braccia di Gesù, distese e inchiodate in un abbraccio perenne, dicono accoglienza che non esclude nessuno. Il suo cuore è dilatato fino a lacerarsi. L’amato nasce dalla ferita del cuore di chi lo ama. L’uomo, ciascuno di noi, nasce dal cuore trafitto del suo creatore.
Sarai con me in paradiso! Parla di uno spazio felice e immenso, lui che ha come spazio appena quel po’ di legno e di terra che basta per morire. Non c’è nulla che possa separarci da Cristo, né male, né tradi-menti. Io vengo a prenderti anche nelle profondità dell’inferno, se tu mi vuoi. Solo se tu mi vuoi. Ma io continuerò a morire d’amore per te, anche se tu non mi vorrai e appena girerai lo sguardo troverai uno eter-namente inchiodato in un abbraccio che grida: ‘Ti amo!’. La crocifissione e la morteCi colpisce la sobrietà dell’evangelista Luca nel narrare la crocifis-sione. Il supplizio più crudele e umiliante che la malvagità umana abbia mai potuto concepire viene presentato in un linguaggio asciutto ed es-senziale da dare quasi l’impressione di qualcosa di normale, di ordina-rio, come se nulla fosse. Alla feroce crudeltà del supplizio fa contrasto la misericordiosa preghiera di Gesù: ‘Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno!’. Luca non registra il grido angosciato: ‘Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?’.
Di Gesù crocifisso vuole sottolineare la misericor-dia infinita che non solo arriva a perdonare un crimine così efferato, ma addirittura lo scusa. Egli vuole mettere in evidenza l’infinita bontà di Gesù che non pensa a sé nemmeno in questa tremenda circostanza. Il contesto, però, intorno a Gesù, anche di fronte a tanta bontà, continua ad essere di ostilità e di disprezzo. I capi e i soldati lo schernivano. L’amore è circondato dall’odio.I segni poi che accompagnano la morte di Gesù sono il buio su tutta la terra e il velo del tempio squarciato. Il buio è simbolo dell’oscurità della morte. Senza Cristo il mondo tutto è avvolto dal buio; il velo squarciato è il segno che il tempio non serve più. Ormai tutto il mondo, tutta la storia è il luogo dove l’uomo può incontrare il suo Dio. Alla fine di tutto Gesù muore gridando ad alta voce, con il suo dolo-re, ma la sua speranza, il suo abbandono fiducioso e filiale: ‘Padre nel-le tue mani consegno il mio spirito!’. Gesù muore da Re. Sulla croce la sua regalità si manifesta in tutto il suo splendore. Gesù muore, ma il racconto della passione non si chiude con lo scon-forto di un totale fallimento. La sua morte sembra produrre subito alcu ni cambiamenti.
Lo scenario improvvisamente si trasforma. ‘Il centurione glorificava Dio’! Le folle se ne ritornavano battendosi il petto, riconoscendo dunque il loro peccato. Anche i suoi conoscenti e le donne che lo avevano assistito fin dalla Galilea, insomma quelli più vicini, forse parenti e amici, hanno partecipato a questi avvenimenti con amore e trepidazione. Il racconto si conclude non a caso, con un accenno alle luci del saba-to che già splendevano, annunciando non solo il nuovo giorno, ma il giorno eterno che di lì a poco la risurrezione di Gesù avrebbe inaugura-to. Gesù è l’immagine dell’homo patiens, dell’uomo solo, dell’uomo sofferente, ma bisogna subito aggiungere che la sofferenza lui non l’ha mai amata. La sofferenza è un male!La croce non è stata una scelta di Gesù. Era infatti pienamente convinto che a salvare non fosse la sofferenza, ma soltanto l’amore. È stato il suo amore verso il Padre e verso le persone più umiliate a procurargli l’opposizione dei capi religiosi e a fargli subire il tormento della croce. La croce è stata la conseguenza della sua fedeltà.
Ma proprio dall’amore che portava nel cuore egli ha potuto attingere quella pace profonda che, nel racconto di Luca, lo accompagnerà fino al mo-mento estremo della morte. Gesù ama fino alla fine morendo sulla Croce. Sulla Croce Gesù è l’illustrazione vivente dell’amore ostinato di Dio, di cui parla tutta la Scrittura. Ci rivela quanto siamo amati e a quale prezzo. L’amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è essere insieme con l’amato, vicino e unito a lui. Gesù è salito sulla Croce per essere con me e come me e perché io possa essere con lui e come lui. Come una madre che vuole prendere su di sé il male del suo bambino, ammalarsi lei per guarire suo figlio. Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Il nostro è il Dio ‘differente’; è il Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte, perché là va ogni suo amato figlio. La Croce è l’abis-so, dove Dio diventa l’amante. Incredibilmente e imprevedibilmente Gesù rivela la sua divinità, proprio nell’annientamento della croce. È in questa prova suprema del suo amore che egli rivela la sua ineffabile divinità. In questa morte che vince la morte, in questa morte che annunzia la risurrezione egli si rivela il Signore della vita.
Contatti: Mirella Clementi miry.clemy@gmail.com
*
 - Teatro
- Teatro
’Progetto Demoni’ - prime date in Campania
Prime date in Campania del "Progetto Demoni"
Top secret per la location dello spettacolo 'Come va a pezzi il tempo'di e con Alessandra Crocco, Alessandro Mielein coproduzione con Capotrave / Kilowatt, Infinito srl.
Per il penultimo appuntamento della Stagione Mutaverso Teatro, il direttore artistico Vincenzo Albano di ErreTeatro, propone lo spettacolo "Come va a pezzi il tempo", prime date in Campania – messo in scena da Progetto Demoni, che potrà essere visto solo in tre date, dal 5 al 7 aprile. La pièce, di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele, si terrà in una location top secret, fuori dai teatri, che sarà comunicata solo al momento della prenotazione, obbligatoria anche per gli abbonati. Lo spettacolo prevede 5 repliche giornaliere, per massimo 5 spettatori alla volta, per rappresentazioni che si terranno ai seguenti orari: h. 17| 18 | 19 | 21 | 22. Lo spettatore entra in una casa abbandonata da poco. Ogni cosa è ancora al suo posto e il tempo sembra essersi fermato. Ma quella casa è stata vissuta ed è carica di segni che a poco a poco iniziano a parlare. Dal silenzio riaffiorano ricordi, momenti differenti, legati eppure distanti. Le porte, le stanze, gli oggetti, gli odori raccontano una storia, evocano le persone che hanno abitato quel luogo, le chiamano a ripetere scene già vissute. È una storia ridotta in pezzi, come la memoria di una vita, come un sogno ripercorso con la mente al risveglio. È l’ultimo canto di un luogo prima che il tempo lo faccia lentamente decadere. Lo spettatore viene condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso tempo le vite di chi le ha abitate, testimone discreto dell'eco di un passato che risuona ancora una volta. Tenuto sul limite tra mondo reale e mondo immaginario, potrà solo andare con gli attori alla "ricerca del tempo perduto" e quasi toccare i due protagonisti ma non intervenire, perché ormai tutto è già accaduto. Vedrà i due rincorrersi, incontrarsi e separarsi nelle diverse stanze e infine lasciare l’appartamento per sempre. Il visitatore si ritroverà quindi di nuovo solo, nel silenzio irreale della casa inanimata eppure ormai familiare. Il distacco provato all’ingresso cederà il passo alla sensazione che si prova quando si abbandonaun luogo pieno di ricordi. Come va a pezzi il tempo è un ritorno ai luoghi non teatrali che erano stati al centro di Demoni-frammenti, il nostro primo progetto. Di questa modalità di lavoro ci interessa la vicinanza tra attori e spettatori e la ricerca di una recitazione fatta di piccole sfumature, quasi cinematografica. In Demoni-Frammenti avevamo estratto da Dostoevskij tre episodi che venivano programmati in giorni diversi, offrendo allo spettatore un appuntamento quotidiano con i personaggi del romanzo.
In "Come va a pezzi il tempo" invece proviamo a riunire i frammenti di una storia in un unico piano sequenza considerando l’occhio dello spettatore come l’obiettivo di una telecamera.5- 6- 7 aprile 2019, ore 17| 18| 19 | 21 | 22 per 5 repliche giornaliere per n. 5 max spettatori alla voltaIl luogo sarà comunicato al momento della prenotazione (obbligatoria anche per gli abbonati)
ALESSANDRA CROCCO Nata nel 1981 a Salerno, dove ha iniziato la sua formazione teatrale con Claudio Di Palma e Ruggero Cappuccio. Dopo la Laurea in Lettere Moderne all'Università di Napoli, si è trasferita a Milano per frequentare la Scuola del Teatro Arsenale diretta da Kuniaki Ida e Marina Spreafico. Ha seguito seminari con diversi maestri tra cui Leo De Berardinis, Elena Bucci, Marco Martinelli, Marco Baliani, Claudio Morganti. Nel 2006 è autrice e attrice con la compagnia “Fuori Quattro” dello spettacolo Chiamiamo a testimoniare il barone di Munchausen, finalista al Premio Scenario Infanzia. Nel 2007 partecipa al Corso di Alta Formazione “Progetto Interregionale Teatro”, organizzato dai Cantieri Teatrali Koreja a Lecce, che si conclude con lo spettacolo Lezioni d'amore – Studio per un Barbablù di Antonio Viganò. Nel 2009 è autrice e interprete di Non ti ho mai tradito, progetto finalista al "Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti". Collabora con i Cantieri Teatrali Koreja come attrice negli spettacoli La parola padre di Gabriele Vacis, Giardini di Plastica, Alice e Il calapranzicon la regia di Salvatore Tramacere, e Mangiadisk, con la regia di Enzo Toma.
ALESSANDRO MIELE Nato a Pompei nel 1983. Dopo la scuola di mimo corporeo diretta da Michele Monetta, ha partecipato al corso di formazione “Epidemie” con il Teatro delle Albe e alla creazione dello spettacolo Salmagundi per la regia di Marco Martinelli (produzione: Ravenna Teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione). Ha seguito seminari diretti da Ermanna Montanari, Fiorenza Menni, Marco Martinelli, Marise Flach, Riccardo Caporossi, Roberto Latini, Roberto Bacci, Claudio Morganti. Nel 2005 è autore e interprete di Sono solo un uomo, testo vincitore del Concorso di Drammaturgia Sportiva indetto dal Festival SportOpera 2005. Nel 2006 è finalista con la compagnia “Fuori Quattro” al Premio Scenario Infanzia 2006 con lo spettacolo Chiamiamo a testimoniare il Barone di Munchausen. Ha fondato con Consuelo Battiston e Gianni Farina la compagnia “Menoventi” (Premio Rete Critica 2011, Premio Hystrio-Castel dei Mondi e Premio Lo Straniero 2012), realizzando come co-autore e attore gli spettacoli In festa, Invisibilmente (produzione: Menoventi – Emilia Romagna Teatro Fondazione), Postilla, Perdere la faccia, L'uomo della sabbia(produzione: Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival delle Colline Torinesi, Programma Cultura dell'Unione Europea nell'ambito del Progetto Prospero)website: www.progettodemoni.it
MUTAVERSO TEATRO(LA) QUARTA STAGIONEIDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA VINCENZO ALBANO/ ERRE TEATROANNO 2018-2019 UFFICIO STAMPA CLAUDIA BONASI|RENATA SAVOcomunicazione@puracultura.it- 339 7099353rensavo@gmail.com- 320 1915523INFO E PRENOTAZIONI info@erreteatro.it - 329 4022021
Da venerdì 5 a domenica 7 aprile
Il luogo sarà comunicato al momento della prenotazione obbligatoria (anche per gli abbonati)
cinque repliche giornaliere per 5 spettatori alla volta (durata: 40 minuti)
turni ore 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
biglietto unico intero: € 10,00
Ufficio Stampa
*
 - Musica
- Musica
“Emozioni private,Lucio Battisti, una biografia psicologica
è questo il titolo della nuova biografia su Lucio Battisti in uscita giovedì 28 marzo, scritta dalla giornalista e critico musicale Amalia Mancini ed edita da Arcana. A 20 anni dalla morte del celebre autore, avvenuta il 9 settembre 1998, questo nuovo volume si discosta dalle precedenti biografie indagando nei meandri più nascosti della vita e della psicologia del “primo” Battisti, rivelando l’intima essenza di un uomo molto diverso dal personaggio pubblico che tutti conoscono, ma così bene trasmessa dalla sua musica.
Reatina come Battisti, Amalia Mancini ha affrontato una lunga fase di ricerca nei luoghi e nel passato dell’artista, culminata con un’intervista esclusiva a Giulio Rapetti, in arte Mogol: l’autore dei testi che hanno contribuito a rendere immortali i brani di Battisti. Il loro è stato il sodalizio più celebre e controverso della canzone italiana: legati da una profonda amicizia, all’inizio degli anni ’80 i due artisti hanno deciso bruscamente di interrompere il loro rapporto, proseguendo su strade diverse.
Nella lunga conversazione con Amalia Mancini, Mogol svela molti segreti dell’amicizia e della fertile collaborazione con Lucio, un artista tanto discreto nella vita pubblica quanto espressivo e sincero in quella musicale.
Nel libro, i temi ricorrenti nelle canzoni di Battisti: l’amore, la malinconia, la libertà, la natura, l’ecologia, la paura, l’alienazione, la solitudine, il timore di una catastrofe naturale e umana.
“Ascoltare significa qualcosa” diceva Lucio, e riascoltare la sua musica, con il punto di vista di questa nuova biografia, può essere un’operazione stimolante e coinvolgente.
Sabato 30 marzo a Roma un evento speciale per festeggiare l’uscita del libro in collaborazione con Honda Moto Roma: dalle 12, presso la filiale Honda di via Tiburtina 1166/1168, il libro autografato dall’autrice andrà in omaggio a tutti coloro che effettueranno un Test Ride dei nuovi modelli Honda in presentazione. Dalle 12, la musica di Lucio Battisti sarà reinterpretata dalla cantante Jen V Blossom.
Amalia Mancini è una giornalista, scrittrice, sceneggiatrice e critico musicale reatina. Collaboratrice di varie testate, ha iniziato giovanissima la sua carriera di scrittrice, aggiudicandosi diversi premi tra cui il Premio Capit Terzo Millennio e il Premio Viareggio Carnevale. E’ autrice di 20 Sillogi Poetiche inedite e dei volumi “Lucio Battisti l’enigma dell’esilio”, “L’amore piace a tutti”, “La Tata dei Divi”; è coautrice del volume “Giovani e Droga, Perché?” e curatrice del libro “Le mie Prime vere Scarpe”.
Ufficio Stampa MArtePress:
Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236 email fiorenza.gherardi@martelive.it
Francesco Lo Brutto – tel. 331.4332700 email francesco.lobrutto@martelive.it
*
 - Psicologia
- Psicologia
La forza del desiderio - un libro di Massimo Recalcati
Del perché leggere Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, è un’esperienza davvero singolare, lo apprendiamo dalle pagine di ogni suo nuovo libro, sia del singolo argomento trattato in ogni suo intervento televisivo (“Lessico amoroso” in onda su RAI3), dal modo in cui riesce ad attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso e affascinato dal suo linguaggio accattivante.
È un fatto che le argomentazioni di ogni suo intervento si basino sull’uso orale e colloquiale della parola, solo qua e là forbita dalla colta conoscenza dell’intelletto umano di cui non fa ostentazione e, per lo più, scandita con voce suadente e specifica nelle risposte, alle domande che il pubblico gli rivolge direttamente. Ciò, proprio perché sono argomentazioni che riguardano il nostro conscio / inconscio, ci si sente pienamente coinvolti in trattazioni professionali.
Non certo allo stesso modo in cui si viene ‘curati’ dallo psicanalista che ci vuole sdraiati sul lettino apposito, sconvenientemente alla stregua delle sue ossessioni interlocutorie che, per quanto ci riguardino da vicino, ci fanno sentire scavati nell’intimità di quella ‘privacy’ che non riveleremmo neppure a noi stessi. È questo il lavoro che l’autore di questo piccolo (ma assai grande) libro che tratta della ‘forza del desiderio’ che improvvisamente scopriamo avere la connotazione del nostro (pur assai grande) essere nascosto: il nostro inconscio.
Massimo Recalcati riflette qui sulle contraddizioni che attraversano quella che secondo lui è “innanzitutto una esperienza” (umana e corporale) che, strutturata com’è dal rischio dello smarrimento e della perdita di qualcosa e/o di qualcuno, ha come effetto l’essere dominati dal desiderio che, talvolta, prende forma di esperienza necessariamente negativa. La direste una contraddizione in termini, ma non è così, non c’è violenza nelle parole, per quanto esse possano avere effetto vessatorio, che non risparmiano né i sentimenti, né la sensibilità dell’individuo.
Ciò non toglie che le parole possano far male nel profondo anche al solo evocarle ma, c’è pur sempre un altro aspetto da considerare, per effetto dei loro ‘sinonimi e contrari’, con cui avvalersi della ragione, (qualunque essa sia), ed è il compromesso che facciamo e/o accettiamo con noi stessi, che già Jacques Lacan, qui ripreso più volte da Recalcati, esprimeva come: ’responsabilità senza padronanza’ e che riguarda l’apertura al desiderio. Quel desiderio che spesso abbiamo tenuto nascosto e/o segregato, perché avevamo e/o abbiamo ‘paura’ di esternarlo, e che guarda caso, come un tarlo continua a condizionare la volontà dei nostri sentimenti e le nostre azioni.
Al punto che tradire di fare l‘esperienza del ‘desiderio’ è un po’ come tradire noi stessi, ma poiché siamo esseri antropici, diversi dagli animali che provano solo istinti, dovremmo anche ammettere a noi stessi di non essere perfetti, anzi di essere imperfetti e quanto più diversi, per questo considerati ‘umani’ e alquanto meravigliosi. Se pure alla stregua di una transumanza d’intenti (di desideri) da considerare senza alcuna colpa e/o responsabilità; nella possibilità di fare d’ogni eventualità un’esperienza:
"Finché c’è desiderio, c’è vita; il desiderio allunga la vita, nella misura in cui il desiderio ci attraversa, dilata l’orizzonte della nostra vita".
Dunque, la prima considerazione da fare è che:
“Noi siamo portati dal desiderio, […] (o meglio), siamo posseduti dal desiderio, non nel senso negativo del termine”,(bensì) “il desiderio ci attraversa, […] che non è la forza dell’io semplicemente, ma che è qualcosa di ulteriore rispetto all’io; […] l’esperienza di una forza che mi supera.”
“Dove c’è l’io, dove c’è la supponenza dell’io di governare il desiderio, non c’è desiderio. Viceversa, esso appare quando l’io si indebolisce, quando l’io riconosce la sua insufficienza. È per questo che l’io è in fondo la malattia mentale dell’uomo: credersi un io è veramente la ‘follia più grande’, (J. Lacan). Credersi un io è una follia, e questa follia adombra l’esperienza del desiderio.”
Si è detta ‘paura’ utilizzando un termine che può sembrare scorretto, ma è questo il vero paradosso: la paura d’essere dominati dal desiderio e/o assoggettati, quanto più permettiamo al desiderio di soppraffarci. È allora che quello che doveva essere “il desiderio del -e/o nel- desiderio dell’altro” (Lacan), diviene la negazione del desiderio stesso. Mentre, invece, il desiderio deve far appello e/o congiungersi con il desiderio dell’altro per avere una sua valenza intrinseca:
“Ed è quando la vita umana prende la forma dell’appello all’altro, dell’invocazione dell’altro, - potremmo dire radicalmente - della preghiera: che la vita umana può dirsi ‘vita che si rivolge all’altro’. Quando ciò che noi siamo, è tradotto in domanda d’amore, in domanda di presenza”; quando cioè il desiderio si fa corrispondenza con l’altro nell’assunzione di corresponsabilità.
Paura che nella notte (dei nostri giorni) possa non rispondere nessuno al nostro grido di desiderio:
“La vita umana per umanizzarsi ha bisogno di questo sì, (corrispondente all’ammissione di presenza), ha bisogno di essere adottata (dall’altro), e dunque che qualcuno dia senso alla nostra vita.”
Nel volervi vedere una qualche contraddizione, se di questa si tratta, sta nel fatto che “il desiderio esige al tempo stesso di realizzarsi in proprio”; mentre è pur vero che “il desiderio dipende dal desiderio dell’altro, […] dall’accoglienza dell’altro”, quasi che il nostro desiderio fosse il desiderio dell’altro e/o, comunque, dipendesse dall’altro. Ma se escludiamo che ciò possa sussistere, il nostro desiderio risulterebbe acefalo, strettamente legato al nostro individualismo, al nostro narcisismo quanto al nostro egoismo.
Semmai dovremmo imputare al nostro desiderio una fuga dalle emozioni, la cui assenza sfocia nella solitudine, nella volontà di non misurarci con gli altri, né con la società, né col mondo che ci circonda; una sorta di patologia malata che non ci mette al riparo dalla sofferenza:
“Il desiderio si nutre del desiderio dell’altro, ma il desiderio esige anche di avere un proprio oggetto (presenza), una propria vita (da spendere e scambiare), un proprio percorso (esperienza), e in questo si manifesta come fuoco (possessione), come forza (volontà). Ciò va riferito agli atti che compiamo e che compiremo, e che “spiega, per esempio, tutta la turbolenza della giovinezza”: le inquitudini, le ripetute crisi, i fallimenti, gli abbandoni, i sensi di colpa e di sbandamento cui si è soggetti in gioventù, e non solo. Ci sono età in cui la giovinezza ostinata, l’invecchiamento, la non accettazione del decadimento fisico, creano quelle ‘paure’ insospettate (spesso inconsce) cui solo la psicoanalisi ha saputo e può dare risposte valide.
La fuga in avanti e/o dalla realtà attuale, ad esempio, ha determinato l’attaccamento morboso all’uso del cellulare, la cui ‘presenza’ è qualcosa che nel bene e nel male ci rassicura; così come i video-giochi ci danno la dimensione della nostra potenza di riuscire ad essere ciò che (ancora) non siamo, o che ‘forse’ non abbiamo il coraggio né la volontà di essere: cioè despoti di noi stessi. Ma attenzione, non saper tenere sotto controllo i sentimenti può anche scatenare in manifestazioni violente di quell’io che crediamo di essere, dacché l’arroganza, la violenza, lo stupro,
il masochismo che ci rende comunque schiavi di noi stessi.
È dunque questa, in assoluto, la ‘forza’ cui detenere il controllo, saperla conformare alle esigenze reali, non utopistiche di ciò che non ci è dato, ma, per fare ciò, in primis bisogna conosce se stessi, chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare, cosa vogliamo costruire, che sono poi i segni di una maturità per certi casi irrangiungibile.
Sia nei casi in cui “la vita si dà come esigenza di separazione” da un precedente status; sia in cui necessita di una rottura col passato e/o con l’attuale status, e si da inizio a una forma di ‘erranza’ dove, oltre ad incontrare se stessi, si va incontro all’altro, in termini di instaurare un rapporto con l’altro, scavalcando le differenze di genere (sesso) che le diversità d’intenti (comunità, famiglia allargata ecc.).
Da cui si evince che, per non entrare in conflitto con se stessi, per continuare a soddisfare il (solo) desiderio dell’altro, veniamo a mancare di quella ‘volontà’ che altresì dovrebbe dare corso alla naturale esposizione dei nostri sentimenti, mancando così di affermare il nostro desiderio di intima soddisfazione:
“Al contrario la vita soddisfatta è la vita che si incammina con decisione (determinazione) lungo la via del proprio desiderio, e il desiderio esige rottura, conflitto. […] Essere ostinati con il proprio desiderio è una buona cosa: rende la vita felice, soddisfatta, e dunque la rende anche generosa, perché vita generosa è la vita soddisfatta.”
Rammento un vecchio detto in cui si affermava con saggezza che «non si vive di solo pane», e questo è il caso più lampante che abbia annotato negli anni della mia lunga esperienza in vita: “Certo, perseguire con determinazione il proprio desiderio significa anche far soffrire”, per quanto le risposte che Recalcati dà su questa argomentazione filosofica prima ancora che scientifica, si avvalgono di esempi maturati nel tempo, vuoi sulla sua persona, vuoi basate sull’esperienza di tanti anni passati a contatto con i giovani presso l’Università di Pavia in cui insegna ‘psicopatoloia del comportamento’.
Ciononostante mette in guardia sull’uso sconsiderato della psicanalisi:
È indubbio –scrive l'autore– che “la psicanalisi è una possibilità di traduzione dell’inconscio, ma rimane il fatto che il desiderio fa fatica a essere accolto, perché straniero a noi stessi, […] parla appunto un’altra lingua – una lingua straniera – che dobbiamo tradurre. Il desiderio non parla la lingua dell’io: è per questo che è difficile coglierlo e avere un rapporto diretto con il proprio desiderio”.
E aggiunge che per certi versi l’analista permette di tradurre metaforicamente la lingua cifrata in cui parla l’inconscio, ma che una volta tradotta, la difficoltà sta nell’indurre il paziente a decidere di andare nella direzione in cui il desiderio spinge; aggiungendo che paradossalmente, il desiderio spinge, ad esempio nei giovani, verso la dipendenza necessaria di andare incontro “all’appartenenza e all’erranza, al desiderio dell’altro e al desiderio di avere un proprio desiderio”.
Si direbbe una forma di realizzazione alquanto singolare, ma è proprio così che accade, almeno per una grossa percentuale di casi, allorché ‘incarniamo il desiderio’:
“Ora, il desiderio è sempre incarnato. Non c’è desiderio separato dal corpo. In questo senso il desiderio è sempre erotico […] in quanto porta con sé il corpo. Il desiderio non è l’io, è più dalla parte del corpo che dalla parte dell’io. Pensiamo all’arte: quando un musicista suona, uno scrittore scrive, un attore recita, quando c’è vocazione nell’arte, lì c’è il corpo, il corpo erotico”. Ovvero, la piena soddisfazione del corpo, qui inteso anche come forma intellettiva.
In fondo il cervello per quanto elastico sia va comunque considerato una parte del corpo, ciò che muove i sentimenti, da cui si sprigiona il desiderio, quell’eros corporale implicito nello spirito che possiamo distinguere in diverse espressioni intellettive consequenziali: nel dare oggettivo (donarsi) e/o nel ricevere (soddisfarsi); nel creare (generare) e/o distruggere (de-strutturare); ma ed anche nell’amore (elettivo - dinamico) e/o nell’odio (destitutivo – distruttivo).
In questo senso ogni evoluzione intermedia è, nel rapporto con il desiderio in quanto: “manifestazione del corpo, della dimensione vivente del corpo, apertura degli orifizi del corpo”; cioè apertura a/del desiderio “perché il desiderio esige l’apertura dei mondi (verso la natura umana, verso gli altri esseri antropici ecc.), perché in questo (e solo in questo) si respira la trascendenza del desiderio”.
“Anche il desiderio di Dio porta con sé il corpo …”, ma questa è un’altra parentesi che si apre dalle pagine di questo libro e in altro modo, più ampio, è documentata dall’autore in altre sue pubblicazioni: “Lacan suggerisce di andare al fondo di questo desiderio come desiderio d’altro. […] Possiamo dire che il desiderio, attratto com’è dall’illusione del nuovo, si trova anche la dimensione di apertura del desiderio”, da cui “emerge una responsabilità irriducibile” (specifica dell’essere). Responsabilità che si traduce in ‘vocazione’: “ una spinta, un orientamento fondamentale e singolare della vita, di una vita”.
Onde ciascuna vita è animata e/o orientata dalla vocazione del desiderio: “una legge che è fondamento di tutte le civiltà, della possibilità del vivere insieme, della possibilità della comunità, che inscrive nel cuore dell’umano l’esperienza dell’impossibile, legge che veicola l’esperienza dell’impossibile. È nella misura in cui la vita fa esperienza del limite (di quel tutto che ci è negato), che diventa possibile generare il desiderio”.
Ma c’è una frase in questo libro che più mi ha sconvolto al pari di un’onda d’urto in pieno petto, e che pur mi affascina e mi sorprende: “C’è un solo peccato, un solo senso di colpa giustificato, ed è quello di cedere, nel senso di indietreggiare, sul proprio desiderio”; che riscatta tutta l’argomentazione dall’essere fin troppo filosofica, per la parte in cui la filosofia infuenza la psicologia e anche la psichiatria.
“Non ci sono altri peccati – ci dice ancora l’autore – il che la futilità del capriccio, quando sentiamo che nella scelta che siamo chiamati a comnpiere, lì c’è la dimensione del desiderio e – come direbbe il filosofo – ne va di tutta un’esistenza, della stessa vita”.
Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista tra i più nori in Italia, è membroanalista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi. Dirige l’Irpa (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) e insegna presso l’Università di Pavia. Tra i suoi libri tradotti in numerose lingue, oltre a quello qui recensito, vanni segnalati: “L’ora di lezione” (2014), “Le mani della madre” (2015), “Il mistero delle cose” (2016), “Contro il sacrificio” (2017), inoltre a “Il segreto del figlio” (2017).
*
 - Letteratura
- Letteratura
Euterpe Rivista di Letteratura n.28
è lieta di comunicare l’uscita del n°28 della Rivista di Letteratura rivolta al tema “Musica e letteratura: influenze e contaminazioni”, con particolare interesse all’attualità delle argomentazioni messe in campo da quanti, poeti e scrittori, hanno inteso partecipare con articoli e saggi di rilievo.
L’apertura di questo numero vuole essere un omaggio al poeta Guido Oldani, padre del ‘realismo terminale’, con alcuni suoi inediti e un commento a cura del critico letterario Lucia Bonanni.
ARTICOLI
Mario De Rosa – “Una mistica fra rock e poesia: Patti Smith”
Iuri Lombardi – “Gli scrittori nella canzone d’autoreitaliana”
Fabia Baldi – “La querelle del Premio Nobel a Bob Dylan”
Corrado Calabro’ – “Musica e poesia”
Bruno Centomo – “Buonaterra e Centomo: la parola in musica”
Cinzia Perrone – “Bob Dylan il menestrello del rock”
Giorgio Mancinelli – “Musicologia all’origine della cultura globalizzata”
Francesca Camponero – “La poetica, cuore del melodramma”
Paolo D’arpini – “Musica come espressione ecologica dell’anima”
Denise Grasselli – “Dalla letteratura alla musica: l’enigmatica storia di Orfeo e Euridice”
Cetta Brancato – “Canto per Francesca”
Vincenzo Prediletto – “Beat in rosa: musica beat ed emancipazione femminile”
SAGGI
Cinzia Baldazzi & Adriano Camerini – “Bob Dylan tra Keats, Leopardi e Shelley”
Luca Benassi – “Del testo e della musica. Un approccio storico ai problemi relativi al rapporto tra poesia e musica”
Stefano Bardi – “La nuova frontiera della poesia in Italia: Rap & Company”
Lucia Bonanni – “Da La terra del rimorso di Ernesto De Martino alla “cinematografia sgrammaticata” di Pier Paolo Pasolini per un percorso interdisciplinare tra etnomusicologia, letteratura popolare e cinema etnografico”
Franco Buffoni – “Ritmo sopra tutto”
Cinzia Demi – “La voce della fontana in Fogazzaro, D’Annunzio, nei Crepuscolari. Una musica per immagini”
Lorenzo Spurio – “Approcci comunicativi e sovrapposizioni di voci nel delirio di Alice nel Paese delle Meraviglie”
Maria Grazia Ferraris – “Fryderyk Chopin e George Sand. La goccia d’acqua”
Gabriella Mongardi – “Letteratura e musica in La morte a Venezia di Thomas Mann”
Valtero Curzi – “Letteratura e musica: influenze e contaminazioni”
Marco Tabellione – “La Musica silenziosa. La poesia e la sua musicalità”
Angelo Ariemma – “Les Chansonniers ovvero poesia permusica”
Graziela Enna – “Due poeti francesi reinterpretati da Fabrizio De André: François Villon e Pierre de Ronsard
Carmen De Stasio – “Pienezza espressiva tra musica e letteratura”
Francesco Martillotto – “La musica, “dolcezza e quasi anima de la poesia” in Torquato Tasso
RECENSIONI
Gabriella Mongardi – “Come se di Luigi Santucci”
Laura Vargiu – “Cattivi dentro. Dominazione, violenza e deviazione in opere scelte della letteratura straniera di Lorenzo Spurio”
Laura Vargiu – “Quadro imperfetto di Stefania Onidi”
Carmelo Consoli – “Così è. Colloqui con Dio di Ermellino Mazzoleni”
La rivista può essere letta e scaricata in formato pdf collegandosi al bottone del sito dell’Ass. Euterpe (www.associazioneeuterpe.com). Segnaliamo la possibilità di poter visualizzare e leggere la rivista anche in altri formati compatibili con altri dispositivi: ISSUU/ Digital Publishing
Formati e-book:
Azw3 per Kindle di ultima generazione
Mobi per compatilità con tutti i Kindle
Epub per tutti i lettori non Kindle
Si ricorda inoltre che il tema del prossimo numero della rivista al quale è possibile ispirarsi sarà “I drammi dei popoli in letteratura: genocidi, guerre dimenticate, questioni irrisolte, rivendicazioni e speranze deluse”. I materiali dovranno essere inviati alla mail rivistaeuterpe@gmail.com entro e non oltre il 31 Maggio 2019 uniformandosi alle “Norme redazionali” della rivista.
È inoltre gradita la partecipazione al 4° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” di cui il bando sul sito concorsostorieinvigaggio@gmail.com entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Dopo le precedenti edizioni che hanno avuto la loro cerimonia di premiazione rispettivamente nei comuni di Cingoli (MC), Camerata Picena (AN) e Corinaldo (AN), ed essendo il Concorso volutamente itinerante, l’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN), con il Patrocinio del Comune di Morro d’Alba e della Provincia di Ancona, indice la quarta edizione del Concorso “Storie in viaggio” cambiando denominazione da “Concorso di Racconti brevi” a “Concorso di Letteratura” a ragione dell’ampliamento delle sezioni di partecipazione. La partecipazione al concorso è regolamentata dal bando pubblicato sul sito suddiviso nelle seguenti sezioni:
1.Racconto a tema il viaggio
2.Racconto a tema libero
3.Libro edito (poesia, saggistica, fotografico, altro riconducibile al tema “il viaggio” e diari di viaggio)
4.Video-poesia / video-racconto riconducibile al tema del viaggio.
Per quanto attiene alle sezioni A e B si partecipa con racconti editi o inediti, ma in quest’ultimo caso è richiesto di indicare in che libro o antologia sono stati precedentemente pubblicati. L’autore, comunque, deve essere l’unico detentore dei diritti sul testo che invierà. Riguardo alla sezione C si partecipa con un libro edito (appartenente ai generi sopra indicati) pubblicato regolarmente con casa editrice o autoprodotto dotato di codice identificativo ISBN.
Relativamente alla tematica del “viaggio” (sezioni A, C e D) si fa presente che può essere interpretata liberamente a intendere viaggi fisici, di spostamento sul territorio nazionale o internazionale e di viaggi interiori, percorsi di approfondimento e di crescita personale, educativo, morale, spirituale o di altra tipologia.
Ass. Culturale Euterpe c/o Lorenzo Spurio
Via Toscana n°3 - 60035 – Jesi (AN)
Per info rivistaeuterpe@gmail.com
*
 - Arte
- Arte
Matera: Capitale Europea della Cultura
Matera, città d’arte, designata dall’UNESCO ‘Capitale Europea della Cultura 2019’.
“Come amorevolmente protetta da robuste braccia, fra le due estreme penisole della Iapigia e della Calabria, regni delle Murge e delle Sile, si apre la classica costa ionica dela Basilicata, alla quale fanno corona la tragica Metaponto, bella ancora di templi dorici, la bianca Pisticci ricca d’industrie, Montalbano Ionico, centro agricolo e la fiorente Policoro, vicina ai resti di Heraclea che col castello dei Berlingieri, attorniato da umili abituri, domina la sua opulenta pianura e il mare. […] La spiaggia e la circostante silenziosa pianura, sembra ora ridestarsi da un sonno che si perde nei tempi ed avvince per il suo vero e molteplice aspetto antico e storico, artistico, culturale e pittoresco: contrada che meglio custodisce il tipo del paesaggio classico, solenne e suggestivo. Proprio in questo sacro silenzio emergono le linee di una energia primaverile, in cui il soffio stesso è il caldo alito di una febbre di altezze e di aspirazioni sante. E la campagna racchiude in sé i segni possenti delle età passate”.
Inizia così il bel libro postumo “La mia Basilicata” in memoria di Concetto Valente che il figlio Giuseppe Valente ha voluto dedicargli nel centenario della sua nascita. Ben poco rimane all’immaginario da fantasticare, la colta descrizione parla da sola, ancor più quando lo scrittore si abbandona al canto lirico del poeta che lo insigna, e che ritroviamo nelle pagine seguenti:
“Dal golfo s’inerpica la terra lucana tra colli e monti, le cui vette brulle ed immacolate immerse nell’azzurro formano la gradinata gigante dinanzi alla immensa valle solitaria ed all’arco aurato della spiaggia. Dalle schiere di colline e monti, interrotte da strette pianure ubertose e da fresche valli, s’innalza repentino, come nube a Mezzogiorno, a confine con la Calabria, il massiccio del Pollino, dalla cui vetta l’occhio abbraccia un vastissimo orizzonte che comprende la visione di mezza Basilicata e spazia dal Tirreno, fino al porto di Taranto ed oltre. [...] E già emergono terre più ricche e sane, specie intorno all’oasi di Policoro, già bella di superbi e fregranti frutteti, e così in tutta la pianura ionica stanno estendendosi più fitti aranceti, albicocchi e pescheti, salutati sulle prime colline dall’antico fluttuare di ulivi, di potenti carrubi, di grandi quercie, di favolosi pini, di pruni, fichi, mandorli ed ancora aranceti e cedri”.
“Le montagne della Basilicata hanno una caratteristica tutta particolare: vette superbe dominanti panorami meravigliosi e vari, profili staglianti ed ora armonici, che a guisa di anfiteatri racchiudono ridentissimi piccoli laghi selvaggi. Spesso città antiche, belle e custodi di opere d’arte d’immenso e pregevole vale subliminano queste alture; l’antichissima Matera dei Sassi, ricca di opere d’arte di ogni tempo d’inestimabile valore, Montescaglioso, Irsina, Tricarico, Acerenza, Venosa, Lavello, Melfi e l’aerea Potenza, che dalla sua altezza giganteggia sull’antica e gloriosa Valle del Basento e su quella ampia di rione S. Maria, verde di boschi, ‘boschetti’, ‘macchie’ e giardini”.
“La Basilicata non è terra improvvisata, cova dentro il suo fuoco ed ha il pudore e la gelosia dei suoi sentimenti più profondi. La bontà gli è riconosciuta; la giustizia presiede a qualsiasi giudizio delle moltitudini. Capace d’impeti mistici e di lunghe vigilie, la sua gente è ragionatrice, ponderata per indole, è vigile nelle analisi e si eleva a mirabili sintesi. Vuole essere epicurea ed è di natura nostalgica. Il suo custico umorismo non uccide ed è edificatore. Vuol ridere e si accora di un niente. Ascoltatela nelle ore gravi, terra sacra ai campi; terra sacra alle opere eterne. La sua gente vi fatica senza amarezza: la stella dell’alba è salutata dal canto del boaro; quella del crepuscolo ancora sente cantare gli uomini che ritornano verso le case disperse, che il monte cova ed il cielo inazzurra. La divina natura spesso inspira il cantore popolare, che commosso trova un’alta espressione sulle labbra per la terra madre”:
“Sienti,sienti! La terra mi parla chiani / sienti sta mamma antica / ca mi chiami e mi vole se songh luntani!”
“Per la gente lucana la maggior vita è all’aperto, la sua primavera è gagliarda, tutta vissuta nei riti agresti della semina, della mietitura, della vendemmia.I contadini di Maratea e di Acquafredda, a breve distanza dal classico lido dei templi pelipteri immortali di Paestum, come quelli delle colline del Mare Ionio, così del Pollino, Volturino, Areoso e Vulture o lungo il Bradano, Basento, Agri, Sinni e Ofanto, al tempo della mietitura del grano, verso sera quando il sole sta per giungere al tramonto, sospendono il lavoro e si inginocchiano dinanzi al sole che muore. Nella dolcezza dell’ora il massaro intona una Ave Maria alla quale i mietitori rispondono in coro sollevando le falci verso il sole”.
“Le tradizionali visioni mistiche ridestano la gente nei campi il contadino è tutt’uno con la sua terra, alla quale la sua vita è connessa immutabilmente. La ama profondamente. Conosce il cammino della sua casa, conosce l’ombra dei suoi pagliai. Ogni angolo dei suo campi, ogni fossatello, ogni vite, ogni olmo gli sono familiari ancor più della faccia della donna sua. E questo gli basta. Egli non può far passare il giorno che non percorra i suoi campi fra le siepi ben tenute; va fra la nebbia o la neve; studia i frusoli delle sue viti, le gemme dei suoi peschi, il verde dei grani pallidi, che debbono cespire. Non chiede di più. Emigra; arricchito ritorna in patria e riprende a lavorare il suo lembo di terra, al quale ha dato una fisionomia, un nome e un cuore. Riprende l’opera di rinascita a favore del suo tempo”.
“Risuonano nel suo cuore di uomo antiche melodie. E così nei vecchi orti di Venosa ove grandi massi poligonali, fra torri, dominano il Vallone Ruscello, formando insieme il loro miracolo di poesia e di realtà, di presente e di passato, di rovine classiche e di architetture medievali, io potetti ascoltare un canto leggere, fresco, di seminatori”:
“Lu cieli si inondava di grazia / mentre la selva mormorava cupa. / A Vergine Maria s’assettò / all’ombra dell’auliv; tutt’e frasche / abbasciannisi vasaren’a Gesù. / Evviva Maria / e chi la creò. / Lu cieli si inondava di grazia / mentre la selva mormorava cupa”.
“La bella strofa mistica, come per un canto umbro, pareva munita, pel suo volo, di candide ali, fra i severi ruderi latini. Un altro canto mistico nel periodo dei pellegrinaggi a San Miche le del Gargano ed alla grotta di San Michele di Monticchio, richiama il culto bizantino per San Luca Corleone e per San Vitale – che dopo aver difeso leoninamente Armento contro i Saraceni, maceravano le loro carni nelle grotte basiliane del torrente Melfia (Vulture), ove dipinsero santi ieratici e simboli del Cristianesimo – e ricorda ancora la tradizione dei cavalieri longobardi e dei loro rappresentanti spirituali, i monaci latini, che ne arricchirono la leggenda introducendo nell’Italia meridionale il culto per San Michele Arcangelo, il cristianizzato giovane Sigfried uccisore del drago, al quale furono dedicati santuari sulle cime dei monti della Lucania”.
Qualcuno leggendo si chiederà dove poter trovare la Lucania, oppure il Cilento, paradossalmente ‘inesistenti’ su gran parte delle carte geografiche, dopo l’avvenuto accorpamento di queste regioni con altre o la cancellazione dai flussi di comunicazione di zone del territorio rurale, ritenute di scarso interesse turistico ed economico. Per trovare alcune notizie interessanti sono tornato a sfogliare la Treccani con davvero scarsi risultati, se non che si tratta di una sub-regione la cui popolazione è dedita alla pastorizia e all’agricoltura. Mentre ho trovato qualcosa in una ‘Guida d’Italia’ del Touring Club Italiano nientemeno che del 1928 in cui si annovera la Lucania, come un’antica regione italica successivamente compresa nella Calabria e, infine, annessa alla Basilicata. Ma solo perché la sua storia è legata alle numerose guerre combattute da Greci e Lucani, fra Lucani e Romani contro Pirro e Annibale seguite da grandi devastazioni del territorio, niente di più.
Quel che verosimilmente rimane di questa regione, è infine un ‘amaro’ che viene regolarmente pubblicizzato in TV. Ovviamente non può essere solo questo, mi sono detto, ne vale la dignità di un popolo autoctono già famoso nell’antichità per la produzione artigianale della ceramica, sono famosi i vasi lucani, in cui si distinse per la sua qualità e il livello artistico. Poco o quasi niente rimane della conoscenza degli usi e costumi dei Lucani e dei Cilentani, letteralmente ignorati nella grande “Storia d’Italia” dell’editore Einaudi che, nei volumi dedicati a ‘I caratteri originali’ e ‘I documenti’ fa riferimento solo alle popolazioni della Basilicata e distrattamente alla Lucania in quanto agglomerato della prima, dacché la Lucania e il Cilento verosimilmente non esistono:
“Non si deve certo disconoscere che vaste aree contadine e pastorali del Sud sono rimaste sostanzialmente escluse dal contatto con le egemonie urbane e con le ‘città contadine’ ed altre ne abbiano subito solo marginalmente la pressione, ma è tuttavia ipotizzabile che il particolre ordinamento socio-economico del Sud abbia potuto mettere in movimento processi trasformativi della cultura tradizionale in grado di riprodursi attivamente lungo un arco temporale assai lungo, considerando la compresenza di altri elementi e il fatto che la tendenza a organizzare su base urbana la società contadina permane, nel Meridione, fino a noi. A questo elemento un altro può essersi congiunto nel determinare una particolare disposizione della comunicazione orale del Sud verso moduli che oggi ci appaiono assai prossimi a forme della ‘poesia culta’ della prima età della nostra storia letteraria.”
“Se infati osserviamo come quei caratteri ‘culti’ paiono essere emergenti più in Sicilia che nelle altre regioni meridionali e come la connotazione più ‘profonda’ e ‘primitiva’ il nostro Sud la trova non già nei suoi territori più meridionali ma piuttosto in un’area, per lo più interna, che comprende Campania, Puglia, Lucania e Calabria settentrionale, possiamo immaginare che anche quel processo di tardiva rilatinizzazione, che i linguisti hanno rilevato in Sicilia e nella Calabria meridionale, possa aver agito nel senso di caratterizzare in modo più ‘moderno’ una parte almeno degli oggetti comunicativi. In una simile prospettiva si può allora ipotizzare un duplice indirizzo d’influenza (dalle città meridionali verso le campagne e dalla Sicilia verso il continente) sulla cultura ‘arcaica’ del nostro Sud, con le conseguenze abbastanza sorprendenti che oggi ci è dato di osservare.” Ciò per quanto concerne le informazioni contenute in “Enciclopedia” (Einaudi 1973).
Tuittavia ritengo autorevole quanto scritto da L. M. Lombardi Satriani (*) sulle possibile ‘tecniche di distruzione di una cultura’ cioè, di un vero e proprio etnocidio a discapito di alcune popolazioni che assistono alla negazione e spogliazione della propria espressione culturale. Quando, a fronte di una cultura sommersa pur comprensibilmente autentica che pur andrebbe finalizzata alla comprensione di un ‘vissuto’, anche se in certi casi inconsapevole, da tutti, in ragione d’una sua comprovata esistenza territoriale.
Sommersa come lo è una certa religiosità commista di antiche superstizioni che sopravvivono nel sacro e nel divino che, ancora oggi sono parte integrante del quotidiano, sintomi di una tensione verso il sacro che il cristianesimo ha storicamente individuato e da sempre incanalato verso una religiosità autentica che si professi più autentica. Per quanto è altrettanto vero che questi agglomerati esistono e sono sempre esistiti, come bisogni non materiali che il godimento di sempre maggiori beni di consumo non riesce a soddisfare, anche se la cultura industriale li ha spinti ai margini, svalutati, soffocati, bollati dentro il loro stesso alone del ridicolo che verosimilmente li ha maturati.
Ma è tempo questo di restituire allo spirito quello spazio che gli concerne con un canto tradizionale raccolto presso un bracciante agricolo di S. Marzano, in cui la discendenza da antichissimi riti di morte e resurrezione, accentuate dall’uso melodico e una metrica insolita, fanno di alcuni canti veri esempi di grande rilevanza dell’espressività popolare:
“Né Carnuvà, pecché si’ muorto” (tipico lamento rituale per la morte del Carnevale)
“Né Carnuvà pecché si’ muorto / che nce vogliono ‘e sorde belle p’e schiattamuorte / che ggioia / t’aggio sentut’o o rummore r’re campanielle / mo se me vene ‘o cavallo ‘e puleciello /che ggioia / t’aggio sentut’o o rummore r’re carrettelle / mo se me venen’ ‘e femmene co’ ‘e canestrelle / che ggioia”.
L’espressività dionisiaca del ritmo, caratteristica di alcune danze più antiche relative alle feste organizzate in onore della divinità pagana, può essere ricondotta alla funzione originaria di scansione musicale e coreutica all’interno del Carnevale sotto la denominazione generica della ‘tarantella’, accomunata ad altre danze ‘taranta spagnola’, ‘tarantulata pugliese’ ecc. in cui la particolare diffusione dell’organetto come strumento d’accompagnamento la fa da padrone. L’originalità del canto che segue sta nel fatto di elencare una serie di strumenti che variano da luogo a luogo e che ci permette di connotarne l’uso:
“Caro cumpare”
(canto sull’organetto, chitarra, tamburello, campanelli)
“Caro cumpare che bai sunanno
vaco sunannu lu viulinu
comme lu suoni lu viulinu (uè cumpà)
minghillu-minghillu fa ‘u viulinu
don-don-don fa ‘u campanone
dan-dan-dan fa la campana
din-dindin fa ‘u campaniello
e dipidindà fa ‘u tamburiello
…
Caru cumpare che bai sunanno
vaco sunannu la rancascia
comme la suoni la rancascia (uè cumpà)
t’ ‘o ‘ncascio t’ ‘o ‘ncascio fa la rancascia
te ‘mponno te ‘mponno fa le zampogne
bai e bbene l’urganettu
nze-nze-nze fa la chitarra
minghillu-minghillu fa ‘u viulinu
don-don-don fa ‘u campanone
dan-dan-dan fa la campana
din-dindin fa ‘u campaniello
e dipidindà fa ‘u tamburiello
…
Caru cumpare che bai sunanno
vacu sunannu lu cuornu re caccia
comme lu suoni lu cuorno re caccia (né cumpà)
e musciu e bbuono t’ ‘o sbattu ‘mpaccia
ecco ca suona lu cuorno re caccia”.
Ed ecco cosa ci dice un vecchio libro scolastico sulle “Regioni d’Italia” sulla Basilicata allorché, superate le informazioni sul clima, la flora, la fauna e l’aspetto orografico del territorio, l’industria e l’artigianato, ci ricorda le principali città come Potenza, Matera, Avigliano, Melfi, Maratea, Piosticci, Tursi, Acerenza, Tricarico Montescaglioso con le rovine della Magna Grecia, così come Metaponto (dove insegnò Pitagora), e che sulle monete rinvenute (Lucania) appare il simbolo della spiga d’orzo, un tempo sacra a Cerere e simbolo della regione. Un solo sporadico accenno è dato sulla Lucania:
“isolata fra i suoi monti, percorsa da profonde vallate di difficile accesso che in tempi antichissimi vide giungere gruppi di ‘coraggiosi’ che spingevano avanti le loro mandrie e trasportando gli utensili agricoli, e che quindi vi si stabilivano attratti dalla bellezza naturale del luogo. Mille anni prima di Cristo giunsero i Lucani; più tardi i Greci, i Goti, i Longobardi, i Bizantini che ne cambiarono il nome in Basilicata da ‘basilikos’ che in greco significa ‘funzionario imperiale’.
Ancora oggi la più grande personalità lucana è il poeta latino Orazio Flacco (Venosa 65 a.C. - Roma 8 aC.) autore di Epodi e Odi, Satire ed Epistole appartenenti al genere lirico. Per saperne di più ho sfogliato quell’incredibile documento storico in due volumi che “Antica Madre” (AA.VV. Garzanti-Scheiwiller 1989) ha dedicato alle genti italiche: “Italia: Le genti della Basilicata antica”, che ci informa sui Lucani anche detti Enotri o Coni di origine arcade, forse discendenti da Sparta, già presenti attorno al 1800 a.C. quindi agli inizi dell’età del bronzo. E successivamente allo spostamento di gruppi etnici dalla Campania alla Sicilia a partire da un certo momento (e dunque da un certo mutamento culturale profondamente ellenizzato), in cui si identifica la fisionomia culturale delle rispettive popolazioni insediatesi nelle regioni meridionali, fra cui i Sanniti in Campania e i Lucani nell’area di Metaponto.
Poco o nulla è detto delle profonde trasformazioni avvenute nell’espressione del sentimento religioso e ancor meno degli strumenti musicali utilizzati nei rituali funebri e nelle feste calendariali in questa zona così sentite profondamente. Tuttavia, per quanto concerne la grande permeabilità culturale che ormai accomuna tutto il mondo italico meridionale, corrisponde una sostanziale unificazione dello scenario culturale si conosce l’esistenza di qualche sporadico flauto di canna (Eboli), della ciaramella (Auletta), dell’aulos a due canne forate, delle nacchere cilentane d’importazione ellenistica, e la cosiddetta ‘tromba degli zingari’ detta anche ‘marranzano’ presente in tutta la Magna Grecia.
Lo strumento importato probabilmente dall'Asia dalle popolazioni nomadi è conosciuto anche con il nome di ‘scacciapensieri’, è costruito in metallo a forma di un piccolo ferro di cavallo, con al centro una linguetta pur’essa di metallo fissata ad una sola estremità al telaio, viene fatto suonare tenendolo tra i denti e facendo vibrare con un dito la linguetta, la cui ‘nota’ può essere in parte modulata variando la forma della cavità orale attraverso il movimento delle guance e della lingua ed usata come accompagnamento negli intervalli musicali nel canto, insieme alla chitarra battente e al tamburello.
Sebbene la trascrizione dei canti non tiene conto delle riprese e delle ripetizioni di temi pur numerosissime, sia nella sua complessità e sia nella varietà, ciò avviene per nuclei musicali separati da brevi pause, attraverso una peculiare successione per ripetizione-cumulazione di un verso dopo l’altro, per cui si collegano in modo frequente di esecuzione, ma spesso anche per bruschi scarti su altro tema o, con improvvisazioni occasionali, tipici del cantare popolare che prevede l’intervento dei presenti secondo la disposizione soggettiva dei cantanti. Tutto ciò spiega in parte la variabilità del contenuto delle sequenze e la successione ininterrotta, ad esempio nella ‘tammurriata’ (canto e ballo alla tammorra) e/o della ‘pizzitata’ eseguita sulla chitarra battente. La nota ‘pizzitata’, termine che designa la tarantella utilizzata nel Salento per l’esorcismo coreutico-musicale nella terapia del ‘tarantismo’, anche conosciuta col nome di ‘pizzica’.
Allo stato della ricerca etnomusicologica si ignora se e quali connessioni e interrelazioni possano essersi sviluppate in passato fra ‘pizzica’ e ‘pizzitata’, la cui esecuzione tuttavia risente idealmente di un solo organico strumentale in accumulo di una serie di strumenti diffusi nell’area cilentana, sui quali una volta la ‘pizzitata’ veniva quasi certamente suonata durante le cerimonie pubbliche lucane: “..una mescolanza di cattolicesimo popolare e di relitti di forme religiose antico-arcaico connessi con i diversi momenti che regolano il mondo agricolo.
“ Tra le feste del ciclo dell’anno ‘carnevale’ e ‘capodanno’ hanno in gran parte hanno conservato caratteristiche abbastanza integre ed autonome. […] Tra queste ultime si pone il ‘giuco della falce’ che ha luogo (almeno fino a pochi anni fa) a San Giorgio Lucano, in provincia di Matera, e che appartiene a quelle feste di mietitura diffuse in gran parte dell’Europa. Elemento essenziale di questo ‘giuoco’ è il mascheramento dell’atto del mietere con quello di una battuta di caccia a un caprone, personificato da un uomo ricoperto da una pelle d’animale. I contadini, fingendo la battuta, in effetti mietono il grano e stringono sempre più il cerchio intorno al capro fino a raggiungerlo e ad ucciderlo simbolicamente”. (C. Valente, op.cit.)
Le cerimonie a carattere privato più diffuse sono quelle magiche, soprattutto la ‘fascinazione’, la pratica ancora presente e soprattutto la memoria culturale ancora viva, nonché l’importanza dell’aspetto etnomusicologico, dovrebbero essere di stimolo per gli operatori culturali e di quanti sono alla ricerca di stimoli musicali, che dal ‘vivo’ del passato, giungono fino a noi a insegnarci quel certo virtuosismo creativo mai dismesso, e che ritroviamo in ogni regione limitrofa. Tuttavia un aspetto particolare e una certa diversità distinguono l’assetto della Lucania/Basilicata dalle altre regioni come la Sicilia o la Campania, pur dividendo con queste talune somiglianze e evidenti scambi, se vogliamo, invevitabili con la Iapigia per il grande dominio culturale che sul litorale ionico ebbero con le città della Magna Grecia, le cui superstizioni sopravvivono nel sacro e nel divino di oggi.
Con ciò si vuole qui offrire un prezioso materiale di demopsicologia con l’intento di studiare l’anima popolare e di offrire alcuni documenti dei valori spirituali della razza, senza escludere quelle che sono le tradizioni pagane tutt’ora ‘vive’ sul territorio. Molti paesi sappiamo, offrono un largo campo di osservazione per quanto riguarda i costumi, i canti, i riti occulti e l’arcano dei ricordi orali, che attraversano la favolosa antichità del medioevo.
“Una usanza senza dubbio del periodo di Metaponto, di Siris, di Heraclea, di Paestum, è il rito che si pratica lungo la costa jonica di Pisticci, di Policoro, di Nova Siri e sui colli del Senise, di Sant’Arcangelo, di Ferrandina, Colobraro (in Lucania), e di Calimera, di Melpignano e di Castrignano (nella Iapigia) e che consiste nella celebrazione delle ‘prefiche’ sui morti, anche dette ‘repite’ che, a somiglianza delle antiche ploratrici, piangono e cantano lungamente sui cadaveri dei defunti” (C. Valente, op.cit.).
A questa usanza l’etnografo Ernesto de Martino dedica nel libro “Morte e pianto rituale” (Boringhieri 1975), un intero capitolo: “Il lamento funebre lucano”: “Può sembrare strano che una ricerca storico-religiosa sull’antico lamento funebre rituale si apra con una giustificazione metodologica che riguarda una particolare indagine etnografica. […]Un procedimento così eccezionale, e a prima vista così discutibile, è certamente bisognoso di una giustificazione che riguarda la determinata ‘tecnica del piangere’ come quella messa in atto nel Sud, cioè un modello di comportamento che la cultura fonda e la tradizione conserva al fine di ridischiudere i valori che la crisi del cordoglio rischia di compromettere. In quanto tecnica (quella del pianto rituale) che riplasma culturalmente lo strazio naturale e astorico (lo strazio per cui tutti piangono ‘ad un modo’), il lamento funebre è azione rituale circoscritta da un orizzonte mitico”.
“Al contrario i relitti folklorici del lamento antico ci permettono ancor oggi di sorprendere l’istituto nel suo reale funzionamento culturale: e ciò che la documentazione antica ci lascia soltanto intravedere o immaginare, cioè il lamento come rito in azione, la documentazione folklorica ce lo pone sotto gli occhi in tutta la sua evidenza drammatica, offrendoci in tal modo non sostituibili opportunità di analisi. […] Tuttavia anche se il lamento funebre folklorico ha perso il nesso organico con i grandi tempi della religiosità antica, e anche se i suoi orizzonti mitici sono particolarmente angusti e frammentari, esso può fornire ancora, almeno nelle aree trattate e di migliore conservazione, utili indicazioni per ricostruire la vicenda rituale che, nel mondo antico, strappava dalla crisi senza orizzonte e si reinseriva nel mondo della cultura autoctona.” (De Martino, op.cit.)
A questo proposito, per meglio comprendere la lezione di De Martino, riporto qui un passaggio riferito alla ‘morte’ di Vincenzo Boda (*) “La religione sommersa” (Rizzoli 1986): “La ripercussione attraverso la parentela (che pure si esplicitava come dolore per la perdita, diventava, ed era, un ‘crisi di gruppo’ di appartenenza. Ciò scaturiva da certi comportamenti rituali (mitici e sociali) nei quali certamente agivano , e interagivano, componenti diverse da quelle mortuarie. Ma non c’è dubbio che in tali mitologemi e in tali comportamenti rituali, sia a livello di crisi collettiva che accompagnava ogni morte, sia a livello della tensione e dell’angoscia che apparivano radicate nel sentimento dell’incertezza e della precarietà esistenziale. La vicenda ‘morte’ aveva ed ha una motivazione predominante e prevalente, tanto che non mancano studiosi i quali, a livello di ipotesi, fanno risalire l’origine della religione al tema della morte. In questa prospettiva, le mitologie dell’al di là, della sopravvivenza, dell’immortalità, i riti di seppellimento, di placazione, di venerazione dei morti e degli antenati si fondevano nella comune funzione di risposta all’illogicità della morte; diventavano tentativi per sostituire la sicurezza alla precarietà. Così il mito assolveva una funzione salvifica nel senso che, reagendo attraverso l’ideazione mitica, l’uomo e il gruppo si riscattavano dall’angoscia esistenziale e risolvevano la crisi emergente da ogni singola morte.”
“Il rito – prosegue Vincenzo Boda – doveva invece soddisfare sia l’esigenza istintiva, immediata, di esprimere il dolore e il dramma del distacco (che era più intensa e naturale quanto più prossimo era il grado di parentela o il rapporto di convivenza e di consuetudine), sia quella di risolvere il problema di fondo che stava nella crisi e nell’angoscia provocata dall’evento. Entro queste linee vanno pure riletti i miti dell’origine della morte e dell’immortalità primordiale, i miti di trasformazione della morte in passaggio all’immoertalità (si pensi, per esempio, nell’ambito dei miti più conosciuti ed elaborati, all’Ade pagano, ai misteri orfici, alla trasmigrazione delle anime ecc.), i miti della sopravvivenza (si pensi ai fantasmi, agli spettri, ma anche ai morti che ritornano, alle anime, alle ombre). Entro tali linee vanno pure riletti i fenomeni di ritualizzazione del duolo e del lutto, trasformati da ‘fatto primario istintivo’ (dolore per la morte e per il distacco) in una manifestazione che, seguendo schemi obbligati, tradizionali che, non solo si rende necessaria anche quando il fatto istintivo viene meno, ma può essere delegata a terzi, come a detentori delle giuste tecniche del duolo, appunto: la prefiche.”
Scrive ancora C. Valente: “Ma, oltre alle laudi severe della Settimana Santa, fra i monti della Lucania risuonano altri canti mistici, lì ove c’è anima, c’è sentimento, c’è dolore, ove c’è finalmente poesia. [...] Come nelle laudi dei poeti umbri, nei canti mistici l’espressione nuda del sentimento ha tutto l’impeto e il singulto della pura verità umana e l’amore divino non è che un riflesso dell’amore umano.” Richiamo qui di seguito un leggero e fresco canto mistico della gente lucana:
“Stedda Mattutina”
“È fatte juorne e sie lu benvenute / beneditte sia Die ca l’ha criate / Ti preje Gesù mje de darme aiute / concedami la pac’e la virtute / inta a chesta santa sciurnate.”
Famosi sono anche i riti nuziali, quelli per il Calendimaggio, le Cavalcate, le Processioni e i Pellegrinaggi che vengono talvolta riproposti con grande partecipazione popolare, come: “Il carro trionfale di Matera”, “Il pellegrinaggio di Fondi” e “La processione dei Turchi a Potenza”; quella per il “Corpus Domini al Santuario di Viggiano”, e la “Leggenda dei petali” (I pip’l): È questa una leggenda di alta ispirazione mistica in cui si narra: che nei tempi del martirologio cristiano una popolana di Potenza, nel lavare la biancheria giù al fiume Basento, ricordandosi che là vicino era stati suppliziati dodici martiri cristiani venuti dall’Africa, volle prendervi qualche loro reliquia – come scrive Paolo da Grazia (cit. Valente):
“Raccolse dei fiori inzuppati del loro sangue e se li portò a casa e li conservò in una pezzuola di candido lino. Dopo parecchi anni trovò i fiori ancora verdi come se fossero stati colti allora. Stupita li portò ad una asceta perché li conservasse in chiesa. Il ministro di Dio così fece e li conservò. E da allora ogni anno, il primo di settembre, in occasione della festa per i Dodici Martiri, si mostranvano al popolo i fiori verdi che aprivano i loro bocciuoli o petali, detti “pip’l”. Per questa tradizione d’ispirazione religiosa e di candida fede migliaia di giovinette del popolo, per la festa del Corpus Domini, dalle finestre e dalle terrazze di via Pretoria, adorne di damaschi, di tappeti e di coperte di seta, come un leggiadro e fantasioso mosaico di broccati, di oro e di ricami, salutano il passaggio del Santissimo sollevato dal Vescovo sotto una pioggia di fiori.”
Propongo quindi un canto ‘umoristico’ legato a “Lo scaricavascio” di Melfi con significazione storica risalente al 1799, epoca in cui i maggiorenti melfitani, in luogo di organizzare una strenua difesa della città, preferirono aprire le pèorte di casa propria alle orde devastatrici del Cardinale Ruffo. L’atto ritenuto vile, urtò il sentimento della popolazione che, non potendo altrimenti esprimere la propria indignazione in quei tempi di scarsa libertà, riuscì a significare nel canto detto dello ‘scaricavascio’, la insicura stabilità del dominio paesano che i maggiorenti, i sanfedisti, avevano ottenuto dal favore del Ruffo in cambio della resa. Il gaio ritornello – (come scrive A. Cantela nel libro di Valente) – è cantato da otto giovani contadini, quattro dei quali danzando sostengono il peso degli altri quattro, che si levano in piedi sulle spalle dei primi, tenmendosi stretti l’uno all’altro con le braccia. Nel balletto faticoso delle improvvisate torri umane che ne conseguono, la fertile fantasia popolare ricamò alcune strofe d’occasione i cui versi rivelano ai dominatori che se il popolo si sottrae al gioco del loro dominio, il capitombolo è inevitabile. Lì dove ‘Pizzic’Andò’ sta a significare: con tutto il pericolo, balliamo pure!
“Canto per lo ‘scaricavascio’”
“Vuoie ca state da sopra / Statev’attinte ancora: cadite … / Se si spezza lu ram di sotto / Ve ne sciate di capisotto. / Lu vide lu scaricavascio? / Lu vide e sembra mo /
Pizzic’Andò, pizzic’Andò.”
Ma in Lucania si canta anche all’amore Valente: “Il canto sgorga su dal cuore innamorato e trae ispirazione dalle tempeste dell’anima. Il popolo canta ed esprime la sua consolazione della fatica, la gioia del vivere e la sua fede con immagini delicate e pensieri pieni di tenerezza. A volte la poesia si fa profonda, più vivace e dolorante e accenna a intime lotte in descrizioni di vita popolare che raggiunge un alto valore lirico. Nenie nostalgiche e canzoni d’amore rivelano una malinconia pensosa, che è poi l’essenza dell’anima lucana, gaia talora solo in superficie, come nell’esempio di ‘fronna’ che segue:
“Canzuna nova” (in C. Valente, op.cit.)
“Voghhiu cantari ‘na canzuna nova,
pa gilusia ca mi struggi u core.
Gioia, l’amuri toj strittu mi teni!
Vurria tuccari l’unna ri lu mari
vurria vulà pi li cieli sireni.
Vurria cent’uocchi pi ti riguardari
milli cori pi ti vulì chiù beni.
La gilusia mi consumi u core
e ti voghhiu cantà a canzuna nova.”
Molte sono le canzoni d’amore cantate come messaggi da una gioventù priva di ogni distrazione, il cui pane e sale della vita era (un tempo) nient’altro che fatto di ansie e di lavoro, di stati d’animo e di desiderio, di sdegno e d’odio che si susseguono con vigorosa autenticità in una vena poetica e schietta, spesso insolita, nella giovinezza ardente … “E sia benedetta questa luce fatta di passione, di sentimento puro inestinguibile”. Tuttavia la Lucania e tutta la Basilicata non è solo questo. Con questa ricerca pur breve, si può ben immaginare quanto ancora ci sarebbe da dire, ma quest’oggi voglio con ciò salutare la gente lucana tutta e dare il benveuto a Matera città d’arte designata dall’UNESCO quale ‘Capitale Europea della Cultura 2019’.
Ma è qui doveroso ricordare lo studioso Concetto Valente che voglio ringraziare per il suo libro più volte citato, dal quale ho tratto a piene mani ogni sfumatura, e che tra le altre interessantissime cose di cui ci narra, ho appreso talune meraqviglie nascoste della città Matera:
“Una nota possente del paesaggio materano [...] è dato dalle ben note gravine scavate nei tufi e nei calcarei compatti – nelle voragini che separano le doline delle murge scendenti a gradinata verso il mar Ionio. La città si distende sui declivi di due valli profonde scavate dalla natura nel tufo seguendone la forma ed il declivio, chiamate Sasso Barisano e Sasso-caveoso. È dominato il Sasso-caveoso da un irto e severo scoglio con ai piedi una chiesetta bizantina scavata nella roccia. E le case dei Sassi, in gran parte aperte nelle doline tufacee, sono costruite in modo che l’una serva di base all’altra. Serpeggiano ripidi viottoli fra abitazioni primitive dominate da rocce e con scalinate sostenute da rozzi archi rampanti., in cui le caratteristiche abitazioni trogloditiche sostengono spesso ampie e impervie vie che si incurvano fra i comignoli delle case, il cui interno è rivestito di intonaco bianco ed ha lo stesso arredamento della casa comune”.
“Del sentimento religioso della gente lucana, le cappelle, le edicole e le croci, presenti nelle costruzioni, ci parlano le leggende sacre, le grotte aperte nei cupi recessi del monte Vulture, del monte Raparo e delle gravine di Matera, [...] ma perché il ‘frutto’ dell’arte si colga, conviene attivare questo semplicissimo criterio: laddove fioriscono forme speciali d’arte esse dovranno rinnovarsi, essere prese, continuate, adattate ai gusti dei tempi nuovi, senza che perdano nell’uso nulla della loro essenza, della natura propria della razza che vi impresse spontaneamente i suoi caratteri, le sue intime tendenze, le sue idealità.”
E con questo commiato, che a me sembra il messaggio più cospicuo e appagante dell’opera di Concetto Valente, scomparso nel 1954, al quale l’insigne Paolo Toschi ha voluto lasciare una dedica in cui gli riconosce la nobiltà della figura di studioso e di poeta, saluto e ringrazio il figlio Giuseppe che ha permesso di accedere all’opera del padre con la già citata sua pubblicazione.
Nota:
Concetto Valente (1881-1954) nativo della Lucania, fu direttore del Museo Archeologico Provinciale della città di Potenza, dal 1928 al 1954 anno della sua morte; colui che più di tutti si occupò di arricchire le collezioni artistiche museali. Nel 1925 ottenne la medaglia d’oro dei “Comuni d’Italia” dal Ministro della Pubblica Istruzione; ancora la medaglia d’argento nel 1942 concessa sempre dal M. della Pubblica Istruzione per la diffusione ed elevazione della cultura e dell’educazione nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione. Infine, nel 1955 è stato insignito della medaglia d’argento alla memoria, dal Presidente della Repubblica per i benemeriti della cultura. Nel 1932 curò la “Guida artistica e turistica della Basilicata” una monografia con testo a stampa, riproposto poi con aggiunte nel 1948.
Note bibliografiche:
“Guida d’Italia” - Touring Club Italiano, 1928.
“Storia d’Italia” - Einaudi in ‘I caratteri originali’ e in ‘I documenti’.
“Enciclopedia” - Einaudi 1973.
“Antica Madre” (AA.VV. Garzanti-Scheiwiller 1989): “Italia”.
(*) Ernesto de Martino, “Morte e pianto rituale” - Boringhieri 1975;
“La terra del rimorso” - “Sud e Magia” - Boringhieri 1976.
(*) Vincenzo Boda, “La religione sommersa” - Rizzoli 1986.
(*) L. M. Lombardi Satriani, sulle possibile ‘tecniche di distruzione di una cultura’. Annabella Rossi in “Basilicata”, in “Santi, Streghe & Diavoli” a cura di L. M. Lombardi-Satriani, Sansoni Editore 1973.
Si ringrazia inoltre il Teatrogruppo di Salerno per le note e la trascrizione dei testi; Gelsomini D’ambrosio per le illustrazioni di copertina e i disegni che accompagnano i booklet davvero preziosi che accompagnano i due LP; l’Editoriale Sciascia di Milano per la produzione del catalogo Albatros/Zodiaco; la Oedipos Edit. per il libro-album "Fantocci, principi e marchesi. Il Teatrogruppo di Salerno" (2011) , scritto e curato da Luciana Libero con un ottimo archivio di foto in bianco e nero che, a prescindere dalla valenza strettamente tecnico-artistica, restituiscono, fanno rivivere e ci lasciano ‘affascinati’ da uno dei periodi più ricchi e creativi della storia della nostra musica popolare.
*
 - Religione
- Religione
Cercatori di Dio : Epifania
‘EPIFANIA’
Carissimi buongiorno.
Vi trasmetto la meditazione di Don Luciano afferente al Vangelo della prossima Domenica Solennità dell' Epifania del Signore.
Rinnovo a ciascuno di voi e ai vostri cari di vivere con gioia il tempo di Natale e un Anno colmo della Grazia del Signore.
Dal Vangelo di Matteo (2,1-12):
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dovè colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.
All’udire questo, il re Erode restà turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
“A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”.
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
“Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra via fecero ritorno al loro paese.‘
La storia dei Magi è la nostra storia; è la storia del credente che risponde alla chiamata di Dio che gli giunge in mezzo alla confusione di questo mondo e che, nonostante le notti dello spirito che deve attraversare, persevera nel suo cammino. Nella loro storia ci sono tutti gli ingredienti di un vero cammino di fede.
Dio spesso si nasconde e raramente si svela a quelli che vuole chiamare al suo servizio, giusto quel tanto per spingerli a un primo passo che dovranno proseguire, come i Magi, nell’oscurità, nella fedeltà e nella fede, fino all’incontro faccia a faccia’
(J. Goldstain).
Mi piacciono i Magi, perché sono uomini in ricerca, cercatori della verità e dell’Assoluto. Il loro viaggio è il ‘santo viaggio’, il pellegrinaggio della fede, che inizia con il rendersi conto che quello che si conosce e che si possiede non basta, ma che bisogna dare ascolto alla propria sete profonda di verità.
Cercano, si mettono in viaggio insieme, interrogano, non pretendono di trovare da soli, non si scoraggiano nella loro ricerca, sanno ricominciare...
Mossi da questa ricerca di verità, i Magi alla fine si incontrano con Gesù Cristo, che è la Verità.
Lessing ha detto: ‘Se Dio mi si presentasse tenendo in una mano tutta la verità e nell’altra tutta la ricerca della verità e mi facesse scegliere, io risponderei: ‘La verità piena è solo per te, Signore: a me, uomo, concedi sempre l’ansia della verità’.
‘Ci hai fatti per te, Signore, ed inquieto è il nostro cuore finché non riposi in te’
(S. Agostino).
Certo, noi non siamo pagani come i Magi, che si accostano per la prima volta alla fede, ma dai Magi siamo stimolati a fare un cammino all’interno della fede che già abbiamo. ’Conduci benigno anche noi, Signore, che già ti abbiamo conosciuto
per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria’
(Colletta).
La ricerca di Cristo non è mai esaurita. ‘Concedici di cercarti ancora dopo averti trovato’. Trovare Cristo vuol dire cercarlo ancor ‘andando di inizio in inizio, per inizi sempre nuovi’
(Gregorio di Nissa).
Quello dei Magi è un autentico percorso di fede; da loro possiamo imparare molto.
• Quali sono le domande più vere e più importanti che riconosciamo nel nostro cuore? Abbiamo mai scelto veramente di muoverci da dove siamo verso la Città di Dio, incontro al suo dono d’amore?
•Siamo pronti a lasciare le nostre certezze per vivere l’avventura della ricerca dell’amore più grande, quello che solo Dio potrà darci? All’inizio c’è un segno più o meno luminoso. Ognuno lo scorge là dove si trova a vivere e a lavorare. Questi Magi scrutano il cielo, il segno lo troveranno lì in una stella. Qui non c’entra tanto l’astrologia; si tratta invece di un atteggiamento esistenziale profondo.
Guardare in alto: cercare una verità sulla propria vita, chiedersi cosa
il Cielo voglia dagli uomini. E’ necessario spesso alzare lo sguardo da se stessi, autotrascendersi. Del resto il presente non basta a nessuno.‘In alto i nostri cuori! ‘
Cercate le cose di lassù! Oggi si corre il rischio di non interrogare più i cieli, tanto siamo oc-cupati a fissare la terra! Il segno ha suscitato nel loro cuore un desiderio. Com’è importante il desiderio nel cammino di fede! Il desiderio di conoscere il senso profondo della nostra vita, il desiderio di verità, il desiderio di Dio!
Il segno più il desiderio spingono i Magi a fare il gesto più coraggioso: quello di partire.
‘Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio!’. E questo desiderio provoca in loro una domanda: ‘Dov’è il Re dei Giudei?’.
Qui emerge con molta chiarezza che l’incontro con Gesù avviene quando si portano in cuore degli interrogativi forti. Diffido di quelle persone che vivono una fede senza interrogarsi mai, senza approfondimento. Oggi c’è il pericolo di soffocare la domanda e di stordirsi nel rumore. E’ l’alienazione nel banale e nel superficiale.
La risposta la si trova nelle Scritture. Per incontrare il Messia non basta consultare il cielo, occorre consultare la rivelazione delle Scritture. Credo che non ci sia domanda nella nostra vita che non trovi una risposta nella Scrittura o nel Vangelo. Potremmo dire che, alla fine, la vera stella che porta i Magi a incontrare quel Bambino è la Scrittura.
Per noi è il Vangelo: ‘Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino’.
Senza seguire la stella del Vangelo non è possibile incontrare Gesù.
Se vuoi incontrare il Dio vivente fidati della sua Parola: mettiti in ascolto umile, perseverante e fiducioso di essa. Impara dalle Sacre Scritture il linguaggio di Dio, che ti aiuta a riconoscere gli appuntamenti con la sua grazia.
•Leggi assiduamente la Parola di Dio?
•La ascolti con desiderio e fede?
‘La civiltà occidentale sembra aver smarrito l’orientamento, naviga a vista. Ma la Chiesa, grazie alla Parola di Dio, vede attraverso queste nebbie. Non possiede soluzioni tecniche, ma tiene lo sguardo rivolto alla meta, e offre la luce del Vangelo a tutti gli uomini di buona volontà’
(Benedetto XVI).
Ma non basta conoscere le Scritture per incontrare Gesù, perché c’è modo e modo di leggerle. La competenza degli scribi sulle Scritture, poiché non è guidata dal desiderio e dalle domande, non porta a nulla.
Non basta il Libro! Sono informati, ma non sono coinvolti, perciò non si decidono mai a intraprendere il ‘santo viaggio’.
C’è poi anche l’incontro pericoloso con Erode, che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Sulla via della ricerca di Dio il vero possibile rischio è fare del nostro ‘io’ e delle nostre ambizioni l’idolo cui sacrificare ogni cosa. Il cercatore di Dio o sarà umile e impegnato a vincere le trappole dell’orgoglio, o non arriverà mai alla meta, sciupando quanto di più bello può esserci nell’esistenza umana.
Per i Magi, invece, l’indicazione della Scritture risulta illuminante e ciò permetterà loro di compiere l’ultima tappa: Betlemme, il bambino con Maria, sua madre. Riconoscono in questo figlio di povera gente, in questo bambino, bisognoso di tutto, l’atteso, il Re dei Giudei.
I Magi portano doni al Signore, ma soprattutto il vero dono che gli fanno è quello di se stessi (si prostrarono e lo adorarono).
Non è possibile credere in Dio e mantenere nello stesso tempo le distanze. Non si va a Dio a mani vuote. L’oro ci invita a offrire a Gesù una fede limpida, sincera, splendente, purificata dalle scorie dell’abitudine, della pigrizia, della superficialità. L’incenso ci invita a portare a Gesù una vita che profuma, generosa, serena e bella. La mirra ha un sapore forte, amaro. Ci invita a offrire a Gesù il coraggio di credere in lui.‘
Per un’altra strada fecero ritorno al loro paese’.
Quando si è veramente incontrato Cristo, nulla può essere più come prima. Quando si ha il Signore nel cuore non si può più percorrere la strada di sempre. Il mio incontro con Cristo quando è autentico incide sulle mie scelte e mi riorienta. Un’altra via sta per un’altra vita. E’ sempre differente il percorso che decidiamo di fare dopo essere stati segnati dall’incontro con Cristo!
Perché lo incontro tante volte e tutto resta come prima?
Signore, fa’ che io mi doni sempre più profondamente a te, che ti sei donato e sempre più ti doni a me.
Nell’abisso che mi separa da te, hai voluto venirmi incontro.
Mi hai chiamato, ti ho cercato: la tua luce mi ha raggiunto nella silenziosa eloquenza del creato, nei segni che mi hai donato nel tempo, nella via della carità vissuta.
Soprattutto, hai voluto parlarmi nella tua Parola, lampada ai miei passi, luce del mio cuore.
Fa’, che io ti doni agli altri per la semplice forza dell’amore che hai
voluto far abitare in me, e che scompaia perché tu solo cresca in ognuno di coloro cui mi mandi e che mi affidi.
Contatti: miry.clemy@gmail.com
VI
Con l’Epifania di Nostro Signore si conclude il ciclo delle festività legate alla Natività. Il Natale e l’Epifania sono infatti interscambiabili, perché storicamente, calendarmente, liturgicamente dicendo, fissavano un tempo, e in qualche modo ancora oggi, la medesima festa solstiziale, che abbraccia quindi i giorni e le notti incluse dal 24 dicembre al 6 di gennaio del nostro Calendario attuale.
È qui utile sapere che il calendario riferito al Natale, fa parte di un ‘ciclo’ di dodici giorni, le cui date d’inizio variano sostanzialmente, sebbene siano scandite dalle ‘calende’ che vanno: dal 13 novembre al 4 dicembre; dal 25 dicembre al 5 gennaio; dal 1 al 21 gennaio; in rapporto con le credenze arcaiche di trarre buoni presagi per il futuro. Recita un vecchio detto popolare ancora in uso:
“Le Calende della festa del Sol
le mostra al mondo quel che
Crist’vol”.
La fantasia popolare ha avuto, indubbiamente, parte preponderante nel costituirsi dell’alone ‘meraviglioso’ che circonda la festa del Natale e ovviamente l’Epifania che la Chiesa celebra nel giorno calendariale del 6 gennaio, con la quale si commemora la visita che i Magi federo, passati tredici giorni dalla nascita del Bambino a Bethleem, e con la quale si stabilisce la continuità del racconto evangelico che riafferma la contemporaneità della realtà storica e la tradizione popolare dell’evento miracoloso.
Più che in ogni altra memoria, l’avventuroso quanto misterico cammino dei Magi, trova nella “Legenda Aurea” del XII sec., di Jacopo da Varagine (1228-1298), e nella successiva “Historia Trium Regum” del XIV sec., di Giovanni da Hildesheim (1310/20-1375), quella immediatezza di linguaggio tipica del racconto popolare, umanamente accettabile, capace di affascinare e stupire dopo quasi un millennio. Il cui significato, trascende il confutabile della storia, per avvicendarsi nell’inconfutabile della narrazione fantastica e che, tiene ‘la vicenda’ come sospesa al filo incantato della ‘favola’ bella.
Il ‘ciclo’ delle leggende riferite all’arrivo dei Magi a Bethleem è indubbiamente tra le cose ‘meravigliose’ riservate dalla tradizione all’evento del Santo Natale. L’arrivo dei Magi va quindi legato ai doni che questi portano al Bambino dall’Oriente: l’oro, l’incenso e la mirra, entrambi simboli della missione ‘divina’ del Signore fin dalla sua nascita. La fantasia popolare, che nulla lascia di intrapreso, ha trasferito l’atto del portare i doni al Bambino di Bethleem, come un gesto d’amore che si ripete ancora oggi, portando in questo giorno calendariale i doni ai bambini, ripetendo così un ‘atto’ divenuto catartico nella storia, delle vicissitudine (leggi colpe) a cui si legano i genitori nel metterli al mondo.
La parte laica, cercando fra i personaggi della realtà cui attribuire questa incombenza, si fa riferimento alla figura del ‘buon padre’, talvolta riconosciuto in uno dei Magi, che torna dal suo viaggio; e dalla Befana nel personaggio della vecchia o la nonna, appartenente in origine al mondo delle fate della più antica tradizione Europea.
Originariamente erano queste giocose giaculatorie e, in seguito, liriche e ispirate canzoni popolari, dedicate alla festa ed entrate a far parte delle festività natalizie, un po’ come lo sono le luminarie, gli addobbi, i biglietti augurali, le candele colorate, i cibi appositamente confezionati e i pacchetti regalo a conferma della trasformazione di una festa dalle origini umili e contadine in ‘fatto’ esclusivamente speculativo e commerciale. All’origine, infatti, rientrava nei ‘gesti di costume’ e prendeva esempio dall’usanza romana delle ‘strenne’, cioè dai rami d’alloro in segno di regalità, e di ulivo in segno di pace che la gente si scambiava come augurio di prosperità e di abbondanza, durante le calende del mese di gennaio.
Lo scambio dei doni avveniva e avviene tutt’ora in segno di amicizia e quindi di fratellanza, quale simbolo augurale e significativo nei rapporti conviviali, di unione, di lieta dipendenza, come segno di affabilità e di felicità raggiunte; ed anche di stretta intimità che da sempre caratterizza il ‘tempo della festa’. Tempo in cui si esprime il ‘senso’ del quotidiano vivere comunitario, e del ‘meraviglioso’ reciproco scambio augurale di ‘pace’ e rinnovata ‘speranza’.
Spero sia gradita ai molti lettori leggere qui di seguito un componimento poetico di Arcangelo Galante davvero provvidenziale inviatomi qualche anno fa e solo oggi riscoperta, che ho il piacere di proporre a tutti voi lettori:
‘IL CANTO DELLA NOTTE DI NATALE’
Giunge sempre
da lontano
dolce e soave canto
mistico accordo
di cori leggeri.
Giunge sempre
lieve sospiro
di delicati sorrisi
sciolti nella notte
di Natale.
Giunge sempre
lieta melodia
nata nella capanna
di un luogo
al tempo sconosciuto.
Giunge sempre
la voce celestiale
armoniosa
incantevole
degli angeli tutti.
Non ascoltiamo oltre
non avviciniamoci.
Tutto languirebbe
nei rumori di sempre.
Restiamo in famiglia.
Quel religioso canto
giungerà sempre
ai nostri cuori.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Etnomusica – alle radici del sole: Giappone
‘Sarugaku-no-Nō’ / ‘La Cerimonia del Tè’ / ‘La Via del Samurai’.
“Sulla spiaggia del mare
sta una capanna solitaria
nella luce evanescente
d’una sera autunnale”.
(Sen no Rikyū)
Il Sole preso a simbolo della terra detta del ‘Sol Levante’ che svetta sulla bandiera del Giappone (1), non è, come si è portati a pensare, una licenza poetica; bensì occupa a ragione un posto di primo piano nella mitologia e nella relione giapponese, che hanno contribuito entrambe a formare il carattere del suo popolo. Secondo la leggendaria cosmologia nipponica, a dare origine al Giappone furono il dio Izanagi e la déa Izanami, entrambi posti all’inizio del tempo nel culto Shintō, basato sull’adorazione della natura e degli antenati, che attribuisce grande importanza alla purezza e alla purificazione.
Leggenda questa che si vuole legata alla rappresentazione scenica carica di pathos di un antichissimo rito, in cui è fatta menzione della déa Amateratsu, anch’essa nume della primigenia religione, alla quale si fa risalire l’origine dell’aristocratico Nō, di cui si è già parlato a lungo nella prima parte di questa ricerca. Qui riproposta in quanto espressione ‘catartica e sacra’ di un ‘fare teatro’ rievocativo di un primario culto religioso che, seppure con ben altri canoni espressivi, si ritrova nelle più popolari configurazioni del teatro Kabuki e del Bunraku. Nei quali, come si è visto, sono confluite modalità caratteristiche dell’intrattenimento popolare. In primis, l’apparizione degli dèi presente nelle forme arcaiche del folklore, e che evidenziano il rapporto dialettico stretto del corpo con la gestualità espressiva nella danza rituale.
“Secondo una teoria avanzata dagli storici, tutto ciò rientra nelle consuetudini tradizionali del Giappone, di riti agrari più arcaici legati alla coltivazione del riso confluiti nella festa danzata ‘dengaku’ che celebrava, sacralizzandolo, il lavoro nei campi coltivati con questo alimento primario, fondamentale nell’avvio allo sviluppo della futura cultura nazionale. In particolare, è testimoniato il fare ricorso ad alcune forme di credenze primitive in cui alcuni individui venivano ritenuti dalla comunità capaci di entrare in comunicazione con le forze misteriose ‘attive’ che risiedevano nell’universo e che permeavano le anime dei defunti e gli spiriti della natura”. (2)
È in questo contesto quindi che si originarono, attraverso il canto e la danza rituali le successive visioni esoteriche ‘taoiste’, da cui la spiritualità legata alle divinità ‘shintoiste’ e ad alcune pratiche ‘buddiste’ iniziatiche alle forme esperienziali della possessione estatica del Nō, in quanto proiezione scenica in grado di allontanare il male a beneficio del bene, riconducibile alla primitiva esorcizzazione degli spiriti ed a stabilizzare l’ordine cosmico della creazione.
Sappiamo inoltre che alla fine del XIII secolo, i sacerdoti della setta Jishu, come gli antichi sciamani con le loro danze e con i loro canti, assolvevano una funzione medianica evocando, in particolare, gli spiriti dei guerrieri caduti in battaglia, afferenti alle figure mitiche dei Samurai, ed alla più rigida disciplina dell’ ‘arte marziale della spada’, in cui essi, facendo rivivere gli spiriti del passato, evocati per esplorare le profondità dell’animo umano, vedevano la rappresentazione dei loro valori incarnata in una forma aristocratica altamente simbolica. Così come abbiamo appreso precedentemente dai drammi Nō riportati nei capitoli I e II, e giunti a noi soprattutto attraverso i veicoli letterari del romanzo e della poesia:
“Aki hiyori / “Cielo chiaro d’autunno
Senb a suzume no / tutti questi passeri
haoto kana” / frullare d’ali”
(Ryōkan)
È così che ritroviamo inglobate nella codificata forma teatrale del “Sarugaku-no-Nō” (3) alcune tradizioni teatrali anteriori, già all’origine delle prime rappresentazioni che si fanno risalire a origini mitico-religiose che, tramandate di padre in figlio fino a Zeami Motokiyo (1363- 1443), che le ha trasmesse nel cerimoniale rituale del Nō. Secondo la tradizione, il “Surugaku-no” nacque dalla danza mitica di Uzume, figura esemplare delle danzatrici sacre ‘miko’, nella quale le donne agitavano un ramo di ciliegio e che veniva eseguita in stato di trance allo scopo di far uscire la ‘déa del sole’ Amateratsu, dalla cavità della caverna dove si era rifugiata, propiziando in tal modo, la fertilità della vegetazione e il riequilibrio dell’ordine cosmico.
“Curt Sacks (4), il noto antropologo studioso di tradizioni popolari dei diversi popoli del mondo, ci ricorda ancora una volta che la visione antropologica aiuta nell’individuare gli intrecci tra la realtà mitica e quella storica, che stanno alle sorgenti delle forme teatrali; a comprendere come le valenze rituali trovino le loro radici, in epoca arcaica, nei fenomeni sciamanici di possessione estatica e, successivamente, nella sfera esoterica e metafisica del sacro e del religioso. […] Inoltre, a decodificare le convenzioni del linguaggio del corpo all’interno delle diverse forme teatrali e quindi, anche quelle specifiche del teatro-danza.”
Come nel ‘Nō’, anche nel ‘Kabuchi’, la modalità di apparizione degli dèi è evidenziata nel rapporto dialettico tra due ruoli dicotomici: il dio ‘kami’ e l’intermediario ‘modoki’. In questa opposizione è rappresentata la dicotomia tra principi opposti quali il ‘sacro’ e il ‘profano’, l’aristocrazia e il popolo, la vecchiaia e la giovinezza. Ma, al contrario, si celebra in esso la vitalità delle nuove classi sociali, fautrici di un’arte popolare rivolta al presente. I modelli di recitativo e dell’azione teatrale, rispettivamente chiamati ‘kata’, si diversificano negli stili detti ‘aragosto’ e ‘wagoto’. Mentre, all’interno della codificazione gestuale troviamo le posizioni ‘mie’ e ‘tate’, all’interno delle quali s’ergono le ‘tecniche di combattimento’ (più di mille), utilizzate nelle cosiddette ‘arti marziali’.
Va qui ricordata la figura dello ‘shite’ del teatro Nō che si muove sul palcoscenico strisciando senza staccare mai i piedi dal suolo ‘fonte di energia’, mentre danza con gesti ieratici e ipnotici nei quali si condensa l’essenza dell’azione, rivelando al tempo stesso il mistero che avvolge la sua anima, al suono del canto del ‘coro’ che, come una voce interiore, commenta le sue azioni. I suoi movimenti sono lenti, tragici e rarefatti e ogni gesto evoca potentemente la dimensione della trance in cui il suo stesso ventaglio, poi entrato nel costume giapponese, è il fulcro della sua danza, in quanto riserva infinita di simboli che arriva a rappresentare persino il pensiero dello ‘shite’ medesimo.
Ad ogni luogo, quindi, così come ad ogni personaggio e situazione, corrispondono specifici brani musicali prodotti per lo più dall’uso dello ‘shamisen’, da flauti di canna, da tamburi di diverse dimensioni e, talvolta, da bastoni di bambu percossi l’uno contro l’altro. Si conoscono almeno cinquecento brani circa, spesso eseguiti in scena da musicisti professionisti con strumenti antichi tradizionali. Cosa questa che ha permesso al noto regista cinematografico Serghej Eizenstein (5) di sintetizzare questa peculiarità: “udiamo il movimento e vediamo il suono”. Da cui si può ben comprendere l’enorme portata di questo patrimonio musicale estemporaneo del quale il popolo giapponese va altamente fiero.
“Ikutsure ka sagi / “Piccoli stormi d’aironi
no tobi yuku / solcano il cielo
aki no kure” / crepuscolo d’autunno”
(Ryōkan)
Anche il costume e il trucco risultano rigorosamente codificati: si conoscono circa duecento tipologie relative al costume, e altrettante per gli arredi di scena, in cui si realizzano l’unione delle arti della danza, della musica e dello stile recitativo. Tutte componenti spettacolari queste, in cui è molto evidente e si presuppone anche un lungo addestramento da parte dell’attore che si cimenta nelle diverse discipline, che gli consentono di interagire con il pubblico, coinvolgendolo con una interpretazione che, pur rispettando le componenti codificate della struttura teatrale, si fonde in una partitura personale che sa cogliere stimoli visivi e sonori.
È così che nel ‘Kabuki’ spesso l’erotismo e la crudeltà sono l’espressione simbolica di un cerimoniale ritualizzato che, pur essendo nato dalle danze della leggendaria Okuni, venne interdetto alle donne e i ruoli femminili interpretati da attori di sesso maschile, gli ‘onnagata’ che, acconciati e truccati alla maniera femminile, vennero presi a simbolo dell’essenza e della ‘bellezza’ sublimata. Codici questi divenuti poi simboli di una fase evolutiva della cultura giapponese che ritroviamo anche nella ‘cerimonia del Tè’ detta ‘cha no yu’, nel solo modo in cui una Gheisha (芸者 gheiscia) colta e raffinata riesce a colmare lo spazio attorno di pura bellezza estetica, al pari di un’opera d’arte originale.
La semplicità e la purezza de “La Cerimonia del Tè” (6), codificata in maniera definitiva nella forma ‘wabi-cha’ dal maestro del tè Sen no Rikyū (1522-1591), il monaco buddhista che a sua volta ne aveva emulato l’uso secondo i fondamenti posti dal cerimoniale rituale Zen, in quanto interpretazione giapponese del buddismo, in cui il tè veniva servito sul ‘takonoma’, il posto d’onore nella stanza giapponese dove, per il piacere degli ospiti che giungevano in visita, venivano disposti creazioni di fiori ‘ikebana’ e piccoli dipinti e xilografie ‘kuchi-e’, rientra tra le forme d’arte più esclusive dell’odierno Giappone.
Tutti i grandi maestri giapponesi del tè furono discepoli Zen e si sfozarono d’introdurne lo spirito nella vita quotidiana. Così la ‘stanza’, come gli altri elementi che la adornano e che sono funzionali nella ‘cerimonia del tè’ a ricreare un ambiente altamente estetico, per quanto minimalista, riflette i molti aspetti dottrinali afferenti al primo stadio della ‘meditazione’. Il pubblico conosce profondamente il valore e il significato di quest’arte sublime e segue affascinato ogni gesto, anche il più impercettibile, rapito dalla precisione e dalla bellezza dei codici gestuali, fin dal momento in cui la Gheisha avvia i propri passi attraverso il ‘rōji’: il ‘sentiero’ che nel giardino Zen conduce dal ‘machiai’ (corpo centrale della casa) alla stanza del tè, e che allude alla sua ‘mistica ispirazione’, concepita nell’infrangere ogni legame col mondo esterno, e muovere lo spirito interiore verso l’auto-illuminazione.
“Chi abbia percorso quello stesso ‘sentiero’, scrive Okakura, autore del “Il Libro del Tè” (7), non può cancellare il ricordo del suo spirito levato sopra le cure quotidiane, mentre, accanto a lanterne di granito che il muschio ricopre, comminava nel giardino, tra la luce crepuscolare dei sempreverdi, sulle regolari irregolarità delle pietre che tracciano il passaggio, tra le quali riposano, ormai secchi, aghi di pino. Si può essere al centro di una città e sentirsi a un tempo in una foresta, lontani dalla polvere e dal frastuono della civiltà. Grande era l’abilità che i maestri del tè hanno mostrato nel ricreare un’atmosfera di serenità e purezza.
La natura delle sensazioni da stimolare percorrendo il ‘rōji’ differiva da maestro a maestro. Alcuni, come Rilyü, miravano a una solitudine assoluta; il segreto di un ‘roji’, sostenevano altri, era contenuto nella canzone antica e cercavano effetti diversi, come diceva un altro ‘maestro del tè’ e straordinario architetto di giardini Kobori Enshū (1579-1647), che l’idea del ‘sentiero’ nel giardino, andava rintracciata nei versi che seguono”:
“Un gruppo d’alberi estivi
un poco di mare
una pallida luna serale”.
(Kobori Enshū)
Un tema questo della ‘solitudine’ interpreato in splendida serenità estatica, quasi che un ‘sentiero di luce’ illumini il cammino di colui che abbracciato lo Zen, (anche fosse solo in una stanza al buio), vede davanti a sé spalancarsi la cosmica natura della creazione. “È questo il tema di “L’allievo e le stelle” (8) in cui un giovane monaco si lamentava con un anziano maestro di non riuscire a giungere alla comprensione. Il maestro allora lo portò una notte nel giardino del monastero e gli chiese: “Le vedi le stelle?”. La storia pone l’attenzione sulla facilità con cui lo Zen pensa si possa giungere alla comprensione, se solo ci si affida al credere piuttosto che al sapere. Molte intuizioni giungono infatti alla mente che si libera dalle sovrastrutture della conoscenza comune, quando essa è intenta solo alla contemplazione delle bellezze del creato”.
“Nessun pensiero, nessuna riflessione
vuoto perfetto.
Eppure in esso qualcosa si muove
seguendo il proprio corso.
L’occhio la scorge
ma la mano non può cogliere
la luna nel rio …”
(Miyamoto Musashi)
Non è difficile leggere il significato intuitivo e complementare di questa immagine poetica, in quanto partecipe di una ‘strategia’ letteraria, in cui è ricreato l’atteggiamento di un’anima appena risvegliata che ancora indugia fra oscuri sogni del passato, mentre (ormai cosciente) s’immerge, nell’incoscienza dolce di una calda luce spirituale, e si meraviglia per la libertà intravista nello spazio più oltre, affatto ‘vuoto’, contenuto in alcuni ‘waka’ (epigrammi in versi) che esprimono lo stesso ‘concetto’ dal punto di vista Zen. La tecnica utilizzata è quella dell’Hejō (strategia), indicata nel “Libro di Ku” (il vuoto), afferente all’arte della spada, e che troviamo nel “Libro dei Cinque Anelli” (9) di Miyamoto Musashi.
Un ‘vuoto perfetto’ qui utilizzato per introdurre il concetto ‘neutro’ dello spazio cosmico in cui si rivela lo spirito Zen, secondo il quale il ‘vuoto’ è l’opposto di ‘nulla’: un grande ‘O’ per significare che tutto esiste già nell’uomo, ma che, per raggiungere la perfetta conoscenza, deve prima eliminare il superfluo, creare cioè il ‘vuoto necessario per ricrearsi’. Un vuoto onirico quindi, che le discipline Tao/Zen (buddista, shintoista), fanno derivare dal comune concetto di ‘sentiero’ da percorrere, onde per cui è detto: «Il ‘ku’ sarà la vostra via e la vostra via è il ‘ku’. Il bene è nel ‘ku’, esso non conosce il male; dov’è la saggezza, la ragione, la Via: lì è il ‘ku’.» (10)
Il ‘sentiero’ designato è quello all’interno del giardino giapponese (日本 庭园 nihon teien), qui preso come metafora di ‘via’ per introdurci nell’ambito intimistico della natura di questo popolo. Natura in cui la specifica ricerca qui avviata intende iniziare il lettore attraverso l’immagine del ‘vuoto onirico’, così come esso si rispecchia nella moltitudine delle sue rappresentazioni: nella scrittura e nell’arte ad esempio, così come nel teatro, nella danza e nella musica. Ma vediamo insieme quali sono le ‘Immagini del vuoto” (11) cui fare riferimento: il primo dei simboli che incontriamo è sicuramente il ‘sacro specchio’ menzionato nel culto della regina Hime(i)ko dell’antica gente Wa, abitante del regno di Yamatai, nel Kyushu (Nara), una regione a nord-ovest del paese.
I giapponesi ritenevano che lo ‘specchio’, a suo tempo importato dalla Cina, fosse un oggetto di grande pregio poiché in esso si ‘rifletteva’ non solo la natura virtuale della figura umana, bensì la trasposizione filosofico-escatologica del ‘vuoto assoluto’, in cui far rientrare la natura nel suo insieme. Quindi non solo uno strumento di grande utilità, bensì oggetto estetizzante del pensiero ‘interiore’ giapponese, che si avvolge della ‘bellezza’ di tutto ciò che lo circonda: dalla cura dedicata alla persona, all’arredo sostanziale della casa, dalla conformazione dei giardini; all’utilizzo dell’ombrello da passeggio per proteggersi dal sole, al ventaglio divenuto a un tempo oggetto di sofisticata gestualità.
Ed oltre, dal trucco facciale in grado di soddisfare l’esigenza estetico-artistica di una bellezza appariscente, fino alla disposizione artistica dei capelli, raccolti in più piani adornati con fiori e pagode come dei piccoli ‘giardini’ in miniatura, talvolta combinati con riempitivi interni e parrucche, tali da concorrere in un autentico capolavoro d’acconciatura. Come ci fa notare il noto cosmetologo Paolo Rovesti in “Alla ricerca dei cosmetici perduti” (12), “A iniziare dal VII secolo, si diede in Giappone la priorità di un culto notevole riguardo alla bellezza non solo nella donna, ma anche della natura, attraverso l’uso di fiori nelle acconciature,nell’abbigliamento e nei profumi, fondendo gli orientamenti estetici dell’arte con le applicazioni cosmetiche del corpo”.
E ancora, in “Alla ricerca dei profumi perduti” (13): “Nell’epoca Heian (I millennio circa) e nei secoli successivi, l’impiego dei cosmetici fu molto intenso, soprattutto più complicato e sofisticato nella donna. […] Pochissimo tenuti in conto dagli uomini, i prodotti di bellezza erano invece usati dalle ‘musmè’, a incominciare dalla grazia fragile dei paesaggi evanescenti ricamati sui loro tradizionali ‘kimono’ di splendida seta, con i loro fantasiosi ricami di fiori esotici, di fantastici pesci d’argento e oro, e degli straordinari uccelli dai più vividi colori, nonché di grandi draghi dalle fauci spalancate, personaggi mitologici di demoni e altre divinità mostruose che facevano e fanno tutt’ora contrasto con la grazia gentile delle indossatrici”.
Sono state scritte pagine su pagine interamente dedicate alla toeletta delle dame nell’antico libro: “Specchio dell’educazione delle vere signore” (14), utilizzato dalle dame della buona società inoltre che dalle Gheishe nella ‘Casa del Tè’, e dalle ‘musmè’, le ragazze delle case di piacere, in cui si parla dell’acconciare la folta capigliatura di cui le donne giapponesi vanno a buon ragione fiere: “La capigliatura raccoglieva gran parte delle cure ed era talvolta così complicata di spille di madreperla e di lacca, pettini di varie grandezze, di fiori e di ornamenti vari, da significare un linguaggio e un valore di convenzione sociale, così come il modo di disporre i fiori e di servire il tè”.
Ecco come un cortigiano del X secolo descrive al suo sovrano una bella dama che vorrebbe introdurre alla sua corte: “Sotto un’onda scintillante di capelli neri in cui brillano come stelle fiori e fermagli, il suo viso lisciato di ‘noi-ambra’, ha la grazia della luna a primavera. Uno sguardo dei suoi occhi languidi allungati di nero e Voi perderete la vostra città; un altro e Voi perderete il vostro regno.” (15)
“Yo no naka / “Tutto attorno a noi
wa sakura no / il mondo non è altro
hana ni nari ni keri” / che fiori di ciliegio”
(Ryōkan)
È fatto qui riferimento al ‘giardino giapponese’e alla sua mimetica reperibilità in natura, in quanto contenitore del senso universale ed esoterico dell’estetica narrativo-filosofica di questa cultura avvolta nel mistero delle sue origini. Senza alcun dubbio l’archetipo del ‘giardino giapponese’ venne progettato per la ricreazione e il piacere estetico degli imperatori e dei nobili di corte, mentre il giardino legato al tempio serviva alla contemplazione e alla discussione filosofica, in particolare con riferimento al ‘mappō’ (dal sanscrito e riferito alla fine del Dharma). Tuttavia, stando alla credenza popolare, il giardino tradizionale è spesso un modo altamente astratto e stilizzato con cui si creano, ispirati dalla meravigliosa natura circostante, paesaggi ideali in miniatura, che ritroviamo sia in pittura che nella grafica e nelle incisioni, arti queste in cui gli artisti giapponesi sanno essere eccelsi.
Per secoli i ‘giardini giapponesi’ (16) si sono sviluppati sotto l'influenza dei giardini cinesi, ma a partire dal periodo Heian (VIII, XII sec.) i progettisti giapponesi cominciarono a sviluppare i loro stili, basati su materiali della cultura giapponese. Ma è durante il periodo Edo (XVII al XIX sec.), che il giardino giapponese raggiunse il suo massimo livello e cristallizzò le sue forme in aspetti distinti. Successivamente, a partire dalla fine del XIX secolo, i giardini giapponesi hanno iniziato a modellarsi fondendosi con le influenze occidentali dando l’avvio ai diversi stili, derivati dalle diverse discipline, e distinti in ‘shodō’ e ‘bonsai’: il cosiddetto ‘karesansui’ giardino secco formato solamente da sabbia e rocce; il ‘roji’, giardino rustico che circonda le case da tè; e il ‘kaiyu-shiki-teien’, dove il visitatore può seguire un percorso per vedere paesaggi ricostruiti; così come il ‘tsubo-niwa’, piccolo giardino situato nel cortile ricavato fra le ali dello stesso edificio, il primo giardino Zen costruito in Giappone da un sacerdote cinese nel 1251 a Kamakura.
Molti giardini-tempio di Kyoto costruiti successivamente, almeno fino agli inizi di questo periodo, comprendono il ‘Kinkaku-ji’, ovvero il ‘Padiglione d'oro’ (17) del 1398, (di rifermento nel romanzo omonimo di Yukio Mishima); e il ‘Ginkaku-ji’, il ‘Padiglione d'Argento’ del 1482, entrambi edificati seguendo i principi Zen di spontaneità, estrema semplicità e moderazione, anche se, per altri aspetti, seguendo la tradizione cinese. In questi due edifici siamo dunque di fronte a una vera e propria rinascita giapponese dell’architettura e delle arti più in generale, in particolar modo alla concezione del vero giardino giappponese improntato sui canoni della religiosità massima. Si pensi che i piani superiori del Padiglione d'Oro erano davvero ricoperti di foglie d'oro, ed erano circondati da giardini acquatici tradizionali, dove vivono numerose specie di ninfee.
Lo stile più notevole inventato in questo periodo è appunto il giardino Zen detto Ryōan-ji a Kyoto, indubbiamente uno degli esempi più belli in assoluto: 9 metri di larghezza per 24 metri di lunghezza, composto da sabbia bianca rastrellata con cura per sembrare acqua e quindici rocce accuratamente disposte come piccole isole. È pensato per essere visto da una posizione seduta sotto il portico della residenza dell'abate del monastero: “Ci sono stati molti dibattiti su ciò che le rocce dovrebbero rappresentare, ma, come lo storico Gunter Nitschke ha scritto, "Il giardino di Ryoan-ji non simboleggia nulla. Non ha il valore di rappresentare una bellezza naturale che può essere trovata in natura, reale o mitica. Lo considero come una composizione astratta ‘naturale’ degli oggetti nello spazio, una composizione la cui funzione è quella di incitare la mediazione.” (18)
“Wasuseretemo / “Sia pur per dimenticanza
kumu ya shitsuran / non attingono
tabibito no / i viaggiatori
Koya no oku no / l’acqua nel giardino
Tamagawa no mitsu”. / all’interno di Koya”.
(Kukai)
È questa una composizione poetica altamente estetica che ritroviamo anche nell’ordinata scrittura giapponese ‘shodō-shodō’. In quanto ‘memoria antica’ del popolo che verosimilmente l’ha concepita e che, interpretata nelle forme più diverse, è servita a trasmettere il grande patrimonio artistico della civiltà giapponese, costituitasi attorno al XIX secolo. Allorché, abbandonate le strutture feudali cinesi, il Giappone si avviò verso un decisivo rinnovamento, risorgendo alla prosperità e portando una nuova ventata di eleganza e raffinatezza che in seguito avrebbe influenzato il resto del mondo.
“Di fatto la nobile ‘arte della scrittura’ giapponese, che il termine occidentale traduce con ‘calligrafia’, non riesce ad esprimere correttamente il significato legato alla sua pratica, e che altresì si può riassumere in ‘la via della scrittura’, richiedente un impegno incessante. E che, seppure in modi diversi, prende le caratteristiche di un ‘percorso’, tramite un certo perfezionamento tecnico che conduce a un affinamento interiore dell’individuo”. (19)
Si noti come nelle descrizioni e nelle definizioni riferite al Giappone, appare costante la parola ‘arte’, ma non è un vezzo di chi scrive, più semplicemente che ogni cosa è parte integrante di una autentica disciplina, assai vicina alla forma dell’arte. In quanto, rappresentativa delle diverse ‘vie’ da perseguire, o meglio di ‘percorsi possibili’ per il raggiungimento dell’autodeterminazione, composta di nozioni stilistiche, formali, utili (se non necessarie), come conoscere e interpretare “l’espressione degli stati d’animo e dei sentimenti”; “l’affinamento della sensibilità e il perfezionamento di sé” e, “la collaborazione e l’instaurarsi di corrette relazioni sociali e di lavoro”. (20)
Una disciplina questa, nata dal processo di mutamento e del ‘divenire di tutte le cose’ su cui si basa la filosofia taoista del ‘Dō’, applicata in Giappone intorno al XIX secolo a numerose arti tradizionali conseguenziali agli influssi di culti autoctoni e alla loro pratica. In particolare desunte dagli insegnamenti delle differenti religioni shintoista e buddhista, da cui derivano le discipline del ‘bushidō’, il codice di condotta e al tempo stesso lo stile di vita adottato dalla casta guerriera dei Samurai; il ‘kendō’, l’arte marziale della scherma, evolutasi dalle tecniche di combattimento con la ‘katana’, anticamente utilizzate dai Samurai nel ‘kenjutsu’; inoltre al ‘Judō’ come forma di lotta difensiva; il ‘kyūdō’ ovvero il tiro con l’arco, e il ‘chadō’ appunto ‘la cerimonia del tè’.
Quanto anche riguarda la ‘scrittura’, dove infatti l’azione del pennello traccia un ‘percorso’ che converte in segni i gesti del calligrafo. Segni che possono essere decisi o incerti, veloci o lenti, sottili o spessi, ma che contengono sempre una forza che tradizionalmente è definita ‘qi/ki’ (traducibile approssimativamente in ‘energia vitale’), la cui forza è circolatoria, che dai singoli segni passa nei rapporti che s’instaurano tra di loro. Nel pronunciamento del singolo ‘carattere’, infatti, si fornisce la rappresentazione di un’idea, ma tracciandolo si tende a trasmettere soprattutto la relazione che s’instaura tra l’interiorità del calligrafo e la circolazione ‘sanguigna’ che il carattere stesso possiede: “ Volendo esprimere in altri termini questo concetto si può dire che l’istantaneità calligrafica permette di registrare un ritratto ‘interiore’ del calligrafo, nel momento stesso in cui questi scrive.” (21)
Ne rendono luminosa testimonianza gli innumerevoli disegni paesaggistici e i pannelli dipinti ‘così pregni di forza vitale’ di Hokusai e Hiroshige, solo per citare i nomi più noti, le cui opere possiamo ammirare nelle ormai innumerevoli mostre che fanno il giro del mondo. Ma anche nell’odierna attività artistica, dalla pittura alla scultura; dalla cartellonistica pubblicitaria ai video-clip; dalla grafica creativa dei cartoons, all’odierna produzione cinematografica (di cui si parlerà nel prossimo articolo), e le cui competenze sono costantemente in evoluzione, grazie anche alla tecnologia avanzata messa in campo nella loro produzione.
Tuttavia si vuole che l’origine della ‘scrittura’ giapponose sia derivata dall’uso della lingua cinese a sua volta appreso dal più famoso testo “Da Xue” (22) o ‘grande apprendimento’, di Kong Zi (Confucio): “Il maestro Kong era convinto che tutta la saggezza risiedesse nell’imparare a chiamare le cose con il loro giusto nome e che solo attraverso la ‘rettificazione dei nomi’ fosse possibile progredire verso un’esistenza illuminata”. Il “Da Xue” è uno dei ‘classici in pietra’ scolpiti intorno al 175 d.C., verso la fine della dinastia Han, nella città capitale di Luoyang, nato come parte integrante del “Li Ji” o ‘memoria dei riti’, divenuto ‘libro’ a sé stante solo settecento anni dopo, quando Lu Ji nei suoi studi sul confucianesimo, nel tardo III secolo avanzato.
Il ‘pittogramma’ (23) alla base della scrittura, fortemente stilizzata, presenta somiglianze sorprendenti con quella cinese sebbene quella odierna giapponese si possa considerare nei caratteri diversa. Ciò per quanto vi sussistano tracce ben visibili di pittogrammi più antichi riconducibili alla sua origine orientale, forse ancora più antica di Cina e Corea, le cui regole compositive obbediscono a una serie di norme ancora più sofisticate e che sono elemento di maggiore unità linguistica. Infatti, nella pittura cinese e giapponese la calligrafia dei caratteri è anche elemento semantico: grafismo, colore e intensità del tratto si uniscono per dare all’elemento visivo tutta la sua intelligibilità, costituendo allo stesso tempo il testo e l’elemento decorativo.
Di particolare interesse nei manoscritti del passato, presi ad esempio, è l’evidenza di combinazioni di alcuni caratteri che, a seconda della grafia, danno a uno stesso suono significati completamente diversi e, tuttavia, una dimensione assolutamente poetica e musicale. Acciò Lu Ji (III sec. d.C.), funzionario di corte e valoroso condottiero di eserciti, nonché scrittore e poeta cinese, è oggi ricordato come autore di un libello dedicato a “L’arte della scrittura” (24) quasi un’ideale prosecuzione del cammino indicato dal maestro Confucio sulla strada della conoscenza. Uno dei primissimi manuali di poetica appartenenti alla tradizione cinese, ormai considerato un classico della cultura orientale, che affronta la scrittura come una rigorosa disciplina spirituale quasi ascetica, in cui la parola diviene forma privilegiata del viaggio interiore, della ricerca e di una più alta comprensione di sé e del mondo. “Il poeta sta al centro / di un universo / contempla l’enigma / e trae nutrimento / dai capolavori del passato.
Suoi sono gli ‘haiku’ seguenti:
“Lo scrittore offre
la fragranza dei fiori freschi
un’abbondanza di germogli che sboccia”.
“Vènti vivaci sollevano le metafore
nuvole si alzano
da una foresta di pennelli”.
Come tutto questo, e molto altro, stiano a monte della ‘cerimonia del tè’ è qui ancora da dimostrare, così come lo è anche il fatto che prima ancora bisogna conoscere come queste arti: la disposizione dei giardini, la disciplina della scrittura, l’estetica nella grafica e nella pittura, nel teatro e nella musica, siano divenute in Giappone, del tutto o quasi, una prerogativa maschile. Ciò perché, a un certo momento, la donna venne esclusa dall’esibirsi davanti al pubblico in teatro e in spettacoli ritenuti offensivi della decenza femminile. Ciò che in altro modo poteva avvenire esclusivamente in luoghi adibiti a forme di intrattenimento comunitario, quali ad esempio, nella festa danzata ‘Denkaku’ che celebrava, sacralizzandolo, il lavoro agrario dei campi di riso, le festività socialmente riconosciute dove la donna poteva esibirsi nelle sfilate dei costumi tradizionali; e in privato, nelle cosiddette ‘case del tè’, a loro discrezione e in completa riservatezza.
Una più recente rivisitazione dei questo aspetto sociale vede molta parte dei cultori di quest’arte, non solo giapponesi, attribuire alla creativà femminile, l’aver dato un grosso contributo alla cultura del paese e, alla sua entrata nel circuito internazionale della moda, della cosmesi, del disporre i fiori, ‘ikebana’, e di quant’altro concernente la grazia e la bellezza del corpo nella danza. Forma quest’ultima che si vuole derivata dalla leggendaria déa Uzume, alla quale si fa risalire l’origine del teatro, nel momento della sua più alta drammaticità emozionale, sottolineato, in scena, dal ‘vuoto’ creato dal silenzio delle lunghe pause, dalla staticità del gesto, scandito dal parossistico ritmo musicale lasciato improvvisamente cadere.
È questo il ‘vuoto’, ricreato ad effetto, che stabilisce a un tempo lo stacco e l’unione di tutti gli elementi fin qui elencati, attuato non necessariamente dalla parola, bensì dal ‘concetto’ espresso dalla sola presenza degli oggetti adibiti alla composizione della scena; che dal ‘gesto’, rappresentativo della sublimazione dello spirito esoterico taoista, atto a favorire l’incontro degli elementi ‘umani’ e non, o forse ‘disumanizzati’, che fanno della ‘cerimonia del tè’ un quadro di assoluta e raffinata ‘bellezza’.
“You sareba / “Quando viene la sera
shiokaze koshite / attraverso il vento del mare
Michinoku no / sul Tamagawa di Noda
Noda no Tamagawa / nel paese di Michinoku
Chidori nakunari” / piangoni i pivieri”.
(Noin)
Apprendiamo ancora da Okakura, redattore de “Il libro del Tè” (25), quanto segue:
“Per la religione, il futuro è dietro di noi. nell’arte, il presente è l’eterno. I maestri del tè ritenevano che l’arte potesse essere compresa appieno soltanto da coloro che ne fanno sostanza viva, capace di alimentare l’esistenza. Essi cercavano quindi di modellare la vita sui vertici della raffinatezza raggiunti nella stanza del tè. In ogni cicostanza, bisogna mantenere la mente serena e si deve conversare senza che sia turbata l’armonia dell’ambiente che più si accosta alla sua ‘bellezza’. Così il maestro del tè cercava di essere qualcosa più dell’artista – l’arte stessa. La perfezione è dovunque, se solo scegliamo di riconoscerla”. È questo uno degli insegnamenti più efficaci dell’estetismo Zen.
“Dal non essere nasce l’essere
dal silenzio
lo scrittore genera una canzone”.
(Lu Ji)
Mi si passi la divagazione musicale basata sul ‘mettere e levare’ per cui in un ‘vuoto ipotetico’ venga ‘levato’ qualcosa per ‘mettere’ qualcos’altro, o viceversa, in fine l’origine non cambia, resta il ‘vuoto assoluto’. Così come, ‘decostruire’ una partitura musicale per poi ‘costruire’, o ricostruirne una più adeguata alla sensibilità del musicista, nulla cambia se quest’ultima corrisponde in modo adeguato all’originale contestualizzato. Nulla dunque, comunque più di quanto si apprende da questo lungo excursus sulla riscoperta del Giappone moderno cui si affida questa ricerca. In sintesi faccio mia la volontà di riempire quel ‘vuoto onirico’ creato attorno a questo popolo che, all’apparenza, sembra confinato all’estremo margine del mondo reale, ma che tuttavia esiste da millenni.
Un popolo che sembra sfuggire alla possibile elencazione imperativa di un Oriente immaginario, e tuttavia giunto ad autodeterminarsi dentro la progressiva unicità dei suoi modelli caratterizzanti. In cui la singola funzione individuale e/o comunitaria nella formazione dello spirito, ha dato risultati altrettanto importanti, seppure in assenza di una qualche valenza superiore dell’uno sull’altro dei modelli di riferimento. Un esempio è dato dalle molte discipline zen/taoiste che da millenni ottemperano sul territorio alla funzione catartica della formazione.
“L’utilizzo, nel rito ‘shintō’ di corde di paglia sacre ‘shime o shimenawa’, al fine di circondare, per esempio, alberi molto vecchi, o legare due rocce l’una all’altra indicando così la presenza di un dio ‘kami’, è una forma di appropeiazione spirituale della natura. Questo tipo di costruzione si incontra dappertutto nel paesaggio giapponese. Giova sottolineare che questa grande sensibilità alla natura è una delle costanti dello spsito giapponese: lo ‘shintō’, “il cammino degli dèi”, è infatti la religione più antica e più diffusa, e prevede tra i riti, la sacralizzazione e talvolta la deificazione dei simboli della natura”. (26)
Stando al mito shintoista che vuole le isole che formano il Giappone generate da Izanagino-mikoto e dalla sua divina sposa Inazami-no-mikoto, dalla cui unione nacque Amaterasu-no-mikoto la grande ‘déa del sole’, che regnò nelle regioni dell’empireo celeste. Isole che, rappresentate nello strano ‘gioiello’ dalle pietre uncinate disposte in forma di collana anche detta ‘magatama‘, e che ritroviamo quale ‘simbolo’ mitico, nella leggenda euroasiatica degli antichi sciamani che verosimilmente l’hanno tramandata. Si narra che Amaterasu, avesse inviato suo nipote, Ninigi-no-mikoto, sulla terra per fondarvi un impero e gli avesse consegnato quelli che sarebbero stati i simboli della sua sovranità: lo specchio detto ‘chokkomon’; il gioiello in forma di collana, fatto di perle, tante quante erano le isole che formavano l’arcipelago; e infine la sciabola di tipo rituale, detta ‘koshigatana‘, facente parte del costume e della formazione del Samurai, a complemento dei tre emblemi della corona imperiale.
Lo ‘specchio’ dunque, in quanto ‘vuoto’ in cui si riflette l’anima ed è giudice inattaccabile di essa, rivelatore della verità assoluta; il gioiello, in cui si concentrano la bellezza e la purezza, a simbolo della morale e della virtù imperitura; la sciabola, nell’accezione di lama tagliente,simbolo di una giustizia efficiente.
Oggetti rituali questi che troviamo riprodotti in molti esempi artistici e che formano il corredo nazionale recuperato nella campagna giapponese di più antiche sepolture dell’era Yayoi (300 a.C. al 250 d.C.), considerate luoghi sacri, in quanto misteriose porte che s’aprono sull’al di là. Un mondo ‘altro’ cui i giapponesi fanno un distaccato riferimento nei miti come un qualcosa di molto lontano, all’estremo di una galassia dorata che hanno saputo riempire di bellezza, ampiamente riportato nelle rappresentazioni teatrali che formano il patrimonio del teatro classico. Soprattutto in letteratura nei numerosi trattati sulla formazione cosmica del ‘chi’ (la terra), allorché, separato dal ‘mizu’ (l’acqua), nel cui scontro molto hanno significato sia ‘hi’ (fuoco), sia ‘kaze’ (vento), che di fatto è all’apice dell’evoluzione artistica e tecnologica tutt’ora in atto, da porsi in riferimento con l’etica e la morale dell’Hejō, riconosciuta quale ‘strategia di vita’ che porta all’illuminazione.
Nel suo “Gorin No Sho”, ovvero “Il libro dei cinque anelli” (27) di Miyamoto Musashi, si apprende come la via dell’Hejo fosse in Giappone un manuale privilegiato di tattica militare che i guerrieri dovevano conoscere perfettamente. In passato l’Hejō era compreso fra le dieci deità e le sette arti come attività utile non solamente alla scherma, tantomeno la sua importanza era confinata soltanto alla tecnica. E per quanto vada qui evidenziato che l’uso della sciabola ‘shira-tachi’ o più semplicemente ‘tachi’, con il fodero a intarsi di madreperla decorato con disegni sul fondo di lacca e oro, corrisponda a un’arma micidiale puntata contro il nemico, l’olimpo shintoista conosce anche una Déa della Misericordia alla quale è dedicato un famoso inno religioso ‘sutra’:
“E se si scontra con dèmoni divoratori di uomini / draghi velenosi e altri mostri / egli pensa al potere di Kannon / e nessuno oserà sfiorarlo. / E quando è circondato da belve spietate / con scaglie aguzze e artigli orrendi / egli pensa al potere di Kannon / e nessuno oserà ucciderlo.” (28)
Dacché, la disciplina medievale dei ‘guerrieri’, dai più umili fanti autorizzati a portare i ‘daisho’, fino a combattenti più agguerriti e di rango più elevato, autorizzati a servirsi di cavalli, tutti appartenenvano alla stessa classe guerriera cosiddetta ‘buke’, ed erano conosciuti come ‘shi, bushi’ o, più comunemente, come ‘shizoku’. Un nome divenuto famoso in molte lingue, in quanto sta a significare ‘uomini di guerra’, i famosi ‘Samurai’, dediti al ‘Dō’, l’imperativo etico che trasforma una tecnica in disciplina d’illuminazione e di perfezionamento sociale che ritroviamo nella ‘startegia’ giapponese improntata sull’ ‘Hejō’.
“Tu sia la benvenuta,
o spada dell’eternità!
Attraverso Buddha,
come attraverso Bodhidharma
ti sei aperta la strada”
(Okakura Kazuzō)
Titolo quello di ‘Samurai’ che nella forma antica era assegnato ai capi dei clan armati del Nord e, in forma lievemente modificata ‘goshozamurai’, a quei guerrieri dei clan aristocratici legati alla corte imperiale dello Shōgun, il generalissimo, (governatore di fatto del Giappone feudale), autorizzati a portare la spada lunga ‘daito’ o ‘tachi-katana’, e la spada corta ‘wakizashi’ o ‘koshigatana’, che mettevano al servizio di un qualche signore feudale ‘daimyō’. Ma per meglio comprendere ciò necessita qui di conoscere (almeno in parte) la struttura medievale della società giapponese in cui il Samurai si trovava ad operare.
“La società emergente durante il periodo Tokugawa operata dal governo Edo era strutturata in classi in cui l’uomo poteva vivere soltanto seguendo una delle quattro ‘vie’, qui di seguito trascritte in ordine d’importanza: la classe militare al vertice ‘buke’, con i suoi guerrieri professionisti e le loro famiglie ‘shi, bushi’; seguita dai contadini e agricoltori ‘hyakushu’; dalla classe industriale ‘ko’ che consisteva soprattutto di artigiani ‘shokunin’, e la classe commerciale ‘sho’, rappresentata dai mercanti ‘akindo, chionin’. In quanto agli individui comuni ‘heimin’, che costituivano la pate di gran lunga più numerosa e produttiva della nazione, per quanto fossero ricchi, saggi e intelligenti, lo volessero o no, essi non avevano quasi diritti politici”. (29)
In Giappone i poeti e gli scrittori ancora oggi paragonano i Samurai ai fiori di ciliegio, la cui bellezza, di breve durata, si disperde al primo vento. La vita del Samurai è simile all’albero di ciliegio, coltivato non per i suoi frutti, ma per il suo fiore, simbolo di purezza e lealtà che, nell’Impero del Sol Levante, designava un principio essenziale del ‘bushi’, soprattutto nell’addestramento dei Samurai: “Ricordate che la vita è un fenomeno breve e passeggero, un evento caduco, e che la morte sul campo di battaglia al servizio dell’imperatore fosse il fatto più glorioso nella vita di un uomo”. (30)
Per quanto nel “La via del Samurai” (31) l’autore, Yukio Mishima, fa dire all’adepto guerriero che si inpegnava a seguire la propria ‘via’ secondo il proprio talento: “Ho scoperto che la Via del Samurai è la morte”; la cui meditazione ripone nel guerriero il gloriarsi delle tradizioni del proprio paese, l’assolvere pienamente i propri doveri, essere leali verso il proprio signore, filiali nei confronti dei genitori, onde prolungare la propria esistenza e accrescere la propria dignità:
“Affrontate ogni giorno della vostra esistenza come se fosse l’ultimo e preoccupatevi di concludere tutti i vostri compiti affidatevi. Non accarezzate mai la fallace illusione di una lunga vita, finireste con l’abbandonarvi ad ogni sorta di dissipazione e concludereste i vostri giorni nella più nera disgrazia. […] Il guerriero dovrebbe seguire con onore almeno due vie: quella della spada (abilità nell’uso della ‘katana’, e quella del pennello (maestria nella scrittura); un’importanza che esorbita dai limiti della concezione comune, conferiva al Samurai una fama e un onore ineluttabili. […] Era noto a tutti che il guerriero doveva accettare stoicamente l’idea della morte; solo ai monaci, alle donne e ai contadini e alla gente appartenente alle classi inferiori, era dato morire per adempiere un dovere oppure per vergogna, ma l’accettazione della morte da parte di un guerriero era una realtà molto più seria e aveva radici profonde”: (32)
Conoscendo la via dell’Hejō, si può comprendere tutto il resto, anche che:
“Takuhodo wa kaze ga motekuru ochiba kana” / “Per fare il fuoco / il vento mi porta in dono / foglie secche d’autunno”.
“Taorure ba taoruru mama no niwa no kusa” / “E là si sdraia, e là resta sdraiata, l’erba del giardino”. (Ryōkan).
Non ci si poteva rattristare davanti all’uscita di scena senza esitare di un Samurai, così come, ancora oggi, non ci si rammarica davanti alla caduta dei fiori di ciliegio:
“La prossima primavera porterà con sé una nuova fioritura”…
E il grande ‘vuoto’ lasciato dai fiori s’aprirà accogliendo i suoi frutti, schiudendosi a una nuova generazione d’uomini, onde l’etica ‘dai severi ideali’ del Samurai, trova la sua ragione d’essere, sospesa sul crinale tra regola ed eccesso, amore per la vita e fascino, il mistero e l’indicibile che separa e congiunge la vita all’arte di vivere, splendidamente rivelata: “solo chi è vissuto nella bellezza, può morire nella sua tragica bellezza”.
“Con tenerezza e un leggero sorriso sulle labbra, Rikyū guarda intensamente lo scintillio della lama fatale, ed entra nell’ignoto” (33)
“Un po’ come separare il seme dal fiore e attribuire maggior valore al fiore”; è detto nell’Hejō, attribuibile a tutte le attitudini cui anche oggi prestiamo il nostro interesse, alle arti come ai mestieri, nella cura di noi stessi come alle cose dello spirito; così come nell’accettazione della vita accettiamo l’essere guerrieri di fronte alla stoica idea della morte. Così come ho affidato in questa ricerca ‘di oscura chiarezza’ la mia interminabile scrittura.
Note / riferimenti bibliografici:
1) Michael Hardwick, “La scoperta del Giappone”, Mondadori 1971
2) Giusy Barbagiovanni, “Le identità del corpo”, Ananke 2006
3) Zeami Motokiyo, “Sarugaku-no-Nō”, dramma
4) Curt Sacks, “Storia della Danza”, Il Saggiatore 1996
5) Serghej Eizenstein, in “Le identità del corpo” op.cit.
6) Sen no Rikyū, “La Cerimonia del Tè”,
7) Okakura Kazuzō , “Il Libro del Tè”, Editoriale Nuova 1983
8) AA.VV., “L’Allievo e le Stelle”, in “Storie Zen”, Edizioni del Baldo, 2009
9) 10) Miyamoto Musashi, “Libro dei Cinque Anelli”, Edizioni Mediterranee 1984
11) Giancarlo Calza, “Immagini del vuoto”, in “Alle Radici del Sole”, CRT/ERI 1983
12) Paolo Rovesti, “Alla ricerca dei cosmetici perduti”, Blow-up / Marsiglio Edit. 1975
13) 14) 15) Paolo Rovesti, “Alla ricerca dei profumi perduti”, 1980
16) Wikipedia, rif. a ‘giardini giapponesi’
17)Yukio Mishima, “Il Padiglione d’Oro”, Feltrinelli 1962
18) Wikipedia, rif. a ‘giardini giapponesi’
19) Miyamoto Musashi, “Libro dei Cinque Anelli”, op.cit.
20) 21) Lu Ji, “L’arte della scrittura”, Guanda 1991
22) Kong Zi (Confucio), “Da Xue”), …………..
23) AA.VV. “La scrittura”, Electa/Gallimard 1992
24) Lu Ji, “L’arte della scrittura”, op.cit.
25) Okakura Kazuzō, “Il Libro del Tè”, op.cit.
26) Ryokan, “Novantanove Hayku”, La Vita Felice Edit. 2012
27) 28) Miyamoto Musashi, “Gorin No Sho”, “Il libro dei cinque anelli”, op.cit.
29) 30) Oboroya Hisashi, ‘Presentazione’ al libro di Miyamoto Musashi, op.cit.
31) Yukio Mishima, “La via del Samurai”, Bompiani 1983
32) Miyamoto Musashi, “Il libro dei cinque anelli”, op.cit.
33) Okakura Kazuzō, “L’ultimo tè di Rikyū”, in “Il Libro del Tè”, op.cit.
Discografia di riferimento:
“Japan” , Semi-classical and Folk Music, Musical Atlas - Unesco Collection, direttore Prof. Alain Daniélou. EMI 1984
“O-Suwa-Daiko” – Japanese Drums, Musical Sources - Unesco Collection, direttore Prof. Alain Daniélou. PHILIPS 1978
“Tradizioni Musicali del Giappone”, Universo Folklore Collection direttore Ariane Sègal, ARION 1975
“Nagauta” Japanese Kabuki Music, The Kyoto Kabuki Orchestra, Albatros 1979
“Koto Kumiuta”, Song Cycles of 17th & 18th siècle, Namino Torii, ALbatros 1979
*
.jpg) - Libri
- Libri
Invito alla lettura d’autunno … Libri poesie e altro
“Il libro vero parla sempre al momento giusto. Lo inventa lui, il momento giusto; con il colore della parola, con la singolarità della battuta, con il piacere della scrittura” - scrive Ezio Raimondi. Quante volte abbiamo aperto un libro e scorrendo le sue pagine ci è sembrato di aver trovato proprio quello che volevamo leggere, o magari, solo sentirci dire? Altre volte, rammento, di aver sfogliato un libro e averlo subito riposto, perché non lo sentivo adatto a me; oppure averlo ricevuto in regalo e messo via, nel limbo delle attese. Come dire, in stand-by, aspettando il momento migliore per leggerlo e che talvolta è arrivato dopo anni, che quasi non rammentavo neppure di averlo nello scaffale. Invece era lì, aspettava il momento giusto, per imporsi alla mia attenzione, e accipicchia, quante volte l’ha spuntata Lui, il Libro e devo ammettere che ‘in qualche modo’ mi ha cambiato la vita. È quanto accaduto con “Pinocchio”, “Cuore”, “Tre uomini in barca”, e con “Bel-Ami” quando ormai avevo l’età giusta, con “La luna e i falò”, “I fratelli Karamazov”, “Il Maestro e Margherita”, e tantissimi altri. Ma il grande libro che più mi ha conquistato, e che è quasi stupido citarlo, è stata “La Divina Commedia”, a seguire “I promessi sposi”, “Iliade” e “L’Odissea”, “Don Chisciotte” e poi “L’interpretazione dei sogni”, “L’idiota”, “La nausea”, “L’odore dell’India”, “Cent’anni di solitudine”, “Memorie di Adriano” e immancabilmente e irrimediabilmente “La Recherche” di Marcel Proust. Quanti altri? Tantissimi altri che, per uno come me, che legge anche il biglietto del tram, non basterebbe questa recensione per elencarli tutti. Ma forse avrei dovuto citare, oltre quelli degli scrittori, i nomi dei poeti che dopo Dante si sono susseguiti instancabilmente nelle mie letture: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Pasolini, Ungaretti, Neruda, Celan, Hölderlin, Kerouac, Carver, e molti di quelli a me contemporanei …
POESIA
GIAN GIACOMO MENON … O LA POESIA DEL TEMPO LINEARE
Essai su “Geologia di silenzi” – Anterem Edizioni / Cierre Grafica 2018.
Apparsa di recente nella collana ‘Itinera’ da Anterem Edizioni 2018, la seguente raccolta poetica rende omaggio a un personaggio così poco conosciuto (direi misconosciuto), portandolo alla ribalta di quanti, ad esempio, si adoperano in ambito poetico, alla divulgazione e alla conoscenza di quella che potremmo definire ‘l’essenza stessa della vita’, o se preferite, in egual misura ‘il sale dell’esistenza’, ciò che rende alla ‘nuda parola’ il colore e la forza dei suoi più reconditi sentimenti: la poesia: “non più di un bisbiglio nella pena dell’essere”.
Gian Giacomo Menon (1910-2000), insegnante emerito di storia patria e filosofia, stimato e rispettato dai suoi allievi, diventa quasi un requisito indispensabile alla comprensione del nostro tempo. Se mai si è amato il proprio professore di lettere questa raccolta di suoi scritti costituisce il ‘dono più sentito e più grande’ da parte dei suoi ex allievi di diverse generazioni che hanno voluto rendere omaggio a colui che ha fatto dell’insegnamento e dello scrivere l’unica sua ragione di vita, e noi tutti non possiamo che essergliene grati. “Geologia di silenzi” riunisce in un unico volume – con il titolo che l’autore avrebbe desiderato – una minima parte del suo capitale poetico dal 1988 al 1998. Sono diverse, infatti, le date di composizione e cifra stilistica delle singole raccolte da cui il libro è desunto, e che pure presentano una comune caratteristica: di essere state personalmente selezionate dall’autore all’interno della sua sterminata produzione in vista di pubblicazione. Il contenuto di questa raccolta poetica, rappresenta solo un breve sapiente assaggio dell’autore di ‘migliaia di carte, foglietti, appunti contenuti nei 25 contenitori trovati nella casa del poeta e confluiti nel Fondo Menon della Biblioteca comunale Vincenzo Joppi di Udine.
Molto dobbiamo all’oculata e dotta biografia di Cesare Sartori che ci introduce alla conoscenza dell’autore: “che per un’ostinata, sofferta ‘decisione di assenza’ praticata con coerenza e determinazione, ha trascorso più della metà della sua vita praticamente tappato in casa […] accuratamente nascosto agli occhi dei più, sfuggendo ogni anche pur minimo côté sociale, ha diligentemente cancellato le proprie tracce dal mondo”; il quale, tuttavia, avverte il lettore che potrebbe “sembrare sciocca presunzione pretendere di racchiudere in poche paginette una vita come quella di Menon, ‘filosofo del nulla e poeta assoluto’ (Carlo Sgorlon), che sembra fatta di niente, ma che in realtà è una foresta lussureggiante” …
«..pomeriggi di infanzia sotto gli alberi
adunata di tende
ruote di spazio sulla città
palloncini rincorsi dai passeri
fucili di luce contro i cartoni
chi grida gli zuccheri
chi le scimmie maestre dell’uomo
l’angelo piombato dentro la carne
lungo tubi di ossa sentieri di midolla
a scuotere fiumi sepolti un ribollire di pietre
la pelle sconsacrata dall’affiorare di un dente
per ferire greggi di stelle navigazione di erbe
non sazia fame dell’essere
e noi nocchieri impazziti per nuove correnti
a reggere inconsulti timoni
nella rapina delle mani»
FRANCA MARIA CATRI … O L’ALTROVE INDICIBILE DELLA POESIA CONTEMPORANEA
“Ti chiedo al vento” – Anterem Edizioni / Cierre Grafica 2018.
Con un’espressione finemente poetica in apertura della sua silloge di recente publicazione “Ti chiedo al vento”, Franca Maria Catri ne offre al lettore un esempio tangibile: “..tra petali di libri / il tramestio di foglie / il giusto e l’ingiusto del fiore”. C’è un tempo di frattura minimale in cui si misura lo spazio restante da quello che precede l’attimo successivo, anche detto crack-up*, che si offre come spazio liminare all’impulso creativo da cui scaturisce la ‘luce’ primordiale e avveniristica dell’idea, dell’arte, della composizione musicale come della poesia. Impulso propulsivo che permette alla parola poetica di disgiungersi dalla materia letteraria e divenire pura essenza dispersa nell’aere della concettualità estetica e percettiva. Ciò che nulla toglie alla scrittura poetica allorché, nell’interscambio modale con il poeta, il lettore interpone la propria empatia a quella dell’autore/trice. In cui la chiave di lettura ‘psicologica’ è fissata nello stato d’animo del poeta in quello che è il suo momento creativo, nel coinvolgere emotivamente il lettore nel suo messaggio: lì dove l’amore per i libri, connaturale alla sostanza fibrosa della materia, si scioglie/sfoglia in petali di fiori che s’aprono alla nascente/morente stagione; in cui il frusciare delle pagine coincide con il tramestio delle foglie al vento/aere che l’accompagna attraverso l’arco/soglia posto tra l’inizio e la fine, al limitare de “il giusto e l’ingiusto del fiore”. Non la ricerca di una soluzione al crack-up iniziale, bensì il responso imperscrutabile di un ‘altrove indicibile’ che trova luogo nell’assenza, nel pieno/vuoto cosmico della sua proiezione filosofica nella poesia contemporanea; di un ultimo grado di investigazione cui sottoporre ogni intima certezza/incertezza della relatività umana. Una ‘immagine inadeguata del morire – scrive Flavio Ermini nella postfazione che accompagna la silloge poetica – in cui lo splendore essenziale, si fa strada attraverso l’inerzia della materia visibile e si riverbera proprio su quell’invisibile alfabeto che immaginiamo ..a un passo dal cuore’. Al dunque, “se la fine ha un principio” – rivela l’autrice Franca Maria Catri – la vita è ciò che sta nel mezzo, quanto ci concerne di apprezzare in quanto dono, nel bene e nel male di un ‘principio che contempla la fine’ quale mezzo di affrancamento al nostro pur meraviglioso esistere.
FABIO SQUEO … O LA DIFFICILE ‘IDENTITÀ’ DEL SUO ESSERE POETA
“I poeti fioriscono al buio” – raccolta poetica – Bibliotheka Edizioni 2017.
Cancellare i vincoli dell’identità per scivolare nell’infinito errare della poesia nel labirinto delle molteplici coincidenze virtuali della contemporaneità, non è cosa facile da intraprendere. Si rischia di condurre una vita impersonale, immergersi in un’attività di erranza nello spazio e nel tempo impropri delle cose del mondo; che è poi come vagheggiare e/o fantasticare, su qualcosa che va oltre la concomitanza delle situazioni, quasi un voler ‘fuggire da se stessi’, dal frastuono delle diverse identità che si è costretti ad assumere nella concretezza del reale. Una tangibilità che, estranea alla dissolvenza filosofica, moltiplica l’identità in numerosi altri sé dalla personalità conforme e/o difforme, solo apparentemente diversa quanto più affine a quella ‘desiderata’, ovvero ‘sospesa’ nel rimando della coscienza, come processo narrativo di sé. È allora che dalla relazione fra le due parti, diverse e uguali, narrativa e poetica, si erge il romanziere e il poeta, l’uno compenetrato nell’altro. Da cui le strutture dotte che spesso s’intersecano, si moltiplicano, si completano nel ‘diverso e uguale’ linguaggio letterario: “..nella bellezza di un sentire che vuol essere dedizione, comprensione, per un’esistenza che oltrepassa le barriere dell’umano.”
Fabio Squeo si inserisce in questa dualità, nei passaggi interstiziali delle forme che appartengono alla parola detta, ancor più che ai segni grafici della scrittura, interponendosi nelle ‘pieghe del tempo’ che ancor giovane ha fatto sue, andando qui alla ricerca del proprio essere poeta pur conservando ‘una mente prigioniera del passato’, che ‘lentamente si consuma’ nelle ‘incertezze degli istanti’ che lo ‘separano dalla vita’. Un ‘consumarsi sotto il sole dell’esistenza’ che sembra non concedere(gli) tregua, ma che altresì l’aiuta a trovarsi e/o ritrovarsi, al di qua e al di là della soglia di avanzamento della propria esperienza poetico – crepuscolare. Perché in fine questo è il ‘poeta’, colui che ha ricevuto in eredità il suono e il canto iniziali, afferente a ciò che noi tutti siamo, individui effettivi del nostro comune essere, spuri abitatori d’una costellazione imperfetta nel ricalcare l’orma pessoana di ‘Una sola moltitudine’, l’essenza stessa della nostra vita: “..nella solitudine del poeta / … / quando il fumo delle notti / agita le sue onde. /…/ la nascita non è più una nenia / oscura / da ricordare / ma una fulgida gemma / di acero fiorito”.
Fabio Squeo, laureato in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è studioso del pensiero di Sartre e della filosofia esistenzialista del XX secolo. Autore di poesie svolge la sua attività di saggista e curatore di opere letterarie e collabora ai progetti editoriali della casa editrice Limina Mentis.
IRIA GORRAN … O ‘L’ARTE DELLA GUERRA’ NELLA POESIA D'AUTORE CONTEMPORANEA
“Corpo di guerra” - Cierre Grafica / Anterem Edizioni 2018.
L’accostamento con l’opera di Sun-Tzu è affatto casuale quanto cercato, per sottolineare la portata di un fare poesia che inscena l’essenza di una tentazione contemporanea: condurre una ‘guerra’ essenzialmente intimistica contro il proprio sé. Questa la cifra elettiva della silloge poetica ‘Corpo di guerra’ di Iria Gorran, in cui la passione competitiva è sempre in bilico tra appagamento e/o perdita mediante l’‘artificio della ‘guerra ’, conflitto questo che si fa scontro duro tra vincitore dominante e il perdente arrendevole, da affrontare con la calma e l’irruenza necessaria …
“Ho sempre sentito il corpo come uno scudo / un mezzo lo strumento di difesa / dal mondo – la macchina umana un filtro / con esigenze minime / […] / che la necessità / l’angoscia hanno spinto quasi oltre il limite / ma tutto quello che volevo era / che mi riconducesse – mi portasse a casa”.
Per quanto si voglia che anche una ‘guerra individuale e personalizzata’ la si faccia per vincerla, altresì essa risulta remissiva di affrancamento e/o riscatto che necessita di continuare a combattere dall’interno, sul campo nemico. Come del resto insegna il ‘fautore di tutte le guerre combattute fin qui', Sun-Tzu: “se non puoi vincere il nemico, allora fallo re”; così facendo “si può sempre vincere senza necessariamente vincere”, poiché “la vittoria si ottiene quando le due parti in lotta, quella superiore e quella inferiore sono animate dallo stesso spirito”… “Atomi dispersi estranei alla configurazione” / “Avevano qui / una vaga idea di questa guerra?” La sottolineatura nel titolo 'arte' è qui utilizzata per meglio evidenziare l’immagine impressa sul fondo di una tela (mettiamo di un corpo materiale) in attesa d’essere riempita di colore, ‘secondo i dettami della propria anima’ e/o secondo il presente-anteriore-infinito che ci siamo preposti fin dall’inizio, qualora riempire gli spazi vuoti divenga sinonimo di volontà: quasi che l’espansione dell’anima nel silenzio della solitudine, similitudine d’assenza e/o di presa coscienza, avalli statue di carne vive per un teatro della fine, in assenza di applausi e tuttavia senza compianto.
Ciò che accade quando il ‘corpo emozionale’ si tinge di un’inquietudine opaca, o avviene a una mutazione incessante per una guerra annunciata col proprio sé fin troppo differita; allorché l’unica condizione possibile per continuare a vivere è in un rapporto nuovo, diverso, con se stessi, con gli altri e con il mondo intero. Ma è tuttavia una ‘guerra costante’, eppure non definitiva, una levata di scudi per un combattimento ‘corpo a corpo’ contro un nemico invisibile, sempre diverso, che fa uso di spade e lance affilate, onde infierire sull’eventuale perdente senza resa.
“Si può sempre vincere senza necessariamente vincere”, rammenta Sun-Tzu l’eclettico filosofo della guerra, di quella stessa ‘guerra’ che Iria Gorran in queste pagine conduce in prima persona attraverso una “scrittura d’esistenza che è lingua di forte energia poetica, spezzata dall’esperienza di sé: dal corpo che la porta dentro e dal linguaggio che ne illumina la percezione. […] Il segno fondante è un’incisione dura, un graffio che designa i luoghi di un brusio dentro il silenzio ‘terribile’ che opprime il parlare e rende incerti i suoni (e le parole), mentre la voce spezza la rapidità del ronzio esistenziale continuo, scuro” – scrive Giorgio Bonacini nella sua intensa postfazione al volume. Incerto il prosieguo, se Iria Gorran vincerà o no la sua guerra lo scopriremo in futuro con l'avanzare della sua esperienza poetica o se magari ritiene di averla già vinta (e perché no) con la pubblicazione di questa sua ‘Opera Prima’ edita da Anterem Edizioni con le immagini grafiche di Bartolomé Ferrando che, come in nessun altro caso, coglie nella mescolanza di lettere dell’alfabeto il senso intrinseco della fugacità dell’autrice dalle parole; segno indubbio di una sensibilità artistica pregna d’inconsuete voci, come di geroglifici di una lingua estensibile all’infinito. L’autrice: Iria Gorran ha origini croate e formazione classica, un curriculum di tutto rispetto in ambito artistico e teatrale, autrice di testi poetico-filosofici e narrativi: ‘Il corvo e i racconti del mistero di Poe’, la ‘Commedia di Dante’. Risiede per lunghi periodi a Vienna e a Londra, attualmente vive a Torre d’Isola (PV). direzione@anteremedizioni.it
AMINA NARIMI … DA UN PUNTO DI PAURA ALLO SPLENDORE.
“Nel bosco senza radici” silloge poetica – Terra d’Ulivi Editore 2015.
“Eppure tutto è / ancora oscuro mentre segreto / ci plasma e ci àncora un volto nuovo / nuova la spinta ad amare / un attimo prima di nascere / un istante prima di dimenticare.”
C’è una poesia che scorre silenziosa lungo il crinale della sofferenza, talvolta solo interiore, perché insormontabile è il dolore che l’ha causata. È allora che questa si mostra a noi come una forza ctonia, allorché la ragione oscura della sopravvivenza richiede un atto di forte solidarietà che la contenga. Ben lo sa il poeta la cui emotività afferra gli spasimi dei sentimenti assopiti nel dolore, quello stesso che, in certo qual modo, esplode nell’anima prima di addivenire verso, parola lirica e canto, prima d'essere preghiera, ancor prima di farsi pianto, cui alcun fiume possa contenere le lacrime sparse … “..tra la crisalide e la rosa ricomposta / c’è un dono che si sporge dalle labbra / danzando per minuscole fiammelle / da un punto di paura allo splendore.”
Nessun altro colore che non sia sporcato di rossa terra, sarebbe accolto nella tavolozza d’amore che l’autrice, Amina Narimi, ancor prima d’essere poeta, usa nel tessere le sue tele che del suo arcano sembiante portano il segreto. Un lontano afflato confidenziale che la restituisce alla natura genitrice di quell’eredità ancestrale, mai venuta meno, che ha attraversato deserti, valicato montagne, navigato fiumi scorsi a cercare l’immensità di quel mare che un giorno, forse troverà, ma solo quando l’incoffessato e profondo amore per la vita, si tacerà dal ridestare i fantasmi del creato, nei suoi versi.
GIORGIO BONACINI … O L’ALGORITMO DELLA POESIA DESCRITTIVA CONTEMPORANEA
“Quattro Metafore Ingenue”, Piero Manni 2005. E in “Argini”, Anterem Edit, Rivista di ricerca letteraria n. 94.
Nello specifico metaforico del linguaggio musicale la ‘poesia’ abbraccia l’idealità del ‘suono puro’ che sta all’origine dell’armonia di fondo, di prevalenza variabile piuttosto che statica, nell’indugiare osservante di una partitura. Suono quindi, partecipe di quella mobilità simbolica che ogni ‘variazione sul tema’ apporta in forma creativa allo svolgimento narrativo di una sinfonia corale ... “Dalla concentrazione pura / le prime parole emergono con una velocità / senza fretta - come se si dovesse / contemplare l’estraneità dei fiori / nella ripetizione di un principio insoddisfatto …” Contestualmente a: “Si pensa allora a un’alternanza di rugiade / a un oscuro lavoro di meditazioni / nella similitudine terrestre …” Formula quella della ‘variazione’ che accomuna all’afflato poetico, per definizione ‘cantabile’, la verbalità per eccellenza ‘orale-narrativa’ della scrittura tensiva di Giorgio Bonacini, che trova nella ‘epitasis’ greca quello che ben possiamo definire l’algoritmo della poesia simbolico-descrittiva che lo contraddistinge, la cui tensione espressiva egli spinge in modo del tutto personale nell’imperfetto contemporaneo ... “Trilli / fonòfoni / e suoni / e quanda’anche / cervello / arzigogoli / chiari / il pasticcio / neurotico / e cerebro”. L’insolita chiave di lettura matematico-filosofica delle ‘performance poetiche’ che l’autore mette in atto, palesa un officiare ‘verità obliate’ che rispondono al richiamo degli elementi in natura che, una volta evocate, si dispongono secondo ‘combinazioni concatenate di locuzioni’ per una esibizione integrale di se stesse, dando senso all’indecidibile derridiano, ineffabile e indefinibile del “..perché si rannuvola il cielo / ad esempio” …
Conformemente a: “L’artificio è equiparabile / al mio sguardo / un astratto rinnovarsi / di andature / in carreggiate fisiche”. La reminiscenza di qualcosa ch’è stato e che invita alla meditazione di quella ‘conoscenza primaria’ che fa da cassa di risonanza al silenzio che tutto avvolge: ‘il silenzio del sacro’; il cui pieno coinvolgimento porta alla separazione dello spirito (soprasensibile) dall’intelletto (sensibile), emotivamente insostenibile in quanto antròpico dell’umano sentire. Ne scaturisce una sorta di ‘discantus’ che nel linguaggio musicale assume forma polifonica del canto, consistente nell'aggiunta di una ‘voce’ in moto contrario all'andamento uniforme e parallelo dell'organum primitivo che si colloca al di sopra del canto dato, per un dialogo diretto con un ‘ipotetico prescelto’, relativo all’ego creativo dei sogni, ma … “La saggezza dei sogni è diversa / trascorre / la sua nitidezza e dilegua/ Nel sonno / la perdita è tutto / la dissipazione stupenda / lo squilibrio abissale […] Immancabile scorre inesausta / la sapienza dei sogni.” La forma del ‘discantus’ si inserisce qui, fra gli interstizi lasciati dalle parole, come suono a se stante, pulito e inequivocabile, di un risentimento di avvenuto distacco che risponde a una intenzionalità superlativa d’elevazione dall’ordinario, di per sé ‘pedestre e spesso mediocre’, equivalente di una fuga dalla realtà ingenerata da una infelicità reiterata nel tempo, alla ricerca costante del proprio riscatto … “Cos’è che ci trattiene dal toccare? / Si isola una prima conoscenza / nella dimestichezza delle gocce naturali / e appare la durezza di una pietra…”.
O meglio, all’ancorché motivata composizione/scomposizione di quella ‘musica assoluta’ che dia equanime risonanza al proprio concerto interiore … “Cosa manca allora per incidere ripetere o svelare in sé la qualità fine di un’ombra? … Penso a ciò che si può amare alla coscienza che cerchiamo nelle cose – non è più quella dell’ombra né il ricordo o l’esclusione che si vuole. […] Forse l’invasione è solo questa – una città dai tempi morti e gli occhi grandi come guardi una figura nell’infanzia o l’illusione che verrà.” Ma se la ‘lingua’ è l’anima che tiene vivo un popolo, la libertà d’espressione equivale alla sua identità come il bene più prezioso da conservare, ciò che da senso all’atto di apprendere, e che l’io collettivo (che non esiste), pur definisce in senso di comunitario e glocalizzato della globalizzazione in atto, necessario a raccontare il mondo attuale, la tecno-sfida di quel linguaggio intraducibile che in qualche modo va riconquistato.
Fra le sue molte pubblicazioni figurano inoltre ‘poesie visive, sonore e artistiche’ nate dalla collaborazione con il gruppo Simposio Differante, in cui figurano testi di critica letteraria apparsi in riviste nazionali quali “Anterem” ad esempio, in cui il ‘linguaggio concreto’ delle performance si spinge alla ricerca dell’assoluto interiore, onde - egli scrive ... “..scavare, conoscere e riconoscere, così come pensare e interrogarse sono l’essenza stessa dell’odierno esistere". È in questo suo vagare tra la distanza e il limite raggiungibile del suo pensiero che la dimensione onirica della ricerca affronta l’algoritmo del ricongiungimento (impossibile) col sacro, in quel dualismo che sta alla base del soccombere umano prima di giungere in cima alla piramide inanimata del divino, ove già Icaro tentò il grande balzo, per poi rovinare in discesa …
C’è da restare sgomenti che nel ‘pensiero finale’ “..la perplessità resiste - / deve darci lo spasimo di un sentimento / inabile, patire i gesti impellenti / e farli vivere / schiudere l’ombra del riconoscimento / l’idea fondamentale di un conflitto / […] / essere il furto di una lingua / un dono amabile e sleale / […] Indicibili i suoni – al riparo del vento (ultimo che gelido spira) / (è allora che più) li senti così irrefrenabili e persi … / e così inafferrabili”. “Ha senso che parlandoci riapriamo / la ferita? L’illusione inospitale del richiamo / non si oppone – non ha nulla da portare / Ma ugualmente è un’esistenza / in altri segni, tra le rocce, nella pioggia / dov’è il nome del bagnato”… Come in questa ‘Chiusura’: “Un segno – un piccolo preciso, indelebile segno È da qui che dovremmo partire – e qui ritornare E se cadono i suoni? E li nomina l’acqua? Le parole ora scrivono là – nel fantasma del sole Un salto e un ricordo – un cespuglio di segni L’inizio oltrepassa così l’illusione e la fine. È qui che dovremmo tornare – e qui ripartire”. Ma non tutto ci è dato! “Non è nostro dunque il sole né il riverbero / dei suoni né la voce – libertà di un’atmosfera / firmamento di follie non destinato, recita / il suo corpo intimorito questa luce, si tortura / per un’ombra e l’universo che la accoglie / fascia il mondo con ardore, senza pace” / […] / «Così, per assenza di voce / un’aria difficile buca e risuona. / E la mente si ferma. Non parte. Rimane.»
TAIYE SELASI – “LA BELLEZZA DELLE COSE FRAGILI” – Libro Einaudi 2013
Una scrittura elegante e raffinata fin nelle virgole e le parentesi per una storia evocativa sopra le righe e al di fuori dei canoni della narrativa tradizionale che ripercorre le tappe eloquenti di una letteratura ancora poco conosciuta e ancor meno studiata quale è quella africana ganaense, nigeriana, senegalese, camerunense ecc. Forse anche relativamente minima e stereotipata, tuttavia generosa di corrispondenze e separazioni per una conoscenza ‘altra’, insolita e arcana. Più vicina alla cifra poetica che alla narrativa tout court cui siamo abituati. Certamente più inerente alla liricità tipica della nenia prossima al canto che accompagna il sonno e che permette al sogno quella ‘felicità’ edenica che il mondo sembra aver perduto, e in cui gli esseri umani si muovono come sospinti dal vento che spazza la savana, che increspa le acque dei grandi laghi e rende impetuoso lo scorrere dei fiumi.
La stessa che ancor più permette alla linfa vitale della ‘natura’ di rigenerarsi, il confluire in essa di legami di appartenenza e sentimenti mai dismessi che accomunano le persone e i popoli dentro un unica grande storia universale che tutti andiamo scrivendo, capace di ricongiungere le famiglie disperse, i cuori spezzati nel segno di quell'amore che - se vogliamo - ancora fa girare il mondo. S’è detto un canto, accompagnato da violini e tamburi “..poi danze e festeggiamenti, il pesce alla griglia (il nutrimento divino), la capra sgozzata (il sacrificio), scintille rosse (il fuoco purificatore) che saltano di gioia elevandosi verso il cielo, un cielo nero fitto di stelle (l’accoglienza generosa) mentre l’oceano ruggisce (l’ospitalità cultuale); la madre con le lacrime agli occhi (la gioia), lo sbigottimento dei fratelli (la meraviglia)” – per una riunione "..improvvisamente consapevole del silenzio" (l'inizio dal nulla), attesa quanto desiderata: “..un ponte; la gioia di sua madre: il primo mattone (della ricostruzione) il rumore della sua solitudine chiaro, assoluto".
Ecco, “La bellezza delle cose fragili” di Taiye Selasi, è ricolma di quel simbolismo africano che va reinterpretato oltre le parole e reinserito nell’ambito ‘vitale’ che continua a scorrere dal passato dentro la contemporaneità: dal linguaggio delle città urbanizzate, alla contaminazione musicale, alla globalizzazione poetica e narrativa, capaci di avvicinare i popoli, di assecondarne la comprensione e di renderla universalmente fruibile senza preclusioni di sorta (pregiudizi, tabu, falsi moralismi). La rivelazione narrativa è tutta qui, contenuta nell’originalità scrittoria dell’autrice che si affaccia sulla scena letteraria con questa sua ‘opera prima’, che a una lettura superficiale può risultare finanche minimalista, perché ‘minimalista’ è la bellezza (senza peso), ‘minimaliste’ sono le cose (fragili). Mentre è l’afflato ispiratore di questa storia ad essere massimalista in senso rivoluzionario, eclatante e sbalorditivo insieme “..come le lacrime non sufficientemente mature” che si sciolgono amare dentro lo sguardo del protagonista Kweku Sai:
“All’inizio erano semplici incrinature che per anni non ha mai curato”. Fin quando: “Il cuore di Kweku si spezzò in un punto. La prima rottura lui la sentì. E Olu guardò sgomento la farfalla poggiata sul dito del piede della nonna. Nera e azzurra appena posatasi, una tonalità quasi fluorescente di turchese, disegni neri, puntini bianchi. Svolazzò pigramente intorno al piede della madre di Kweku, poi volò via, sbattendo allegramente le ali, verso la cupola triangolare, e uscì dalla piccola finestra” (della capanna).
Il passo qui riportato è argomento antropologico lì dove mette in relazione le credenze ‘animiste’ mai abbandonate del tutto, con la religiosità cristiana che ne confuta il significato intrinseco ma che pure ne accoglie la simbologia, seppur relegandola all’uopo alla escatologia tipica delle popolazioni africane.
Confluita, successivamente, nella ritualità e nelle usanze tribali; nella narrativa orale in chiave di miti e leggende così come nella favolistica e nella poesia che, se vogliamo, ripercorrono le strade che sono state degli avi ancestrali, eredità di un ‘archetipo primordiale’ mai venuto meno. Allora ecco che la ‘farfalla’ (allegoria univoca di fragilità e leggerezza), recupera qui il simbolismo cui è appartenuta nel tempo: l’esalazione dell’anima che si allontana dal corpo del defunto; il colore turchese delle notti africane costellate dalle stelle amiche; il ‘fragile’ equilibrio tra il vento e le dune, la savana e la foresta, il bene e il male, l’amore e la morte nei grovigli di forze contrastanti mai dissipate. Così come la ‘leggerezza’ che si esprime nel battito delle sue ali, capace di mettere in moto una tempesta di sabbia capace di cancellare ogni cosa; come del suono sordo e cantilenante di un’immensa orchestra formata dalla polvere del Tempo.
“Un’ode all’oblio … senza clamore né premeditazione, come si spostarono (un tempo) le greggi … per istinto, senza bagagli, alle prime luci dell’alba”. Finché la farfalla, svolazzante nel giardino, si sofferma sopra il piede di Kweku e vi si adagia “..Un contrasto spettacolare, turchese e rosa. Una cosa che si apre e poi si chiude, ed è dunque la morte", allorquando il ‘Silenzio’ inonda la pagina lasciata appositamente in bianco e torna a invadere tutto nella calma ritrovata del creato.
Ma è anche un’elegia delicata e intima all’amore di una donna, un’amante, una madre – suggerisce Selase – nell’introdurre Folásadé Savage, detta anche Fola, e la sua ricerca della felicità. Una donna che come ‘madre’ dei propri figli ha fatto della sua famiglia una costruzione grande come una cattedrale; che come ‘amante’ ha dovuto affrontare la solitudine dei sentimenti; e come ‘donna’ l’umiliazione dell’abbandono, la frustrazione di dover farcela da sola e ricominciare. Mettendo in pratica quello spirito di sopravvivenza che solo la donna (in quanto femmina del branco) a un certo momento sente salire dal profondo del proprio inconscio, allorché è chiamata a difendere la progenie in quanto ‘sangue del suo sangue’, la discendenza della propria stirpe, il fondamento e il ricongiungimento.
Quasi ad avere qui il ribaltamento di un ruolo che si è sempre voluto individuare nel maschio (maschilismo storico), quando invece, e in questo romanzo è reso palese, l’uomo è all’opposto del carisma esistenziale della donna. Quasi che all’uomo, in quanto maschio del branco, non spetti l’osservanza della paternità dopo il concepimento ma solo di raccogliere la palma dell’impresa, così come nella lotta per il primato, nel combattimento o in battaglia, nell’offesa come nella vendetta, tale da apparire egli (solo) lo spirito del bene, il regolatore di conti sospesi. Altresì egli è il male, dispensatore di piacere e dolore, sofferenza e conforto, patimento e infelicità.
Non è così, non questo intende la scrittrice mettendo in evidenza le qualità di Sela, la protagonista presente/assente (perché abbandonata e quindi sospesa) di questa storia (di viaggio, perché di questo infine si tratta, di un viaggio all'interno dell'animo umano), dai tratti drammatici eppure miracolosi: “E questa scoperta è un’assoluta rivelazione!”, solo per il fatto che in essa si rincorrere la felicità da una città a un’altra, da un continente a un altro, da un passato remoto al presente contemporaneo che tutti ci accomuna. Ma quale felicità? In che modo? Quando? Non sono domande che Taiye Selasi pone ai suoi protagonisti, e i lettori farebbero bene a non attendersi risposte, per quanto queste risultino in forma di allegorie nelle immagini copiose che si rincorrono attraverso i flashback narrativi, traslate dalla realtà (nei colori, nei suoni e nelle forme che le compongono), per un quadro che fuoriesce dalla cornice e si espande sulla parete intima di una sensibilità poetica diffusa in ogni pagina, ora illuminata dall’aura di una verità ‘altra’ reinventata all’uopo che la rende universale; ora nella completezza infinitesimale della nostra ‘fragile’ esistenza.
Taiye Selasi è scrittrice e fotografa, nata a Londra e cresciuta in Massachusetts, da padre ghanese e madre nigeriana. Laureatasi a Yale ha conseguito un Master of Philosophy in Relazioni internazionali a Oxford. Attualmente vive a Roma. Il suo racconto d’esordio, 'The Sex Lives of African Girls' (Granta 2011), è contenuto in 'Best American Short Stories' 2012 ed inoltre è stata selezionata tra i migliori venti scrittori contemporanei.
ALESSANDRO D’AVENIA – UN LIBRO ‘RICOLMO DI STELLE’
“L’arte di essere fragili”– Mondadori 2016.
Cari amici poeti …
all’inizio pensavo di dover leggere un romanzo e invece stavo leggendo una fiaba che, per quanto menzognera, scorreva leggera come impastata di quell'amorevolezza verso l'incredulità che ognuno si porta dentro. In realtà era poesia vestita da fiaba quella che stavo leggendo e di quella più pura, quasi che, a un certo punto, mi sono convinto che qualcuno mi stesse dicendo che le stelle nascono sugli alberi e che, al contrario delle foglie, anziché cadere all’ingiù, salgono verso cielo per perdersi nell’universo infinto, e vi ho creduto. Più avanti ho però mutato opinione, quello che avevo tra le mani non era il frutto di una favola menzognera al pari di un oroscopo, come quello che si va a cercare aulle pagine del quotidiano, era davvero un libro di poesia ricolmo di stelle, delle stelle dei poeti, quelle che invitano a sognare, che elargiscono la speranza, che inebriano e si lasciano afferrare, ma solo se si è capaci di apprendere ‘..l’arte di essere fragili’.
Ecco detto il titolo del libro che non avrei voluto svelare perché preso dalla gelosia morbosa di tenerlo per me, a tenermi compagnia sul comodino o meglio, sotto il cuscino, per poter dare adito a quei sogni di ragazzo che verosimilmente sono stati dell’autore così come i miei e immagino anche di qualcuno di voi. Sì, ‘L’arte di essere fragili’ di Alessandro d’Avenia non è un romanzo, ma neppure un libro qualunque, ci si può innamorare nel leggerlo così come si è sempre innamorati della ‘bellezza’. Finanche nella sua sfuggevole accezione, quando cioè la bellezza trova il suo equivalente nella ‘fragilità’ di ciò che non si può afferrare, che solo è lasciata all’incanto dell’osservatore attento, che la esalta e la celebra su tutte le cose: come il pittore fa con la natura, l’uomo con la donna, quando il sentimento sublima l’amore.
Dopo ‘I libri ti cambiano la vita’ di Romano Montroni (vedi recensione su questo stesso sito) e ‘Le voci dei libri’ di Ezio Raimondi (citato nel testo), che hanno segnato momenti di piacevolezza dove tutto avviene per una sorta di simbiosi, data dalla necessità interiore di interloquire che ci fa stendere la mano verso il libro e le parole ‘scritte’ che in quel momento più necessitiamo, ècco arriva d’Avenia a farci dono di un ‘salvavita’ che molti non stenteranno a riconoscere come il più bel libro mai letto prima. Insieme a tanti altri ovviamente, ma in senso assoluto quello che più asseconda la necessità attuale di riconciliazione con gli altri, col mondo in cui viviamo, con la bellezza della natura che ci circonda e, non in ultimo, con noi stessi.
Quei ‘noi’ che forse non conosciamo fino in fondo o che volutamente disconosciamo per scelta, per ansietà o per disamore di quelle cose che pure abbiamo amate, alle quali senza ragione non prestiamo più alcuna attenzione.
Paul Celan afferma essere “..l’attenzione, la preghiera spontanea dell’anima”, che come in “Francesco (d’Assisi), trae il suo canto dal dolore.” E che d’Avenia giustamente attesta all’immenso Giacomo Leopardi, a quella sua breve vita costellata di stelle, fissate per un così breve scorcio di tempo dentro il cielo oscuro delle sue pene, eppure ‘luminosissimo’ che ha traslato nelle sue opere. Non c’è in questo trattato poetico nulla che sappia di vecchia morale, di nebbiosa credulità, di ingiusta etica, nulla che nel bene e nel male delle faccende umane sappia di stantio, tutto è qui riportato al giorno d’oggi. Così le storie che vi sono riportate, le impressioni che danno lustro alla nostra modernità obsoleta, le esperienze maturate sul campo dal giovane prof d’Avenia calatosi nel raffronto agevole con il poeta, sono tali da riuscire a formulare un epistolario impossibile eppure verosimilmente attestabile ai nostri giorni.
È il caso di questo passaggio dedicato all’insegnamento: «L’uomo superficiale; l’uomo che non sa mettere la sua mente nello stato in cui era quella dell’autore (..) intende materialmente quello che legge, ma non vede (..) il campo che l’autore scopriva, non conosce i rapporti e i legami delle cose ch’egli vedeva.» (Leopardi: Zibaldone 1820) Scrive d’Avenia: «Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra, e ciò che la rallegra è la scoperta dei legami che uniscono cose e persone, che rendono viva la vita. Cogliere quei legami, e ripararli è la felicità del cuore e della mente.» Ed è forse questo il breve lucido resoconto che scaturisce da un dialogo siffatto in cui il termine ‘raffronto’, produce tuttavia una sorta di seduzione che modella l’incanto della lettura, lo scherzo intelligente di esistere e di nascondersi a noi cercatori d’oppio letterario che stanchi, lasciamo talvolta al caso di offrirci le sue leccornie poetico-filosofiche.
Che sia il caso o l’attrazione di una così ‘idilliaca’ quanto delicata copertina, ma ancor più il titolo ‘l’arte di essere fragili’ a suggerirne la lettura? Forse l’una e l’altra delle cose, per quanto è l’aver scoperto che le ‘cose’ davvero «..tornano a reclamare i loro diritti, la loro tenerezza, la loro impurità, la loro ombra luminosa, la loro fragilità. Le cose e le persone, i loro volti, tornano a invocare la nostra misericordia: custoditeci e riparateci, nonostante tutto.(..) Così è la poesia, ci costringe ad abbassare la luce artificiale e tornare a vedere il mondo, mutilato e fragile, ridotto così dalla nostra indifferenza. (..) Se le stelle riuscissero ancora a colpire i nostri occhi, non solo una volta all’anno quando cadono, credo che avremmo più possibilità di costruire la nostra casa su fondamenta celesti, quelle della nostra unicità.» (d’Avenia).
Un libro quindi che consiglio di leggere per la sua ricercatezza e nascosta seduzione; che riapre una discussione sempre in corso e mai conclusa, sulla lettura e sui lettori, nel momento in cui i mezzi, gli scrittori, gli editori, stanno cambiando con il cambiare della società e dei suoi interessi; nel momento in cui la ‘lingua’ sta perdendo e acquisendo connotati talvolta controversi, o quando ormai sembra non si parli d’altro che delle solite cose obsolete, ma che forse torna utile per contrastare la ‘stupidità’ di certi programmi televisivi, improbabili quanto inutili. All'occorrenza trovo molto interessante l’enunciato di Ginevra Bompiani che in “Vari” ipotizza sui libri quanto segue: “Se i libri non ti cambiano la vita, certo la fanno. (..) Direi piuttosto che i libri ti costruiscono la vita, la ondeggiano, la sprofondano e poi la sollevano, come un sentiero in cresta fra le colline. (..) Non c’è difesa da loro, non c’è protezione. L’emozione e la cattura sono totali. (..) L’emozione non ha sempre a che fare con la qualità, piuttosto con la forza. Quando si invecchia, si scopre che l’emozione è una forma di malattia. Non sempre si guarisce, ma quando la malattia si spegne, si rimane svuotati, come in una mattina di ottobre, tersa, pungente, senza veli di nebbia, persi in un orizzonte che non ha segreti”.
Ed è questa malattia che spesso diventa ‘magia’ capace di stravolgere la vita con le parole. Una ‘magia’ che incanta e che lascia spazio ai sogni, alle illusioni, al canto lirico e alla poesia, quando ottimisticamente “credevamo altresì di trovarci all’alba di qualcosa di nuovo”, quel qualcosa che Enrico Brizzi nel parlarci de “Il giovane Holden” di Salinger, ci ha condotti per mano nella sensazione d’incredulità irreligiosità e diffidenza che ci attraversa tutti. E chi meglio di Giacomo Leopardi che non ha avuto il tempo di invecchiare, ha potuto investigare nei sentimenti umani la fragile essenza dell’essere? – si chiede l’autore d’Avenia – Chi ha dato a questa nostra epoca, la dimensione di come davvero "la poesia può salvarci la vita”? «Forse se il nostro lettore, Giacomo, stanotte spegnesse tutte le luci e guardasse il cielo in silenzio, saprebbe che la bellezza e la gratitudine ci salvano dallo smarrimento dovuto alla nostra carenza di destino e destinazione.
Forse se in quel buio luminoso avesse accanto o nel cuore qualcuno, ne scorgerebbe meglio la seducente fragilità, un infinito ferito che chiede cura e riparazione, e capirebbe di esser ‘poeta’, cioè chiamato a fare qualcosa di bello al mondo, costi quel che costi. Forse allora saprebbe che solo uno è il metodo della faticosa ed entusiasmante arte di dare compimento a se stessi e alle cose fragili, per salvarle dalla morte: l’amore. Questo è il segreto per rinascere … questa è l’arte di essere fragili.» Per poi aggiungere in poscritto quanto segue: «I libri, scelti bene, caro Giacomo, possono salvare la vita, soprattutto quella fragile, facendole cogliere il frutto del futuro che si porta dentro. (..) Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a vivere solo se perfetti. Ogni insufficienza, ogni debolezza, ogni fragilità sembra bandita. Ma c’è un altro modo per mettersi in salvo, ed è costruire, come te, Giacomo, un’altra terra, fecondissima, la terra di coloro che sanno essere fragili.»
L'autore: Alessandro d’Avenia, dottore di ricerca in Lettere classiche, vanno ricordati ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’ (Mondadori 2010) dal quale è stato tratto nel 2013 l’omonimo film; ‘Cose che nessuno sa (2011); ‘Ciò che inferno non è’ (2014) con il quale ha vinto il premio speciale del presidente al premio Mondello 2015. Da questo libro l’autore ha tratto un racconto teatrale che porterà in giro per l’Italia.
Grazie Alessandro.
ALTRO
MASSIMO CERULO – “SOCIOLOGIA DELLE EMOZIONI” : Autori, teorie, concetti - il Mulino 2018
Questo innovativo manuale introduce alla sociologia delle emozioni attraverso una puntuale disamina degli autori, delle teorie e dei concetti che definiscono il campo della disciplina. Partendo dai testi dei pensatori classici per giungere ai contributi più recenti, gli stati emotivi si configurano come una preziosa lente di ingrandimento per analizzare le interazioni fra gli individui e le tipologie di agire che prendono forma nelle dinamiche sociali.
Indice:
Introduzione.
- Parte prima. la sociologia classica. - I. I padri fondatori. - II. Gli innovatori. - III Gli autori «di passaggio».
- Parte Seconda. La Sociologia Contemporanea. - IV. L’ufficializzazione della disciplina. - V. I concetti chiave I. - VI. I concetti chiave II. - VII. Il dibattito in corso. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
Massimo Cerulo insegna Sociologia e Sociologia delle emozioni nel Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia. È chercheur associé presso il laboratorio CERLIS alla Sorbona - Paris V. Tra i suoi libri: «Il sentire controverso. Introduzione alla sociologia delle emozioni» (Carocci, 2010), «La società delle emozioni. Teorie e studi di caso tra politica e sfera pubblica» (Orthotes, 2014) e «Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei» (Rubbettino, 2015).
GARETH KNIGHT – “VIAGGIO INIZIATICO NEI MONDI INTERIORI” - Un corso in magia cabalistica cristiana – Spazio Interiore Editore 2018
“Come si è scoperto recentemente, per risolvere un problema non serve tanto saper rispondere a una domanda difficile, ma riuscire a porre la domanda giusta”, avverte cauto Emanuele Mocarelli in chiusura della sua esaustiva prefazione a questo libro appena tradotto in italiano e che ci ha colti tutti di sorpresa, studiosi e intenditori, ricercatori e semplici appassionati di esoterismo, che a loro volta disquisiscono di accadimenti rimandanti all'inconscio, di apparizioni e di miracoli, di immagini oniriche e quant’altro, talvolta ponendosi domande, talaltre dandosi risposte che spesso scaturiscono in ulteriori interrogativi cui necessita dare risposte adeguate.
Ciò per quanto l’argomento esoterico, che pure ha una sua consistente letteratura volutamente tenuta sottobanco, a lungo andare è naufragato nello sconvolgimento dell’informazione primaria che, originariamente si poneva quale domanda di un problema di difficile soluzione, e che, tuttavia, riusciva sempre (o quasi) a trovare una spiegazione ‘altra’, più o meno inerente alla tipologia di vita che l’individuo e/o la comunità sviluppava all’interno del propria realtà domestica e/o della società di appartenenza che altresì, proprio nell’essergli familiare, trovava nella natura circostante in risposta a una domanda di realistica necessità.
Lasciato questo approccio per così dire ‘intuitivo-naturalistico’, il problema di porre la domanda ‘giusta’ rimane irrisolto in ragione del fatto che non governiamo più la nostra esistenza bensì, ci sottoponiamo a quelle che sono le esigenze di mercato e le intransigenze dell’attività speculativa che la società odierna richiede, finendo per soggiacere a stili di vita sempre più effimeri che non soddisfano nessuna delle nostre reali esigenze, o almeno quelle che dovrebbero essere considerate primarie, cioè relative alla scansione del tempo del lavoro, del riposo, della ricreazione spirituale, ecc. mettendo a repentaglio la stessa nostra sopravvivenza. Non c’è più il ‘tempo’ per apprendere dalla natura tutto ciò che ancora ha da insegnarci in fatto di conservazione e sussistenza, in quanto tutto avviene ormai al chiuso di laboratori scientifico-tecnologici in autonomia. Allo stesso modo che non troviamo il ‘tempo’ da dedicare alle cose dello spirito, divenuto terreno arido spazzato dal vento della contemporaneità, in cui tutto accade nel momento stesso del suo accadimento, che se da una parte ci sorprende, dall’altra ci spaventa non poco, perché a detta di Zigmunt Bauman, si trasforma in ‘Paura liquida’ tutto quanto ci sconcerta, da un verso e l’altro delle nostre buone o cattive intenzioni. Allora la domanda ‘dove trovare riparo?’, se non addirittura ‘come proteggerci?’ è in ogni modo sbagliata.
Non una quindi ma due preminenti domande cui è difficile rispondere, tuttavia riuscire a formulare la domanda giusta significa anche dare (non solo cercare) risposta a un’obiettiva esigenza che oggi diremmo ‘virtuale’, cioè coinvolgente entrambe le nostre capacità intellettive razionali e irrazionali, compenetrando il nostro ‘inconscio istintivo’ e il nostro ’inconscio somatico’, nei termini congruenti di un’esplicita equazione con quelli adoperati dal grande psichiatra svizzero C. G. Jung; il quale in ‘Psicologia e alchimia’ aggiunge: “..ogni vita non vissuta rappresenta un potere distruttore e irresistibile che opera in modo silenzioso e spietato”. Che sia questa l’irresistibile domanda cui non sappiamo dare una risposta plausibile? È dunque questo il ‘quid’ su cui ci si barcamena lungo la nostra esistenza spirituale? Conosciamo una eticità che possa aiutarci a discernere le ragioni del nostro ‘presente anteriore infinito’ dal nostro ‘presente finito’ che si prospetta senza futuro? Se capire i linguaggi interiori, imperfetti e capaci al tempo stesso di realizzare quella suprema incompiutezza che ci differenzia l’uno dall’altro, o meglio, che diversifica il nostro impatto irrazionale del passato con la nostra ‘spiritualità’ negando ogni possibile verbalizzazione razionale con la ‘materialità’ del nostro presente, questa a mio avviso rappresenta l’unica conclusione di ogni ricerca; allora inseguire l’idea di una possibile ‘perfezione’ che pure ha contrassegnato fin qui il cammino della nostra inspiegabile esistenza, è stata erronea, cioè frutto di un’utopia mai raggiunta e che mai raggiungeremo. Forse sì, forse no?
Ovviamente non è tutto qui, la magia cabalistica cristiana prospettata nel titolo è in sé rappresentativa di quella “branca della scienza fisica che studia le forze e le forme occulte immediatamente evidenti alla nostra percezione fisica, […] per quanto il fatto che non si riconosca l’esistenza di tali forze sia irrilevante, non significa che esse non esistano, […] solo che non sono così facilmente dimostrabili come quelle della scienza fisica. […] La confusione che insorge su questo punto è dovuta soprattutto alla mancata distinzione tra ‘mistica’ e ‘magia’, ovvero tra ciò che appartiene allo spirito elevato e ciò che appartiene alla dimensione interiore del creato.
Per indagare meglio questa ‘incoerenza’ si potrebbe prendere come riferimento la distinzione che ne fa lo stesso Jung: “Ciò che però continua a rimanere oscuro, proprio per questo miscuglio di fisico e psichico, è se le trasformazioni ultime di questo processo (alchimistico) vadano ricercate maggiormente in campo materiale o in campo spirituale? La domanda in effetti è mal posta: a quei tempi non si trattava di alternativa; esisteva piuttosto un regno intermedio tra materia e spirito: cioè un regno psichico di corpi sottili aventi la proprietà di manifestarsi in forma sia spirituale che materiale.” E in prosieguo: “Naturalmente questo regno intermedio di corpi sottili in sé e per sé, prescindendo da qualsiasi proiezione, rimane nell’ambito della non-esistenza finché noi crediamo di sapere qualcosa di definitivo sulla materia e sull’anima. Ma se viene il momento in cui la fisica sfiora ‘regioni inesplorate, inesplorabili’, e contemporaneamente la psicologia è costretta ad ammettere che esistono altre forme d’esistenza psichica al di fuori delle acquisizioni personali della coscienza, in cui cioè anche la psicologia cozza contro un’oscurità impenetrabile, allora quel regno intermedio ritorna in vita, e il fisico e lo psichico si fondono una volta di più in un’unità indivisibile”.
Ciò sebbene oggi sappiamo che l’indivisibile non esiste, che tutto è frammentabile dal momento che ogni cosa è formata da miliardi di infinitesime particelle che siamo riusciti a scorporare, a suddividere ed elencare, in breve a ‘quantificare’ e a rendere visibili nella loro essenza sia materiale che immateriale. Al dunque sorge una ulteriore domanda sulla materia e sull’anima: dove avviene l’innesto dello ‘spirito elevato’ con la dimensione ‘dello spirito interiore’? In quale campo della quantistica tutto ciò si consuma? Seppure qualcosa ancora sfugga della nostra conoscenza occulta, ‘inesplorabile’, quanto è possibile dire di definitivo su ‘misticismo’ e ‘occultismo’?
A tal proposito l’autore scrive: “La struttura psichica interna a ogni corpo celeste riflette il modello archetipico dell’universo. All’interno della sfera eterica del pianeta una coscienza individuale non consapevole della divinità dal proprio punto di vista soggettivo potrebbe benissimo identificare Dio con la totalità delle cose che percepisce, supponendo inoltre che al di là della realtà di cui è consapevole esista il caos informe o il mondo ‘immanifesto”. […] Per l’uomo Dio è totalmente inimmaginabile, proprio come per un pensiero è impossibile immaginare la persona nella cui mente esso si trova”.
Molte sono le risposte prospettate da Gareth Knight in questo suo ‘viaggio iniziatico’ che non s’arresta davanti ad alcuna ‘soglia’, ottemperando in pieno a quanto premesso introducendo il lettore nel labirinto contemporaneo nei ‘luoghi del silenzio imparziale’, muovendosi liberamente sulla superficie dello spazio, aggrovigliandosi talvolta entro le pulsioni dello spirito, contrastanti e continue, come solo un Maestro (dell’occulto) riesce a fare, schiudendo l’esistenza a mille esiti imprevedibili, fuori dalle direzioni previste e/o prevedibili, lungo sentieri non praticabili da certezze anticipate o da progetti rassicuranti. Ciò che gli è possibile servendosi del fattore ‘tempo’ per misurare il ‘non-tempo’ della sua narrazione forbita di citazioni e rimandi a numerosi testi (spesso introvabili) di riferimento; la cui distanza presiede ogni scambio interlocutorio tra l’autore e il lettore, senza la possibilità del riconoscimento della memoria, nella disseminazione di bivii e incroci intercambiabili, avvitandosi sul proprio perno senza sosta e senza commuoversi davanti alla catastrofi silenziose prodotte dal suo movimento delimitato dai termini della ‘vita’ e della ‘morte’ in cui l’esistenza è disseminata dentro l’interstizio che corre tra le due diverse circostanze temporali.
Come se la ‘vita’, per lo più fondata sul sentimento e/o sull’emotività individuale che sfiora la tragedia subliminale di una solitudine pervadente e assidua rigidamente fissata dal segno cabalistico dell’ ‘infinito’, che non conosce altra direzione se non quella prefissata dal ‘fato’ (destino?), o da un Dio ineluttabile che, prescindendo dalla creazione, ha posto la sua creatura lungo sentieri mistici e/o occulti che lo portano ad errare, non riuscendo egli a produrre risposte all’arrovellata investigazione sulla sua esistenza, in cui la verità e la conoscenza non hanno approdo se non nell’astrattezza di un percorso senza fine, per l’appunto ‘infinito’. […] Non credete che bisognerebbe aggiungere che la vita eterna non è semplicemente una vita che continua all’infinito, ma una vita che possiede la particolare qualità di essere al di fuori dello spazio e del tempo? Forse sì, forse no.
Ma, poichè viaggiare è anche un modo per conoscere se stessi, i progressi in questo campo sono altresì coadiuvati dalla proposta e/o invito di Gareth Knight, a dare seguito a un ‘corso di magia’ che egli ha incluso in ‘indice’ di questo libro afferente all’occultismo come scienza pratica da utilizzare per neofiti e principianti in chiusura dei singoli capitoli con ‘esercizi spirituali’ ed altri di chiaro riferimento ‘mistico-magico’ e un’ampia visualizzazione grafica dei simboli cabalistici onde proseguire il viaggio iniziatico prospettato : “L’immaginazione non è semplicemente uno strumento della fantasia, ma un organo con cui si percepiscono cose reali”. Interessante è l’apparato storico-cronologico delle citazioni che vanno dal ‘Corpus hermeticum’, al ‘Picatrix’, alla ‘Magia naturale e talismanica di Marsilio Ficino’, gli ‘Inni orfici e Thomas Taylor’; da ‘Dante Alighieri’ a ‘Pico della Mirandola e la magia cabalistica’, alle ‘Gerarchie angeliche e celesti’, da ‘Cornelius Agrippa alla Filosofia magica e religione di John Dee, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, fino a ‘L’universo modello dei Rosacroce, Athanasius Kiecher e Robert Fldd, alla separazione tra scienza e magia. Infine, ma non ultimo è il percorso e il lavoro di consultazione occulta, coadiuvata da esperienze di magia teatrale, esercizi magici, sviluppo di alcuni rituali fino allo sviluppo della preghiera di invocazione.
“Qui non stiamo parlando di cavilli accademici, teologici o filosofici; infatti, credere una cosa o l’altra ha delle conseguenze molto profonde e rilevanti. Per costruire un edificio teologico o filosofico dobbiamo conoscere molto bene il terreno su cui verrà fondato.” Pertanto l’esigenza di un testo elaborato su questa materia così esposto rientra in quel ‘vuoto editoriale’ creatosi dopo che l’esercizio intellettuale, manualistico e informativo è, in un certo qual modo, scemato a livello di curiosità per addetti ai lavori, e/o speculativa per generazioni di ginnasti mentali per sviluppare l’intuito, a patto che non si prendano troppo sul serio i suoi contenuti. Di realtiva importanza letteraria (alfine di non dover sembrare tendenziosa) risulta quanto afferma Gareth Knight in chiusura del libro: “Ho scritto questo libro con lo scopo di presentare un sistema di insegnamenti e di pratiche dell’occulto che affondano le radici nel contesto della tradizione e della fede cristiana. È davvero un peccato, a mio modo di vedere, che la magia in quanto arte e scienza sia separata dal pensiero scientifico e dalla religione ufficiale. La magia è stata così privata di una certa impostazione razionale e disciplinata, la scienza è diventata senz’anima e la religione ha perso molta della propria vitalità. Spero che questo libro possa servire agli apprendisti di occultismo per recuperare le fila di una tradizione vitale che è parte integrante della nostra eredità spirituale e culturale”.
L’autore:
Gareth Knight è un esoterista britannico, annoverato fra i più profondi conoscitori della tradizione esoterica occidentale e della Kabbalah, e autore di decine di libri su svariati argomenti, tra cui ‘Tarocchi’, ‘Kabbalah magia e occultismo’ con i quali conduce gli appassionati di occultismo a riappropriarsi di una tradizione vitale che è parte integrante dell’eredità spirituale e culturale dell’uomo occidentale. Nel 1954 entrò a far partedella Fraternità della Luce Interiore, organizzazione esoterica fondata da Dion Fortune nel 1924, per poi fondare un suo gruppo di ricerca ora conosciuto come Avalon Group. Ha trascorso tutta la sua vita riscoprendo e insegnando i principi della magia come disciplina spirituale e metodo di autorealizzazione. Delle sue innumerevoli opere è stato tradotto in italiano anche un altro libro importante dal titolo ‘Tarocchi e Magia’ – Spazio Interiore 2017.
IN RICORDO DI STEFANO RODOTÀ.
Tutti gli articoli rintracciabili sulla rivista on-line larecherche.it
“IL MONDO NELLA RETE” - Quali i diritti, quali i vincoli.
Articolo di Giorgio Mancinelli - Argomento: Informatica
Editori Laterza 2012
“IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI”
Articolo di Giorgio Mancinelli - Argomento: Economia – Editori Laterza 2012
“INTERVISTA SU PRIVACY E LIBERTÀ” – Stefano Rodotà e Paolo Conti – Recensione di Giorgio Mancinelli - Editori Laterza 2013
“ELOGIO DEL MORALISMO” – Editori Laterza 2012
“L’obbligo di verità da parte delle istituzioni diviene diritto d’informazione sul versante dei cittadini”.
“Non un sussulto moralistico ma l’affidabilità stessa del politico rende inammissibile la menzogna”...
...Scrive Stefano Rodotà in questo breve e concentrato ‘elogio’ della moralità rivolto ai fatti più recenti della politica italiana e il quadro che se ne evince non è certo dei più illuminati della nostra storia patria. Tuttavia, “nessun discorso nostalgico, ma la presa d’atto dell’accantonamento colpevole di un tema politico centrale (la mancanza di moralità), causa non ultima della crisi di cui siamo (noi tutti) vittime” e aggiungerei ‘carnefici’. Quasi fossimo tutti quanti superstiti di una carneficina autolesionista che ci siamo inflitti masochisticamente. Ed è così. “Rifiutata, appunto, come manifestazione di fastidioso moralismo, l’aborrita «questione morale» si è via via rivelata come la vera, ineludibile «questione politica»” da tutti noi accettata e sostenuta coi nostri voti. “Ma questa spiegazione (per così dire) antropologica non è convincente, anzi rischia di offrire una giustificazione e una legittimazione ulteriore a chi vuole sottrarsi agli imperativi della legalità e della moralità pubblica” cui siamo chiamati, tutti indistintamente, a incominciare dai politici che abbiamo visti derubricare l’imperativo della ‘moralità’ a sostegno di situazioni materiali indecenti (leggi disoneste), e prendere le difese di posizioni immorali indifendibili.
“Di che cosa sia il moralismo si può certo discutere – scrive Rodotà – ma la critica non può trasformarsi in pretesto per espellere dal discorso pubblico ogni barlume di etica civile. L’intransigenza morale può non piacere, ma la sua ripulsa non può divenire la via che conduce a girare la testa di fronte a fatti di corruzione pubblica, derubricandoli a ininfluenti vizi privati, annegandoli nel «così fan tutti» (e tutte, non tanto per tornare alla corretta citazione mozartiana, ma per alludere a recentissimi costumi). La caduta dell’etica pubblica, indiscutibile, è divenuta così un potente incentivo al diffondersi dell’illegalità, ad una sua legittimazione, sociale”. Far decadere o archiviare una sentenza (per colpa o innocenza che sia) della Magistratura significa delegittimare uno Stato di Diritto a favore della barbarie istituzionale, la ratifica dell’illegalità, a scapito dell’autorità giudiziaria e l’imparzialità della giustizia.
L’esigenza di razionalità come criterio per discernere la qualità metodologica di un comportamento morale, corrisponde a una presa di coscienza formativa che ha come oggetto la ‘responsabilità morale’ che, non andrebbe mai messa in discussione, come invece spesso avviene, in ambito politico. Poiché attinente alla dignità della persona, infatti, essa rientra in quella condizione, per cui ci si sente in dovere di rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, un ruolo determinante: si dice, infatti: “assumersi le proprie responsabilità; fare qualcosa sotto la propria responsabilità; incarico, mansione di cui si è responsabili; così come assumere un impegno, o obblighi che derivano dalla posizione che si occupa, compiti, e incarichi che si sono assunti, ecc. per cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere della violazione amministrativa, civile, penale, da cui si forma spesso un giudizio”.
Addio Professore!
OMAGGIO A SEBASTIANO VASSALLI
Nuovo libro “I racconti del Mattino” edito da Interlinea 2017, curato e introdotto da Salvatore Violante.
Dello scrittore scomparso nel 2015 emergono dalle pagine del Mattino, il quotidiano di Napoli, una serie di racconti pubblicati dall’82 all’85 grazie alle amicizie partenopee dell’autore della Chimera nate al tempo della neoavanguardia e del Gruppo 63. Vassalli mette in scena storie in cui si sente il profumo del Sessantotto, con il 18 politico e il dibattito sul nozionismo di quella stagione, la violenza che accompagna la passione cieca del tifoso di calcio, la superstizione bonaria, lo stile della politica italiana. L’ironia pervade le brevi narrazioni che compongono un primo mosaico di quel carattere degli italiani che l’autore ha rappresentato nei suoi romanzi in cui «l’Italia non è soltanto un Paese vecchio e sostanzialmente immobile: è anche due Paesi in uno. C’è il Paese Legale, sotto gli occhi di tutti, e c’è il Paese Sommerso, che tutti più o meno fanno finta di non vedere». Questi testi lo raccontano.
L’investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che illumini l’inquietudine del presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani approda al Seicento con ‘La chimera’, un successo editoriale del 1990 (premio Strega), poi al Settecento di ‘Marco e Mattio’, uscito l’anno dopo, quindi all’Ottocento e agli inizi del Novecento con ‘Il Cigno’ nel 1993.
Dopo la parentesi quasi fantascientifica, inquietante e satirica, di 3012 e il viaggio al tempo di Virgilio e Augusto di ‘Un infinito numero’, ricrea in ‘Cuore di pietra’ un’epopea della storia democratica dell’unità d’Italia simbolizzata da un grande edificio di Novara, Casa Bossi dell’architetto Antonelli. Nei libri a cavallo del Duemila lo scrittore si avvicina al presente riscoprendo anche il genere del racconto, soprattutto con ‘La morte di Marx e altri racconti’ del 2006 e ‘L’italiano’ dell’anno successivo, prima del ritorno al romanzo fondato sulla storia: la prima guerra mondiale in ‘Le due chiese’, del 2010, e gli antichi Romani in ‘Terre selvagge’, che segna nel 2014 il passaggio dall’editore di quasi cinquant’anni di libri, Einaudi, a Rizzoli, dove appare nello stesso anno una nuova edizione di ‘Chimera’.
Con Interlinea Vassalli pubblica ‘Il mio Piemonte’, la raccolta illustrata’ Terra d’acque’ e, tra gli altri titoli (oltre a ‘Natale a Marradi’ e ‘Il robot di Natale’ nella collana Nativitas), l’autobiografia Un nulla pieno di storie. Ricordi e considerazioni di un viaggiatore nel tempo (con Giovanni Tesio in forma di intervista con documenti e immagini) e ‘Maestri e no’. Dodici incontri tra vita e letteratura. Tra gli studi sullo scrittore novarese si segnala il recente numero di Microprovincia 49 (2011) La parola e le storie in Sebastiano Vassalli, oltre a 'La chimera'. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, a cura di Roberto Cicala e Giovanni Tesio (Interlinea, Novara 2003). Una curiosità: allo scrittore è dedicata la prima guida italiana di itinerari letterari cicloturistici: Nella pianura delle storie di Sebastiano Vassalli, in italiano e inglese (Interlinea-ATL, Novara 2013).
Vassalli pubblica interventi militanti su quotidiani: dopo la collaborazione a La Repubblica e La Stampa, è opinionista del Corriere della Sera (i suoi Improvvisi. 1998-2015 sono raccolti dalla Fondazione Corriere della Sera nel 2016). Muore nel luglio 2015 e nello stesso anno esce postumo da Rizzoli ‘ Io, Partenope’.
OMAGGIO A ERMANNO REA
“La parola del padre” - Manni Editore 2017
Napoli L'Inquisitore accusa Caravaggio: di non ubbidire a Santa romana Chiesa, di essere un ribelle, un seguace dell'eretico Giordano Bruno, di dipingere prostitute, ubriaconi e tavernieri nella convinzione che Dio va cercato proprio lì. È un monologo in cui le parole e le espressioni del pittore si raccontano attraverso gli occhi e la voce dell'Inquisitore. Il quale è un uomo a un passo dalla morte: più volte durante il suo discorso gli mancano le forze, ed è sfiorato dai dubbi di chi sta facendo i conti con la fine e non può certo mentire a se stesso, ed è quasi tentato di riconoscere le ragioni di Caravaggio, di cedere all'ammirazione che nutre per lui. Ma sono solo istanti, perché il suo dovere è richiamare all'obbedienza, all'obbedienza dell'Autorità, all'obbedienza del Padre: il padre che è Dio, il padre che è il Papa, il padre che è il Cesare, il padre che è il genitore.
È questo un viaggio attraverso i quadri di Caravaggio, uomo libero, è l'arringa di un potere ottuso, che si immagina nel Cinquecento ma in realtà ci parla del potere di oggi. Sinossi. Si racconta della vostra passione, di anno in anno sempre più incontenibile, per uomini e donne di basso rango; della vostra smania di riprodurre sulla tela bari, indovine, musici, ubriaconi, tavernieri; del vostro concepire la pittura quasi come cronaca o specchio di quella vita degradata che alligna ai margini di tutte le città – ma soprattutto oggi qui a Roma, diventata la capitale di ogni genere di malaffare – nella convinzione che è là che Dio va cercato.
Per voi insomma è la carne il luogo di residenza di ogni verità. E questa, prima ancora che una bestemmia, è un’eresia. L'Inquisitore accusa Caravaggio: di non ubbidire a Santa romana Chiesa, di essere un ribelle, un seguace dell'eretico Giordano Bruno, di dipingere prostitute, ubriaconi e tavernieri nella convinzione che Dio va cercato proprio lì. È un monologo in cui le parole e le espressioni del pittore si raccontano attraverso gli occhi e la voce dell'Inquisitore. Il quale è un uomo a un passo dalla morte: più volte durante il suo discorso gli mancano le forze, ed è sfiorato dai dubbi di chi sta facendo i conti con la fine e non può certo mentire a se stesso, ed è quasi tentato di riconoscere le ragioni di Caravaggio, di cedere all'ammirazione che nutre per lui.
Un documento carico di tensione civile, una riflessione sull'autorità, sulla ragione critica e la difficoltà di esercitarla, è un viaggio attraverso i quadri di Caravaggio, uomo libero, è l'arringa di un potere ottuso, che si immagina nel Cinquecento ma in realtà ci parla del potere di oggi. “Io stesso mi facevo personaggio dell'intreccio”, scriveva Ermanno Rea. E raramente è stato così vero: in 'La parola del padre' il comunista critico, il fotografo che è arrivato alla grande letteratura partendo dalla durezza del giornalismo d'inchiesta, si fa Caravaggio che passa dalla aspra e vile realtà, e si fa Inquisitore che vive di dubbi e riconosce la stoltezza delle certezze incrollabili.
ALBERTO ROLLO – “UN’EDUCAZIONE MILANESE: Il romanzo di una città e di una generazione” – Manni Editori 2016.
“Cerco ponti in cui lo spaesamento e il sentirmi a casa coincidano. E su quei ponti finiscono con l’apparire, teneri e meridiani, i fantasmi che mi riconducono là dove io sono cominciato e dove è cominciata, per me, questa città.”
Questa è una ricognizione autobiografica ed è il racconto della città che l’ha ispirata. Si entra nella storia dagli anni Cinquanta: l’infanzia nei nuovi quartieri periferici, con le paterne “lezioni di cultura operaia”, le materne divagazioni sulla magia del lavoro sartoriale, la famiglia comunista e quella cattolica, le ascendenze lombarde e quelle leccesi, le gite in tram, le gite in moto, la morte di John F. Kennedy e quella di papa Giovanni, Rocco e i suoi fratelli, l’oratorio, il cinema, i giochi, le amicizie adolescenziali e i primi amori fra scali merci e recinti incustoditi. E si procede con lo scatto della giovinezza, accanto l’amico maestro di vita e di visioni, sullo sfondo le grandi lotte operaie, la vitalità dei gruppi extraparlamentari, il sognante melting pot sociale di una generazione che voleva “occhi diversi”. A questa formazione si mescola la percezione dell’oggi, il prosciugamento della città industriale, i progetti urbanistici per una Grande Milano, le trasformazioni dello skyline, il trionfo della capitale della moda e degli archistar. Un romanzo autobiografico magistralmente scritto, lo sguardo teso della visione: la storia di una città, di una generazione.
L’autore:
Alberto Rollo è nato a Milano. Dal 2005 è Direttore letterario della casa editrice Feltrinelli, dove lavora da oltre vent'anni. Nei decenni Ottanta e Novanta ha firmato recensioni di libri, teatro e cinema per vari quotidiani nazionali, e saggi su riviste (“Belfagor”, “Quaderni Piacentini”, “Ombre Rosse”, “Il Maltese”, Tirature); è stato collaboratore di “Linea d’Ombra” e ha tradotto autori inglesi e americani contemporanei, da Jonathan Coe a William Faulkner. Ha scritto per il teatro e ha realizzato documentari per la tv.
Questa è la sua prima opera di narrativa. info@mannieditori.it
OMAGGIO A ZYGMUNT BAUMAN. Saggi / recensioni di Giorgio Mancinelli.
"La nostra vita è un'opera d'arte, / che lo sappiamo o no, / che ci piaccia o no. . . . / Che lo vogliamo o no.”
"Zigmunt Bauman ... O la coscienza liquida" - saggio di Giorgio Mancinelli in larecherche.it argomento filosofia / sociologia.
Zigmunt Bauman ... "Paura Liquida" - Saggio / Recensione libro in larecherche.it argomento sociologia.
Zygmunt Bauman è uno dei più noti e influenti pensatori al mondo. A lui si deve la folgorante definizione della «modernità liquida», di cui è uno dei più acuti osservatori. Professore emerito di Sociologia nelle Università di Leeds e Varsavia, ha pubblicato numerose ricerche sull’argomento, fra le quali mi sento in dovere di sottolineare: “Voglia di comunità” (2008); “La società sotto assedio” (2008); “Vita liquida” (2009); “Modernità liquida” (2009); “Intervista sull’identità” a cura di B. Vecchi, (2009).
VIAGGI
FRANCO CARDINI
“LA VIA DELLA SETA” IL VOSTRO PROSSIMO VIAGGIO NELLA LEGGENDA – di Franco Cardini e Alessandro Vanoli - il Mulino 2017. RECENSIONE DI GIORGIO MANCINELLI IN LARECHERCHE.IT
“SAMARCANDA” - Franco Cardini - il Mulino 2016 . RECENSIONE DI GIORGIO MANCINELLI IN LARECHERCHE.IT
“ISTANBUL” - Franco Cardini - il Mulino 2015. RECENSIONE DI GIORGIO MANCINELLI IN LARECHERCHE.IT
Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, un viaggio attraverso chiese cristiane, alti minareti e grandiose moschee, bazar e labirinti di piccole strade in cui una moltitudine variopinta di turisti spesso s’inoltrano senza neppure conoscere ciò che osservano con tanto clamore, mescolando al mito la narrazione della storia che i luoghi, e non solo quelli adibiti al culto, raccontano di conquiste e distruzioni, di regni caduti e risollevati, di splendori e meraviglie, ma anche di ricchezze e fasti così come di ombre e oscurità improvvise nonché di orrori e miserie umane che nel tempo ne hanno fatto una ‘seduttrice, conquistatrice, sovrana’. L’unica città al mondo che più d’ogni altra sfugge ostinatamente dalla sua cornice ‘metropolitana’ per innalzarsi al di sopra delle sue cupole nel mistero che la contempla, separata dal resto del mondo, come di soglia posta fra Oriente e Occidente a rimarcare un’ultima possibilità di congiungimento.
Quasi una ‘fibbia di civiltà’ che pure contiene le due diverse sponde del vecchio e del nuovo mondo (la Roma Imperiale e la Nuova Roma), non necessariamente in contrasto con la modernità dei tempi, né con il medioevo in cui ciò che rimane del passato debba considerarsi oscuro e polveroso. Il futuro della modernità passa da Istanbul, una città viva in cui ogni pietra, ogni accadimento, parla della storia che sarà, una storia ancora tutta da scrivere in cui il passato si congiunge con il futuro. Una storia che Franco Cardini pone come ‘in prospettiva’ e che un soprassalto di civiltà salverà dall’eterno conflitto con se stessa e con il mondo intero, la cui vera identità è forse da cercare nella conoscenza (mai obsoleta) di ciò che la distingue, all’interno del conflitto religioso che ne contende la supremazia. In quel suo essere stata Bisanzio e poi Costantinopoli e in epoca moderna essere Istanbul la cui ‘storia’ va riletta e reinterpretata secondo il punto di vista degli storici arabo-mussulmani, osservata dalla parte opposta del Bosforo, cioè dalla parte orientale-balcanica, per acquisire veridicità.
Dunque non una qualsiasi guida ma più di una semplice guida, la città di ‘Istanbul’ contenuta in questo libro ‘unico’ rivendica a suo favore un confronto con l’approssimarsi del tempo che la separa da noi occidentali per riprendere a correre nel tempo della realtà, in cui il dibattito delle idee (che ci siamo fatte) su di essa, trovano un loro riordino della costruzione smessa, intrapresa in illo tempore, della Nuova Roma, con quella in atto di Istanbul in quanto nuova città metropolitana condivisa e sostenibile. Innumerevoli quindi i punti di osservazione suggeriti, e quanti aspetti inusitati da quelli proposti al visitatore e dal turista che si voglia chiamare; tuttavia la differenza è quasi totale perché ciò che si propone il visitatore è qualcosa di diverso da ciò che riesce a malapena a cogliere il turista. C’è un mare di cultura di mezzo, la conoscenza in primis, cosicché documentarsi, consultare, aprirsi è quanto suggerisce di fare Franco Cardini con questo ‘libro’ documentatissimo di storia, di aneddoti ricercati, d’arte e di stili, di usi e costumi di popoli a confronto, che in ‘Istanbul’ egli propone come una lunga narrazione mai interrotta:
“Ed eccola Istanbul: caotica e rumorosa eppur fasciata dall’assordante silenzio delle sue pietre e dei suoi secoli; cupa sotto l’abbacinante sole meridiano che obbliga a chiudere gli occhi o a proteggerli dietro spesse lenti color verdi o bruno; iridescente nella coltre di bruma che così spesso la fascia nei crepuscoli; luminosa di millanta luci nelle notti con e senza luna, con e senza le stelle. Inutile illudersi di conquistarla. (..) Istanbul non si conquista, esiste solo un modo per impadronirsene. Lasciarsene impadronire. (..) si fa presto a dire Istanbul. La città è propriamente una e trina, divisa in tre parti: dalle acque del golfo mediterraneo detto Mar di Marmara a sud – Propontis, la «Propontide» (il mare anteriore) -, il vasto e profondo bacino lungo 280 chilometri e largo 80 che attraverso i Dardanelli comunica con il Mar Egeo e che verso nord si biforca insinuandosi a nordest in uno stretto che misura più o meno una trentina di chilometri (Bogaziçi), che separa la costa europea dall’asiatica fino al Mar Nero; dal Corno d’Oro (Haliç), l’ampio fiordo che dal Mar di Marmara e Corno d’Oro, è la vera e propria sede dell’antica Costantinopoli”.
Dacché si comprende come Franco Cardini procede nell’illustrarci un suo (fra i molti possibili) itinerario per visitare la città, spostandosi di conseguenza da una zona all’altra, da una storia all’altra, da una realtà all’altra e raccogliere così quello che si definisce lo ‘spirito del viaggio’ che tutto coinvolge e trasforma: in cui la storia si fa dapprima leggenda per poi entrare nel mito. È allora che la narrazione di Istanbul diventa ‘una città nel mare della storia’; i frangenti dei mari che la bagnano ‘i flutti del tempo contro il molo dell’eternità’; la falce di luna simbolo dell’Islam turco ‘il segreto del crescente lunare’ che rischiara le notti del harem e del Serraglio, con le sue storie ‘romantiche’ e ‘sanguinarie’, tuttavia eccitanti quanto sconvenienti (per la nostra cultura). E inoltre le musiche, le danzatrici di ‘belly dance’, i sultani coi loro ‘padiglioni’ ricoperti di tappeti e cuscini, il tè alla menta, il caffè turco, l’hammam (sauna), le armi dalle impugnature incrostate d’oro e di pietre preziose, i vapori odorosi di essenze pregiate ecc. ecc.
Accompagnati dalla guida esperta di Franco Cardini sostiamo per un istante davanti al Gran Palazzo, in turco il Sarayi (da cui l’italiano Serraglio), cioè il palazzo imperiale d’epoca ottomana: “Si trattava in realtà di un insieme di giardini e padiglioni (..) separato dal resto della città da una cinta muraria esterna, all’interno della quale si situavano – come il visitatore moderno può ancor oggi constatare – spazi ordinati in cortili e giardini disseminati di padiglioni adibiti a vari uffici e servizi. Entriamo quindi nell’immenso complesso che ancora oggi prende il nome dal suo portale fortificato aperto verso la piazza Sultan Ahmet, il ‘Topkapi’, ovvero la «Porta del Cannone», praticabile da parte di sudditi e di stranieri fino ai quartieri riservati ai militari di guardia, ai funzionari di governo, alle donne”. Ben altre sono le porte che si richiamano alle diverse ‘corti’, a cominciare dalla «Grande Porta» (Bab-|Alì), denominata anche «Soglia della Felicità» o «Sublime Porta» destinata a divenire proverbiale:
Mi fermo qui, anche se ho trovato utile (quanto accattivante) da parte dell’autore l’avvisaglia di retro-copertina dedicata al lettore: “Viaggiatori avveduti e turisti intelligenti che mettete in conto di affidarvi, prima di partire, a voluminose guide: nelle mie intenzioni – e nelle mie speranze – l’ideale sarebbe che lasciaste da parte libri, guide e mappe e vi affidaste fiduciosamente a queste pagine. Certo, questa è la «mia» Istanbul. Non pretendo che diventi anche la «vostra»: mi basterebbe che quanto qui leggete vi aiutasse a trovarla”. Ha scritto Iosif Brodskij (citato nel libro): “Ci sono luoghi in cui la storia è inevitabile come un incidente automobilistico – luoghi in cui la geografia provoca la storia”.
Ed è così, qui ogni pagina racconta più d’una storia, una dentro l’altra che s’intersecano a formare un grande quadro d’insieme, finanche poetico che permette al lettore di spostarsi dal reale all’immaginario con la disinvoltura che solo Franco Cardini, per questo unico e quindi raro, ha nel districarsi in certe faccende di per sé complicate, che cedono, arrendendosi, alla sagace penna del narratore per eccellenza che occupa un suo preciso spazio nella nostra letteratura, in quanto storico e saggista, che ha sfruttato al meglio la sua potenza istruttoria negli studi sul Medioevo di cui è indubbiamente il più apprezzato conoscitore di scritti cristiani e arabo-islamici. Inutile qui ripercorrere la sua enciclopedica attività professionale la conoscenza della quale è oggi accessibile su tutti i media, così come citare la sua sterminata bibliografia. Pertanto mi limito a segnalare quelle che sono le sue più recenti pubblicazioni:
“Testimone del tempo. Ritorno a Coblenza”, Rimini, Il Cerchio, 2009 “7 dicembre 374. Ambrogio vescovo di Milano, in I giorni di Milano”, Roma-Bari, Editori Laterza, 2010 “Cristiani perseguitati e persecutori, Roma, Salerno Editrice, 2011 “Il turco a Vienna”, Roma, Laterza, I Robinson. Letture, 2011 “Gerusalemme”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2012 “Istanbul”, Bologna, Il Mulino, Intersezioni, 2014 comprende inoltre un’ampia appendice ricca di note, cronologia, carte, glossario, bibliografia e delle bellissime riproduzioni d’arte.
Per il lungo ponte del 1° novembre, due proposte molto differenti tra loro, ma entrambe di grande spessore, realizzate in collaborazione con Viaggi di Cultura de il Mulino.
‘SULLA VIA DELLA SETA . IRAN’ - 27 ottobre - 4 novembre
“Da Ciro il Grande a Khomeini, storia di un grande impero e della sua presenza nel vicino Oriente.
Assistenti culturali: Giovanni Curatola, esperto d'arte e dell'Islam persiano e Vittorio Emanuele Parsi, esperto di Relazioni internazionali”.
Per informazioni: diffusione@mulino.it
Società editrice il Mulino - Strada Maggiore 37 - 40125 Bologna
tel. 051 256011 - fax 051 256041
Giunti al dunque, non mi resta che augurarvi: Buon Viaggio!
LE PAROLE E I LIBRI (recensioni)
GIANRICO CAROFIGLIO – “LA MANOMISSIONE DELLE PAROLE” - Rizzoli 2011, recensione di Giorgio Mancinelli in larecherche.it
Pochi libri hanno la capacità di affabulare il lettore e convincerlo di quello che dicono dalla prima pagina all'ultima, da lasciarlo addirittura senza fiato, per la sua sconvolgente autorevolezza. Spogliato qua e là di qualche marcata presa di posizione che non cambia l'indirizzo etico ed estetico del saggio, il resto è tutto un rincorrere concetti, di cui abbiamo perduto il senso, che Gianrico Carofiglio recupera e ci omaggia di una chiave di lettura più vicina a noi, al nostro tempo, alla società attuale che, sempre più, si perde nelle concatenazioni superate e fittizie della politica. Nell'economia del libro, infatti, la politica è nelle cose, negli atti, così come nei pensieri e addirittura nelle parole divenute "sconvenienti" perché - come scrive l'autore - manomesse in funzione di qualcos'altro che non è il terreno originario per cui sono state coniate. Inutile dire che qualcosa non funziona in questa società (che ricordo abbiamo costruito noi), in questa democrazia che, pure, ci siamo dati noi.
Qualcosa certo non deve aver funzionato a dovere se stiamo ancora qui a sbattere la testa contro il muro, dopo aver affrontato ogni argomentazione per milioni di volte, esserci fatti propositi, aver fatto promesse (a noi stessi prima che agli altri), se poi siamo rimasti più o meno quelli che eravamo un secolo fa. Viene da domandarci a cosa sono servite tutte le guerre se ce ne sono ancora in corso? Tutti gli incontri al vertice (G8 - G10 - G20 e quelli sulla fame, sull'ecologia, sul nucleare, sul salviamo il mondo) tra le nazioni, se tutto rimane come è sempre stato, anzi peggiora di giorno in giorno? Tutto questo per pensare in grande per quanto riguarda la comunità, l'intera umanità, ma che succede se per un istante ci inoltriamo nel "labirinto" di noi stessi, noi intesi singolarmente come entità pensante e giuridicamente responsabile?
Nota d'autore: "Mi è difficile definire la natura di questo libro che verrà classificato come un saggio (e in un certo senso lo è), ma tengo a dire che, per me, è soprattutto l'esito di un gioco di sconfinamenti. Un'antologia anarchica. Una ricerca di senso, anche, soprattutto attraverso le parole e le pagine di altri, da Hannah Arendt a don Milani, da Aristotile a Bob Dylan, da Goethe a Gramsci, fino alle pagine esemplari della nostra Costituzione". E ciò che egli vuole dirci è che dovremmo re-incominciare a chiamare le cose con il loro nome, ripensare il linguaggio come un gesto in prospettiva che vada verso il futuro, "immaginare una nuova forma di vita".
L’autore:
Gianrico Caeofiglio è uno scrittore, politico ed ex magistrato italiano. Autore di numerosi romanzi ha pubblicato recentemente Il 25 ottobre 2016 esce L'estate fredda con un nuovo caso per maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese in servizio nel Sud delle mafie, già conosciuto come protagonista di Una mutevole verità.
A Ottobre 2017 esce Le tre del mattino, storia del serrato confronto fra un padre ed un figlio, confronto da cui ambedue riemergeranno profondamente diversi.
Nel febbraio 2018 esce Con i piedi nel fango, Conversazioni su politica e verità, un saggio socio-politico all'insegna del dialogo sotto forma di intervista, con Jacopo Rosatelli.
In totale i suoi libri hanno venduto cinque milioni di copie e sono stati tradotti in ventotto lingue.
CARLO POMPILI – “La Prova” – Augh! Edizioni 2017 - recensione di Giorgio Mancinelli in larecherche.it.
La reiterata descrizione di un ambiente naturale all’interno di un romanzo d’azione solitamente determina una stasi nell’evoluzione dinamica dell’azione stessa, l’equivalente del flash-back in una pellicola cinematografica che rallenta lo scorrimento della trama, non consentendo il raggiungimento ultimo di quella vertigine, di puro stile giornalistico, che di per sé costituisce il ‘fatto di cronaca’ in un qualsiasi thriller …
“Qualche istante ancora, ed ecco mille piccole gocce di pioggia, ritmare il loro suono cadendo copiose sulle tavole dell’impiantito, allegre, leggere, inascoltato presagio del temporale che, di lì a poco, si sarebbe scatenato vittorioso. Neppure qualche cupo brontolio, dapprima indistinto, quindi, sempre più rabbioso, era riuscito a rimuovere Valeri da quella postura. Fu solamente alcuni istanti più tardi che l’uomo decise di allontanarsi dal pontile, quando il cielo, compatto nel suo colore cinereo, ebbe raggiunto l’apice della sua drammaticità, squassato dal bagliore delle scariche. Il lago (Bolsena) appariva come un gigante intrappolato nel suo bacino vulcanico, percosso dai giochi concentrici che si susseguivano sempre più intensi sulla superficie dello specchio d’acqua.”
Sorprendentemente, ‘il caso’ afferente a questo romanzo poliziesco, porta in scena gli insoliti anfratti della tranquilla provincia viterbese: la verde Tuscia, infatti, è una nicchia ecologica la cui condizione sociale e quella umana, storicamente integrate sul territorio, interagiscono nel comportamento psicologico dei personaggi, fornendo loro un ‘alibi moralistico’ necessario al riscatto ultimo delle loro azioni, bonarie o malevoli che siano, per quanto condizionate nell’intento scrittorio dell’autore, la cui penna sagace penetra efficacemente nella psicologia addomesticata dei personaggi creati …
L’autore:
Scrittore fine ed oculato, appassionato di storia e cultura dell’Alto Lazio, coltiva interessi grafici e letterari, dando seguito a sue collaborazioni in campo commerciale e pubblicitario. Dopo ‘Il potere’ (Alter Ego 2014) con questo suo nuovo romanzo “riporta i suoi lettori in quell’atmosfera da lui creata dove thriller e storia si intersecano strettamente con richiami ancestrali e misteriosi, in un sequel nel quale ogni colpo di scena conduce magistralmente fino a un epilogo inaspettato”.
Buona lettura!
*
 - Libri
- Libri
La Prova un libro di Carlo Pompili
La reiterata descrizione di un ambiente naturale all’interno di un romanzo d’azione solitamente determina una stasi nell’evoluzione dinamica dell’azione stessa, l’equivalente del flash-back in una pellicola cinematografica che rallenta lo scorrimento della trama, non consentendo il raggiungimento ultimo di quella vertigine, di puro stile giornalistico, che di per sé costituisce il ‘fatto di cronaca’ in un qualsiasi thriller …
“Qualche istante ancora, ed ecco mille piccole gocce di pioggia, ritmare il loro suono cadendo copiose sulle tavole dell’impiantito, allegre, leggere, inascoltato presagio del temporale che, di lì a poco, si sarebbe scatenato vittorioso. Neppure qualche cupo brontolio, dapprima indistinto, quindi, sempre più rabbioso, era riuscito a rimuovere Valeri da quella postura. Fu solamente alcuni istanti più tardi che l’uomo decise di allontanarsi dal pontile, quando il cielo, compatto nel suo colore cinereo, ebbe raggiunto l’apice della sua drammaticità, squassato dal bagliore delle scariche. Il lago (Bolsena) appariva come un gigante intrappolato nel suo bacino vulcanico, percosso dai giochi concentrici che si susseguivano sempre più intensi sulla superficie dello specchio d’acqua.”
Sorprendentemente, ‘il caso’ afferente a questo romanzo poliziesco, porta in scena gli insoliti anfratti della tranquilla provincia viterbese: la verde Tuscia, infatti, è una nicchia ecologica la cui condizione sociale e quella umana, storicamente integrate sul territorio, interagiscono nel comportamento psicologico dei personaggi, fornendo loro un ‘alibi moralistico’ necessario al riscatto ultimo delle loro azioni, bonarie o malevoli che siano, per quanto condizionate nell’intento scrittorio dell’autore, la cui penna sagace penetra efficacemente nella psicologia addomesticata dei personaggi creati …
“Fino a quando sarebbe durata quell’angoscia? Un dolore mai espresso pienamente, che avrebbe voluto condividere con lei (sua madre), allo scopo di scacciare quel fantasma che sembrava allontanarle sempre più l’una dall’altra”. […] Sara si voltò rapidamente, serrando le braccia in modo tale da nascondere il nervosismo che provava, tradito da uno spasmo inconsulto della spalla destra.”
Sebbene ‘la prova’ (del titolo) sia qui intesa quale indizio finale che porta alla scoperta dell’assassino, si è messi di fronte ad una realtà provinciale talmente radicata sul territorio, ‘da trasformare ogni abitante in un possibile indiziato’, la cui esistenza travalica i limiti imposti dall’ambiente se non in chiave onirica, fantasticando, e tuttavia senza mai superarli. Limitandosi, in almeno un caso, a una diversa realtà sociale, e forse (mentendo a se stessi), a una vita differente da doversi realizzare lontano dal proprio habitat naturale, magari nella grande città, dove ricominciare e/o forse ‘fuggire’ …
Fuggire dove, da chi, dagli altri, dalle malelingue del paese, dai misfatti della sorte, dalle anomalie delle cose? “Non si diranno le cose, si diranno le cose stravolte […] dalla sua forma e dal suo senso vero, supposto, inventato da una parola” – scrive il poeta (*); una parola bisbigliata in un confessionale, succube di un pensiero cattivo, di un sentimento atipico, in malafede. Se ne trova riscontro nel linguaggio esteso dei dialoghi, a tratti scarno, solo talvolta ridondante a causa dell’interferenza che l’ambiente esercita sul quotidiano in cui agiscono i personaggi: il bonario maggiore dei Carabinieri Lorenzo Valeri, l’amichevole medico legale Giacomo Serra, il parroco suadente, il contadino sanguigno, la madre benevola, il ragazzo sciocco, ed altri che, appunto, come in un film di carattere, s’adoperano dentro la cornice statica di un ‘evento’ legato a una sorta di ‘passato-presente-passato’ che contrassegna il loro insoddisfatto esistere …
“Federica, affannata, aprì la porta dell’appartamento di colpo, richiudendola rumorosamente dietro di sé. Fuori di ogni sentimento, si lasciò cadere su di una delle poltrone della sala, tenendosi la testa tra le mani. Fu allora che diede sfogo a tutte le sue ansie, esplodendo in un pianto liberatorio, fragoroso e incontenibile, tale da consentirle di esorcizzare, con quel gesto, le mille tensioni accumulate. Il dialogo appena concluso con Sara le aveva consentito solo parzialmente di condividere i timori che la turbavano, ma, nel contempo, le sembrava di aver tradito le aspettative del suo nuovo compagno.”
Un altro fattore importante in questo romanzo è rappresentato dallo ‘spazio-tempo’ che pure funge da contenitore di una catena di omicidi consequenziali, non sempre dettati da una effettiva ragione, bensì da quel passato-presente-passato cui nessuno sembra in grado di sfuggire, e che trasforma ‘ogni abitante in possibile indiziato’. Da qualcuno che pure s’aggira furtivo nell’ombra e che colpisce non proprio allo scopo di compiere un omicidio, quanto di voler dare seguito a una vendetta ‘morale’, azzarderei quasi ‘etica’, che riporti a quel ‘passato’ che non può morire, complice per l’appunto, la reiterata tranquillità dell’ambiente naturale in cui la storia si dispiega. La prova provata che ‘tutto cambia e nulla cambia’ se non cambiando il verso delle cose, la concezione della nostra vita interiore …
“Lorenzo Valeri aveva tentato tutto ciò che era umanamente possibile per scongiurare quella fine atroce, al punto da mettere in gioco la propria vita , pur di salvare quella altrui. […] Valeri fece cenno al suo subalterno di fermarsi, affiancandosi, egli solo, all’uomo ritto in piedi di fronte alla lapide. […] La sua espressione non era mutata affatto. Solamente quando i due uomini in divisa furono a qualche metro da lui, sollevò lentamente lo sguardo, come colui che attende un ineluttabile avvenimento nell’atto di compiersi. Quelle pupille , stanche e afflitte, non trovavano alcun conforto nella cornice marmorea che lo attorniava; nessun giovamento al tormento che straziava un’anima in costante tumulto. […] Ma ciò non era stato sufficiente. Sara non sarebbe mai ritornata sui suoi passi, di questo ne era certo. Un triste destino davvero, il suo, che sentiva di non meritare, ma contro il quale non desiderava più combattere, comprendendo, questo sì, davvero, l’inutilità di ogni iniziativa personale.”
L’autore Carlo Pompili:
Scrittore fine ed oculato, appassionato di storia e cultura dell’Alto Lazio, coltiva interessi grafici e letterari, dando seguito a sue collaborazioni in campo commerciale e pubblicitario. Dopo ‘Il potere’ (Alter Ego 2014) con questo suo nuovo romanzo “riporta i suoi lettori in quell’atmosfera da lui creata dove thriller e storia si intersecano strettamente con richiami ancestrali e misteriosi, in un sequel nel quale ogni colpo di scena conduce magistralmente fino a un epilogo inaspettato”.
Note:
(*) Gian Giacomo Menon “Geologia dei silenzi” – Anterem Edizioni 2018.
*
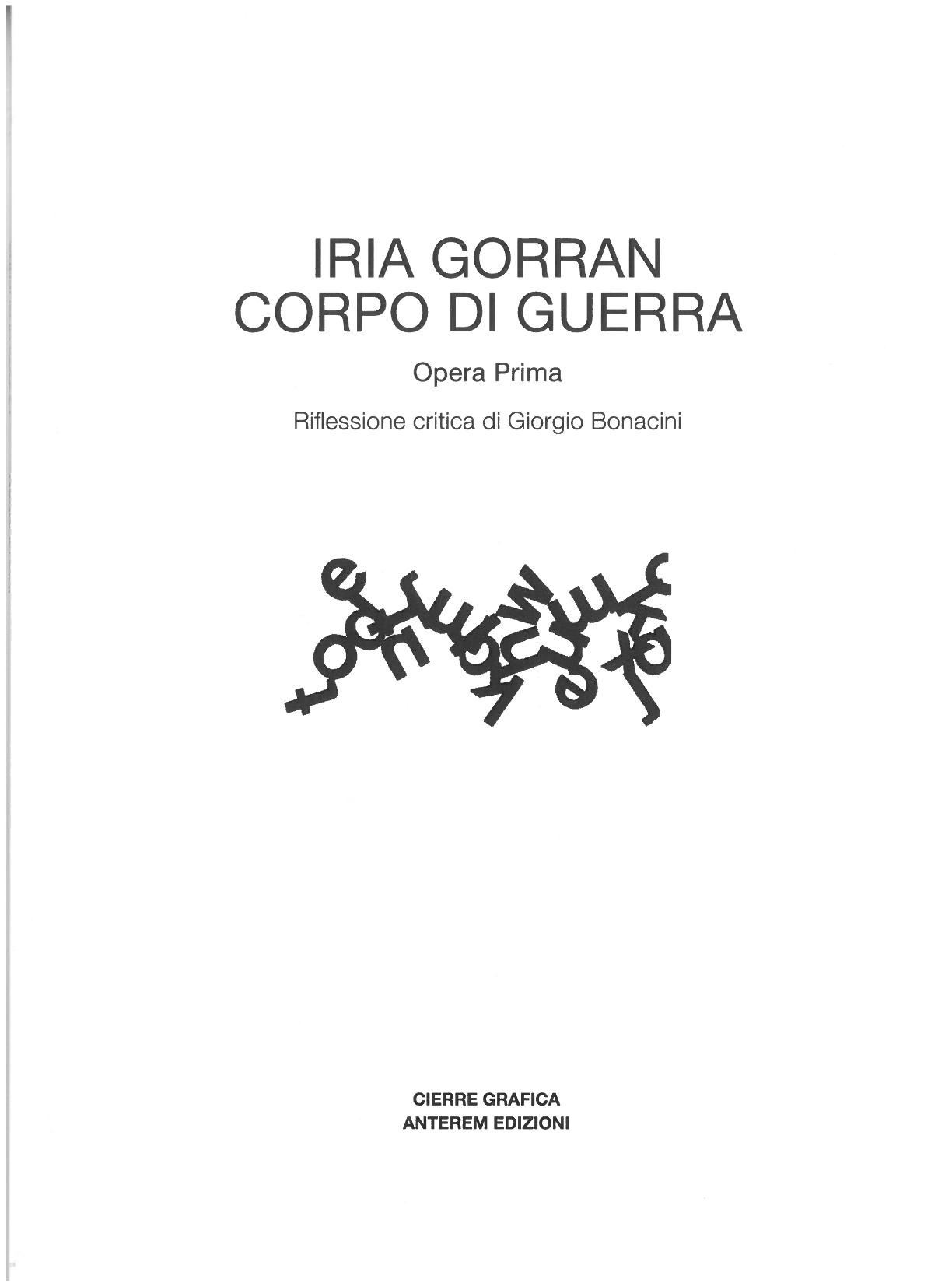 - Poesia
- Poesia
Iria Gorran o l’arte della guerra’ nella poesia d’autore
Iria Gorran o ‘l’arte della guerra’ nella poesia d'autore contemporanea – Cierre Grafica / Anterem Edizioni 2018.
L’accostamento con l’opera di Sun-Tzu è affatto casuale quanto cercato, per sottolineare la portata di un fare poesia che inscena l’essenza di una tentazione contemporanea: condurre una ‘guerra’ essenzialmente intimistica contro il proprio sé. Questa la cifra elettiva della silloge poetica ‘Corpo di guerra’ di Iria Gorran, in cui la passione competitiva è sempre in bilico tra appagamento e/o perdita mediante l’‘artificio della ‘guerra ’, conflitto questo che si fa scontro duro tra vincitore dominante e il perdente arrendevole, da affrontare con la calma e l’irruenza necessaria …
“Ho sempre sentito il corpo come uno scudo / un mezzo lo strumento di difesa / dal mondo – la macchina umana un filtro / con esigenze minime / […] / che la necessità / l’angoscia hanno spinto quasi oltre il limite / ma tutto quello che volevo era / che mi riconducesse – mi portasse a casa”
Per quanto si voglia che anche una ‘guerra individuale e personalizzata’ la si faccia per vincerla, altresì essa risulta remissiva di affrancamento e/o riscatto che necessita di continuare a combattere dall’interno, sul campo nemico. Come del resto insegna il ‘fautore di tutte le guerre combattute fin qui', Sun-Tzu: “se non puoi vincere il nemico, allora fallo re”; così facendo “si può sempre vincere senza necessariamente vincere”, poiché “la vittoria si ottiene quando le due parti in lotta, quella superiore e quella inferiore sono animate dallo stesso spirito”…
“Atomi dispersi estranei alla configurazione” / “Avevano qui / una vaga idea di questa guerra?”
La sottolineatura nel titolo 'arte' è qui utilizzata per meglio evidenziare l’immagine impressa sul fondo di una tela (mettiamo di un corpo materiale) in attesa d’essere riempita di colore, ‘secondo i dettami della propria anima’ e/o secondo il presente-anteriore-infinito che ci siamo preposti fin dall’inizio, qualora riempire gli spazi vuoti divenga sinonimo di volontà: quasi che l’espansione dell’anima nel silenzio della solitudine, similitudine d’assenza e/o di presa coscienza, avalli statue di carne vive per un teatro della fine, in assenza di applausi e tuttavia senza compianto …
“Annuvola sulla fuga dei pioppi / in faccia ai girasoli / oppongo un argine fulmineo / al cuore esploso a un altro pomeriggio / la dea delle stagioni il fuoco vivo / sono vapore e cenere / sul lungo sguardo di marmo del nemico”
Ciò che accade quando il ‘corpo emozionale’ si tinge di un’inquietudine opaca, o avviene a una mutazione incessante per una guerra annunciata col proprio sé fin troppo differita; allorché l’unica condizione possibile per continuare a vivere è in un rapporto nuovo, diverso, con se stessi, con gli altri e con il mondo intero. Ma è tuttavia una ‘guerra costante’, eppure non definitiva, una levata di scudi per un combattimento ‘corpo a corpo’ contro un nemico invisibile, sempre diverso, che fa uso di spade e lance affilate, onde infierire sull’eventuale perdente senza resa …
“..voluta di fumo nella monocromia metallica / s’increspa lo sguardo / segregato nel cielo di Marte / assorbi il mio mistero senza conoscerlo / inscritto nella città di pietra / nel corpo estraneo”
Non rimane che - allerta Sun-tzu: “Quando muovi, sii rapido come il vento, maestoso come la foresta, avido come il fuoco, incrollabile come la montagna”, e aggiunge: “Adesca (il nemico) con la prospettiva di un vantaggio, e conquistalo con la confusione; se è solido preparati (a combatterlo); se è forte evitalo, se è collerico mostrati cedevole, se è umile, arrogante. Se è pigro affaticalo, se è compatto disperdilo. Attaccalo quando è impreparato e appari all’improvviso”, l’effetto sorpresa sgomina la paura rimessa, onde vincere è solo un’ultima prerogativa …
“Acqua sulle mani / non splenderà / in gocce brillanti / alto l’azzurro si spacca / come una torre crolla / fatto spiraglio / taglia indica la stanza / un piccolo silenzio / passa / l’estate si è appoggiata / alle nostre tende chiuse / e quasi è l’Ora”
Oppure ci si arrende e si subiscono le conseguenze sperando nell’indulgenza del vincitore, che non tarderà ad arrivare, spietato e violento che sia, forse sì / forse no, per una remissione di colpe sottratte al giudizio ultimo, contro il proprio sé; onde col passare del tempo si spegneranno le arsure, le istintive voglie, la vanità della giovinezza, l’avidità del potere; l’insana voglia di condurre il proprio ‘corpo di guerra’ sul filo del crinale e rimettere il tutto nel fondo del burrone, per una ‘pace dei sensi’ di una ‘guerra a perdere’ che rende vincitori …
“E la meravigliosa morte / come la prima luce / mi assolverà dal non essere / Fiamma / avrei assorbito / l’umidità terrestre / che mi trattiene / nel susseguirsi di cicli / divampare / staccando il respiro di vendetta / non c’è amore in questa vanità / il mondo è stato uno spiraglio”
“Si può sempre vincere senza necessariamente vincere”, rammenta Sun-Tzu l’eclettico filosofo della guerra, di quella stessa ‘guerra’ che Iria Gorran in queste pagine conduce in prima persona attraverso una “scrittura d’esistenza che è lingua di forte energia poetica, spezzata dall’esperienza di sé: dal corpo che la porta dentro e dal linguaggio che ne illumina la percezione. […] Il segno fondante è un’incisione dura, un graffio che designa i luoghi di un brusio dentro il silenzio ‘terribile’ che opprime il parlare e rende incerti i suoni (e le parole), mentre la voce spezza la rapidità del ronzio esistenziale continuo, scuro” – scrive Giorgio Bonacini nella sua intensa postfazione al volume …
“Calata in questo luogo nel corpo di guerra / esco dalla trincea la mia sommossa fredda / densa la tua paura /.../ al circo di parole sul filo del trucco / non si scioglie / Guardami scorrere non si scusa la mia faccia nuda / in un silenzio di passaggio”
Incerto il prosieguo, se Iria Gorran vincerà o no la sua guerra lo scopriremo in futuro con l'avanzare della sua esperienza poetica o se magari ritiene di averla già vinta (e perché no) con la pubblicazione di questa sua ‘Opera Prima’ (*) edita da Anterem Edizioni con le immagini grafiche di Bartolomé Ferrando che, come in nessun altro caso, coglie nella mescolanza di lettere dell’alfabeto il senso intrinseco della fugacità dell’autrice dalle parole; segno indubbio di una sensibilità artistica pregna d’inconsuete voci, come di geroglifici di una lingua estensibile all’infinito.
L’autrice: Iria Gorran ha origini croate e formazione classica, un curriculum di tutto rispetto in ambito artistico e teatrale, autrice di testi poetico-filosofici e narrativi: ‘Il corvo e i racconti del mistero di Poe’, la ‘Commedia di Dante’. Risiede per lunghi periodi a Vienna e a Londra, attualmente vive a Torre d’Isola (PV).
Note:
(*) Sun-Tzu (544 a.C., 496 a.C.) è stato un generale e filosofo cinese, a lui si attribuisce uno dei più importanti trattati di strategia militare di tutti I tempi: ‘Larte della guerra’ – Mondadori 2003.
(*) ‘Opera Prima’ , collana di poesia e prosa poetica a cura di Flavio Ermini, dedicata ad autori che ancora non hanno pubblicato i loro testi poetici in volume. L’iniziativa, fondata nel 2003 non ha finalità di lucro tanto che i libri non sono destinati alla vendita, ma inviati a università, centri culturali, stampo petica, biblioteche, oltre che a filosofi e a teorici della letteratura e dell’arte. ‘Opera Prima’ si propone di mettere in scena eventi di scrittura che spingono a portarsi più in là degli esiti espressivi, verso il pensiero: quella particolare forma di pensiero che nasce dalla poesia.
Contatti:
direzione@anteremedizioni.it / www.poesia2punto0.com
*
 - Teatro
- Teatro
La Costituzione: valori a voce alta - a Bologna
concerto- spettacolo dedicato ai 70 anni della Costituzione Italiana
Mercoledì 5 settembre ore 21:00
Giardino Parker Lennon (via del Lavoro – via Vezza) Bologna
Simona Sagone: voce; Salvatore Panu: fisarmonica; Mauro Malaguti: chitarra
A cura di Associazione Culturale Youkali APS
Rassegna “Parker Lennon: ci giochiamo l’estate 2”, sezione "Ci cantiamo d'estate"
Ulteriori informazioni www.youkali.it
Sostenuta dal Quartiere San Donato San Vitale - Lato baracchina Gelateria Modà.
Youkali è l’isola che non c’è, è l’utopia, che con il nostro lavoro quotidiano in associazione, noi soci vogliamo realizzare concretamente nel nostro territorio, 'che include e non esclude' il lavoro fatto da attori e musicisti professionisti che credono fortemente che l’arte serva per rendere migliore la società e che attraverso Youkali si possano concretizzare progetti per il bene comune.
L'Associazione Youkali organizza concorsi letterari per l’infanzia, festival di teatro e storytelling, convegni sulla narrazione, rassegne spettacoli e corsi teatrali e musicali, con attenzione ai temi interculturali collaborando con Il Comune di Bologna e la Città Metropolitana, nonchè con numerose Istituzioni Pubbliche e private.
Dalla sua fondazione, nel 2000, ha inteso rivalutare la narrazione orale e valorizzare l’inventare fiabe come attività fondamentali alla crescita delle bambine e dei bambini. Il progetto ha prodotto la trasmissione radiofonica Il Polverone Magico in onda dal 2004 al 2015 su emittenti locali, nonchè laboratori teatrali e musicali realizzati in scuole e Centri Sociali di Bologna.
Dal 2004 al 2012 ha realizzato un concorso letterario Oggi racconto io: la fantastoria del popolo migrante che ha coinvolto centinaia di ragazzi, famiglie e adulti, nella scrittura di fantastorie, progetto che valgono a Youkali 3 medaglie dalla Presidenza della Repubblica. Nel 2012 il progetto è passato dalla dimensione provinciale a quella nazionale grazie al Ministero dell’Istruzione e alla collaborazione dell’ Associazione Italiana Biblioteche.
Dal 2004 ha ideato il progetto teatrale per fascia 3 e 6 anni Maga Rossina racconta… realizzandolo da allora spettacoli nei Comuni di Monzuno, Sala Bolognese, Anzola e nei Quartieri di Bologna Reno, Porto e S. Donato.
Dal 2004 al 2013 collabora all’organizzazione di manifestazioni culturali per Festa Internazionale della Storia e il Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica dell’Università di Bologna realizzando spettacoli, trasmissioni televisive e presentando per alcuni anni la manifestazione “Il passamano per San Luca” grazie all’attrice Simona Sagone.
Nel 2005 nasce la rassegna di lezioni spettacoli per la fascia 8- 12 anni Fiabe dal mondo in collaborazione con Sala Bolognese -replicata nei Quartieri Reno, S. Donato, Porto. Dal 2008 al 2012 Fiabe dal mondo diventa una rassegna provinciale parallela al concorso di fiabe.
Tra il 2008 e 2015 tiene corsi sulla lettura espressiva, la costruzione di radiodrammi e audiofiabe, di teatro e canto presso Istituti scolastici anche con il riconoscimento del MIUR Emilia Romagna.
Youkali ha creato negli anni numerosi spettacoli per il pubblico adulto sia di prosa che musicali, molti centrati su temi sociali tra cui ricordiamo Bertolt Brecht dell’amore e della guerra, Las Madres, dedicato alle Madres de Plaza de Majo e Per il pane la pace e la libertà dedicato alle partigiane del territorio di Bologna e Provincia.
Nel 2013 ha vinto il premio AMITIE’ per le creatività plurali – sezione teatro consegnato dal Comune di Bologna per lo spettacolo Le regole del migrare realizzato insieme al Coro Multietnico Mikrokosmos.
Dal 2012 Youkali è impegnata in un percorso di costruzione de Le vie delle fiabe europee. Il progetto Le vie delle fiabe ha prodotto tra il 2012 e 2014 quattro convegni realizzati a Bologna con ospiti di rilievo a livello nazionale.
Nel giugno 2013 realizza a Bologna il primo Festival di Narrazioni Interculturali per l’infanzia Le vie delle fiabe: percorsi interculturali
Dal 2013 al 2015 è stata partner del Progetto Europeo Comenius Regio Cahrs- Bologna guidato dal comune francese di Cahors realizzando laboratori e conferenze sull’uso del teatro per l’apprendimento attivo della storia.
Nel 2014 parte il progetto Media allo scoperto prima attraverso un bando LFA del Quartiere Saragozza e poi, nel 2015, come progetto di Cittadinanza Attiva finalizzato alla creazione di una redazione permanente di cittadini che lavorino sulla comunicazione di tutti i progetti di Cittadinanza Attiva avviati dal Comune di Bologna, verso la costruzione di una start up creativa autonoma sui temi della comunicazione.
Il 10 dicembre 2015 si avvia il progetto Portiamo a scuola la comunicazione di genere finanziato con i fondi dell’8 x 1000 della Chiesa Valdese.
*Youkali è l’isola inesistente immaginata da Kurt Weill nel 1933 durante l’Esilio in Francia, allorquando la sua musica era stata considerata “Musica degenerata” dal regime nazista.
•Portiamo a scuola la comunicazione di genere , seconda edizione
•Un nuovo corso di formazione gratuito per adulti di 70 ore; 4 seminari sullo stalking, 8 laboratori da realizzare in Scuole e Centri giovanili di Bologna per prevenire forme di violenza e abuso e vincere gli stereotipi di genere
•L’Associazione Culturale Youkali insieme a Tavola delle donne sulla violenza e la sicurezza nella città, UDI Bologna e al Circolo Arci Guernelli di Bologna, con la collaborazione di Radio Città Fujiko e di AICS, hanno ottenuto un finanziamento di 7.500 euro dalla Regione Emilia Romagna tramite il bando volto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere sulle annualità 2016/2017 ed è in attesa di un sostegno di 14.000 euro dalla Tavola Valdese tramite il bando 2016 per l’assegnazione dei fondi dell’8 x 1000 per realizzare il progetto Portiamo a scuola la comunicazione di genere 2.
•In continuità con il progetto chiuso il 31 dicembre 2016, Portiamo a scuola la comunicazione di genere 2 intende diffondere nell’ambito scolastico e dei centri di aggregazione giovanile di Bologna, azioni di empowerment relative alla consapevolezza della convivenza tra i generi attraverso l’elaborazione creativa del tema utilizzando gli strumenti della comunicazione massmediatica quali la radio, il web, i giornali (off e on line) per catturare l’attenzione dei giovani allievi rendendoli al contempo protagonisti attivi nel riconoscere e individuare forme attive e creattive di gestione dei conflitti, in particolare di genere.
•Mentre i formatori perseguiranno l’obiettivo primario di consentire ai ragazzi partecipanti ai laboratori scolastici di essere in grado di riconoscere i propri e altrui pregiudizi e stereotipi legati al genere e di acquisire sicurezza nell’uso di un linguaggio sessuato, specialmente quando si parla di professioni al femminile, al contempo promuoveranno la piena partecipazione dei giovani alla vita democratica cittadina, fornendo strumenti per l’acquisizione di competenze inerenti il funzionamento del linguaggio dei media.
•I laboratori scolastici già realizzati nel 2016, così come i nuovi laboratori che a breve verranno attivati negli istituti scolastici che ne faranno richiesta, mirano in ultima analisi a incentivare l’innovazione sociale anche attraverso l’autonoma formazione tramite l’utilizzo di piattaforme e ambienti digitali, software liberi e open source. La diffusione dei risultati dei laboratori tramite il blog Mediaalloscoperto.it e la pagina facebook dedicata al progetto (Portiamo a scuola la comunicazione di genere), consente ai giovani partecipanti di attivare una formazione tra pari agendo essi stessi da moltiplicatori dei risultati.
•Il 13 marzo 2017 verrà avviato un nuovo corso di formazione per adulti di 70 ore che si terrà a Bologna presso il Circolo Arci Guernelli di V. Gandusio 6 per realizzare il quale l’Associazione Culturale Youkali si avvarrà della stretta collaborazione di esperte dell’Associazione Tavola delle donne sulla violenza e la sicurezza nella città e di UDI sezione di Bologna, come anche di giornalisti e blogger.
•Il Corso di formazione, come il precedente, è diviso in due parti: Riconoscere e prevenire le forme di violenza e abuso nelle relazioni di genere e Comunicazione di genere.
•I volontari ammessi alla formazione saranno scelti tra: studenti universitari, giovani sotto i 35 anni in cerca di occupazione, disoccupati di lungo corso (in particolare over 45), in cerca di riqualificazione, onde offrire loro occasione di specializzarsi e/o riqualificarsi nel campo della comunicazione sociale. Si preferiranno candidati con formazione umanistica.
•Attraverso la formazione degli adulti intendiamo porre le basi per la realizzazione di nuovi progetti all’interno delle scuole che uniscano la tematica della gestione del conflitto, con la produzione di spot, video, radiodrammi, articoli giornalistici, spettacoli teatrali.
•Grazie al personale già formato nel corso della prima edizione del progetto, sostenuto da Tavola Valdese, tra ottobre e novembre 2016, sono già stati realizzati 2 laboratori scolastici presso la Scuola secondaria di I grado di Sant’Agata Bolognese e, grazie ai finanziamenti regionali, altri 2 laboratori gratuiti di 8 ore sui temi dello smascheramento degli stereotipi di genere verranno realizzati entro maggio 2017 in altri Istituti Secondari di I e II grado di Bologna e Provincia che ne faranno richiesta. E’ prevista inoltre l’attivazione di 4 seminari di 2 ore sullo Stalking che saranno tenuti dall’Avvocata Nicoletta Macrì di Tavola delle donne.
•A beneficiare del nuovo progetto, così come nel corso della prima edizione, non sono solo gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado, ma gli stessi volontari in gran parte giovani o disoccupati di lungo corso che, attraverso il percorso di formazione, acquisiscono nuove competenze. Conclusa la formazione, ai corsisti viene offerta l’occasione di una sorta di tirocinio con un rimborso orario, durante il quale sperimentare immediatamente le strategie definite nel workshop finale confrontandosi con una classe di giovanissimi sotto la supervisione dei tutor esperti.
•Qualora il progetto riceva, a settembre 2017, un sostegno dai fondi dell’ 8 x 1000 della Tavola Valdese, verrà completata la formazione degli adulti con i moduli laboratoriali previsti tra settembre e novembre 2017; verranno realizzati altri 2 laboratori di 10 ore presso centri giovanili; un laboratorio teatrale di 20 ore e altri 3 laboratori di 8 ore su tematiche di genere presso istituti scolastici che si renderanno disponibili ad accoglierli.
•Già nel 2016 è stata attivata una Palestra digitale, attraverso il sito web Mediaalloscoperto.it, per la condivisione dei materiali e buone pratiche prodotte sia dai formatori volontari che vanno nelle scuole, che dagli allievi degli Istituti Scolastici e centri giovanili. La palestra digitale attualmente bisognosa di implementazione, è un utile strumento per tenere traccia delle esperienze formative.
•E’ prevista anche un’azione di valutazione trasversale all’intero progetto che consentirà aggiustamenti in itinere della progettualità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
•A breve verrà attivata una campagna di crowdfunding per sostenere il progetto dal basso assicurando i finanziamenti necessari al suo completamento anche nella peggiore delle ipotesi che i co- finanziamenti richiesti non vengano accordati. Il crowdfunding consentirà a chiunque creda nelle metodologie attivate dalle associazioni proponenti, di donare anche pochi euro perché possa essere portata avanti la necessaria campagna contro gli stereotipi di genere partendo dall’educazione dei più piccoli.
INFO@YOUKALI.IT
•VIA DEL PRATELLO 97 SCALA B, 40122 BOLOGNA 051 8493013
*
 - Società
- Società
Bla, bla, bla, una questione di dignità
Se per ‘dignità’ intendiamo quel rispetto che l'uomo, conscio del proprio valore sul piano morale, deve sentire nei confronti di sé stesso e tradurre in un comportamento e in un contegno adeguati, possiamo dire che la politica è fuori come un ombrellone da spiaggia, cui il sole di questa estate infuocata deve aver confuso non solo le idee ma anche la cognizione della realtà. Perché la mancanza di rispetto di se stessi equivale a un ‘non valore’ e non a un ‘plusvalore’ come qualcuno pensa di far passare nell’ignoranza dei molti che, al contrario del suo significato intrinseco, spaccia (leggi spacciatori di vergogna) come comportamento responsabile, misurato ed equilibrato che si dovrebbe tradurre in rispettabilità e decoro. Niente affatto, siamo piuttosto dalla parte opposta della decenza, per cui la traduzione che più si adatta è l’indegnità, la scorrettezza, la disonestà, l’arroganza.
Per non dire della bassezza d’intenti, la volgarità dei linguaggi, la villania e la maleducazione dei molti, dei tanti parlamentari, sindacalisti, giornalisti, e di quanti ‘leccano il culo’ a tutta quella risma di irrispettosi della Costituzione e della Democrazia. Insomma di quanti senza contegno parlano (bla, bla, bla) senza dire niente ‘in nome del popolo italiano’ e ‘per il bene dell’Italia e degli Italiani’. Di quanti ormai sono saliti sul carro dei vincitori senza sapere neppure se l’ ‘orgoglio’ nazionale di cui parlano li riguarda in prima persona o se li stanno solo fregando a più non posso. Il fatto eclatante è che ‘gli piace’, e godono quando qualcuno se la prende coi gay, con le lesbiche, con gli immigrati, i clandestini, e con tutti gli ‘altri’ che non sono loro. Ma forse hanno dimenticato che arriverà anche il loro momento (storia docet), quando caduta la maschera si ritroveranno fottuti e contenti.
Se invece con il termine dignità, ci si riferisce al valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni uomo/donna, in quanto persona, è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella necessità di liberamente mantenerli per sé stesso e per gli altri e di tutelarli nei confronti di chi non li rispetta, ecco che entriamo in ambito socio-legislativo ancor prima di quello culturale-spirituale che alla fin fine rende il termine degno di rispetto. Ciò per quanto il ‘rispetto’ si vuole sia retaggio di un ordinamento pre-costituito sancito dal ‘diritto giuridico’ in vigore, le cui leggi hanno dato forma a quell’ ‘ordinamento’ che non trova più alcun riscontro nell’ampio spettro dell’universalità: per cui ‘ogni uomo è libero’ nell’ambito della globalità dello sviluppo storico-sociale in stretta relazione con il pensiero filosofico dominante.
Concettualmente paritetico di quel processo di conversione che ha trasformato il ‘positivismo relativo’ del secolo scorso, nel ‘pensiero negazionista’ contemporaneo, in cui il ‘tutto’ è verosimilmente sostituito dal ‘nulla’, di per sé non uguagliabile al ‘vuoto cosmico’ da riempire di pericolose ideologie. Bensì un ‘nulla’ antropico, cioè relativo all’analisi degli assetti organizzativi umani conseguiti, ovvero allo studio (scientifico) di quei processi che nel corso del ‘tempo’ hanno condotto alla formazione degli assetti evolutivi comunitari che oggi trovano nell’unione delle nazioni una ragione di sopravvivenza e di evoluzione all’interno di una cooperazione fattiva che nell’unità fanno un ‘pieno’ di energie da spendere all’insegna della solidarietà e della pace duratura.
Come ci si rapporta alla situazione politico-giuridica in una realtà democratica consistente nella possibilità di costituire, modificare o estinguere un ‘rapporto giuridico’, attraverso un ‘atto’ che non sia al tempo stesso la configurazione di un qualcosa di ‘preconcetto’ e/o ‘insostenibile’ che tuttavia permetta una risoluzione del problema suddetto? A una siffatta domanda, previene Emmanuel Levinas nel suo “Gli imprevisti della storia” (*), il quale intravede una leggittima linea ideale equivalente a un salto nel buio, poiché: “Questo mondo che trascende il mondo in cui siamo immersi, non è anche al di là di questa comprensione specifica che noi abbiamo dell’individuale, dello storico, dell’umano, e in cui il reale si presenta non solo come una concatenazione di proposizioni ma come un’esistenza che vale e che pesa”.
Ma di quale ‘dignità’ parliamo quando si parla di ‘rispetto? Le risposte sono delle più variegate quando tutti se ne riempiono la bocca, trascurando che parlare di ‘rispetto’ è una questione metodologica basata sul riconoscimento dell’uguaglianza, sul consenso individuale alla reciproca fiducia e all’equilibrio sociale. Nel dibattito su quelli che definiamo ‘valori morali’ e se questi sono relativi o assoluti (?), la risposta di gran lunga più motivata è ‘che sono relativi’: “Se molti sono i modi ragionevoli in cui gli esseri umani possono organizzare la loro vita – scrive Maurizio Ferraris (*) – resta che ce ne sono alcuni che sono sicuramente inaccettabili.” Ma se è altrettanto scontato che il ‘relativismo’ presenta dei limiti, la cui soglia oggi è stata abbondantemente superata, è altresì realistico che persi nei meandri dell’attuale complessità sociale, multietnica e multiculturale, ci si pongano alcuni interrogativi fondamentali. Uno dei quali riguarda il ‘senso del proprio agire’ nell’ambito della proprie scelte, che non può più essere solo individuale ma riguarda la società nella sua percezione globale o comunque comunitaria, che va esaminata nel suo insieme.
Un’analisi approfondita diviene pertanto necessaria se, come in questo breve saggio, si vogliono individuare gli strumenti di una possibile ricognizione del ‘rispetto’ in seno all’etica morale e l’intrinseca criticità di merito che l’accompagna. Acciò, e nel migliore dei casi, è necessario tornare al passato e rileggere il cartesiano “Discorso del metodo” (René Descartes 1596-1650) (*), lo strumento per eccellenza che più ci aiuta a comprendere i termini e i limiti, pur nella logica della scoperta scientifica, vuoi filosofica che sociologica del pensiero libero concettuale, è questo ancora oggi considerato un caposaldo della liberalità civile.
Un testo tra i “..più rivoluzionari su cui meditare, in quanto il suo autore aveva perfettamente compreso che le vere rivoluzioni cominciano nel proprio intimo e non nel cambiamento delle cose, ma nella riforma di se stessi” – scrive Giovanni Reale nella Prefazione al testo. (*). Una ‘questione di metodo’ dunque, la cui applicazione restituisce al ‘rispetto’ una sua posizione prioritaria all’interno delle ‘virtù etico-morali’, qui individuata in tre passaggi essenziali che ben definiscono la relativa prova scientifica: ‘Metodo del riconoscimento dell’uguaglianza’, ‘Metodo del rispetto civile’, ‘Metodo del consenso basato sulla fiducia e la temperanza’.
1) Metodo del riconoscimento dell’uguaglianza
Volendo significare l’insieme delle varianti insite in una probabile ‘anatomia del rispetto’ qui presa a soggetto, è obbligo avvalersi di discipline diverse (antropologia, sociologia, psicologia, etica e filosofia) che, in qualche modo ed entro i limiti consentiti, permettono di individuare quegli elementi sostanziali alla metodologia della ricerca, da osservare nell’ottica della ‘volontà’ più volte espressa dalla società, di risolvere quelle che sono oggi considerate ‘problematiche sociali’. Una volontà attualmente evasiva se esaminata nella prospettiva pragmatica delle politiche giuridiche (pari opportunità, coppie di fatto ecc.) ad essa inerenti.
Alla luce dei mutamenti sopravvenuti nella società e delle nuove realtà ideologiche, la costruzione etico-morale del ‘rispetto’, pur impostata sulle basi antropologiche dei ‘riti di riferimento’ come la tradizione e la cultura, la religiosità e la sacralità degli affetti, si è rivelata da qualche tempo a questa parte, inaspettatamente anacronistica, mostrando le sue crepe profonde. Segni di una erosione che non l’ha risparmiata da risentimenti diffusi e punti di criticità, sia per i suoi aspetti discordanti (quanto inevitabili), che ne hanno limitato il ‘riconoscimento’ configurativo all’interno di una specifica ‘tipologia virtuosa’; sia in ambito famigliare che educazionale, formativa ecc., che da sempre vieicolano le cosiddette ‘differenze di genere’.
In qualità di ‘soggetto sociale’, infatti, la rilevanza delle ‘differenze di genere’ ha dato luogo a un fenomeno collettivo d’interesse antropico che un ‘liberalismo’ metodologicamente preconcetto, attribuisce a forme di ‘società’ e di ‘economia’ migliori di sempre, neppure fosse l’‘archetipo’ di una modernità immaginaria quanto inafferrabile e tuttavia possibile; nonostante i ‘comportamenti umani’, si siano gradualmente integrati con le nuove problematiche introdotte nella società, secondo le ripartizioni attuate dalla ‘psicologia sociale’ all’interno di discipline meglio diversificate come: ‘individuali’, ‘collettive’ e ‘comunitarie’ che comunque rimangono universali.
Ciò, per quanto l’esperienza esistenziale dell’individuo sociale (umano), pur nella sua identificazione e la sua irriducibile complessità, sia ancora oggi tutt’altro che scontata e in antitesi con una completa istituzionalizzazione, a causa dell’ ‘assenza o mancanza’ (anomia) di norme sociali specifiche che, entro certi limiti, risultino appropriate al comportamento dell’individuo stesso nei confronti degli altri e, pertanto, volte a costituire una specifica ‘identità’ nel processo educativo e di ‘socializzazione’ (paideia) in atto. Onde per cui, il ‘riconoscimento’ è il primo passo necessario per il superamento relativo alle ‘differenze di genere’ e la definitiva attuazione del processo di uniformazione dell’ ‘ethos politico’ nell’ambito della riorganizzazione sociale.
Se vogliamo, è a partire dalla ricerca dinamica del ‘riconoscimento’ che prende il via la giustificazione metodologica che si vuole qui perseguire: cioè, nell’individuare quei fattori relativi, intrinsechi della sfera della ‘personalità individuale’ e dell’ ‘identità collettiva’ in quanto ‘soggetti’ delle ‘differenze di genere’, ai quali pur ineriscono esperienze di rifiuto di ‘legittimazione’ e ‘approvazione’ di diritti più spesso negati. “Il riconoscimento dunque - scrive Mario Manfredi (*) – come obiettivo di un processo di piena responsabilità radicale verso i soggetti di ‘genere’ (umani e non), specialmente quando si confrontano posizioni di potere da una parte, e di vulnerabilità dall’altra. Soprattutto perché la responsabilità che ne deriva, si fa carico anche di realtà remote nello spazio (uomini e territori lontani) e, nel tempo (l’umanità futura)”.
Certamente la modernizzazione dei costumi e delle idee non è approdata a un risultato integrale ed esaustivo perché si è dovuta misurare con fattori limitanti, con istanze individuali e sociali di tipo politico, economico e imprenditoriale non sempre confacenti al ‘rispetto sociale’. Non a caso il sociologo Zigmunt Bauman (*) ha molto insistito nella ricerca instancabile di quell’ ‘identità’ che è poi “..divenuta precaria come tutto nella nostra vita”, essendo venuto meno il vincolo temporale nei rapporti interpersonali a causa di dialoghi preferibilmente a distanza, pause troppo lunghe di riflessione, richieste di chiarimenti mai espletate e sconfinamenti in territori diversi.
Sconfinamenti che hanno dato seguito al senso di smarrimento, incapacità di introspezione, inconsapevolezza dell’attenzione, che ha colpito tutti, uomini e donne indistintamente, trascinandoli in un processo di sterilizzazione dell’immagine sedimentata di “ciò che è stato” (assenza di memoria storica), per approntare una domanda tipo: “chi sono io oggi?” (mancanza di identità futura), che ha portato l’individuo a discernere nella “paura liquida” che affligge l’intera comunità umana, segno evidente di una collettività in dissolvimento che non contempla in sé alcuna risposta propositiva. Sebbene si metta ancor più in evidenza il sorgere di un nuovo ‘problema’ – individuato da Bauman – che va ad aggiungersi ai tanti altri che una ‘società liquida’ quale è quella in cui viviamo, che all’apparenza sembra impossibile contestualizzare, se non andando a “...ricercare un modello ‘ultimo’, migliore di tutti gli altri, perfetto, da non poter essere ulteriormente migliorato, perché niente di meglio esiste né è immaginabile”.
“Ma non basta ‘concettualizzare’ una identità qualsiasi – ha inoltre asserito Bauman – bisogna puntare sulla ‘identità sociale’, radicale e irreversibile, che coinvolga gli ordinamenti statali, la condizione lavorativa, i rapporti interstatali, le soggettività collettive, il rapporto tra l’io e l’altro, la produzione culturale e la vita quotidiana di uomini e donne”. Quasi si fosse davanti a una catastrofe considerata inevitabile; conforme cioè all’intraprendenza della ‘natura umana’ di fronte a una forzata convivenza democratica e alla mancanza di un comportamento ‘etico’ austero che non lascia comprendere e non giustifica le proprie e le altrui convinzioni.
Una chiave di investigazione su base teorica questa, che non consente qui di considerare la “trasformazione del presente” in atto, cui volenti o nolenti assistiamo, in quanto “costruzione di senso” attraverso l’utopia di un agire solo apparentemente incondizionato, anche se spesso utilizzato come interfaccia di nuove aggregazioni dell’esperienza fenomenologica che, si vuole, portino a una “ridefinizione critica del reale”. Un argomentazione che a sua volta aveva appassionato Alberto Melucci (*), ritenuto il ‘sociologo dell’ascolto’, aperto ai temi della pace, delle mobilitazioni giovanili, dei movimenti delle donne, delle questioni ecologiche, delle forme di solidarietà e del lavoro psicoterapeutico.
“Sono convinto – scrive Melucci – che il mondo contemporaneo abbia bisogno di una sociologia dell’ascolto. Non una conoscenza fredda, che si ferma al livello delle facoltà razionali, ma una conoscenza che considera gli altri dei soggetti. Non una conoscenza che crea una distanza, una separazione fra osservatore e osservato, bensì una conoscenza capace di ascoltare, che riesce a riconoscere i bisogni, le domande e gli interrogativi di chi osserva, ma anche capace, allo stesso tempo, di mettersi davvero in contatto, con gli altri. Gli altri che non sono solo degli oggetti, ma sono dei soggetti, delle persone come noi, che hanno spesso i nostri stessi interrogativi, si pongono le stesse domande e hanno le stesse debolezze, e le stesse paure”.
2) Metodo del consenso individuale alla fiducia
La consapevolezza del ‘rispetto’ è quindi una questione metodologica basata sul riconoscimento dell’uguaglianza che, ai fini di una valida prerogativa di senso è tuttavia carente di un supporto solido che lo sostenga e che solo una certa dose di altruistico ‘consenso’ può, in certo qual modo, convalidare. Cioè l’accettazione di una fattiva ‘uguaglianza nella diversità’ necessaria per una convivenza senza conflitti, in cui vengano riconosciute e accettate le differenze di razza, di colore, le diversità di status sociale, i comportamentali degli individui e i diversi ruoli che ognuno si trova ad occupare, in ragione di favorire le relazioni interpersonali e intergovernative, in una società sempre più rivolta alla cooperazione tra i popoli e gli stati, dedita agli scambi reciproci di idee, informazioni, conoscenza, tecnologia ecc..
Altresì nel ‘rispetto’ individuale e nel confronto fattivo con le diverse posizioni dell’altro/a, e cioè nell’investire il proprio ‘consenso’ nelle scelte della/e partnership individuata come consone alla qualità della vita che si vuole o si vorrebbe attuare, ponderata sulla ‘fiducia’ e comunque nel ‘rispetto’ delle ‘differenze individuali’ (genetiche, pedagogiche, psicologiche), dell’estrazione pedagogico-socio-culturale, formativa, nonché delle diverse disposizioni comportamentali acquisite, senza cercare di manipolarle; così come di non giudicare le scelte e le opinioni dell’altro/a in modo sommario perché considerate minoritarie che rasentino una qualche forma di razzismo.
Per quanto, in ambito giuridico il ‘rispetto’ si affacci alla soglia del ‘diritto’ di ogni individuo di avere un suo modo di pensare, di esprimere la propria opinione, di sentire, di agire e persino di scegliere i suoi gusti e le sue preferenze di vita, di pretendere che nessun altro possa permettersi di obiettare o decidere al suo posto; nella specifica tipologia delle ‘scienze umane’ si tratta di offrire/accordare una relazione consensuale basata sul ‘consenso’ che porti all’ascolto non valutativo, dove si concentra la comprensione dei sentimenti nel rapporto emozionale e/o intellettuale di merito e di partecipazione ai bisogni fondamentali degli altri.
Nell’uso comune è detta ‘empatia’ l’attitudine ad essere completamente e/o parzialmente disponibili verso gli altri, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri individuali, pronti ad offrire la piena attenzione al processo di comunicazione, accesso all’informazione e partecipazione alla cooperazione attiva ‘non coercitiva’ che, secondo il ‘metodo del consenso’, non significa ‘unanimità’ di intenti e di voleri di singoli individui o del gruppo di appartenenza, bensì di funzione espletata democraticamente cui la maggioranza dei soggetti avrà acconsentito secondo la propria onestà intellettuale. Se non c’è l’onesta volontà di venirsi incontro, il metodo del consenso non funziona, bensì si rende più che mai necessario anche nella difesa di quella ‘privacy’ che ostinatamente promulghiamo come visione utopistica di una realtà che non è più tale, se mai lo sia stata.
Acciò, dare oggi il ‘consenso’ all’utilizzo dei propri dati personali che diventano così di pubblico dominio può essere un modo (facendo attenzione) di aprirsi al mondo degli scambi e della collaborazione reciproca a livello internazionale; così come mettersi in gioco sul web significa la ‘volontà’ di ampliare la propria cerchia di conoscenze, e perché no di fare nuove amicizie e così abbassare il tasso dilagante di sentirsi abbandonati, sotto l’egida del “non siamo soli”, necessaria ai fini della reciprocità sociale che ci vede sempre più affetti dalla solitudine.
3) Metodo del consenso alla temperanza comunitaria
L’approccio qui espletato equivale a ‘farsi un’opinione’ sul merito se oggi il ‘rispetto’ sia o no essenziale nei rapporti umani (?) Se la domanda serve di fatto a chiarificare un problema etico-teorico, la risposta non può che essere: «sì, è essenziale», ma è come asserire l’esistenza di un 'dualismo’ insopprimibile per cui la risposta non è affatto univoca. Gli ultimi avvenimenti di cronaca ben lo evidenziano ponendoci di fronte situazioni insostenibili quanto sconvolgenti, riferite all’assoluta mancanza di tolleranza, reciprocità, liberalità e democracità che superano ogni limite di sopportazione e comprensione umana. Per quanto intraprendere guerre fratricide e stermini di massa, privazioni e allontanamenti dagli originari territori di appartenenza, innalzare muri ai confini e barriere di chiusura al libero accesso, più spesso eretti in nome di questa o quella ‘supremazia’ territoriale-supernazionale in cui domina l’intransigenza e la severità di giochi di potere, non sembra portare a una risoluzione dei problemi.
Tanto meno risultano determinanti i molti tentativi di ‘risoluzioni di pace’ affatto conciliabili e, sempre più spesso, avanzati in nome di una diversità etico-morale del tutto confutabile, di cui sono andate perdute quelle che sono le ‘ragioni primarie’ di una possibile convivenza fra i più deboli e i diseredati, venendo così a mancare quel ‘rispetto’ e quell’indulgenza necessaria che mettono a rischio la sopravvivenza. Ma non è già il falso ‘moralismo intelluale’ dei pochi ad erigere le barriere che oggi delimitano le frontiere degli stati e i campi d’azione dei politici del malaffare, quanto la mancanza di ‘temperanza’ e l’indifferenza fraudolenta dei molti a derubricare il sistema economico-produttivo e la convivenza dell’illegalità giuridica e l’illegittimazione sociale.
“Di che cosa sia il moralismo si può certo discutere – scrive Stefano Rodotà (*) – ma la critica non può trasformarsi in pretesto per espellere dal dibattito pubblico ogni barlume di etica civile. (..) Contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni decise ad applicarle. Ma serve soprattutto una difusa e costante intransigenza morale, un’azione convinta di cittadini che non abbiano il timore d’essere definiti moralisti, che ricordino in ogni momento che la vita pubblica esige rigore e correttezza.” Il merito di una tale affermazione si gioca su quei comportamenti resi affidabili dal rapporto fiduciario che in illo tempore è stato stabilito con la natura e successivamente tra le diverse comunità interessate a limitare i rischi delle carestie e della fame, quantomeno coinvolte nella volenterosa sopravvivenza della specie. In una società complessa come quella in cui siamo chiamati a vivere (o sopravvivere dipende dai punti di vista), la crisi nella ‘fiducia’ non riguarda solo chi viola la legge o non si adegua agli standard di vita diffusa, ma investe ogni ambito della vita socialee comunitaria.
“Di fatto – scrive Umberto Galimberti (*) – non possiamo prescindere dal ricorrervi (alla fiducia), perché degli altri, piaccia o non piaccia, non possiamo fare a meno. (..) Nei nostri comportamenti accordiamo di continuo una fiducia che intimamente non (sempre) nutriamo, perché non abbiamo alternative. Infatti, laddove le abbiamo, non esitiamo ad adottarle, affidandoci a tecnologie sempre più complesse”. D’altro canto “Il mercato indotto dalla sfiducia ha assunto proporzioni notevoli, sforzi e costi sono cresciuti in proporzioni, ma i risultati sono tutt’altro che esaltanti. Quanto più la nostra società si fa complessa, quanto più diventiamo gli uni estranei agli altri, tanto più siamo costretti a muoverci e a vivere tra attività, organizzazioni e istituzioni le cui procedure e i cui effetti non riusciamo a controllare e a capire. E perciò siamo inclini a crederci esposti a pericoli invisibili e indecifrabili, con conseguente perenne stato d’ansia facilmente leggibile nei tratti tirati e circospetti dei volti di ciasscuno di noi, (..) caratterizzati dalla precarietà dell’esistenza.”
“Allo stesso modo – accorda Galimberti – questa nostra ‘società del rischio’ è percorsa per intero da una sospettosità diffusa, dovuta ad un tasso troppo elevato di estraneità degli individui che compongono il sociale. A meno che non si debba pensare che la cultura dell’individualismo, tipica dell’Occidente, e la fruizione delle libertà individuali, che vantiamo nei confronti del resto del mondo, abbiano passato a tal punto il segno da rendere ciascuno di noi una singolarità così precaria che, oltre a fare esclusivamente i propri interessi, o forse proprio per questo, non sa più muoversi nel mondo se non all’interno di una cultura del sospetto. Questo mi pare il punto dove le nostre società sono le più vulnerabili, più di quanto vulnerabili le renda il terrorismo”.
In conclusione dignità e umanità sono quindi termini sovrapponibili collegati alla libertà dell'individuo di potersi esprimere senza vincoli di sorta. Ma il dibattito è ancora aperto, una risposta alla domanda “che cos’è il rispetto?”, è tuttavia possibile: cos’è se non un principio etico che ci restituisce la libertà di scegliere (libero arbitrio). Cos’altro, se non quella virtù morale che più d’ogni altra ci rende ‘umani’ (?) o, come scrive Alasdair MacIntyre, ‘Animali razionali dipendenti’ (*) e così poco sociali (?). “Che cos’è la dignità”, se non l’unico e sufficiente titolo necessario per il riconoscimento di un individuo è la sua partecipazione alla comune umanità.
Tutti gli uomini, senza distinzioni di età, stato di salute, sesso, razza, religione, grado d'istruzione, nazionalità, cultura, impiego, opinione politica o condizione sociale meritano un rispetto incondizionato, sul quale nessuna ‘ragion di stato’, nessun ‘interesse superiore’, la ‘razza’, o la ‘società’, può imporsi. Secondo Papa Bergoglio, “ogni uomo è un fine in se stesso, ugualmente riconosce dignità alle alte cariche dello stato, politiche o ecclesiastiche quando chi le ricopre agisca per il rispetto della dignità umana. Pertanto la ‘dignità’ non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli”.
La dignità nelle sue prime concezioni non aveva niente a che vedere con il significato odierno essendo al contrario collegata all'esercizio di una carica pubblica: un significato aristocratico, elitario questo che permane nel termine di ‘dignitario’ e che si oppone al senso democratico che caratterizza oggi questo termine. Così per Thomas Hobbes la dignità non è un valore intrinseco dell'uomo ma solo il ‘valore pubblico’ dell'uomo che gli viene attribuito dallo Stato. Così anche per Montesquieu la dignità denota la distinzione propria dell'aristocrazia e si oppone in questo senso all'uguaglianza, cui attribuisce come primo significato del termine ‘dignità’ quello di ‘funzione eminente di rispetto che si deve a sé stessi’. Nella filosofia morale di Kant la dignità viene riconosciuta a ogni uomo in quanto essere razionale e perciò degno di essere considerato sempre come fine mai come mezzo.
Ma non serve qui rifare la storia del pensiero filosofico morale o politico per comprendere dove stiamo andando (?), oggi si abusa fin troppo del termine e tutti ne parlano come se fosse merce di scambio e non il risultato delle azioni individuali tali da far perdere quella ‘dignità’ di cui parlano, quella ‘dignità’, in quanto ‘entità’ sovrasensibile, che contraddistingue l’essere umano, cioè tutti coloro che agiscono moralmente al di sopra delle determinazioni sensibili della sua volontà che deve essere libera dalle inclinazioni del desiderio e della carnalità (Kant), e che va oltre il rispetto della vita in quanto essa è, al contrario nel rispetto della libertà umana.
Sembra a voi che oggi tutto questo accada? Dov’è finita la ‘dignità’ di questa classe politica? Come del resto accade per le parole ‘cultura’, ‘rispetto’, ‘fratellanza’, ‘comunanza’, ‘pace’ e tantissime altre, anche per ‘dignità’ sembra arrivato il momento della sua cancellazione dal vocabolario della lingua italiana (e non solo). Ma va qui rammentato che è quando un popolo lascia decadere la propria lingua in uno stato confusionale e nel progressivo abbandono, è sintomatico il suo ravvicinato e devastante declino morale.
È questo che vogliamo? Se la risposta è sì, personalmente non sto dalla vostra parte. Urge fare qualcosa per arrestare il flusso di questo degrado incombente. Meditate gente!
Bibliografia di riferimento:
(*) Emmanuel Levinas “Gli imprevisti della storia” – Inschibbollet 2016
(*)Maurizio Ferraris, ‘Introduzione’ a “Morale” ed a “Uguaglianza” in Le domande della Filosofia - Gruppo Edit. L’Espresso 2012 ,
(*)René Descartes, “Discorso del metodo”, RCS Libri 2010
(*)Giovanni Reale, ‘Prefazione’ a “Discorso del metodo”, op.cit.
(*)Mario Manfredi, “Teoria del riconoscimento”, Le Lettere 2004
(*)Zigmunt Bauman, “Intervista sull’identità”, Editori Laterza 2008 e “Modernità liquida”, Editori Laterza 2011
(*)Alberto Melucci, "Rassegna italiana di sociologia", n.43 (2002), e in “Identita e movimenti sociali in una societa planetaria: in ricordo di Alberto Melucci”, Milano, Guerini Studio, 2003.
(*)Stefano Rodotà, “Il diritto di avere diritti”, Editori Laterza 2012
(*)Umberto Galimberti, “Fiducia”, in ‘Le grandi parole’ – Polizia Moderna 2010
(*) Alasdair MacIntyre, “Animali razionali dipendenti” – Vita e Pensiero Edit. 2001
E inoltre:
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)
Paul Ricœur, in J.-F. de Raymond, Les Enjeux des droits de l'homme, Paris, Larousse, 1988.
Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, 2013
Vatican insider Documenti (in La stampa , 2015)
Th. Hobbes, Leviatano, cap.X , in A.Schulman, Definizione della dignità[collegamento interrotto]
I. Kant, La metafisica dei costumi
*
 - Teatro
- Teatro
Algeciras tra Flamenco e Oriente a Santa Severa
Se non sarete ancora partiti per le vacanze l'invito è per il 12 agosto alle 21.30 nella magnifica cornice del Castello Di Santa Severa per lo spettacolo ALGECIRAS, TRA FLAMENCO E MEDIORIENTE della compagnia Algeciras Flamenco.
'La danza gitana e il baile flamenco', tratta da 'Gitanos' articolo di GioMa presente in questo stesso sito.
Delle danze più arcaiche che il popolo nomade dei Gitanos era in uso improvvisare davanti al fuoco nelle notti di luna piena, come quelle propriamente rituali d’origine mitologica, oggi non si hanno notizie certe o quantomeno attendibili. Chiunque abbia avuto modo di vedere un gruppo danzare può rendersi conto che quei passi scaltri e quei gesti ieratici non appartengono a un linguaggio coreografico bensì sono l’espressione tipica dell’improvvisazione, tali da rispondere al riproporsi di una tradizione che non è mai venuta meno, che rispondono a una creatività sempre nuova e inaspettata, mai sconsiderata, che definirei piuttosto impulsiva nella loro arcana fruibilità. Riguardo allo stile si può facilmente dire che la ‘danza gitana’ come il ‘baile flamenco’ abbiano derivato la loro forma attuale partendo da concezioni diverse pur non del tutto dissimili. Diversi appaiono infatti i modi di esecuzione rilevati in un gruppo ‘gitano’ da un altro ‘flamenco’, variabile di zona in zona che sia il Sud o un’altra regione della Spagna; così come diversi sono gli esecutori ‘bailadores’ che improvvisano indipendentemente in uno stile o l’altro, una ‘zambra’ eseguita in una ‘cueva andalusa’ o di eseguire un ‘flamenco’ sul ‘tablao’ di un baraccamento gitano.
Influenze di altre danze risultano circoscritte all’interno del corpus fondante sia del ‘flamenco’ che della ‘danza gitana’ entrambe relegate a una forma espressiva per una certo verso ieratica, dall’altra tipicamente sensuale. In entrambi i casi legate all’interiorità del ‘gesto’ o a tutta una serie di ‘passi’, (aspetto esteriore della danza), come anche di un atteggiamento amoroso e passionale (che rispecchi invece l’aspetto interiore della stessa). Per questo è necessario scrutare nell’abilità e nel rigore di chi danza e di chi interpreta la danza. È così che nella costante ricerca delle culture individuate si possono riscontrare influenze etniche diverse: indiane, ebraiche, egiziane ed arabe confluite nel ‘baile flamenco’come nella ‘danza gitana, tali da renderle ancora più suggestive agli occhi di chi l’osserva. Oltre alla ‘zambra mora’ dove non mancano testimonianze dell’uso delle nacchere, troviamo la ‘moresca’, il ‘bolero’, la ‘malaguena’, la ‘sevilliana’ tutte estrapolazioni della ‘zambra’ medesima di cui si rintracciano poche e superficiali alterazioni nel ‘flamenco’ma che, in qualche modo riprendono lontane danze rituali importate dalla lontana India (accertata terra d’origine dei Gitanos), sebbene lontana ormai da ogni contestuale riferimento per la perdita del significato rituale originale.
Il ‘baile flamenco’ propriamente detto si presenta come una sequenza composita di temi espressi con costante ed eccessivo straniamento, capace di una trasposizione che in qualche modo vuole essere manifestazione fisica dell’emozione appassionata e furtiva dell’emozione intimistica, espressa nella tremenda liturgia della danza. Manuel Barrios scrive: “Con il sudore che le scende per tutto il corpo, nel mentre ripete una, mille volte un passo; una mille volte trasfigura nel tremore del gesto che l’accompagna; come tenuto da un fantasma nell’esercizio della grazia e del dolore, con lo sguardo al suolo, con la bocca contratta in un sorriso sdegnoso, arcano”. Sì che viene da chiedersi perché di tutto questo, la cui risposta è racchiusa nel ‘duende’. Quel ‘duende’ che Garcia Lorca ha pienamente espresso nella conferenza “Teorya y fuego del duende” come principio spirituale e demoniaco dell’estetica gitana, che supera ogni esteriorità folkloristica ed imprime un’estrema purezza alla rappresentazione “..in cui le forme si fondono in un anelito superante le loro espressioni visibili”.
Una serata che mette in scena il fascino della molteplicità culturale depositata nel bacino del Mediterraneo.
Lo spettacolo è inserito all'interno del prestigioso Festival Sere D'Estate 2018.
Elisa Fantinel
Ufficio Stampa e Comunicazione
3358160566
www.elisafantinel.it
*
 - Cinema
- Cinema
Giornate degli Autori a Venezia
Rithy Panh, Joachim Lafosse e Stefano Savona alle Giornate degli Autori
di Vittoria Scarpa
24/07/2018 - La 15a edizione della sezione parallela alla Mostra si svolgerà a Venezia dal 29 agosto all’8 settembre, con 11 film in concorso, eventi speciali e Jonas Carpignano presidente di giuria.
Un ‘festival nel festival’ ricco e variegato, con proiezioni, eventi speciali, incontri con gli autori e momenti di riflessione sul cinema, la creatività e l’identità europea. E’ quanto promette la 15a edizione delle Giornate degli Autori, la prestigiosa e vitale sezione autonoma guidata da Giorgio Gosetti che si svolgerà parallelamente alla Mostra di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre 2018.
Undici i film in concorso, tra opere prime, seconde e di cineasti affermati, di cui la metà diretti da donne. Si partirà con Rithy Panh (candidato all’Oscar 2013 per L’immagine mancante e la sua coproduzione Cambogia-Francia, Les Tombeaux sans noms, che, attraverso la storia di un uomo che va alla ricerca delle tombe dei suoi familiari sterminati dai Khmer rossi, si interroga sul senso della memoria. Un western femminile è Continuer di Joachim Lafosse (Belgio-Francia), con Virgine Efira, primo adattamento letterario (dal romanzo omonimo di Laurent Mauvignier) per il regista di À perdre la raison e Dopo l’amore. La francese Claire Burger debutta ‘in solitaria’, dopo il premiato Party Girl, con C’est ça l’amour, racconto della vita di un uomo (interpretato da Bouli Lanners), che in assenza di sua moglie deve occuparsi di due figlie adolescenti in crisi. L’italiano Valerio Mieli torna invece a Venezia, dopo Dieci inverni nel 2009, con Ricordi?, una lunga storia d’amore raccontata attraverso i ricordi, ‘un fantastico viaggio nella testa di ciascuno di noi’ lo definisce il delegato generale Gosetti, con protagonista Luca Marinelli.
Tra gli altri titoli europei in concorso, l’austriaco Joy di Sudabeh Mortezai, viaggio verso la libertà di una donna nigeriana costretta a prostituirsi, e l’opera prima franco-svizzera P.E.A.R.L. di Elsa Amiel, ambientato nel mondo del bodybuilding femminile. Coprodotto dalla Francia è il brasiliano Domingo, tragicommedia surreale co-diretta da Clara Linhart e Fellipe Barbosa (Gabriel e la montagna); belgo-canadese è il film di chiusura, fuori concorso, di Nicole Palo, Emma Peeters, una commedia che tratta in modo originale e ironico il tema del malessere dei trentenni.
Tra gli eventi speciali si segnala l’omaggio al tedesco Alexander Kluge, classe 1932, di cui sarà presentato in prima mondiale Happy Lamento, un film che Gosetti definisce ‘sorprendente, spiazzante, giovanile’, e poi Il bene mio dell’italiano Pippo Mezzapesa, il titolo cipriota The Ghost of Peter Sellers di Peter Medak e la produzione tedesca Why Are We Creative?, in cui Hermann Vaske pone ad artisti, intellettuali, premi Nobel e Oscar, nell’arco di trent’anni, la stessa domanda: Perché siamo creativi?
La rivelazione dell’anno Stefano Savona, premiato a Cannes per il suo La strada dei Samouni, animerà una delle ‘Notti veneziane’ alla Villa degli Autori, pensate quest’anno come uno spazio informale di dialogo e riflessione con gli autori, tra cinema e racconti personali. I Miu Miu Women’s Tales di questa edizione sono diretti da Dakota Fanning, al suo esordio come regista, e da Haifaa Al-Mansour (La bicicletta verde).
Si ricorda infine che ad assegnare il GdA Director’s Award 2018 saranno i 28 giovani europei selezionati nell’ambito del programma 28 Times Cinema, realizzato in collaborazione con Cineuropa. Quest’anno la giuria sarà guidata per la prima volta da un regista italiano, Jonas Carpignano, candidato nazionale all’ultima edizione degli Oscar con A Ciambra.
Tutti i film in concorso delle Giornate degli Autori 2018:
Les Tombeaux sans noms - Rithy Panh (Cambogia/Francia)
C’est ça l’amour - Claire Burger (Francia)
Continuer - Joachim Lafosse (Belgio/Francia)
Domingo - Clara Linhart, Fellipe Barbosa (Brasile/Francia)
Joy - Sudabeh Mortezai (Austria)
José - Li Cheng (Guatemala/Stati Uniti)
Mafax - Bassam Jarbawi (Palestina/Stati Uniti/Qatar)
P.E.A.R.L. - Elsa Amiel (Francia/Svizzera)
Ricordi? - Valerio Mieli (Italia/Francia)
Three Adventures of Brooke - Yuan Qing (Cina/Malesia)
Ville Neuve - Felix Oufour-Laperrière (Canada)
Fuori concorso
Emma Peeters - Nicole Palo (Belgio/Canada)
Eventi speciali
As We Were Tuna - Francesco Zizola (Stati Uniti/Italia)
Dead Women Walking - Hagar Ben-Asher (Stati Uniti, in collaborazione con il Tribeca Film Festival)
Goodbye Marilyn - Maria Di Razza (Italia)
Happy Lamento - Alexander Kluge (Germania)
Il bene mio - Pippo Mezzapesa (Italia)
The Ghost of Peter Sellers - Peter Medak (Cipro)
Why Are We Creative? - Hermann Vaske (Germania)
Notti veneziane
‘Carta bianca a Stefano Savona’
Il teatro al lavoro - Massimiliano Pacifico (Italia)
I villani - Daniele de Michele (Italia)
L’unica lezione - Peter Marcias (Italia)
One Ocean - Anne De Carbuccia (Italia)
Miu Miu Women’s Tales
Hello Apartment - Dakota Fanning (Italia/Stati Uniti)
The Wedding Singer’s Daughter - Haifaa Al-Mansour (Italia/Stati Uniti)
PREMIO LUX 2018
Styx, Woman at War e The Other Side of Everything in lizza per il Premio LUX
di David González.
24/07/2018 - I tre finalisti viaggeranno per tutto il continente. Il premio verrà consegnato al Parlamento europeo il 14 novembre.
Today, at the Giornate degli Autori press conference, President of the European Parliament Antonio Tajani and Coordinator of the Committee on Culture and Education Silvia Costa announced the three films in competition for the 2018 LUX Prize. Styx by Wolfgang Fischer (Germany/Austria), The Other Side of Everything by Mila Turajlić (Serbia/France/Qatar) and Woman at War by Benedikt Erlingsson (Iceland/France/Ukraine) have been chosen from the ten-title Official Selection.
The three films – all of which coincidentally put female characters in the spotlight – and the topical themes that they address are a call to action in these difficult times. Styx is the odyssey of a solitary woman into the blue of the ocean, tackling the vital challenge of immigration and refugees. The Other Side of Everything marks the second time in LUX Prize history that a documentary has featured among the three finalists and is a tender portrayal of a woman, whose story tells the history of her country and Europe as a whole, from a tumultuous political past to the dangers of nationalism. Meanwhile, Woman at War is an energetic, environmental and feminist saga, a call for civil resistance to fight for and save nature from industrial greed and hegemony.
The announcement followed the screening at Casa del Cinema in Rome of last year’s LUX Prize winner, Sámi Blood by Amanda Kernell. The film, which was also awarded with the Audience Mention at the Karlovy Vary International Film Festival recently, was introduced to audiences by Silvia Costa.
The three films will become the core of the 2018 LUX Film Days in the autumn, and will be screened in more than 50 cities and festivals across 28 European countries. With each film subtitled in the 24 official languages of the European Union, every year an even wider audience will be able to discover these films and identify with the topics they address. This year’s LUX Film Days will again be organized by the European Parliament Liaison Offices, and thanks to the cooperation with Creative Europe, audiences throughout Europe can enjoy the unique cinematic events of simultaneous screenings: the movies will be screened in several theatres at the same time, connecting audiences via live interactive discussions with the filmmakers.
The winning title, voted for by the members of the European Parliament, will be further adapted for those with visual and hearing impairments. The winner – which will be announced on 14 November in Strasbourg – will also receive promotional support during its international release.
Lastly, this year’s participants in the 28 Times Cinema initiative will be attending LUX Prize events during the Giornate degli Autori at Venice, taking part in workshops and debates, before becoming the LUX Ambassadors in order to present the seventh edition of the LUX Film Days in their respective countries.
Diciannove in tutto i film della sezione dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale, che saranno valutati da una giuria presieduta dalla regista greca Athina Tsangari e composta dal regista americano Michael Almereyda, l’attrice iraniana Fatemeh Motamed-Aria, il critico cinematografico francese Frédéric Bonnaud, lo sceneggiatore egiziano Mohamed Hefzy, la regista canadese Alison Mclean e il regista italiano Andrea Pallaoro.
Tra i titoli selezionati, altri due film italiani, entrambe opere prime: Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, ‘un piccolo film che rischia di passare inosservato ma che, come Manuel l’anno scorso, potrebbe diventare un piccolo caso. Da non sottovalutare’, assicura Barbera; e La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi, dalla graphic novel del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare.
Dalla Francia arrivano i debutti di Mikhaël Hers (Amanda) e di Sarah Marx (L’Enkas). Il resto della selezione spazia in tutto il mondo, ma con una diffusa partecipazione europea: tra gli altri, La noche de 12 años, terzo lungometraggio dell’uruguayano Álvaro Brechner (una coproduzione Spagna/Argentina/Francia), l’opera prima autobiografica Deslembro di Flavia Castro (Brasile/Francia/Qatar) e il titolo kazako coprodotto da Polonia e Norvegia The River di Emir Baigazin.
Si segnalano inoltre l’israeliano Stripped di Yaron Shani (coprodotto dalla Germania), primo capitolo di una trilogia che svela, secondo Barbera, ‘un grande talento registico’, e il terzo film dell’autore palestinese Sameh Zoabi, Tel Aviv on Fire, una commedia satirica sui conflitti culturali tra israeliani e palestinesi, coprodotta da Lussemburgo, Francia, Israele e Belgio.
Infine, un cenno alla nuova sezione non competitiva Sconfini, dedicata alle opere senza vincoli di genere, durata e destinazione: da segnalare il nuovo film del fumettista Gipi, Il ragazzo più felice del mondo; Arrivederci Saigon di Wilma Labate, l’incredibile storia di una girl band in tour in Vietnam durante la guerra; e l’extended cut (189 minuti) di The Tree of Life di Terrence Malick.
I film della selezione Orizzonti 2018:
Sulla mia pelle - Alessio Cremonini (Italia) (film d’apertura)
Manta Ray - Phuttiphong Aroonpheng (Thailandia/Francia/Cina)
Soni - Ivan Ayr (India)
The River - Emir Baigazin (Kazakistan/Polonia/Norvegia)
La noche de 12 años - Álvaro Brechner (Spagna/Argentina/Francia)
Deslembro - Flavia Castro (Brasile/Francia/Qatar)
The Announcement - Mahmut Fazil Coşkun (Turchia/Bulgaria)
Un giorno all’improvviso - Ciro D’Emilio (Italia)
Charlie Says - Mary Harron (Stati Uniti)
Amanda - Mikhaël Hers (Francia)
The Day I Lost My Shadow - Soudade Kaadan (Siria/Libano/Francia/Qatar)
L’Enkas - Sarah Marx (Francia)
The Man Who Surprised Everyone - Natasha Merkulova, Aleksey Chupov (Russia/Estonia/Francia)
Memories of My Body - Garin Nugroho (Indonesia/Australia)
As I Lay Dying - Mostafa Sayyari (Iran)
La profezia dell’armadillo - Emanuele Scaringi (Italia)
Stripped - Yaron Shani (Israele/Germania)
Jinpa - Pema Tseden (Cina)
Tel Aviv on Fire - Sameh Zoabi (Lussemburgo/Francia/Israele/Belgio)
PALIĆ 2018
Neil Young • Programmatore, EFF Palić
‘L'idea è di rispondere a ciò che sta succedendo’ di Bénédicte Prot
23/07/2018 - Cineuropa ha incontrato il nuovo programmatore di EFF Palić, il critico cinematografico britannico Neil Young, per parlare dell'identità del festival.
Starting this year, for the 25th edition of the European Film Festival Palić, film critic Neil Young (The Hollywood Reporter, Sight & Sound, Tribune), also the former director of the Bradford International Film Festival and a consultant for such events as the Viennale, has been called upon to bring his distinctive eye and enthusiasm for fresh, daring, surprising offerings to two different programmers: the competitive Parallels and Encounters section, which gathers together Central and Eastern European films ‘touching on political and social topics in accessible and illuminating ways’, in Young's words, and Young Spirit of Europe, which screens movies in an open-air theatre and takes the public on a trip through a selection of ‘experimental, avant-garde, offbeat, underground and unclassifiable cinema from all over the continent’.
Cineuropa: What brought you to Palić? How would you describe the identity of the festival?
Neil Young: I first came here as a jury member in 2011. At the time, I didn't know much about Palić or Subotica in terms of culture, etc – although I had been interested in the ex-Yugoslavian area ever since I reviewed Bread and Milk by Jan Cvitković [who has a film here, Out of Competition, The Basics of Killing) back in 2001 at Tallinn, which took me to the Ljubljana Festival, which then led me to meet Serbian people, etc – but I've been here pretty much every year since then, and I've learnt more about the area.
Over the last 25 years, Palić has gradually developed as a film festival, of course, but in the last seven years, this part of the world has become a focus internationally, as a kind of geopolitical frontline between the EU and the non-EU. In 2011, the Hungarian border, just a few kilometers away from Subotica, was basically a metal pole that you went through – I remember an old lady cycling through – but as it became a key point where lots of migrants and refugees were crossing into Europe, now it's like a fortified military encampment, and ‘Fortress Europe’ is the new catchphrase, if you listen to people like Austrian Chancellor Sebastian Kurz. So Palić is a film event, but it is also part of this region, and you cannot ignore the fact that there are things happening that we are now at the epicenter of, which of course culture has to respond to.
Parallels and Encounters is in fact dedicated specifically to the Central and Eastern European film industries.
We are actually talking about a gigantic area extending from, let's say, Slovenia and the Czech Republic to Vladivostok – so that's half of Eurasia there, and in this gigantic area, we also decided to include Turkey. So diversity is the key word here. In this spirit, this year, we have selected three short films in the section, which hadn't been done before, as well as two documentaries. The idea is, again, to respond to what is going on in the world of cinema. What the artists do can be very different, from Slovenia to Murmansk, and funneling that into a limited number of programmers, that is the challenge – but if there are interesting artists making short films or documentaries [such as Radu Jude with The Dead Nation, which is the final film in the program, in agreement with Miroslav Mogorović, the other selector for the program, I'm choosing to respond to that. If the audience, in turn, is receptive, next year I might add some more short films. It's all about adjusting the balance and trying things. With a festival of this size, you get direct feedback, so if the audience don't like it, they will tell you.
The bold and surprising qualities of both of your programmer suggest that you are keen on bringing something new to the table. Is there a certain direction you would like to see the sections you are curetting take?
Obviously, there is a certain degree of autonomy for each programmer, but we have to work within the structure that the festival has developed over the years, as a team, also bearing in mind the fact that there are a dozen sections which are catering to different audiences – again, it's a very diverse festival – and that you have to work with them in mind, and think of the kind of audience that you can develop for the films. The movies that Nenad Dukić is showing in the evening at the big outdoors Summer Stage, which is beautiful, are mainly seen by local people and some holidaymakers, while obviously I get a very different audience at 10pm at the outdoors screenings showing more avant-garde, experimental cinema. What we want to do is keep that diversity and extend it, to get even more of everybody.
KARLOVY VARY 2018
Adele Tulli • Regista
‘Miro a generare prospettive per contrastare le narrative eteronormative’ di David González
17/07/2018 - KARLOVY VARY 2018: Abbiamo incontrato la filmmaker italiana Adele Tulli, che ha vinto l'Eurimages Lab Project Award a Karlovy Vary con il suo progetto Normal
The Karlovy Vary International Film Festival’s industry events included the Eurimages Lab Project Award selection once again this year, boasting projects with concepts that go beyond traditional film methods and are based on international cooperation. A €50,000 prize was bestowed upon the project by Italian filmmaker Adele Tulli, entitled Normal and produced by FilmAffair, and depicting a journey through gender norms in contemporary Italy. We met up with her to discuss the film, still in the making.
Cineuropa: What is at the core of your project? What are its origins?
Adele Tulli: I began this project as a piece of PhD research four years ago. At the time, while the Italian Parliament was discussing several progressive issues such as gender education in schools and gay civil unions, the very word "normal" became omnipresent within the national public debate: it was being used by both the conservative groups encouraging the protests against the bills, and the organisations defending and promoting them. Both sides were somehow involved in defining polar-opposite ideas of what counts as "normal" – which gender roles and sexual preferences are worthy of a respectable social identity. My intention with the film was to articulate some of the thoughts and ideas regarding the everyday practices and routines that establish what is acceptable group conduct in terms of gender and sexuality. By sketching a portrait of the ritualised performance of femininity and masculinity during ordinary interactions, Normal looks at the daily spectacle of gender normativity through a slightly distorted yet intimate lens, exploring the contradictions and struggles that populate our existences, as we have to conform to society’s expectations.
How do you think your film will respond to the current issue of the representation of gender in art, and in cinema in particular?
The representation of gender in art and cinema has generated the most challenging, thought-provoking and revolutionary approaches as well as the most normative and even offensive ones. I think my film does not intend to offer any clear-cut responses, but rather aims to raise critical questions about how we construct and inhabit our identities as females and males, and what the internalized behaviors’, gestures, attitudes, roles and expectations are for each gender. Essentially, the film investigates the complex dynamics that shape people’s desires and identities, and it attempts to do so by using cinema as a form of art that can interrogate and challenge reality, rather than simply representing it.
You are one of two female professionals behind this project. Will the female experience be highlighted in it particularly?
For me, being a female director does not equate to having a specifically ‘feminine’ point of view, which is necessarily antagonistic to that of a male colleague. I do not believe in anything ‘essentially’ feminine or masculine. I think we need to fight in order to have more films directed by women simply because opportunities are not the same at the moment: despite women now being well represented in film schools, very few manage to get their first film made, and on average, women directors get lower budgets than their male counterparts. In Normal, my aim is to stimulate reflection on how both genders are constructed and performed by individuals in contemporary society, and how this process translates into several forms of oppression.
What are your views on the flagrant inequality between women and men in the film industry? How can we work to fix it?
The statistics on gender inequality in the film industry are disheartening. In almost every role – from directors to writers and cinematographers – women are underrepresented. But this is also true in so many other sectors. It is difficult to say in a few words how we can work to fix this, but I believe the first step in every change always starts with education. As I have the privilege to teach film students, I invest a lot of energy in creating a feminist learning environment (which for me includes not only what and how you teach, but also being aware of the power dynamics within the classroom). Then, of course, at the industry level there should be programmers encouraging equal gender representation in festival selections, juries, funding bodies and so on, to build a more inclusive industry.
You are interested in exploring this topic through creative documentary. What are the positive things that this approach can bring to the subject?
I consider documentary to be a ‘per formative act’ between images and the reality that they are supposed to represent. My approach to non-fiction does not necessarily pursue objective truths, but instead subjective perspectives. In other words, for me, documentary forms can be used to provoke a critical interpretation of the reality they observe. In my film, I aim to present a disorientating portrait of accepted ideas of normality, and to generate critical and open-ended perspectives to counter hetero normative narratives.
What will the Eurimages award help you with in particular? What do you still need in order to complete the film?
We are extremely happy and grateful to have won the Eurimages award because it will help us to complete the post-production of the film.
*
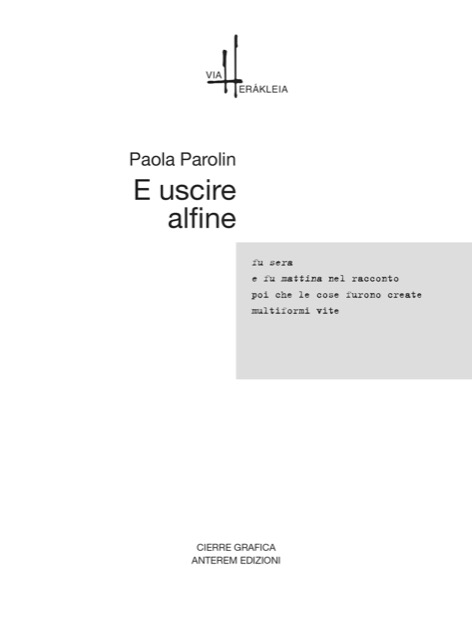 - Poesia
- Poesia
Paola Parolin - intrigo e magia della poesia-descrittiva
“E uscire alfine” – Cierre Grafica - Anterem Edizioni 2018.
“… il piano sequenza di vita / unica / in evoluzione / non per giustapposizione di esperienze / - vero viso vero nudo - / rivelato”
Brevità e concisione per una scrittura senza maiuscole, ove finanche gli accapo risultano fittizi di un discorso sospeso, distonico e audace. Altre volte del disimpegmo ma solo apparentemente, poiché la sintassi in realtà non sembra servire al linguaggio descrittivo dell’autrice basato non sulla narrazione bensì nell’adempiersi di una concezione ontologica del senso, oltremodo racchiuso nell’oggettività del concetto medesimo cui è tolto il senso, preso in ‘a solo’ e nella piena significazione della parola scritta …
Esempi:
“quanto di tanto conosciuto fidato sentire amicale se non / amoroso al ricordo icona di cavaliere su stele marmorea / in appartato luogo oppure in spazio vitale aperto alle folle / uno solo tradito e per tutti un’ombra scura cappa di malinconia / i passi futuri a ricordare come chi segue rivive del / fatto incompiuto come il tradito ricostruisce ogni giorno / il cammino”
“una raggiera di righi / da un foro centrale / specchio o cervello malato / una ragnatela che chiude / quanto più s’allarga // spicchi taglienti / immagini distorte / un pensiero unico scabro / si rannicchia nel vuoto / e ancora // spicchi di foro / in cervello a raggiera // scabri righi / damnatio memoriae”
Dove non c’è significazione di frase, nulla è tolto alla chiarezza delle parole che altresì si affermano per quelle che sono, cioè singole portatrici di senso, scaturito dalla stessa materia connettiva che ne determina la portata e che il potere della mente mnemonica predispone a un medesimo denominatore ‘altro’, libero dal pretesto poetico-letterario del significare, del diffondere messaggi o distribuire morale. Si è qui davanti a un atto creativo del linguaggio, funzionale di una scrittura dettata non tanto da emozioni contenute quanto dall’intuizione dell’attimo …
Esempi:
“Il saluto gioioso al principio / si spegne / poi / quando si stringe il contatto / vira in poche sillabe il disincanto (discanto) // stupore / dolore / - il saluto gioioso al principio / ingessato / nel suo non significare”
“dal coro / le voci / un’eco / nello spazio – sequenza - // parlano / oggetti angeli rosa turrite città / trasparenti fonemi da triplici segni – e unico sentire -// per quanto sono parola / leggerezza spogliata / isolata un poco / dissociata / fuori dal mondo”
Quasi che il linguaggio poetico di Paola Parolin abiti sì la lingua parlata dall’autrice ma non la sua scrittura che appartiene invece all’esperienza inintelligibile dell’ultima generazione poetica che non lascia spazio a interpretazioni di sorta, in ragione di una forma di astenia che la imprigiona nel chiuso del guscio espressivo dal quale stenta a liberarsi ed esternare ‘en plein aire’ la linfa che altresì scorre fluente nelle sue vene. È indubbiamente un fatto di ‘ipersensibilità’ sonora di cui si avvale la musica contemporanea che ha destabilizzato l’‘armonia’ assoluta, in funzione dell’assorbimento degli effetti sonori esteriori, cioè esterni al luogo di registrazione o della sala da concerto deputati all’ascolto ...
Esempi:
“cosa hanno veduto / quanto era stato mostrato / binari di genere / consolidate armonie / consuetudini / in cerca // una radice / a formare vero / un dire forte / come / in principio era il verbo”
“altro / lo sguardo perduto / provoca la sua impazienza / inerte // richiama la sua stizzita attenzione / schizoide / male appaiato / all’anima // un impeto / soltanto per aggredire / dall’altra parte // mostra il suo viso”
Ovviamente senza nulla togliere alla poesia contemporanea che si esprime per linee urbane e metropolitane, ci troviamo davanti a un uso ‘pedestre’ dei concetti assorbiti dalla porosità dei muri sui quali sono graffiti, coadiuvati da una scrittura nuova o, per così dire ‘altra’ non conforme alla grafia poetico-letteraria cui siamo abituati; ciò nulla toglie alla sua validità, che va oltremodo studiata e apprezzata per la sua capacità immediata di comunicare di cui il linguaggio poetico è spesso stato carente. Se verosimilmente la musica è ferma alle ultime battute della contaminazione sonora e della manipolazione elettronica spesso asettica, altresì il testo ha sviluppato linee di un lessico assoluto e incondizionato proprio della insonorizzazione delle parole di cui fa uso …
Esempi:
“travolgente / strafottente / esilarante / esagerato / il deserto per mettersi a nudo / per mascherarsi la città / nello specchio / lo stesso riflesso / ingentilito dalla luce del tramonto”
“fu sera / e fu mattina nel racconto / poi che le cose furono create / multiformi vite / insieme con occhi diversi / le danze del convito un simulacro / pure si va con piede leggero / uno accanto all’altro / in disegno complicato / cercando il nucleo di quella fede”
Lo rileviamo nell’odierna ‘canzone’ la cui base musicale, pur essendo per lo più sempre la stessa, fa da supporto a interazioni lessicali straordinarie, non solo di un certo spessore culturale, quanto portatrice di contenuti inusitati, per l’appunto ‘altri’ che sforano (spaccano), i consensi ordinari di un fare comunicazione oltremodo ficcante (cioè che arriva) che è poi il raggiungimento dello scopo non sempre e necessariamente predeterminato, ma altresì dinamico-creativo …
Esempi:
“in una dimensione sferica / s’incontrerebbero tutti / - visi a occupare lo spazio - / dimenticando la sequenza dei giorni / atmosfere corrosive hanno sottratto colore / fantasmi di frme felici / dove era il tempo / una malinconia concreta di niente / si appesantisce come cappa”
“la bellezza in un attimo / riconoscersi effimere sull’acqua / che divora // si può così / non lasciare il segno anime visibili // - un mondo sull’acqua (mondo liquido) / parla / la lingua trattenuta ora e là / in concorrenza / disvela senza pudore la via / la tua corrisponde”
Ovviamente l’autrice di questa silloge non scrive canzoni, tantomeno si presta all’uso rapper di volgere la rima ma, c’è sempre un ma che adocchia da dietro lo stipite di una porta, il musicista rap potrebbe fare buon uso dei suoi testi e volgerli nella giusta direzione ‘sonora’ e altrettanto accattivante di quella che senza alcun dubbio è la cifra poetica di Paola Parolin.
Lo confermano le immagni grafiche di David Raimondo utilizzate nell’impaginazione, riprese dall’immaginario simbolico del pensiero taumaturgico, e lo stesso inserimento nella collana ‘Via Herákleia’ che accoglie le divrse ‘forme della poesia contemporanea’… “il nulla dei giorni a venire all’improvviso voi mortificati di / nuovo imparare per rimandi in immagini moltiplicate dal / tempo evoluta creazione i risorgenti sulle strade di/ Darwin disconoscono il diritto del sangue e del suolo e / camminano sulle tracce dei fratelli minori”.
L’autrice Paola Parolin è medico in Verona, più volte segnalata al Prenio Lorenzo Montano, ha partecipato ad alcuni laboratori poetici coordinati da Ida Travi negli anni 1999-2008. È del 2011 il libro “Parola corale”. Nel 2013 ha pubblicato la raccolta in versi “Interni, Esterni, Interni”. Nel 2007 insieme ad altri autori ha pubblicatola raccolta poetica “Trittico della sera di carta”, tutti editi da Cierre Grafica.
‘E uscire alfine ‘… per ritrovarci insieme a parlare di poesia ‘oltre le apparenze’.
*
 - Poesia
- Poesia
Giorgio Bonacini o l’algoritmo della poesia descrittiva
Giorgio Bonacini o … l’algoritmo della ‘poesia descrittiva’ contemporanea.
Nello specifico metaforico del linguaggio musicale la ‘poesia’ abbraccia l’idealità del ‘suono puro’ che sta all’origine dell’armonia di fondo, di prevalenza variabile piuttosto che statica, nell’indugiare osservante di una partitura. Suono quindi, partecipe di quella mobilità simbolica che ogni ‘variazione sul tema’ apporta in forma creativa allo svolgimento narrativo di una sinfonia corale ...
“Dalla concentrazione pura / le prime parole emergono con una velocità / senza fretta - come se si dovesse / contemplare l’estraneità dei fiori / nella ripetizione di un principio insoddisfatto …”
Contestualmente a: “Si pensa allora a un’alternanza di rugiade / a un oscuro lavoro di meditazioni / nella similitudine terrestre …”
Formula quella della ‘variazione’ che accomuna all’afflato poetico, per definizione ‘cantabile’, la verbalità per eccellenza ‘orale-narrativa’ della scrittura tensiva di Giorgio Bonacini, che trova nella ‘epitasis’ greca quello che ben possiamo definire l’algoritmo della poesia simbolico-descrittiva che lo contraddistinge, la cui tensione espressiva egli spinge in modo del tutto personale nell’imperfetto contemporaneo ... “Trilli / fonòfoni / e suoni / e quanda’anche / cervello / arzigogoli / chiari / il pasticcio / neurotico / e cerebro”.
L’insolita chiave di lettura matematico-filosofica delle ‘performance poetiche’ che l’autore mette in atto, palesa un officiare ‘verità obliate’ che rispondono al richiamo degli elementi in natura che, una volta evocate, si dispongono secondo ‘combinazioni concatenate di locuzioni’ per una esibizione integrale di se stesse, dando senso all’indecidibile derridiano, ineffabile e indefinibile del “..perché si rannuvola il cielo / ad esempio” …
“È quindi impossibile / perdere il senso / di roccia nel vento / l’immagine attende / e si vede la calma / si forma l’inganno”.
Secondo la teoria introiettata dall’autore di “Quattro metafore ingenue” (*), la ‘poesia’, quando osservata da vicino, s’avvale di un’autonomia essenziale che la rende ‘invisibile’, (da cui l’inganno), in ragione di una sospensione del tempo che la proietta verso una soglia estrema, irraggiungibile, tuttavia partecipe di quella ‘esistenza interiore’ precipua dello spirito eletto …
“I rami che si staccano dai rami / cadono / e non ci dice più nulla / della loro caduta / il loro schianto / sensibile”.
Conformemente a: “L’artificio è equiparabile / al mio sguardo / un astratto rinnovarsi / di andature / in carreggiate fisiche”.
La reminiscenza di qualcosa ch’è stato e che invita alla meditazione di quella ‘conoscenza primaria’ che fa da cassa di risonanza al silenzio che tutto avvolge: ‘il silenzio del sacro’; il cui pieno coinvolgimento porta alla separazione dello spirito (soprasensibile) dall’intelletto (sensibile), emotivamente insostenibile in quanto antròpico dell’umano sentire.
Ne scaturisce una sorta di ‘discantus’ che nel linguaggio musicale assume forma polifonica del canto, consistente nell'aggiunta di una ‘voce’ in moto contrario all'andamento uniforme e parallelo dell'organum primitivo che si colloca al di sopra del canto dato, per un dialogo diretto con un ‘ipotetico prescelto’, relativo all’ego creativo dei sogni, ma …
“La saggezza dei sogni è diversa / trascorre / la sua nitidezza e dilegua/ Nel sonno / la perdita è tutto / la dissipazione stupenda / lo squilibrio abissale […] Immancabile scorre inesausta / la sapienza dei sogni.”
La forma del ‘discantus’ si inserisce qui, fra gli interstizi lasciati dalle parole, come suono a se stante, pulito e inequivocabile, di un risentimento di avvenuto distacco che risponde a una intenzionalità superlativa d’elevazione dall’ordinario, di per sé ‘pedestre e spesso mediocre’, equivalente di una fuga dalla realtà ingenerata da una infelicità reiterata nel tempo, alla ricerca costante del proprio riscatto …
“Cos’è che ci trattiene dal toccare? / Si isola una prima conoscenza / nella dimestichezza delle gocce naturali / e appare la durezza di una pietra…”.
O meglio, all’ancorché motivata composizione/scomposizione di quella ‘musica assoluta’ che dia equanime risonanza al proprio concerto interiore …
“Cosa manca allora per incidere ripetere o svelare in sé la qualità fine di un’ombra? … Penso a ciò che si può amare alla coscienza che cerchiamo nelle cose – non è più quella dell’ombra né il ricordo o l’esclusione che si vuole. […] Forse l’invasione è solo questa – una città dai tempi morti e gli occhi grandi come guardi una figura nell’infanzia o l’illusione che verrà.”
Ma se la ‘lingua’ è l’anima che tiene vivo un popolo, la libertà d’espressione equivale alla sua identità come il bene più prezioso da conservare, ciò che da senso all’atto di apprendere, e che l’io collettivo (che non esiste), pur definisce in senso di comunitario e glocalizzato della globalizzazione in atto, necessario a raccontare il mondo attuale, la tecno-sfida di quel linguaggio intraducibile che in qualche modo va riconquistato.
Come andare alla riconquista di un passato latente che va incontro, strano caso futuribile, al pensiero ancestrale degli antenati, in quanto sindrome illusoria d’illegalità legittimata dall’ego, privato e isolato, che esprime la propria individualità, al tempo stesso ambivalente e unanime, in ambito sociale, per un’autonomia della vita interiore, che si rivela nella …
“..forza contratta / esclusiva / (come di) una forma di fuoco / che inventa nel nulla / e induce il suo canto / tra il ritmo battente / e ciò che soltanto / le ciglia pensiamo / possano avere / se fossero fili / intuibili d’erba / di pioggia e di vento / […] / o alternanze di scavi / di anfratti / visibili solo / immergendo le dita / in quel vuoto / impassibile duro / dissimile in tutto / dal mondo di […] di chi scrive / e rivolge lo sguardo / a una sillaba assurda / a un dolore apparente / ma vivo”.
Come in Gaston Bachelard, filosofo, epistemologo illustre, autore di numerose riflessioni legate alla conoscenza e alla ricerca del nuovo spirito scientifico, le cui osservazioni sul ‘l’impegno razionalista’ e ‘l’intuizione dell’istante’, la ‘poetica dello spazio’ e la ‘psicoanalisi del fuoco’ aperte alla disamina filosofica contemporanea, Giorgio Bonacini può vantare nel suo stretto ambito critico, un’importante intromissione ‘poetica’ nel campo della linguistica emergente.
Fra le sue molte pubblicazioni figurano inoltre ‘poesie visive, sonore e artistiche’ nate dalla collaborazione con il gruppo Simposio Differante, in cui figurano testi di critica letteraria apparsi in riviste nazionali quali “Anterem” ad esempio, in cui il ‘linguaggio concreto’ delle performance si spinge alla ricerca dell’assoluto interiore, onde - egli scrive ...
“..scavare, conoscere e riconoscere, così come pensare e interrogarse sono l’essenza stessa dell’odierno esistere".
Contestualmente a: “Di tutto non si può dire. / Qualcosa ci attraversa / e ci separa – il vetro è silenzioso / il paesaggio muto / […] / Di noi si è senza /Non ho visto mescolanze / non ho visto niente / […] Ma non è così stabile / questo sgomento – ha l’incauta esattezza / dell’erba e la stessa aderenza / Di noi si è senza, impropriamente / senza / drasticamente senza / […] Ha devastato l’illusione il corpo / d’ombra, la sua impronta, l’equilibrio / del disegno nel ricordo del riflesso / Non ho visto smarrimenti / non ho visto niente – di noi / si è senza, naturalmente senza”.
È in questo suo vagare tra la distanza e il limite raggiungibile del suo pensiero che la dimensione onirica della ricerca affronta l’algoritmo del ricongiungimento (impossibile) col sacro, in quel dualismo che sta alla base del soccombere umano prima di giungere in cima alla piramide inanimata del divino, ove già Icaro tentò il grande balzo, per poi rovinare in discesa …
“Troppa la distanza, il limite / il confine – l’esistenza di un distacco / ancora opaco e irraggiungibile / […] / Troppo antica quell’altezza / in sommità – il prolungamento / innumerabile disposto nel disagio / […] / Mi riduco a sconfinare / a farti correre all’istante proprio qui / in un tempo preso ad inseguire / ad esaudire una distanza / Ma nel viaggio resto immobile / e costretto – e mi concentro in ogni cosa / cerco il vuoto di un tormento / Forse è l’albero, la luce, il forte / esempio che raggela e salta in bilico / agli antipodi di un suono – furto / e falso, senza limite né fuoco”.
C’è da restare sgomenti che nel ‘pensiero finale’ “..la perplessità resiste - / deve darci lo spasimo di un sentimento / inabile, patire i gesti impellenti / e farli vivere / schiudere l’ombra del riconoscimento / l’idea fondamentale di un conflitto / […] / essere il furto di una lingua / un dono amabile e sleale / […] Indicibili i suoni – al riparo del vento (ultimo che gelido spira) / (è allora che più) li senti così irrefrenabili e persi … / e così inafferrabili”.
. . .
“Ha senso che parlandoci riapriamo / la ferita? L’illusione inospitale del richiamo / non si oppone – non ha nulla da portare / Ma ugualmente è un’esistenza / in altri segni, tra le rocce, nella pioggia / dov’è il nome del bagnato”… Come in questa ‘Chiusura’: “Un segno – un piccolo preciso, indelebile segno È da qui che dovremmo partire – e qui ritornare E se cadono i suoni? E li nomina l’acqua? Le parole ora scrivono là – nel fantasma del sole Un salto e un ricordo – un cespuglio di segni L’inizio oltrepassa così l’illusione e la fine È qui che dovremmo tornare – e qui ripartire”.
Ma non tutto ci è dato!
“Non è nostro dunque il sole né il riverbero / dei suoni né la voce – libertà di un’atmosfera / firmamento di follie non destinato, recita / il suo corpo intimorito questa luce, si tortura / per un’ombra e l’universo che la accoglie / fascia il mondo con ardore, senza pace” / […] / «Così, per assenza di voce / un’aria difficile buca e risuona. / E la mente si ferma. Non parte. Rimane.» (*)
Referenze:
Giorgio Bonacini, “Quattro metafore ingenue”, Piero Manni 2005. (*) in “Argini”, “Anterem”, Rivista di ricerca letteraria n. 94 – Anterem Edizioni.
Gaston Bachelard, “L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco”, Dedalo 1993.
Jacques Derrida, “Luoghi dell’indecidibile”, Rubettino Editore 2012
*
 - Arte
- Arte
International Tattoo Fest Napoli
Dal 25 maggio alle 13:00 al 27 maggio alle 12:00
Quasi 300 tatuatori di fama nazionale ed internazionale, si presenteranno al pubblico in una cornice di grande fascino e bellezza e in un contesto di puro divertimento.
All’interno degli spazi dedicati alla convention troverete aree per lo svago e il relax, con artisti di strada, balli e giochi di animazione e aree per il ristoro, con manufatti della tradizione artistica partenopea e non solo.
L’evento si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli, una delle più importanti e caratteristiche sedi fieristiche in Italia. La Mostra si trova nella zona di Fuorigrotta ed è facilmente raggiungibile da qualunque parte del capoluogo campano.
Dal 25 maggio ore : 13:00 al 27 maggio ore : 22:00 presso i padiglioni della Fiera:Padiglione 10 e Giardino dei Cedri - Piazzale Tecchio - Napoli, 80125
Contatti:
http://www.tattoofestnapoli.com
INTERNATIONAL TATTOO NAPOLI S.R.L.
Telefono: 0818854876 - Email: info@tattoofestnapoli.com
Sito web: www.tattoonapoliexpo.it
Programma:
Venerdì 25/05/2018
ore 13:00 – Apertura al pubblico
"BACK TO THE STYLE"
writers live performance Mr.Pencil & Zeus40 su furgoncino Volkswagen
“APERITIF PARTY” ore 13:00 – 17:00
Dj Set – Pj Jonson + GGNO ore 17:00 – 19:00
Dj Set Marco Corvino alle 19:00 – “Gablis Circus” – Performance Danza Aerea 19:00 – 21:00
Dj Set Hollen alle 21:00 – End Live performance con Dario Rossi
Sabato 26/05/2018 dalle ore 12:00 – Apertura al pubblico
"BACK TO THE STYLE"
Graffiti live performance area giardino dei Cedri ore 13:00 – “X35” – Music Live ore 14:00 – “Gablis Circus” – Spettacoli Danza aerea.
Ore 15:00 – Break Dance Battle (2 vs 2) Dj Set – Dj Uncino
– Dj Max Bucci Hosting: Oyoshe
16:00 – Iscrizione Tattoo Contest
19:30 – “Gablis Circus” – Perfomance Danza aerea
20:00 – Contest Tattoo
Dj Set Frank Carpentieri
Mc Gallo
21:00 – Sfilata Tattoo
22:00 – Premiazione Contest Tattoo
Domenica 27/05/2018
12:00 – Apertura al pubblico
Live concert – The Steel
Esposizione lavori BACK TO THE STYLE
14:00 – Dj Set Pj Jonson + GGNO
“Gablis Circus” – Spettacoli Danza aerea
16:00 – Iscrizione Tattoo Contest
18:30 – “Gablis Circus” – Perfomance Danza aerea
19:00 – Contest Tattoo
Dj Set Frank Carpentieri
Mc Gallo
20:00 – Sfilata Tattoo
21:00 – Premiazione Contest Tattoo
22:00 – See you Next Year!
ETNOMUSICOLOGIA 4 - “Tattoo & Body Art” by Giorgio Mancinelli in larecherche.it
Alla base di questa ricerca comparativa che vuole anche essere un’inchiesta sulle diverse forme di comunicazione visiva e artistica, e la gestualità e i modi comportamentali, dall’uomo primitivo a quello moderno, del perché ci si tatua, la psicologia del tatuaggio e i suoi significati, del perché ha influenzato intere generazioni su scala mondiale e abbia influenzato nel profondo il comportamento sia degli uomini che delle donne. A incominciare dai cosi detti “mosaici” corporali ottenuti con l’ausilio di minuscole tessere lisce di legno o di pietre colorate che vengono applicate sulla pelle preventivamente preparata con disegni rituali e fissate con sostanze adesive, usate nelle feste e nelle cerimonie iniziatiche e, particolarmente, per segnare il numero dei figli o degli adepti di una setta, o nel caso di amputazione e forme di mutilazione tribale. Un esempio lo sono la limatura dei denti incisivi nelle popolazioni dell’Africa e l’uso di incastonare pietre di solito preziose o semipreziose, sullo smalto dei denti dell’ultima moda, già praticata in India e da alcune popolazioni sud sahariane.
È noto che l’immagine del proprio corpo da sempre ha provocato un effetto considerevole sui comportamenti degli uni verso gli altri. Alcuni studiosi hanno rilevato l’importanza per i due sessi di stabilire le loro prerogative sentimentali e sessuali: il sesso maschile, quella di possedere un sesso di più grandi dimensioni; quello femminile di possederne uno più piccolo, ma dotato di seni e glutei più grandi, anche se indubbiamente sono cambiate molte cose. È evidente che esiste una correlazione fra l’autovalutazione del proprio corpo e la ricerca di giudizio positivo da parte del sesso opposto. Non a caso molte persone sono considerate più attraenti di quanto esse stesse credono e viceversa.
Così amuleti, costumi e ornamenti finiscono con l’essere sotto controllo di chi li indossa a scopo apotropaico, cioè servono ad allontanare o ad annullare influssi magici maligni, in modo da ottenere particolari effetti negativi provenienti dagli altri, e che invece oggigiorno vengono esposti per una forma di narcisismo. A questo desiderio di comunicare, che è considerato esigenza primaria dell’uomo, fa riscontro un desiderio più grande che è quello di esprimersi. Scrive Edmund Husserl (11): “Fra ciò che veramente mi appartiene io trovo solo il mio corpo che si distingue da tutti gli altri per una particolarità unica. È il solo corpo all’interno dello strato astratto ritagliato da me nel mondo, al quale, conformemente all’esperienza, io coordino, in modi diversi, campi di sensazioni”.
Desmond Morris (12) nel suo famoso “L’uomo e i suoi gesti” rileva quanto segue: “L’indossare abiti è soltanto uno dei modi in cui l’animale uomo si adorna . Ma oltre a vestirsi, egli si può incidere la pelle, forare la carne, tagliare i capelli, profumarsi, dipingersi gli occhi e le labbra, incipriare la faccia e limare i denti, truccarsi, mettersi parrucche, travestirsi con forme di abbellimento che operano come importanti esibizioni umane, che indicano lo stato sociale, la condizione sessuale, la disponibilità individuale, l’alleanza di gruppo”. Ma si tratta di ornamenti per lo più temporanei. Le decorazioni costanti, quelle che comportano qualche forma di mutilazione fisica, sono forse quelle più tipiche del linguaggio visivo che danno l’avvio alla nostra ricerca improntata come si è detto sul tatuaggio.
Il progredire del senso estetico porta successivamente al compiacimento di sé, a un incipiente narcisismo che fa scoprire nuovi mezzi naturali per arricchire sempre più il proprio corpo con colori, ornamenti e forme estetiche originali. Creatività che raggiunge valori e livelli notevoli nel tatuaggio, un’espressione cosmetica usata per gli scopi più diversi. Ci dice il professor Rovesti: “Per le figurazioni più semplici la reazione cutanea è di solito poco dolorosa, ma per quelle più estese si può verificare una reazione edematosa più o meno intensa e dolorosa che però scompare in pochi giorni. Se i tatuaggi sono limitati a pochi punti, di solito costituiscono solo segni di riconoscimento fra tribù, ma quando interessano tutto il corpo significa che si perseguono scopi ben diversi, estetico, religioso, propiziatorio, medico, magico”.
Può farci degli esempi?
“I tatuaggi più complessi e appariscenti li troviamo tra i melanesiani e i polinesiani; tatuaggi che occupano nei capi e nelle persone di maggiore importanza nella tribù, quasi la totalità del corpo. Si conoscono diverse preferenze di tatuaggio che in un certo senso segnano la diversità tra i vari popoli anche dello stesso continente”.
Quali parti del corpo sono prevalentemente sottoposte al tatuaggio?
“Sono preferite le spalle e le natiche, il volto, il petto negli uomini nel caso si tratti di etero tatuaggi, mentre gli auto tatuaggi di preferenza sono l’avambraccio, le cosce, la zona palmare sinistra, le dita della mano sinistra. In realtà è più nella simbologia e nella grafia che si trovano queste differenze. Nelle isole Cook, ad esempio, troviamo numerosi i tattoo sugli organi genitali maschili; mentre nelle isole Ponape troviamo in prevalenza tattoo sugli organi di riproduzione femminili. Curiosa può risultare l’usanza di farsi tatuare la lingua dalle vedove nelle isole Sandwich, o di farsi tatuare il cranio calvo dei vecchi nelle isole Marchesi. Mentre invece a Tahiti troviamo quasi esclusivamente tatuaggi sui seni e i glutei femminili con uccelli, lucertole, pesci, mani maschili. Nelle isole della Sonda alcune ragazze adornano la loro bocca con corone di fiorellini tatuati. Nelle Caroline, appena una fanciulla diviene donna si fa tatuare un triangolo sul basso ventre più o meno vistoso, senza il quale, nessun uomo l’avvicinerebbe”.
Non si pensi che mi sia dimenticato della nostra ricerca primaria riferita all’etnomusicologia applicata. Se la tematica sembra non dover lasciare spazio alla musica o al canto, è solo perché in questa specifica trattazione scritta, non c’è lo spazio materiale per l’ascolto, in cui l’ascoltatore è chiamato a partecipare della ricerca musicale che accompagna i testi. Cercherò di rimediare con un’ampia sezione discografica di riferimento, di cui ci si potrà avvalere per indurvi all’ascolto di alcuni brani che ho scovato nell’ampia discoteca che ho raccolto nei miei frequenti spostamenti in giro per il mondo. Come in questo caso del brano “saka” registrato nell’isola di Bellona in Melanesia, cantata durante il tattoo di una isolana per distrarre la sua mente dal dolore. La canzone, più semplicemente “canto per il tatuaggio” è stata composta da un esponente di questa cultura dal nome originale “Mautikitiki” (13). L’accompagnamento è costituito dal suono di un bastoncino che scandisce il picchiettio dell’ago a imitazione del tatuaggio reale. Una pratica interrotta solo da pochissimi anni.
Esistono quindi diverse tecniche di esecuzione del tatuaggio? – chiedo al professor Rovesti.
“Il tattoo per infissione è certamente quello più diffuso nei paesi che ce lo hanno trasmesso, quali l’Oceania, Melanesia, Nuova Guinea, Tasmania e in alcune zone centrali dell’Australia dove, ancora oggi, sopravvivono un gran numero di popolazioni allo stato aborigeno. Mentre in Africa è maggiormente in uso la scarificazione, in India e nei paesi arabi troviamo il tatuaggio per puntura sulla fronte, sul mento e sulle mani, e solo raramente si sono visti casi di tatuaggio totale, come ad esempio presso alcuni popoli della Siberia”.
Immagino si riferisca al rinvenimento archeologico dell’uomo tatuato di Pazyryk nel massiccio montuoso dell’Altai?
“Certamente, anche se non ho sufficiente documentazione per parlarne”.
Ho raccolto alcune notizie stampa e sono venuto a conoscenza che si tratta di uno dei più importanti ritrovamenti d’interesse antropologico del secolo, avvenuto tra le sepolture della vallata da cui ha preso il nome. Il corpo completamente tatuato, sembra appartenesse a un capo o forse uno stregone di una tribù nomade risalente addirittura al IV° V° secolo a. C. giunto fino a noi grazie alla protezione del gelo che lo ha mantenuto in buono stato di conservazione, insieme agli animali e gli oggetti con cui era stato sepolto. A Pazyryk (14) nella regione dei monti Altai (Siberia - Russia) è presente un gruppo di circa 40 tombe preistoriche rinvenute dall' archeologo Rudenko nel 1920. Queste tombe (del quinto secolo avanti Cristo), quasi tutte violate durante la storia, fin’ora hanno restituito 3 corpi, imbalsamati, ben conservati e, quasi incredibile a dirsi, ricoperti di splendidi tatuaggi. I Pazyryk erano cavalieri con la passione per la caccia, pastori pronti a combattere per aggiudicarsi i pascoli migliori ed artisti erano a stretto contatto con il mondo naturale - un mondo che comprendendo leopardi della neve, aquile, renne - favoriva in questi artisti la propensione a rappresentare animali fantastici.
Uno di questi corpi apparteneva quasi certamente ad un capo, un uomo dalla corporatura possente, intorno ai 50 anni. Sul suo corpo, disegni vari che rappresentano una varietà di creature fantastiche e non. I tattoo ancora riconoscibili ci mostrano un asino, un ariete, cervi stilizzati dalle lunghe corna ed un feroce predatore sul braccio destro. Due bestie mostruose decorano il torace e sul braccio sinistro si intravedono figure che sembrano rappresentare due cervi ed una capra. Dal piede al ginocchio si dipana il disegno di un pesce, un mostro sul piede sinistro e sul polpaccio quattro figure di arieti in corsa si uniscono a formare un solo disegno. Sul dorso piccoli cerchi in corrispondenza della colonna vertebrale. Si tratta dunque di una ridda di animali fantastici che sembrano “in movimento” su quel corpo come esseri viventi: “una moltitudine di animali reali e immaginari, saltanti sulle prede, galoppanti, scalpitanti o fuggenti, che corrono alla rinfusa sulle due braccia, su una parte della gamba destra, sul petto e sul dorso. I motivi erano stati ottenuti per mezzo di punture nelle quali veniva iniettata della fuliggine. Una tecnica già conosciuta che è rimasta per lo più la stessa da allora.
Un altro rinvenimento di cui si è molto parlato, risale al 1993, anno in cui l'archeologa Natalia Polosmak (15) scoprì la tomba di una donna soprannominata poi "La Dama di Ghiaccio". Sotto i corpi di 6 cavalli sacrificati all'occasione, la dama giaceva in una tomba ricavata da un tronco di larice. La tomba è decorata da immagini di cervi e leopardi delle nevi intagliate nel cuoio. Il corpo, adagiato come se si fosse dolcemente addormentato, apparteneva ad una ragazza sui 25 anni dai capelli biondi, alta circa 1,65 m. Anche la dama presenta diversi tatuaggi (di un blu intenso) sulla sua pelle chiara: creature dotate di lunghe corna che si compongono in immagini floreali. Due anni dopo il marito dell'archeologa, Vyacheslav Molodin (16), scopriva il corpo di un altro uomo, con un elaborato tatuaggio raffigurante un alce, due lunghe trecce, sepolto con le proprie armi.
Si pensa che, come nel caso di Oetzi (17), nelle Alpi italiane dove, nel 1991 è stata trovata una mummia databile al IV millennio a.C.. con bellissimi tatuaggi, il che lascia pensare che anche queste antiche popolazioni adoperassero il tatuaggio a scopi lenitivi, ma in questo caso ottenendo allo stesso tempo risultati dalla grande valenza artistica. Non si conosce come venissero eseguiti i loro tatuaggi, ma è probabile si servissero degli stessi finissimi aghi utilizzati per creare tessuti e tappeti, arte nella quale erano maestri.
“Come vediamo dalle date se ne ricava che la storia del tatuaggio inizia con la storia dell'uomo in epoca preistorica (uomo di Cro-Magnon, 35000 – 10000 a.C., e Neolitico, VIII – IV millennio a.C.). Grazie ad alcuni ritrovamenti di statuette con segni geometrici sul corpo, si suppone che gli uomini, dotati dell'abilità di ricavare colori da minerali e vegetali, utilizzassero strumenti appuntiti per realizzare segni permanenti sul corpo”.
Ma c’è un altro fatto da prendere qui in considerazione ed è il mondo dell’immaginazione e la raffigurazione legato ad animali fantastici, come motivo ricorrente nel tatuaggio. Rammento che in una mostra che poi ha fatto il giro dell’Europa sugli “Ori degli Sciti” gli animali fantastici e “straordinari” vi erano frequentemente raffigurati: leoni con la testa di bue, grifoni rampanti, tutti resi nella dinamica del movimento.
“Ancor più ne troviamo nei tessuti e nel cuoio, o parzialmente ricoperti d’oro che oggi abbelliscono corpetti, giubbe e selle delle popolazioni siberiane. E che non sono soltanto belle a vedersi ma riflettono di una cultura che richiederebbe però uno studio più approfondito nell’ambito dell’artigianato e dell’arte”.
Ma che dobbiamo rimandare ad altra sede e in un altro momento. Per adesso soffermiamoci ancora sull’aspetto, come dire, cosmetico del tatuaggio. Cosa ci dice in proposito?
“Non si tratta di un accessorio cosmetico inutile o di pura e semplice decorazione occasionale, bensì che riveste un significato profondo e importante, come quello che si è dimostrato in alcuni popoli con diversa cultura dalla nostra, addirittura lontana migliaia di anni da noi contemporanei che lo facciamo quasi per metterci alla prova. Si pensi il dispendio di tempo, di pazienza, di sacrificio e di dolore fisico che chi vi si sottopone deve affrontare. Ovviamente chi vi si sottopone lo fa con convinzione di aver accolto in sé qualcosa che gli altri non hanno, una sorta di “tesoro” di bellezza che porterà per sempre sulla propria pelle”.
A questo proposito ho scovato i versi di un ritornello polinesiano che dice:
“Ho imprigionato bellezza nella mia pelle e nessuno potrà mai rubarmela, nemmeno gli spiriti del male”.
Canta una ragazza polinesiana:
“Mi sono scelta i miei compagni / che nella loro casa dentro la mia pelle / non mi lasceranno mai sola. / Sono uccellini e fiori dai vivaci colori. / E quando abbraccio il mio amore / mi sembra di sentire sommessamente / sulla mia pelle / con le sue carezze, i cinguettii e i profumi squisiti dei fiori”.
Sorge evidente che la pratica del tatoo non serve soltanto a trasferire segni sulla pelle, ma ha motivazioni diverse e complesse. Mentre per i primitivi, di cui ne abbiamo dimostrato la necessità, facciamo ricorso al fatto che lo praticavano come norma di costume, e che quindi mantenevano una certa purezza d’intenzione e una loro poesia di fondo, possiamo ben intuire come a confronto, prevale in noi moderni una certa sofisticazione riferita alla moda, grazie anche a fatto che l’evoluzione tecnologica ha ridotto di molto l’effetto dolore. Dobbiamo ammettere che la pratica del tatuaggio oggi si pone in disaccordo con la natura, sia con l’ambiente urbano che ci circonda, sia con l’abbigliamento che lo nasconde, e ancor più con quella poesia, talvolta benevola, altre oscura, nell’uso discutibile che ne fa la moda. Non è invece da considerare solo una moda la pratica del “piercing”, tornata in auge in occidente al seguito dell’esperienza in musica del punk. In parte autentica e in parte mimetizzazione di un coraggio di cui andare fieri, l’uso di spilli, barrette, anelli, infissi nelle guance e nel naso, nelle orecchie e le sopracciglia, sulle labbra e sulla lingua, colorazioni indelebili del viso, lenti a contatto di diversi colori, e altri accessori da falsare le ciglia o le palpebre degli occhi, è espressione di un disagio profondo in cui il nostro corpo non ci basta più, la nostra sicurezza interiore necessita di prove per essere poi messa al bando a fronte di un vuoto culturale che non ha eguali.
Colgo l’occasione per farvi leggere il bellissimo racconto di un pescatore somalo il quale porta tatuato sul petto, il volto della sua ex ragazza:
“Questa è Liré, la mia ragazza scomparsa in mare non più di un anno fa. Qui ride col capo rovesciato all’indietro, come faceva quando le parlavo d’amore. la sua vera tomba è qui, dove pulsa il mio cuore, dove ella può ancora vivere il dolce ricordo. E qui, si anima della luce del sole, del moto che faccio quando esco in mare, dell’argento lunare che la rendeva adorabile, delle mie parole e dei miei baci. Da un lato all’altro del viso ci sono i fiori che lei amava tanto; sopra e sotto i pesciolini d’argento che ora le tengono compagnia nel profondo del mare”.
Sembra di leggere un ingenuo Lee Masters, tanto è limpida la sua dimensione poetica raccolta nel tatuaggio che porta nel cuore. È il canto di un uomo nudo, solitario che osserva il mare, quanto mai ricco di un gioiello sentimentale che oggi può venerare al pari di un idolo. A questo proposito si potrebbe parlare della superstizione che accompagna il tatuaggio che vede la sua creatura incontaminata da sovrapposizioni fantastiche, quanto invece infervorata da un profondo credo.
Il tatuaggio (più in generale), porta con sé un retaggio favoloso di tradizioni estetiche e rappresenta l’esempio più toccante di una tradizione artistica mai venuta meno. È indubbiamente una forma dell’arte naturalistica, spontanea come solo può essere una sorgente, per dire una trasfigurazione della realtà in una zona viva come la pelle.
Non c’è dubbio che molti tatuaggi vanno attribuiti alla superstizione latente che stenta a scomparire e che ritroviamo nella riproduzione di “ferri di cavalli”, “corna”, “chiavi” ecc. usati contro il malocchio e la iattura, così come anche ve ne sono detti di scongiuro a forma di “stella”, “lampada”, “fiore”, “bandiera”; o di vendetta come di “teschio” o di “testa recisa”, di “cassa da morto”, di “cuore morso dal serpente” o “trapassato dal ferro di un pugnale” con l’aggiunta spesso di motti e scritte di difficile interpretazione, ma è proprio qui, nel messaggio che si rappresenta, nella veridicità della sua funzione, che il tatuaggio esprime il suo linguaggio poetico e virtuoso, tutta la sua forza comunicativa che le parole, talvolta, non possono o non riescono a esprimere.
Formule magiche di sicura origine onomatopeica, fonosimbolica e imitativa, accompagnano spesso i disegni e le figurazioni propiziatorie contro le influenze del male. Fra questi vanno ricordati i tatuaggi dei pastori della Lombardia e dei pellegrini al santuario di Loreto, che consistono in una croce sovrapposta a una sfera o a un cuore, a una stella, e riferiti all’immagine del sacramento, al santo Patrono, ai simboli della Passione. In altre regioni, come la Romagna e l’Abruzzo, ad esempio, è in uso il monogramma di Cristo, spesso ridotto a una H maiuscola. C’è però un altro tipo di tatuaggio di cui vorrei qui parlare, ed è quello a scopo erotico/indicativo.
In proposito ne parla il prof Paolo Rovesti:
“I tatuaggi con soggetti erotici e comunque eseguiti su quelle parti del corpo cosiddette erogene, tanto scarsi fra i primitivi, sono invece frequenti fra i marinai, i soldati, i carcerati, i delinquenti, e solo recentemente fra la gente comune. Vi figurano ideogrammi riferiti a prove d’amore, e piccole poesie amorose dedicate ora a questa o quella donna, ma solo raramente, immagini di lussuria e oscenità, che vanno riferiti a promesse fatte o a giuramenti”.
A quale simbologia si rifanno?
“Per lo più, possiamo dire che dimostrano “un carattere osceno” distinto dagli altri dato dalla loro estensione ma, anche, perché spesso sono eseguiti in parti invereconde. Diversi da altri che si contraddistinguono in specie che sono di “castigo” o di “sfregio”, o come abbiamo già detto, di “vendetta””.
Vi sono poi quelli di tipo informativo.
“Soprattutto nelle associazioni criminose, dove il tattoo serve a indicare i gradi gerarchici, così come, ad esempio, avveniva nella vecchia Camorra in cui, una lineetta e un puntino servivano a indicare il giovanotto onorato; una lineetta e due puntini il “picciotto”, una lineetta e tre puntina il camorrista vero e proprio. Il tatuaggio allora chiamato in gergo “devozione”, così detto perché suppliva al santino che suggellava la sua spavalda identità, il gusto spacconesco, l’estro picaro della Camorra”.
E ovviamente quelli per così dire “a ricordo”.
“Questi vengono eseguiti in onore di una persona cara perduta, un animale prediletto scomparso, ecc. allo scopo di indicare, almeno presso i primitivi, che l’iniziato tatuato era maturo per la vita sociale e pronto per la vita sessuale. Presso alcuni popoli invece era indicativo della tribù d’appartenenza, in altre semplicemente un segno d’onore o sanciva un patto di sangue, o anche per distinguere i capi, i sacerdoti, gli sciamani. In alcuni casi il tattoo esposto informava dei nemici uccisi, delle bestie feroci catturate, delle imprese memorabili compiute, che ne facevano, agli occhi degli altri, quasi un eroe”.
Diverso è invece il tatuaggio strettamente simbolico di tipo “totemico” di non facile interpretazione, la cui funzione magica, fa parte del retaggio di una tradizione artistica e devozionale che attribuiscono al tatuaggio una funzione magica, che pur se lontano, “ricondurranno l’anima del defunto alla sua terra e al suo popolo”. L’esempio più eclatante che ci viene in mente, lo stavamo appunto dicendo con il professor Rovesti – è quello descritto da Herman Melville in “Moby Dick”, lì dove parlando del ramponiere Quiqueg, egli ravvisa:
“Con una stravaganza bizzarria, egli adibì ora la bara a cassetta e, vuotandoci dentro il sacco di tela degli abiti, ve li ordinò. Trascorse molte ore libere a intagliarne il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi, e pareva che con ciò cercasse di riprodurre, nella sua rozza maniera, parti dell’intricato tatuaggio del suo corpo (..) opera di un defunto profeta veggente della sua isola, che per mezzo di quei segni geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un mistico trattato sull’arte di conseguire la Verità, cosicché Quiqueg era nella sua persona stessa un enigma da spiegare, un’opera meravigliosa in un volume, i misteri della quale però neanche lui sapeva leggere benché sotto vi pulsasse il suo cuore vivo. Questi misteri erano quindi destinati a perire alla fine insieme alla pergamena vivente dov’erano tracciati e così restare insoluti fino all’ultimo. E doveva essere stato questo pensiero che suggerì ad Achab quella sua fiera esclamazione, un mattino mentre si voltava ad osservare il povero Quiqueg: «Oh, diabolica tentazione degli dèi!».
Ma non è tutto. All'interno dell'International Tattoo Fest Napoli 2018 avrete occasione di incontrare un artista di cui ci siamo già occupati in passato: "Mario Compostella … ‘o la memoria creativa del tempo’" -(vedi articolo in larecherche.it)ento' che ha preparato un 'evento' speciale per l'occasione e di cui ci occuperemo prossimamente.
Un grande evento per una grande città che vi aspetta tutti indistintamente per una grande festa insieme.
*
 - Società
- Società
Bla, bla, bla, 2 come reinterpretare il futuro
“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale, la capacità di valorizzare al meglio ciò che distingue una persona dall’altra.” (Nelson Mandela)
Secondo l’ironia del banale che mi identifica, preludere a tale specifica affermazione può essere un modo, uno dei tanti, per eludere la realtà che ci circonda e dare libero sfogo al dibattito sempre aperto sull’educazione. Un incarico indubbiamente molto impegnativo se si considera l’incresciosa debacle socio-culturale in cui noi tutti ci dimeniamo, talvolta senza sapere perché. Come dire di un annaspare a occhi chiusi per cercare quello che è andato smarrito di una formazione culturale come la nostra, e dover mantenere la salvaguardia delle parole che più volentieri avrei usate (spregevoli volgarità) e, al tempo stesso, aprire qui a un dialogo professionale (politically correct) ma sensa senso, copia-conforme di un menefreghismo generalizzato.
Da dove incominciare? E perché no dalla scuola. Del resto la scuola rimane, come qualcuno afferma, ancora il luogo dei valori (?), il punto di riferimento forte in cui ricercarare e ritrovare certezze e convinzioni sempre più solide (?), seppure in questo mondo ‘liquido’ (Z. Bauman), e sempre più spesso ‘del disimpegno’ (J. Derrida), che tutti ci travolge. Acciò si dovrebbe immaginare una scuola dinamica, democratica e partecipata che assicuri uno ‘status’ equanime di responsabilità (compiti di servizio, clima di lavoro costruttivo e condiviso) al fine di garantire una scuola efficace e di alto livello. Inoltre credere fermamente che una comunità educante richieda sempre e comunque un approccio sereno, basato sull’accoglienza e sulla comunicazione efficace, fattiva di una presa-di-coscienza-sociale (utopia?) che attualmente non c’è.
Un ‘edificio di vetro’ dunque (al pari di uno zoo), per far sì che il corpo insegnante, gli alunni, le famiglie e l’intera comunità sociale arrivino a comprendere come realmente riformare un’istituzione scolastica che si dica ‘aperta al futuro’, cosciente delle diversità socio-culturali (autoctone, regionali, immigrate) presenti sul territorio e, più in generale, di quelle esistenti nel mondo (etnia, religione, ideologia). Acciò di consentire la perfetta integrazione individuale all’interno della sfera sociale di appartenenza che di per sé escluda diversificazioni di colore di pelle, di sessualità (utopia?). In breve di ciò che oggi distinguiamo, più o meno consapevolmente, come rilevanti di ‘genere’, con la possibilità di cadere in errore nella valutazione a seconda degli stimoli emozionali, per cui siamo indotti a includere e/o escludere gli altri dalla nostra sfera sociale.
Educare, pur con le crescenti difficoltà di contesto, significa il raggiungimento di importanti obiettivi istituzionali nel panorama dell’istruzione (elementare e professionale) al fine di formare menti brillanti e mani (risorse umane) in grado di intervenire in ogni ambito di lavoro. Cioè, guardare con attenzione ai cambiamenti sociali ed economici del contesto territoriale; intraprendere lo studio di stategie tendenti ad aumentare le capacità di intervento (fattivo) nelle esigenze comunitarie (incidenti di gravità superiore, catastrofi naturali ecc.). Dare adito all’emergente offerta formativa tecnologica, alternativa a quella classica, la più completa possibile, per l’inserimento nel mondo produttivo.
Il confronto e il dialogo su questa possibile riforma ‘educazionale’ di formazione-istruzione dovrebbe interessare l’intero ordinamento scolastico proprio in funzione di quella reciprocità che i cittadini (contribuenti alla gestione dello stato) reclamano da tempo. È detto: “chi educa è anche educato e il suo sapere si gioca nell’atto dell’educazione”, che va letto nel modo seguente: “chi educa è (dovrebbe essere) anche educato e il suo sapere (che va costantemente aggiornato) si gioca nell’atto dell’educazione”. Un’ulteriore prova con qualche possibilità di successo in cui si intuisce una corresponsabilità educativa, al processo formativo e alla crescita gestionale delle nuove generazioni, al fine di mantenere la custodia dell’immenso patrimonio culturale di cui siamo eredi e divenire guide instancabili del loro futuro.
In un tempo in cui sembra prevalere il contrario, l’educazione prioritaria rimane indubbiamente quella familiare, nella quale trovare (si dovrebbe) quell’accoglienza e solidarietà (fin troppo spesso negata), la sola capace di avvalorare, indirizzare e sollecitare le prospettive future dei propri figli, così come di instaurare rapporti di correttezza e cogliere i segnali positivi nel relazionarsi con gli altri. Il cui fine è nella formazione identitaria soggettiva che li rende ‘protagonisti’ del proprio ‘sapere’ (conoscenza) attraverso l’impegno e la partecipazione allo studio. Ed a tenere un comportamento corretto e collaborativo in sede comunitaria per rispondere alla complessità del quotidiano di cittadini attivi e consapevoli, nonché futuri professionisti e imprenditori seri e preparati.
La famiglia deve (o almeno dovrebbe) operare la sua azione educativa delle sue possibilità, affinché i giovani sappiano davvero dare il meglio di sé: i loro sogni, il desiderio di ottimizzare e potenziare le loro capacità, la forza di chiedere aiuto, il valore di un sorriso, l’ottimismo, la ricerca dell’amicizia autentica, l’impegno attraverso il sacrificio personale. Insomma, le solite cose che si dicono da sempre, anche se noi genitori, al nostro tempo figli, non le ascoltavamo, se ben anche oggi non vengono ascoltate, insomma, aiutarli a crescere significa essenzialmente coltivare questa parte positiva di sé e della relazione con il prossimo.
La Buona Scuola? ...è un'idea!
Da parte mia posso dire di non aver mai smesso di studiare, tant’è che sono iscritto almeno in due università pur senza frequentarne alcuna, e forse solo per tenermi aggiornato sul metodo d’insegnamento che dovrebbe essere per così dire ‘up-to-date’ ma che di fatto non è. O almeno non da ché io, or sono decenni, frequentavo i banchi col calamaio incorporato e la scanalatura per le penne e le matite, col piano di sotto dove riporre i libri e i quaderni, e i sedili erano tutt’uno (a coppia) senza nessuna possibilità di agili spostamenti se capitavi dalla parte della parete.Poi gli anni corrono e ti ritrovi già grande con un sacco di minchiate per la testa e non sai se alle molte domande hai sempre delle risposte da dare. Ma le risposte no, non te le hanno insegnate ...e allora che fare? Devi metterti alla prova e affrontare la realtà!
Ma la realtà qual'è?
È una parola, ci vuole tanto di spinta interiore per mettersi continuamente alla prova. Tant'è che ti ritrovi con i ‘i figli’ che non ti permettono di rimanere indietro, per cui puoi anche essere quel mostro che in verità sei, che loro immancabilmente esercitano su di te una sorta di ‘giurisdizione’ scolastica che giammai può essere pari alla loro ma nemmeno indietro, almeno un tantino più avanti. Quel tanto che serve a insegnargli alcune cose (leggi furberie), che se non le hai apprese in precedenza, sei comunque tagliato fuori perché loro, da lì a breve, ne sapranno molte più di te. Se minimo non sei stato un secchione o un bambino prodigio, preparati a subire quel poco che (per rispetto di paternità e se qualcuno glielo ha insegnato) hanno appreso pro-loro in ambito scolastico ...
Così i loro libri diventano i tuoi libri per quanto riguarda il contenuto, rimasto lo stesso da decenni, ma non i loro quaderni, perché mentre tu eri occupato a tenerli in ordine, senza macchie, senza orecchie, senza … I loro non sono neppure quaderni, sono per così dire ‘differenziati’: stralciati, bisunti, scarabocchiati, simili in tutto a chiazze di una qualche ‘allergia della pelle’, o forse di ‘orticaria’ pregressa per quelle che sono state per noi le ‘regole’ inerenti allo ‘scritto’, prima che l’istruzione tendesse alla sola ‘oralità’ delle parole, parolacce incluse. Sì, perché se le parole scritte (in italiano) ieri avevano un senso, oggi suonano come strafalcioni; tant’è che anche quelle scritte o trascritte che sia non sono più in una qualche lingua comprensibile (conosciuta), bensì un misto di vernacolo siculo-calabro-milanese o romanesco-laziale-partenopeo, se non addirittura appartenenti a un certo gergo etrusco-tosco-umbro.
Per così dire, uno ‘slang’ oceanico-indoeuropeo-turcomanno, passato attraverso l’antica Persia o l’antico Egitto, ècco sì l’antico che si vuole chiamare ‘moderno’… Rammento che non c’era verso che t’insegnassero a copiare, né dai libri né dai compagni che ne sapevano di più (sbagliando). Perché se c’era una cosa che si doveva rendere più semplice era proprio ‘copiare’, molto più vicino alla rivisitazione e all’interpretazione di un testo che non dover creare, reinventare, resuscitare dal nulla qualcosa che non avevi affatto compreso. E dire che copiare rimane l’unico vero momento di creatività che non ripetere le parole del libro a pappardella. Per il resto si continua a studiare date e fatti di battaglie, guerre, pestilenze, la storia più bieca che nulla ha insegnato all’umanità se non la violenza, il sopruso, la vendetta, il razzismo, l’intolleranza, l’apartheid; e non (pensate, pensate) l’evoluzione del genere umano, le scoperte scientifiche, le ‘passioni’ della mente, la socializzazione, il rispetto civico, l’amore per l’arte, per la musica, l’amore per gli altri, insomma, quella ‘bellezza’ che pure fa grande l’essere umano e lo riscatta dai primordi di un ‘cannibalismo’ allora latente, oggi presente più che mai.
Sì, insegnare quell’amore per la vita, che non conosce ostacoli insormontabili, o diversità di genere, di razza, di colore della pelle, di confini geografici invalicabili. Quell’amore che ci rende tutti ugualmente liberi, gerenti di noi stessi, dei nostri affetti, del nostro corpo come del nostro sesso che sempre bistrattato ha creato mostri di narcisismo, di egotismo, di vanità; per tacere di super-uomini, eroi-divini, ecce omini diventati quelli che siamo, anticristi senza alcun credo e senza orgoglio. No, l’amore che qui intendo elogiare è quello più naturale che si esprime nella ‘bellezza’ per il creato, per tutto ciò che ci è dato e che immancabilmente stiamo distruggendo. Utopia? Forse, come moneta di scambio non meno apprezzabile di quell’odio razziale che oggigiorno spendiamo nell’indifferenza che ci allontana dagli altri e da noi stessi, trasformati in esseri ‘umani (fin) troppo umani’, appunto mostri di malvagità, disonestà, iniquità: ingiusti nella giustizia, volgari pur nella moralità, scorretti finanche nelle opportunità, blasfemi perché irriverenti, sacrileghi, miscredenti.
Allora ben tornino gli ideali, le chimere alate che s’involano, le illusioni che infine ci aprano gli occhi su questa realtà ‘umana’ fatiscente e obsoleta; che si torni a sognare in nome della ‘bellezza’ e cercarla fino al limite dei mondi possibili, in quella sostenibilità che pur ci consente di sopravvivere. «La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no...» – scrive Zygmunt Bauman e con modestia mi sento di aggiungere: “..che lo vogliamo o no.” Perché è nella volontà/non volontà che si gioca la ‘gran partita’ fin dall’infanzia; e la volontà in tutto questo assume il ruolo più importante. Rammento che alla domanda se mi sarebbe piaciuto andare a scuola, di aver risposto no perché non sapevo né leggere né scrivere. Oggi, a distanza di tempo, viene da chiedermi: perché si nasce ignoranti? Perché non conosciamo già quelle cose ‘essenziali’ che ci permettono di proseguire nel nostro cammino verso l’infinito? La verità è che non tutto ci è dato, che solo la volontà e la nostra determinazione e forse l’intraprendenza ci permette di svelare a noi stessi tutta la ‘bellezza’ del mondo in cui viviamo, e afferrare il senso della ‘grandezza’ che sì ci è data …
Ecco che allora la Scuola non può essere l’’utopia dei pochi’, non può trascurare quelli che sono i valori acquisiti da millenni di scoperte (in campo scientifico, meccanico-industriale, spaziale e tecnologico, medico-terapeutico, logistico - informatico, artistico e filosofico, linguistico - letterario, idealistico e spirituale, ecc.). Non può disconoscere l’importanza del ‘vissuto’ a livello antropologico e strutturale dell’esistenza umana, come neppure cancellare i segni del passato di antiche civiltà che a loro modo pur hanno lasciato testimonianze importanti dell’evoluzione umana. Oggi ci si chiede: quali materie abbiano ancora una precipua funzione conoscitivo/educativa? Quali materie se non quelle basate sullo studio dell’ ‘evoluzione umana’ in ogni campo della sua applicazione pratico-logistica alla base del nostro esprimerci (linguaggio); di osservazione (conoscere, distinguere); del pensare (formulare concetti) che sono all’origine del nostro ‘essere’.
Al dunque m’accorgo d’essere andato oltre, come dire, di essermi lasciato prendere la mano stufo di dover rileggere sui libri dei miei figli, tutto quello che a mia volta avevo studiato (?) sui miei libri di scuola: che in quella data si sono svolte le Guerre Puniche, in quell’altra si sono consumate le ‘Idi di Marzo’ con l’uccisione di Giulio Cesare, quindi facendo un salto di tempo si è giunti all’egemonia delle Repubbliche Marinare, alle lotte intestine dei Comuni, e poi Trafalgar Square con la statua di Nelson che ha sconfitto Napoleone, quindi la Prima, la Seconda, la Terza (?) no quella si è consumata con Hiroshima e Nagasaki, ecc. Che l’Italia è una penisola che fa parte dell’Europa unita (?), che Gli Stati Uniti si chiamano così perché … (?), che la Cina è una grande potenza mondiale, che siamo ormai più di due, tre, quattro miliardi (chi più ne ha più ne metta) di individui che affollano il pianeta, e che …
Ma che palle! (passatemi l'esclamazione), davvero non se ne può più. Allora perché cambiarli ogni anno questi libri se le date restano le stesse (?), se gli accadimenti sono sempre uguali come in un film d’azione che finisce per mancanza d’attori (?). Che forse la Peste a Milano al tempo del Manzoni ha fatto più morti di Auschwitz? Che Don Abbondio lo hanno fatto Papa? Lo capirei se la Rivoluzione Francese dov’esse ancora avvenire (ops!), oppure se Lorenzo de’ Medici fosse in gara per la presidenza della Banca Centrale Europea. Perché se non è così, allora Italo Svevo, classe 1898, che nel suo romanzo ‘Senilità’ narrava di Emilio, un uomo inetto diviso tra la brama d’amore e il piacere che prova per non averli goduti, oggi potrebbe riscriverlo in chiave erotico - viagrano sulla falsariga di ‘Cinquanta sfumature di sesso estremo’.
Chissà, magari Albertino, il primo della classe che raccoglieva le foglie nel parco, anziché farne quadretti di natura morta, potrebbe arrotolarle e farne delle canne per i vivi. E forse Marietta, la mia ex compagna di banco della Terza A, anziché collezionare farfalle spiaccicate tra le pagine dei libri potrebbe succhiare il lecca-lecca sotto il banco. Fatto è che la scuola non mi ha insegnato che Dante, ad esempio, soffriva di incubi notturni e che portava sfiga; che Monti era un triste frequentatore di tombe; che Leopardi era un anarchico rivoluzionario; che Pasolini guardava alla realtà più bieca, o che Lussuria.. beh, lasciamo perdere. Comunque resta il fatto che tanti sarebbero i modelli da ‘copiare’ e che in qualche caso la ‘volontà’ non c’entra se si diventa bravissimi a copiare, come del resto hanno fatto e continuano a fare tutti, da sempre. L’importante è superare il proprio modello.
Per il resto si può essere diversi esattamente come fare cose diverse nella vita, non c’è un ‘must’ che regoli il flusso delle emozioni e dei sentimenti: «Il problema dell'umanità è che gli sciocchi e i fanatici sono estremamente sicuri di loro stessi, mentre le persone più sagge sono piene di dubbi.» - scriveva filosofando Bertrand Russell. Mentre io sono qua che mi sbatto il cervello su cos’altro la scuola potrebbe fare (?). Infine convengo che forse, anziché insegnare ai giovani, così come ai genitori, oltre agli inutili tabù sessuali e le idiosincrasie sociali, si dovrebbe insegnare loro come diventare adulti e anziché contrastarlo, riscoprire il piacere sottile della masturbazione, (in modo da non mettere al mondo così tanti prof imbecilli).
D'evesserci pur stata una ragione se Albert Einstein dopo aver tanto studiato è arrivato a dichiarare: "Temo il giorno in cui il mondo sarà popolato da una generazione di idioti."
Dobbiamo dargli ragione ... oppure no? E che dire in fatto di religione?
Una plausibile risposta è data in “L’eredità della Secular Conference 2017: la libertà dalla religione come diritto umano”. articolo di Monica Lanfranco ripreso da ‘MicroMega’. https://www.nuovaresistenza.org/.../leredita-della-secular-conference-2017-la-liberta-d...
Mentre montavo le brevi interviste che ho realizzato alla Secular Conference di luglio a Londra cercavo di capire cosa mi disturbava, (al netto dell’ovvio disgusto per il tracimare di razzismo e sessismo della rovente estate italiana), nel dibattito intorno agli stupri e alla nazionalità di chi li commette, tralasciando (si fa per dire) l’hate speech diffuso nei social, ormai un must come l’ombrello pieghevole in autunno. L’ho capito quando ho rivolto lo sguardo alla borsa di tela distribuita all’incontro londinese contenente il programma dei lavori: il suo titolo, che ogni anno cambia e sintetizza l’angolazione scelta per ragionare di fondamentalismo, cultura femminista, critica al multiculturalismo era lì, stampato e chiaro:
#Iwant2Bfree recitava il logo: voglio essere libera/libero.
Da cosa? Volendo semplificare si tratta di liberarsi dalla religione, il che non significa dal proprio anelito alla spiritualità, ma dal legame pesante del dogma e dell’osservanza di regole su base religiosa che diventano dettami sociali e politici. Dall’automatismo che, a seconda del colore della pelle, dei tratti somatici e della provenienza geografica ingabbia e categorizza gli esseri umani in uno specifico ambito religioso, culturale, tradizionale. E, così facendo, antepone le (presunte) caratteristiche legate dall’appartenenza culturale all’universalità dei diritti e dei doveri.
Nel caso di Rimini, infatti, molti degli scambi, il più delle volte violenti e rancorosi, si sono appuntati non tanto sullo stupro, ma sul fatto che gli stupratori fossero africani, quindi tout court islamici. Un procedimento di spostamento dal problema della violenza contro le donne, (che è un problema universale) a quello della nazionalità/religione degli stupratori, che è relativo e sposta l’attenzione dal tema principale. Si tratta di un modo di ragionare pericoloso, perché sposta continuamente il focus dal problema principale che, nel caso del fondamentalismo religioso, è il bisogno di rimettere al centro il diritto di critica e la libertà di espressione e di pensiero.
Come ha ben spiegato a Londra Pranga Patel, fondatrice delle Southall Black Sisters:
“La libertà di espressione e di pensiero sono fondamentali, sono scritti nella Dichiarazione dei diritti umani universali e sono il cardine di ogni altro diritto, quindi sono connessi all’autodeterminazione, alla libertà di cultura e di professare, o non professare, la religione, senza essere minacciati da intimidazioni. Poter discutere e criticare è espressione di progresso, e viceversa il progresso si nutre della libertà di espressione. Tuttavia esiste un limite alla libertà di espressione, e per me questo limite scatta quando si diffondono odio e intimidazione contro le altre persone o quando la libertà di espressione viene usata per manipolare e creare un contesto che fomenta la violenza attraverso l’uso regressivo della religione e della fede, che alimenta la violenza e l’odio. L’esercizio della libertà di espressione e di coscienza è fondamentalmente connesso con la libertà di dissentire. Come femministe dobbiamo occuparci del dissenso in varie forme: dissenso verso il patriarcato, verso il neoliberismo, verso il razzismo, verso ogni forma di discriminazione”.
Ciò che alla Secular Conference è stato ribadito in ogni panel è che la libertà di pensiero e di espressione non sono pienamente attuati se nel mondo ci sono paesi dove esiste il reato di blasfemia e apostasia e si rischia il carcere, e la morte, per accuse relative all’offesa della religione. Secondo il recente ‘report pubblicato dall’Economist, citato anche alla Secular Conference’, si tratta di 71 paesi del mondo, a maggioranza islamica, nei quali l’attivismo laico e ateo è perseguito con una repressione violentissima, che quasi sempre colpisce donne e persone omosessuali, due categorie in prima fila nella difesa dell’universalità dei diritti.
L’esistenza così diffusa e persistente nel mondo dei reati di blasfemia e apostasia è un preoccupante indicatore di resistenza del totalitarismo politico su base religiosa.
“Non si tratta di un dibattito filosofico, ha sottolineato Imad Iddine Habib, fondatore del Consiglio degli Ex Musulmani in Marocco; si tratta di questione di vita o di morte per molte persone che si trovano a dover abbandonare tutto ciò che hanno solo per la paura di esprimere quello che sentono. Penso che sia importante stare a fianco e sostenere le persone coraggiose che osano sfidare le regole e alzare la voce dicendo di non essere d’accordo con le imposizioni religiose e di non avere problemi con l’omosessualità o l’apostasia”.
Alla domanda sul perché la libertà di espressione e di pensiero, le due parole chiave della Secular Conference 2017, siano così importanti l’attivista curdo-irachena Houzan Mahmoud non ha esitazione: “La libertà di espressione è sotto attacco nel mondo quando si cerca di criticare la religione, ogni religione: se lo fai nel caso dell’islam, però, il rischio in Occidente è quello di essere accusata di essere razzista o islamofobica. Questo è il motivo per il quale è importante enfatizzare la centralità della libertà di espressione e difendere il diritto alla laicità”.
È il nodo più evidente che a Londra ha percorso tutti gli interventi, come emerso in modo potente nei due momenti di apertura e chiusura dell’assise londinese, affidati rispettivamente a Inna Shevchenko, leader del gruppo Femen, e a Zineb El Razoui, giornalista di ‘Charlie Hebdo’. Mentre la prima ha sostenuto che diritti delle donne e religioni sono incompatibili, El Razoui si è rivolta direttamente alle seconde generazioni in Europa e alla sinistra, che crede di rendere un buon servizio alla causa migrante e antirazzista sottovalutando il fondamentalismo islamico e abbracciando il relativismo abbandonando l’universalismo dei diritti.
“Non ho dubbi sul fatto che l’estrema destra da fermare in Occidente sia l’islamismo - ha scandito El Razoui. Voglio dire agli europei e specialmente alla sinistra: ‘Non cadete in questa trappola. Ricordate cosa hanno fatto gli islamisti alle persone comuniste e di sinistra in Iran o in Afganistan; ricordate che gli islamisti sono finanziati dai peggiori sistemi capitalistici come l’Arabia Saudita o il Qatar. Queste persone non sono rappresentative della cultura del mondo musulmano. Voglio dire in particolare ai giovani musulmani che vivono in Europa: è una cosa buona se volete far conoscere la vostra cultura, ma allora imparate la lingua, scoprite la bellissima letteratura del mondo musulmano, scoprite la musica del mondo arabo invece di vestire un burka o un costume afgano pensando che questo rifletta la cultura del nord Africa”.
Per Zehra Pala, presidente dell'Atheism Association of Turkey: “la laicità è importante per me come donna e come attivista in Turchia, perché è molto più difficile vivere nel mio paese, oggi diventato più islamista: il governo ha ristretto le libertà di espressione soprattutto nei confronti delle donne. Se giri per la strada con i pantaloncini rischi le botte perché i fondamentalisti ti attaccano; se vai alla polizia a denunciare le violenze ti viene detto che sei contro l’islam, visto come ti comporti, e quindi non ti difendono.
Nel mio paese c’è una forte pressione sia in famiglia che a scuola affinché tu stia dentro una gabbia ideologica. Oggi a scuola, sin dalle elementari, viene insegnata la jihad e si è deciso eliminare dai programmi la teoria darwiniana dell’evoluzione perché si tratta di una visione laica.
Come motivo il governo sostiene che il cervello infantile non può capire Darwin, ma mi chiedo: e invece nell’infanzia si possono capire le regole della jihad islamica? È una abile tecnica manipolatoria, perché è più facile avere consenso se sin dall’infanzia si indottrinano le menti. La violenza non è solo quella fatta al tuo corpo con lo stupro, ma anche quella che si fa manipolando le menti più fragili e malleabili. Il meccanismo adottato è anche quello della paura, perché a scuola si minacciano i piccoli dicendo che se non segui queste regole vai all’inferno. È così che sono stata educata anche io: la mia famiglia ha provato a fare pressione su di me, così come la scuola, ma non ha funzionato perché ero lì continuamente a fare domande. Per questo è così importante pensare in modo libero e, anche se ci sono pressioni, dobbiamo fare in modo che le persone possano pensare liberamente con la loro testa”.
Pensiamo allora a come ‘reinterpretare il futuro’ che se non spetta a noi matusalemme certamente spetta ai nostri figli, e costruiamo insieme oltre che de-costruire il passato, per sostituirlo con il nulla (di fatto e di pensato), e postiamoci a diventare creativi di nuova volontà, se non altro per lasciare la possibilità di rimettere insieme i pezzi di questo mondo (pianeta) che abbiamo ridotto in frantumi. In “Non sperate di liberarvi dei libri” – Umberto Eco / Jan-Claude Carrière, scrive, parafrasando in chiave brillante l’ammonimento a non buttare via il passato di una cultura di conoscenza, la cui universalità è parte integrante del DNA antropico. Piuttosto preoccupiamoci “..quando la salvaguardia è possibile, quando si trova il tempo (e il modo) di mettere gli emblemi di una cultura in luogo sicuro”, di ripararla dalle incursioni disgregative (de-costruttive), pensiamo piuttosto a come salvarla, a cosa salvare, prima di esporla al rogo di icariana memoria.
Se “..il sogno di volare ossessiona(va) l’immaginario collettivo da tempi immemorabili”, oggi non è più così. “Io credo – scrive Jean-Claude Carrière (op.cit. Bompiani 2009) – in effetti che molte invenzioni del nostro tempo siano la concretizzazione di sogni molto antichi. […] Come se Virgilio, scendendo negli inferi, avesse preconizato il mondo virtuale del quale ci stiamo compiacendo. Questa duscesa agli inferi è un tema molto bello che la letteratura mondiale ha affrontato in modi molto diversi. È il solo modo che ci è stato dato per vincere contemporaneamente lo spazio e il tempo, ovvero per penetrare nel regno dei morti, o delle ombre, e viaggiare contemporaneamente nel passato e nell’avvenire, nell’essere e nel nulla (che non è il ‘niente’ come ultima parola). Di raggiungere così una forma di immortalità virtuale”.
Come re-impossessarci del futuro imprevedibile (?).
“Il futuro non tiene conto del passato ma neanche del presente – scrive ancora J.C. Carrère - . Entri cinquant’anni saremo tutte creature bioniche. Quello che veramente mi colpisce è la completa sparizione del presente. […] L’avvenire è come sempre incerto e il presente progressivamente si restringe e si sottrae. […] Se la nostra memoria è corta, allora è questo passato recente che incalza il presente e lo spinge, lo sbilancia verso un futuro che ha assunto la forma di un immenso punto interrogativo. O forse esclamativo. Dov’è passato il presente? Il meraviglioso mopmento che stiamo vivendo e che molti cospiratori cercano di rubarci?” …
“Riprendo contatto con questi momenti, certe volte, in campagna, ascoltando la campana della chiesa che suonando le ore mi dà una specie di ‘la’ che mi riporta a me stesso: Ah, sono solo le cinque… Come te (Umberto), anch’io viaggio molto, mi perdo nei corridoi del tempo, nelle sfasature delle ore e ho bisogno, sempre di più, di riconnettermi a questo presente che ci è ormai impercettibile. Altrimenti avrei l’impressione di essere perso. E forse, anche, di essere morto”.
“In questo caso – scrive ancora U. Eco (op.cit.) – non è un problema di memoria [collettiva] che va perduta. Si tratta piuttosto, a mio parere, di un problema di labilità del presente. Non viviamo più un presente placido ma siamo costantemente sotto sforzo nel prepararci al futuro.” A cui risponde J.C. Carrère (op.cit.): Sì, certo “quando il mondo è in rivoluzione permanente, sono i figli che insegnano ai genitori. Ma i loro figli cosa impareranno da loro”, se avranno buttato via il bagaglio che tanto abbiamo fin qui salvaguardato? “Siamo ormai collocati nella mobilità, nella mutevolezza, nella rinnovabilità, nell’effimero (spinto), in un’epoca in cui, paradossalmente viviamo sempre più a lungo”.
Riprendiamoci la speranza ... già che ci siamo (?)
Se il futuro è imprevedibile voglio pensare che da qualche parte uno spiraglio di luce, seppure effimero, ci aspetti:
‘nella luce del tempo’ (Gioma)
..fin dentro il mistero della vita
nato e rinato
un’infinità di volte
senza coscienza del trascorso
d’intraprendere mai stanco
nuove strade
nel segno dell’avventura
d’ogni giorno
ciò che mi suggerisce
di spingermi alla ricerca
di continenti visti forse
ignorati sempre
luoghi e paesi diversi
luminosi e oscuri mai
dove risorgere e rigenerarmi
felice infelice
d’elemosinare l’acqua al cielo
nutrirmi di radici
trovare linfa e forza
nella madre terra
la cui natura forse ho calpestata
violata mai
genti diverse
volti conosciuti mai e sempre
con gli stessi fardelli portati
sulla testa con dignità
dentro il peso degli anni
sulle spalle stanche
di un vivere conteso
a un destino benevolo
solo talvolta iroso
crudele
solo un modo di dire
l’afflato della vita che scorre
a oltranza è un fiume
mai nato / mai morto.
“Be’ allora smetto di imparare a memoria (e di scrivere) poesie e mi bevo due bottiglie di whisky al giorno. Grazie di avermi dato una speranza. ‘Merdre!’, come diceva sempre Ubu” (U. Eco op.cit.).
Se è vero che il passato non smette di sorprenderci, più del presente, più del futuro forse! Voglio qui ricordare – scrive J.C. Carrière – una citazione del comico bavarese Karl Valebtin: “Anche l’avvenire era meglio un tempo”. È sua anche quest’altra annotazione piena di buon senso: “Tutto è già stato detto, ma non per tutti”. “Siamo in ogni caso arrivati a un momento della storia in cui possiamo delegare a delle macchine intelligenti, intelligenti dal nostro punto di vista, la preoccupazione di ricordare al nostro posto, sia le cose buone che quelle cattive. Michel Serres ha toccato questi temi in un’intervista rilasciata a “Le Monde de l’éducation” dicendo che se non riusciamo più in questo sforzo di memorizzazione, allora “ci resta solo l’intelligenza”.
“Probabilmente c’è una cosa che non sparisce (e che dobbiamo preservare dallo scomparire), ed è la memoria di ciò che abbiamo provato nei diversi momenti della nostra vita. La memoria preziosa, e talvolta ingannevole (pur sempre meravigliosa), dei sentimenti, delle emozioni. La memoria affettiva. Chi potrebbe liberarcene e a che pro?”.
Non disperate, ci sarà un prossimo 'Bla, bla, bla', è una promessa.
Note:
“Non sperate di liberarvi dei libri” – Umberto Eco / Jean-Claude Carrière - Bompiani 2009.
Jean-Claude Carrière
È sceneggiatore cinematografico e televisivo, autore teatrale, romanziere, poeta e saggista. Ha collaborato con Buñuel, Marco Ferreri, Giuseppe Bertolucci, Louis Malle, Jean-Luc Godard e Jasùs Franco.
Umberto Eco
È stato un filosofo, medievalista, critico e saggista, semiologo e romanziere di chiara fama, tra le sue opere ricordiamo “I limiti dell’interpretazione” 1990; “Kant e l’ornitorinco” 1997; “Dall’albero al labirinto” 2007; e numerosi romanzi, fra i quali “Il nome della rosa” 1980 cui hanno fatto seguito numerosi altri, fino a “Numero Zero” settimo ed ultimo romanzo edito da Bompiani 2015.
Monica Lanfranco
È giornalista indipendente, femminista, blogger di Micromega e del Fatto Quotidiano, scrittrice e formatrice su differenza di genere, sessismo, comunicazione e conflitto. Nel 1994 fonda il trimestrale Marea. Dal 2013 gira l’Italia con la piéce teatrale “Manutenzioni, uomini a nudo”, primo laboratorio italiano per uomini contro la violenza tratto da “Uomini che odiano amano le donne”. Nel 2016 è uscito “Parole madri. Ritratti di femministe: narrazioni e visioni sul materno”.
*
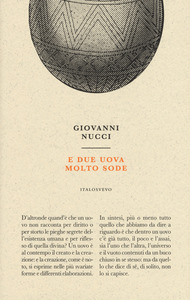 - Libri
- Libri
Felice come una PasQua - filosofia e altro.
(una risposta filosofica al ‘rito della festa’ e ‘due uova molto sode’ magari di buon cioccolato).
Il mondo è pieno di luoghi incerti, suscettibili e variabili che non sempre si rivelano o a cui semplicemente non facciamo caso. Spazi che cambiano come cambia il vento, la stagione o il punto di vista di chi li osserva. L’indole dell’uomo è multiforme ma la verità raggiunta finora ha una sola forma: la ‘forma dell’uovo’.
«Dell’uovo?»
Sì, proprio così, in quanto simbolo millenario, l’uovo ha guadagnato un ruolo di tutto rispetto nella storia dell’alimentazione come dell’arte, della musica come della letteratura. Fra pitture rinascimentali e declinazioni contemporanee, fra storici interpreti e nuove valenze performative, la forma dell’uovo è riconosciuto quale archetipo ‘cosmico’.
Simbolo di fecondità e di rigenerazione, rinascita e trasfigurazione ha assunto nel tempo gli aspetti del tutto particolari che sono poi confluiti nella tradizione cristiana, e non solo, della vita eterna, e che ritroviamo fino ai giorni nostri nella produzione di forme nuove proprie dell’immaginario collettivo: dalle nuove vie della rappresentazione, della metafisica applicata alle nuove tecnologie, alla fantascienza.
Insomma, quella che sembra una domanda impropria, un banale trompe l’oeuf sul dilemma più sterile nell’universo delle domande retoriche, è invece seria. Quante volte ci siamo sentiti domandare se ‘è nato prima l’uovo o la gallina?’, e mai siamo stati in grado di rispondere; mai che qualcuno ci abbia dato una spiegazione verosimilmente logica.
A quanto pare la logica c’entra fino a un certo punto, ma se spostiamo la domanda e la riferiamo a un’intenzione di ricerca della forma, potremmo ben dire che è piuttosto un progetto infinito dell’estetica dell’arte. Altresì se la riferiamo alla socializzazione del pensiero e/o dell’immaginario, ècco entrare in campo l’estetica filosofica. Non di meno, nella prospettiva filosofica, alla domanda iniziale, potremmo rispondere con un’altra domanda: ‘la forma dell’uovo’ è un presupposto di un processo di teorizzazione dell’ozio?’.
«Dell’ozio?»
Sì, proprio così, in quanto è figlia del senso altruistico dell’ozio, che trova nell’attività riflessiva (della gallina), il significato fenomenologico dello spirito (Hegel) che gli da forma. Dove si descrive il percorso che ogni individuo deve compiere, partendo dalla sua coscienza, per identificare le manifestazioni (la "scienza di ciò che appare", la "fenomenologia"), attraverso le quali lo spirito si innalza dalle forme più semplici di conoscenza a quelle più generali fino al sapere assoluto.
Un’appropriazione, come dire, impropria, che non nasconde segni di criticità se la confrontiamo con l’affermarsi dell’individualismo moderno dove molti ‘vizi’ del passato diventano ‘virtù’ del presente come fossero principi cardine di ogni relazione sociale. Non è affatto così che può girare l’uovo che abbiamo appena trovato, né può esserlo se non a scapito di quelle attività che ci sforziamo di promuovere come la socievolezza, il collettivismo, la solidarietà, l’altruismo, non vi pare?
«No, non ci pare!»
Al contrario l’egoismo, l’indifferenza verso l’altro, si tramutano dal bene (verso l’altro / gli altri) nel male, producendo feroci gerarchie, dinamiche di esclusione, disuguaglianze foriere di guerre e stermini di massa, di intere popolazioni che fuggono in massa ecc. La realtà della ‘forma dell’uovo’ sta ad affermare un principio ‘etico altruistico’ (Nussbaum) di appartenenza ed empatia sociale, capace di stabilire un rapporto empatico anche con qualcuno che sta al di fuori del proprio gruppo: in termini sociali, della propria comunità, della sfera pubblica come di quella privata, di fare della sobrietà uno stile di vita.
L’ozio quindi come forma di altruismo che si colloca nello spazio-tempo di una scelta di vita, per ritrovare il senso della libertà che viene meno a causa dei ‘paletti’ (confini, soglie, impegni, scelte ecc.) che costantemente usiamo per infliggerci, masochisticamente, quel ‘qualcosa da fare’ che tenga impegnati, e che ha schiavizzato, demoralizzato e depresso l’umanità fin dalle origini. Ma attenzione, ‘oziare’ non significa libertà di ‘non fare niente’ ma di scegliere di essere liberi di vivere la vita che vogliamo fare con dignità, nel rispetto degli altri e della società in cui viviamo. Preso alla lettera significa anche ottemperare ai doveri sociali pur mantenendo il ‘libero arbitrio’ dei gioudizi.
«Libero arbitrio?»
Non è forse autodeterminazione della gallina fare l’uovo o non farlo? Non c’è nulla che dev’essere fatto per forza, in fondo aver deciso ‘la forma dell’uovo’ è stato indubbiamente frutto di una costruzione mentale. Un pensiero autonomamente riflesso di ciò che la natura in sé permetteva di esprimere. Ciò per quanto ‘la gallina non sia un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente’ (Jannacci –Pozzoni-Pozzetto) e che, infine, conferma di avvalersi del ‘libero arbitrio’ (proprio degli animali) di lasciarsi prendere e cucinare.
Compiacente o no la gallina può pensare senza l’uso delle parole e ciò che pensa è che per quanto ce la possiamo mettere tutta, non siamo capaci di fare le uova, solo di romperle. È così che noi ‘..facciamo uso di una montagna di parole tutti i giorni, parliamo spesso troppo, e a volte abbiamo la fondata impressione di parlare senza pensare. Il che ci sembra una cosa sconsigliabile, non solo per le sue conseguenze pratiche (non logiche), ma anche perché lede una sorta di presupposto implicito del linguaggio: che dietro a ogni parola ci sia un pensiero’ (Ferraris).
«Perché, che cosa si fa con il linguaggio oltre a pensare?»
No, proprio non saprei. Ciò che so è che ‘..il nesso tra pensiero e linguaggio non è sempre coerente; che la dimensione pragmatica del linguaggio va oltre ogni dimensione pratica; e infine, che ‘..consiste in quello che nel gergo dei filosofi si chiama caveat, cioè una messa in guardia contro quello che, sempre nel gergo, si chiama olismo linguistico, l’idea che tutto sia linguaggio (per strano che possa apparire qualcuno l’ha davvero pensato) o che il linguaggio possa tutto’ (Ferraris).
Ma non tutto avviene così, sarebbe come ‘mettere tutte le uova in un paniere’, similarmente alla nota canzone ‘I'm putting all my eggs in one basket’ (Berlin); magari scommettendo di non romperne nemmeno una. ‘Be, è chiaro, tutto dipende da come vogliamo cuocerle , avverte Giovanni Nucci, autore di “E due uova molto sode” (Gaffi Edit. 2017) apparso nella Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile.
Niente di più azzeccato se si tiene in conto l’efficacia di una scrittura come metafora della cottura delle uova, in cui ‘la forma dell’uovo’ è ‘..al contempo il creato e la creazione: e la creazione, come è noto, si esprime nelle più svariate forme e differenti elaborazioni. In sintesi, più o meno tutto quello che abbiamo da dire a riguardo è che dentro un (solo) uovo c’è già tutto, il poco e l’assai, sia l’uno che l’altra, l’universo e il vuoto contenuti da un buco chiuso in se stesso: ma da quello che dice di sé, di solito, non lo si capisce’ (Nucci).
«Ma di che cosa stiamo parlando?»
Non certo dell’Uovo di Colombo che è tutt’altra cosa, come è noto l'espressione 'Uovo di Colombo' si usa quando si descrive un modo incredibilmente banale di risolvere un problema che sembrava senza soluzione. Si narra infatti che Cristoforo Colombo venne invitato a una cena al suo ritorno dall’America e che durante tale banchetto alcuni gentiluomini spagnoli cercarono di sminuire le sue imprese, dicendo che chiunque ci sarebbe riuscito. Ebbene Colombo li sfidò a mettere un uovo diritto sul tavolo, senza che cadesse. Non riuscendoci, i gentiluomini sfidarono Colombo, chiedendo anche a lui di farlo: il navigatore battè leggermente l’uovo sul piano e lì lo lasciò, dritto e fermo. Gli spagnoli si lamentarono affermando che anche loro potevano fare una cosa così e Colombo rispose che loro l’avrebbero potuto fare, ma lui l’aveva fatto. Come dire che “l’uovo ha una forma perfetta benché sia fatto col culo”. (Munari)
«Tutto qui?»
Assolutamente no, ‘..Inutile cercare di classificare questa raccolta. Non si tratta propriamente di racconti – avverte l’autore – semmai sarebbe il caso di parlare di resoconti, e neppure troppo attendibili. Certamente questo non è un libro di cucina. Forse l’unica sua certezza risiede nel fatto che qui si parla di uova. Per il resto è un po’ come in uno di quei pasticci di spaghetti che sanno fare così bene a Napoli: sono le uova atenerlo insieme, ma dentro puoi trovarci di tutto.’
Un ricco menu quindi in cui troviamo piatti originali di chicche filosofiche, aneddoti, short stories più o meno inventate, e ossimori come dessert:
Intro:
Stracciatella per principianti.
Primi piatti:
Uova alla Benedict – al prosciutto cotto o al salmone affumicato
Lo scrittore alla coque – con tanto di sigla musicale ‘Morning Glory’
Il Maestro al piatto – musicista e letterato e quant’altro
Secondi piatti:
Frittate e Soufflé – per tutti i gusti
L’uovo di Amleto – per gli addetti ai lavori un po’ pesante da digerire
E due uova molto sode … (un epilogo improprio)
Certo direte voi, non sono tutte uova di giornata, però l’autore Giovanni Nucci, cela fra le righe una freschezza degna di uno scrittore di grande attualità linguistica. Convincente a tal punto da far credere che le preferisce con la maionese, ‘piuttosto che al tartufo’, nel modo in cui Mina canta “Più del tartufo sulle uova” di A. Mingardi …
“Più di qualsiasi cosa possa dire
Più di una giornata in riva al mare
Più del pane col salame
Più di quando mangio quando ho fame
Più di un tramonto rosso fuoco
Più di una vincita al gioco
Di una serata con gli amici
Più dei bei tempi felici
Io ti amo, io ti amo
E forse è meglio che lo dica piano
Perché ho paura che il mondo se ne accorga
E mi riporti dall'alto fino a giù
Più di un grattacielo di New York
Di una medaglia d'oro nello sport
Più di un rialzo in borsa
Più di una bella corsa
Più di un qualsiasi invito
Di un lavoro ben riuscito
Più del tartufo sulle uova
Di una motocicletta nuova
Io ti amo, io ti amo
E forse è meglio …
Più di un qualsiasi invito
Di un lavoro ben riuscito
Più del tartufo sulle uova
Di una motocicletta nuova
Io ti amo, io ti amo
E forse è meglio …
Fino a giù, fino a giù
Io ti amo, io ti amo, ti amo di più.”
E che dire di ‘sei uova alla coque’ che Lelio Luttazzi elenca in “Canto” (anche se sono stonato)? Solo …
“Perché da cinque mesi canto
il mio amore in sordina perché,
cara,
temo di farmi sentire da te.
Ma da quest’oggi ho deciso di cambiare,
provando ad urlare con voce da rock.
Mi faccio sei uova alla coque
e come una belva da ring,
ti sforno quintali di swing.
Sperando di darti lo shock
che forse mi dirai di sì.”
E voi come le preferite?, con la maionese o con il salmone, strapazzate con una goccia di aceto balsamico o al chili che più piccante non si può, a voi la scelta. L’importante è continuare a leggere, ben sapendo che si tratta di ‘letteratura inutile’ benché di prestigio.
www.italo0-svevo.it
@italosvevolibri.it
*
 - Poesia
- Poesia
Flavio Ermini o la ricerca infinita della Poesia d’Autore
“l’alto dei cieli”
non ha fondamento né gravità l’alto dei cieli
discosto com’è dal fuoco al pari del mondo abitato
che dalle acque creaturali viene circoscritto
per quanto non si tratti che di assecondarne la caduta
consentendo così alle forze relittuali
di protendersi una volta ancora verso il principio
per misurare delle forme il grado di accoglienza
nell’inclinazione dei sensi entro i poli del finito
in cui si situa il divino per annunciare il dolore
(Flavio Ermini)
Immagini per a-solo di poesia.
Con l’affermazione “La poesia non è un genere letterario”, tema del Simposio aperto nell’Ottobre 2017 alla Biblioteca Nazionale Braidense, Flavio Ermini, poeta, narratore e saggista, nonché direttore della rivista di ricerca letteraria Anterem fondata nel 1976 con Silvano Martini, di fatto conferisce alla ‘poesia’ una prospettiva dinamica esclusiva che la distingue dalle altre forme narrativo-letterarie, in ragione di una di empatia sostanziale che l’accomuna al canto e alla musica, per lo più afferenti alla sfera del patrimonio immateriale. La ‘poesia’, non necessariamente scritta, offre quindi la possibilità di catturare molti aspetti della vita delle immagini che ancora oggi sfuggono alla descrizione letteraria, per quanto la si concentri in due ambiti distinti che si profilano nella nostra incompiutezza e nella nostra mancanza d’essere, ancorché non rispondenti alla domanda sulla nostra esistenza:
“L’essere umano è il suo avvenire ma anche la domanda sul suo avvenire, cioè non solo esiste, ma vuole sapere il perché della sua esistenza.” (Fabio Squeo)
Da un lato, quindi, la rappresentazione onomatopeica della ricerca linguistica oltre che acustico-sonora che è all’origine della parola, e “che consente di riguadagnare la continuità originaria tra parola e mondo”; dall’altro, l’avanzare costante di una ricerca che adotta dalle varie scuole stilistiche, i differenti approcci teorici e metodologici, riguardanti ‘il pensiero visivo’ e la ‘percezione dell’immagine’, qui intesa nell’accezione di ‘percezione delle forme dell’arte’. La ‘poesia’ dunque come forma d’arte a se stante di un “pensare che può strettamente coniugarsi con il poetare, alla luce di un rapporto sempre nuovo tra parola e senso”, e per quanto la ‘ricerca di senso’ oggi possa sembrare in contrasto con l’attualità intimistico-minimalista inerente più all’indicibile che al non-detto. O, diversamente, con il linguaggio massimalista-globalizzato in cui la ‘poesia’ ripone la riflessione sul ‘senso’ che, seppure in differenti modalità di ricezione e comunicazione, ciò non diminuisce la portata antropologico-culturale del messaggio poetico che racchiude in sé.
La natura della poesia, infatti, si avvale di suoni ‘suggestivi d’immagini’ che si traducono in lineamenti audio-visivi conformi alle diverse espressioni dell’arte tout-court; e successivamente in forme connaturate al canto e alla danza (vedi il canto degli uccelli, la danza di corteggiamento di molte specie animali, ecc.). Ciò che nel tempo ha permesso di penetrare l’universo sonoro dell’habitat in cui viviamo, riscattandolo da culture e tradizioni diverse, entrate a far parte del ‘patrimonio immateriale’ dell’umanità. Ma ‘vedere la poesia’ nelle immagini della rappresentazione visiva, ed ascoltarne la musicalità intrinseca (nelle forme come nei colori), fa capo al concetto fondamentale della ‘performance‘, (Victor Turner) inerente all’estetica e al liminale:
“La performatività può essere utilizzata come chiave interpretativa di alcuni caratteri delle nuove tecnologie e in particolar modo può essere una nozione utile per connotare di una veste teorica la ‘costruzione di senso’ attraverso l’agire favorita dagli strumenti mediatici digitali”, oggi a nostra disposizione. “Per comprendere appieno il concetto di ‘performatività’ è però necessario leggerlo come pratica necessaria a una ridefinizione critica del reale e potenziale non-luogo di margine e di passaggio da situazioni sociali e culturali definite a nuove aggregazioni sperimentali. La riflessione teorica sul concetto di ‘performance’ permette infatti di penetrare le fenomenologie liminoidi (zone potenzialmente feconde di riscrittura dei codici culturali) e da qui anche la trasformazione sociale stessa” (Wikipedia).
Poesia per immagini.
Con l’aver dato ‘forma scritta’ al ‘dire’, attraverso il percorso accidentato dei segni grafici e, successivamente, alla sua trasposizione simbolica in quanto metafora figurativa, la ‘poesia’ assurge alla sua forma preminente di ‘creatrice d’immagini’, raggiungendo il suo apice nell’aver dato ‘voce’ all’immagine che la rappresenta. Per cui attribuire alla ‘poesia’ una certa corrispondenza e/o la relazione con l’immagine (grafica, pittura, scultura, fotografia ecc.), è inevitabile. L’alleanza introspettiva, di segreta comunicazione fra le parti, è, per così dire, incommensurabile. Al punto tale che un’immagine è poetica anche senza la suggestione del verso scritto che l’accompagna. Allo stesso modo che si può vedere un componimento poetico, se non addirittura ascoltarlo, senza la necessità di utilizzo di una immagine o di una forma specifica d’arte. In questo la ‘poesia’ è paritetica alla musica, al canto e alla danza, perché: “fonte di formazione e deformazione di un nuovo atto significante” (Giorgio Bonacini).
Atto comprensibile di un prevedibile prosieguo di andare ‘oltre’ la forma, aprire un varco subliminale al testo scritto o figurativo, alla esegesi della parola contenuta e/o scivolata negli interstizi bianchi che intercorrono tra le righe, in cui il ‘dire’ risulta destrutturato dalla forma del ‘voler dire o non voler dire’ (nel senso di edificazione); e dal logos in quanto pensiero e verbo (edificante) del poetare. “Il dire del poeta ci parla di un ‘altrove’ dov’è in opera una prospettiva rovesciata rispetto al mondo sensibile” – scrive Flavio Ermini (in “L’altrove poetico” Editoriale n. 95 - Anterem), in cui l’immaginario è il vero interfaccia del poeta che se “non nomina le cose esperibili”, pur si avvale di binomi di ‘senso’ come: fisico-psichico, interiore-esteriore, indefinito e comunque intenso e/o estremo. Allora l’ ‘altrove’ è il Nulla e il Tutto è l’oceano e il deserto, la germinazione e la seccura, la speranza e l’abbandono, il moto e la quiete, l’essenza e l’assenza, l’immobilità e il trapasso, la stasi e la morte, plausibilmente contenuti nel dialogo poetico.
Immagini e forme queste, preminenti di concetto e contenuto, tuttavia impossibili da identificare e/o configurare se non nell’ambito di un ‘altrove’ in costante trasformazione, nelle differenti modalità di una cultura recepita nelle sue diverse identificazioni verbali-acustiche e sonoro-musicali, nonché coloristiche e luminose che danno luogo alla trasparenza dell’aere, in cui il ‘senso smarrito della poesia’ si ritrova e ci orienta verso il mistero del nostro essere. ‘Immagini coloristiche’ e ‘forme poetiche’ dunque, come memoria storica dell’esistenza antropico-naturale compresa tra realtà massima e finzione estrema, all’interno di una location-abitativa e una docu-fiction in cui la presenza e/o l’assenza umana si realizza nello ‘sconfinamento di senso’, allo stesso modo che nell’espresso sentimentalismo e nell’amore fugace, nella commedia liminale (farsa), come nella drammaticità luttuosa (tragedia), al livello della soglia della coscienza e della percezione.
Le dimore della poesia.
“Qui si viene non per celebrare una dimora, un giardino, ma perché ci si è persi” – cita Flavio Ermini (in “Non c’è fine al principio” Editoriale n. 94 - Anterem). La frase è del filosofo Lacoue-Labarthe alla quale inavvertitamente sembra rispondere proponendo alla lettura un’altra frase: “Se volete incontrarmi, cercatemi dove non mi trovo. Non so indicarvi altro luogo.”, del poeta Giorgio Caproni (in “L’altrove poetico” n. 95 - Anterem). Un non-luogo dunque che pure è “il luogo che ospita la domanda sull’essere, testimoniando la profondità della physis quale si era rivelata agli albori del pensiero”. Se si considerano qui le due frasi contigue, non senza una forzatura intellettuale, si potrebbe qui raffigurare un ‘ossimoro’ dove dimora-persi / altro luogo (dove non mi trovo), spingono verso quell’ ‘altrove’ dove “non c’è fine né principio”, che è poi il luogo della ‘poesia’, in cui:
“… la natura può ancora parlarci come all’origine parlava ... dove le antiche parole tornano alle nostre labbra come strappate al silenzio; vere quanto è vero lo sgomento dinanzi all’inconoscibile.” (Flavio Ermini)
Ancora più significativo è il principio immateriale poetico espresso nella ‘physis’ nel quale fin dall’antichità si cercò di cogliere il ‘senso’ della realtà in cui l’uomo è immerso nel suo divenire: “La poesia impone di accettare l’essere nel mondo in cui si dà, e implica un interrogarsi sul venirci incontro della molteplicità, un interrogarci sul come la parola può salvaguardare l’essere dall’apparenza. La parola è poetica – e quindi vera – allorché fa sì che l’essere sia. È in questo ‘lasciar essere’ che la parola svela il senso (della poesia) ed è dunque presso di essa quando ne preserva la differenza”. Differenza in quanto termine di opposizione e contrapposizione che interviene a spiegare le realtà particolari intrinseche della funzione poetica sottoposta al divenire, che dev’essere immutabile, previo l’inconfutabilità del pensiero che l’ha espressa, nel modo e nei termini del poeta, perché verità dell’essere.
Il ‘gioco filosofico’ (perché di questo si tratta) si avvale qui dell’interposizione di punti di riferimento alquanto labili, in cui la ‘poesia’ è sinonimo di mobile (solubile), contro la ‘parola’ per sua natura immobile (insolubile), malgrado l’alterità dei contrari che ne negano la relativa effettuazione. Si ha dunque che se possiamo considerare la ‘parola’ come ‘liquida’ per effetto della ‘Retrotopia’ (Zigmunt Bauman) in atto; ancor più la ‘poesia’ si fa evanescente, si volatizza nell’aere, spingendosi nella germinazione del nuovo che, al pari della fotosintesi clorofilliana s’avvale della metamorfosi della forma data, onde per cui dissoi-logoi “le parti mutano ma tutto resta immutevole” (Anassimandro), in quanto le differenze ‘affermazione e negazione’ mantengono uno stesso valore.
Flavio Ermini, in qualità di scrittore e poeta si inserisce nel ‘gioco’ sfruttando proprio questa formula inconfutabile con le sue pertinenti scelte Editoriali, interponendosi, per così dire, nelle linee direttrici della raccolta dei testi che compongono ogni singolo numero della Rivista Letteraria Anterem.
Alcuni esempi di ‘altrove’ poetico:
“Non m’interessa pensare al mondo al di qua del mondo” (Nietzsche)
“Si potrebbe dire che abbiamo due destini: uno mobile e senza importanza, che si compie; e un altro, immobile e importante, che non si conosce mai.” (Musil)
“Lontano dal cammino degli uomini.” (Parmenide)
“Ma i viventi commettono tutti l’errore di troppo forte distinguere. Fiorire e inaridire sono a noi ugualmente noti.” (Rilke)
Alcuni dialoghi inerenti all’ ‘altrove’ poetico:
“Poesia e pensiero in dialogo” - di Adriano Marchetti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017 (estratto).
Poesia e pensiero sono distinti come i due poli in cui si coniuga il linguaggio, in ciò che vi è di più profondo, di più elementare e più iniziale, per vibrare infinitamente in tutta la sua estensione. […] Appartiene alla tradizione occidentale una poesia che parla nella convinta presunzione di essere poetica. Diventa arte, il suo rapporto con la filosofia è apparso difficile, forse ossessivo. Nell’arroccamento sul proprio territorio autonomo e nella irresponsabilità verso qualunque altra disciplina che ha attraversato, si riflettono i grandi stereotipi: si dice per esempio che la poesia è irrazionale, emozione, sentimento, immaginazione, rivelazione. Mentre il pensiero sarebbe rappresentazione, razionalità, logica. Il filosofo, difende in forme diverse la sua idea. Il poeta maschera in forme diverse quell’idea. L’ambiguità che nel filosofo è una colpa, nel poeta è un pregio. […] I decostruzionisti giungono persino a ipotizzare che poesia e filosofia siano la stessa cosa e che si diversificano solo nella scrittura che utilizzano. […] La filosofia inizia come una domanda di senso e non ripudia la rivelazione verbale del canto. E la poesia sa di trasmettere un certo sapere.
C’è, per così dire, una sovranità terroristica della poesia rispetto a una sorveglianza sapiente dei filosofi. Il tessuto del linguaggio filosofico si sottopone a una sorta di metafora continua, costringendo gli stessi concetti che utilizza a trasformarsi. In più ambiti i filosofi riconoscono nei versi forme dell’esperienza che già hanno avuto una sorta di canonizzazione filosofica; si fanno aiutare dai poeti in ciò che dicono a cornice della loro opera. Tuttavia non si tratta né di poesia filosofca né di filosofia poetica. Per comprendere tale indissolubilità e insieme singolarità occorre risemantizzare i due termini del rapporto. La poesia che pensa spporta la contraddizione, porta dentro di sé il pensiero e resta come in attesa sulla soglia, lasciando che le domande siano sospese al centro della coscienza profonda e dolorosa dell’ambiguità. Da una parte il rigoglio dell’essere e dall’altro la sofferenza – facce di una stessa medaglia – fanno sì che il poeta assuma su di sé, […] “tutte le forme d’amore, di sofferenza, di follia” (Arthur Rimbaud). […] La filosofia non smette d’interrogare la poesia e si trattiene su quella soglia dove la poesia continuando a pro-vocarla e a sfidarla, le restituisce le parole con un tono nuovo.
La poesia smaschera la filosofia se questa presume di essere l’ultima parola del mondo. L’ultimissima parola non è mai stata detta; risuonerà al di là del mondo, altrove. […] Dal canto suo il pensiero impedisce al canto di essere poesia di se stessa. Né identità né confusione, né esclusivamente ombra né piena luce, né reciproca impenetrabilità. Il loro dialogo è possibile a condizione che il pensiero non sia ridotto a esoressione logica autosufficiente e che la poesia non sia compresa come un riflettersi estetico di se stessa. La nostra epoca, enigmatica nella sua oscillazione tra illimitata potenza e radicale alienazione, ci offre la prova dell’assenza di fondamento. […] Il tempo favoloso della scoperta del mondo – l’infanzia del mondo – è solo un relitto alla deriva, e risibile è il progresso nella sua presunzione di perfezione ‘naturale’. […] Il linguaggio raggiunge il poeta che lo eredita per la sua estrema sfida nell’epoca di compimento ed esaurimento della metafisica. […] Anche la filosofia, o (ri)pensa se stessa su modalità conoscitive che a lungo andare la inducono a riconoscere il proprio vuoto, o deve uscire da sé, dal circolo virtuoso dell’autotrasparenza, rinunciando al dominio logico che si dà ragione da sé.
La separazione tra poesia e pensiero è in realtà una relazione unitiva dei due modi ritmici che portano il linguaggio al linguaggio. La poesia dà da pensare al pensiero e si accolla il dovere di pensare, ma non si pensa. Da parte sua, il pensiero, benché con modalità differenti, scruta la poesia, impedendole di essere poesia della poesia, cioè autolegitimazione di fronte al pensiero. Quest’ultimo, per quanto assolutamente radicale, non è in funzione di una conoscenza fondatrice, ragionevole e rassicurante, così come la poesia non è letteratura assoluta né tanto meno mistica ante litteram. […] La loro conversazione accade nell’intersezione della loro comune origine. L’origine non può essere pensata né come nulla né come qualcosa; la poesia scaturisce tra quel nulla e quel qulcosa, tra l’indefinito della negazione e la potenza dell’affermazione. Tra il nulla del nichilismo che nega il reale e l’illusione della rappresentazione che imita la natura c’è questo luogo vuoto , in cui ciò che è può apparire e raccogliersi nel suo dire silenzioso: un prima dell’inizio, un movimento inaugurale – vibrazione scaturente di ciò che perviene continuamente a sé.
Non c’è origine, ma accordo immediato con una perpetua nascita a cui s’intonano i modi e le interrogazioni della scrittura, attraverso l’arte della variazione, della brevità esplosiva dell’istante al vocativo ostinato, verso qualcosa che si rivela riservandosi. […] La parte radiosa, l’alêtheia della physis, si lascia intravedere solo sfuggendo alla vista. Il suo dischiudersi universale appare nel suo ritiro in seno all’oscurità, dove la parola si rifiuta di dimostrare e decifrare, facendo solamente segno alla sua scaturigine. (Del resto), … se fosse la piena chiarezza, sarebbe compiuto e immutabile; se fosse totale oscurità, il suo accesso sarebbe impossibile. L’esperienza della rivelazione è nella rivelazione stessa, nel circolo del rivelarsi sottraendosi. Il poeta corre il massimo rischio, arrischia la propria identità di poeta:
“Io è un altro”, annuncia Rimbaud.
“… di insensato gioco di scrivere”, dice Mallarmé.
“… di cadere in servitù di parole”, parla Ungaretti.
“… (rischia) attraverso l’intuizione della ‘decreazione’, l’unico atto autentico di donazione la sua identità”, affiora negli appunti di Simone Weill.
“Il lavoro della poesia” – di Giampiero Moretti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017 (estratto).
[…] “La grandezza artistica (del fare poetico) può mai essere storicamente efficace, può inserirsi nel processo del divenire?”; (la domanda è così posta nel saggio “Problematica della poesia” da Gottfried Benn), e si pone nella prospettiva evoluzionista interpretata in senso biologico-meccanico, e non invece in senso ‘spirituale’. Spirituale vuol dire per Benn: che il cambiamento, lo sviluppo, nel grande e nel piccolo, avviene in senso goethiano, in maniera tale cioè che sia una variazione sul fondamento e non una variazione-accrescimento del fondamento.
In campo poetico, la differenza sta nel fatto che nel primo caso l’individualità lirica resta ‘soggetta’ a una sostanza che, mutandosi, muta il soggetto poetico, mentre, nel secondo caso, l’individualità lirica assoggetta a sé il fondamento che, il fatto, scompare nell’Io che lo ‘esprime’. Il fondamento insomma, ‘resta’. […] In effetti, Benn sottolinea la preminenza della libertà poetica dell’Io lirico sulla meccanicità della sostanza interpretata in senso positivistico. […]
Tra le considerazioni più degna di nota, e massimamente in linea con il pensiero di Nietzsche, troviamo quella secondo cui «l’Io è un tardo stato d’animo della natura, e addirittura uno stato d’animo fuggevole», ricondotta perciò al contesto fortemente nietzschiano all’interno del quale e dal quale nasce la prospettiva poetica di Benn, quella affermazione significa che l’Io ha un ‘suo’ tempo, dal quale emerge, e che esso è del pari fatto di tempo, e ciò senza alternative, senza ulteriori possibilità che non siano veri e propri inganni, abbagli (non insomma finzioni poetiche ‘volute’). […] Tra queste due strettoie, l’Io poetico esprime la sostanza, che non è però mai un mero niente e che quindi non può mai semplicemente appartenere all’Io che la esprime. […] E tuttavia: quell’espressione è dell’Io, gli appartiene come una ‘cosa’, una pertinenza (?) […] La poesia (e la sua espressione dell’Io) non viene tanto legata e collegata alla vita ‘spirituale’ del singolo, quanto piuttosto al suo ‘corpo’, come zona autenticamente antica, arcaica, in cui in qualche misura riposa l’emozione come dimensione e fatto primario: non frutto di mero stimolo esteriore, dunque, quanto piuttosto di una temporalità interiore, profonda e intensa che nessun cervello può oltrepassare o trascurare. […]
Quella temporalità arcaica è ‘già spirituale’, ed è al contempo un fatto, irraggiungibile tuttavia dalla scienza intesa in maniera diversa da Goethe. Entra qui in scena, secondo la nostra lettura di Benn, la sua ‘proposta’ della poesia come un ‘fare’ che abbia, al contempo, caratteri individuali e universali, aspetti sia di irripetibilità (e quindi in un certo qual modo se non proprio irrazionali quantomeno a-razionali), sia di stile, comunicativamente avvicinabili, quest’ultimo, all’ambito del sapere. […] Poesia (quindi) come linguaggio e però come conoscenza, una mescolanza all’interno della quale non indisciplina e sregolatezza, bensì disciplina e regola sono al centro del processo poetico. […] In questa prospettiva, è possibile concludere che il ‘fare poetico’ è un fare ben più somatico che cerebrale e che esso presenta caratteri di universalità non di rado iscritti ‘nel corpo stesso del poeta’ non solo.
Affrontando la questione del sorgere e del significato della genialità Benn evidenzia efficacemente come, nella sua prospettiva, l’elemento individuale (‘degenerativo’) della genialità si trasformi in qualcosa di universalmente riconosciuto, accertato e celebrato soltanto nella misura in cui l’universalità popolare (oggi diremmo: il pubblico) ne decreta il successo che viene fondato, radicato – diremmo noi – sul ‘corpo’ del poeta, vale a dire radicato in quelle profondità arcaiche le quali, sole, garantiscono una universalità non effimera all’opera d’arte ‘espressa’ dal genio. […]
Le poesie vengono fatte, scrive Benn, e intende : le ‘poesie’ non sono il resoconto, il ‘racconto’ di stati d’animo individuali e passeggeri. Il ‘fare’ poetico è dunque ora al centro della riflessione; il difficile ciò che rende ‘rara’ la poesia, consiste nel fatto che essa non ha tema-argomento ma deve trasformare ciò che l’esistenza ‘sente’ in poesia. Se l’esistenza sente se stessa è ‘solo’ se stessa, la poesia sarà forse anche per certi aspetti ‘ben riuscita, ma non vera in senso ultimo. […] Forse, ma non è poco, se consideriamo che quella ricerca consapevole di un’apparenza (che non può mai, naturalmente, essere mera maniera) poggia a sua volta non tanto o soltanto sulla volontà artistica ‘del’ poeta quanto invece sulla potenzialità poetica dell’essere. È quest’ultima, se così stanno le cose, che ‘libera’ la poesia come risultato puro e semplice dalle strettoie del mestiere. Naturalmente, indicare cosa, in una poesia, non va nella direzione suddetta, è molto spesso ben più semplice del contrario.
Si leggano con attenzione, a tal proposito, le pagine che Benn dedica a sottolineare i quattro elementi che (a suo dire) tanto frequentemente compaiono nelle poesie quanto altrettanto frequentemente, segnalano un cortocircuito nella poesia. In conclusione però il punto è uno solo e uno soltanto, nella poetica moderna, la poesia del nostro tempo è quella in cui la nostra esistenza si ritrova appieno, o almeno può ritrovarsi l’Io che, parlando di se stesso parla d’altro, e questo altro non è una sua proiezione, ma è davvero Altro. E se non è, tale parlare,una modificazione, davvero diventa difficile ipotizzarne una più radicale.
Poesia dunque come variazione, cambiamento, sconfinamento, digressione, erranza.
Queste le tematiche ampiamente trattate dalla Rivista Letteraria da illustri studiosi traduttori e commentatori di saggi filosofici e poetici dei migliori e riconosciuti scrittori di ogni epoca, con particolare riguardo agli autori a noi contemporanei. Nelle sue pagine troviamo, inoltre a Flavio Ermini, Giorgio Bonacini, Vincenzo Vitiello, Carlo Sini, Alejandra Pizarnik, Laura Caccia, Enrico Castelli Gattinara, Alfonso Cariolato, Ranieri Teti, Massimo Donà, Henri Michaux, Davide Campi, Mara Cini, Marco Furia, e numerosi altri collaboratori. Ma non è tutto, sono regolarmente accolte inoltre le ‘voci’ dei grandi poeti, come Friedrich Hölderlin, Paul Celan, Emily Dickinson, Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi, Marina Cvetaeva, Claude Esteban, Camillo Pennati, Rainer Maria Rilke, Yang Lian, solo per citarne alcuni. Anche se è facile immaginare che nei 42 anni dalla fondazione della Rivista siano apparsi, verosimilmente, tutti o quasi sulle sue pagine.
Un pregio questo che attribuisce ad Anterem il primato di una lunga impegnativa produzione letteraria, della quale, Flavio Ermini, da sempre, mantiene alto il vessillo dell’impegno filantropico socio-culturale nel nostro paese. “Non c’è fine al principio” va quindi considerata come ‘massima’ che da sempre distingue e sostiene Flavio Ermini, e va letta come impegno progressivo e conseguente nel duro lavoro di direttore e redattore della Rivista, giunta quest’anno al suo 95 numero con il quale si è voluto in questo articolo, dare una risposta confacente a “La poesia non è un genere letterario”, come abbiamo avuto modo di accertare. Relativamente a un modo dirompente e in qualche modo provocatorio di tornare ad argomentare un dialogo schiuso in illo tempore, ma pur sempre attuale, sul ‘fare’ poesia e sul ‘lavoro’ del poeta, con l’affrontare tematiche vecchie e nuove inerenti e/o differenti all’argomento poetico.
Lo attestano le numerose adesioni alle diverse ‘sezioni’ del Premio, ed ancor più le varie pubblicazioni indotte ad esso, come avviene ad esempio con ‘Limina’ Collezione di scritture, e con ‘Opera Prima’ che accoglie fra le sue pagine le ‘voci’ di autori inediti e in parte sconosciuti nella scuderia del Premio intitolato a Lorenzo Montano giunto alla sua XXXII edizione, che la Rivista Anterem indice ogni anno nella ricerca infinita della Poesia d’Autore. Autori che si aprono con spirito innovativo a questa parte legittima di infinito, dando maggiore forza al riconoscimento della ‘poesia’ come forma d’arte a se stante, capace di affermare l’universalità del suo messaggio, sconosciuto in quanto imperscrutabile, suggestivo quanto più ispirato. Afferente al pensiero e alla parola, così come al canto e alla musica, in quanto ‘voce poetica’ definitivamente liberata dai lacci misteriosi delle afasie di un linguaggio ampiamente superato, appartenuto al passato, per quanto glorioso, ma che oggi pur s’avvale della bellezza terrena dei sentimenti e dell’ebbrezza spirituale che inevitabilmente pervade l’universo futuro.
Flavio Ermini (Verona, 1947), poeta e saggista.
Dirige dalla fondazione (1976) la rivista di ricerca letteraria “Anterem”. Tra le sue ultime pubblicazioni: ‘Poema n. 10. Tra pensiero e poesia’, (poesia 2001; edito in Francia nel 2007 da Champ Social), ‘Il compito terreno dei mortali’ (poesia, 2010; edito in Francia nel 2012 da Lucie Éditions), ‘Il matrimonio del cielo con la terra’ (saggio e poesia, 2010), ‘Il secondo bene’ (saggio, 2012), ‘Essere il nemico’ (pamphlet, 2013), ‘Rilke e la natura dell’oscurità’ (saggio, 2015), ‘Il giardino conteso’ (saggio e poesia, 2016), ‘Della fine’ (prosa poetica, 2016). Collabora all’attività culturale degli “Amici della Scala” di Milano. Per Moretti&Vitali cura la collana di saggistica “Narrazioni della conoscenza”. Partecipa a seminari e convegni in molte istituzioni accademiche italiane e straniere. Vive a Verona, dove lavora in ambito editoriale.
Riferimenti bibliografici oltre quelli citati:
Fabio Squeo, “L’altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza”, Bibliotheka Edizioni 2017.
Victor Turner, “Antropologia della performance”, Il Mulino 1993.
Wikipedia, Enciclopedia libera on-line – by Wikimedia Foundation
Giorgio Bonacini, Prefazione a “L’inarrivabile mosaico” di Enzo Campi – Anterem Ed. Premio Lorenzo Montano ‘Raccolta inedita’ 2017.
Zigmunt Bauman, “Retrotopia”, Laterza Editori 2017.
Gottfried Benn, “Lo smalto sul nulla”, Problematica della poesia, Adelphi 1992, in
“Il lavoro della poesia” – di Giampiero Moretti, in Anterem n. 95 - Dicembre 2017.
Artur Rimbaud, in “Poesia e pensiero in dialogo” di Adriano Marchetti, Anterem n. 95 - Dicembre 2017.
Recensioni di Giorgio Mancinelli sul sito larecherche.it:
Flavio Ermini, "Il Giardino Conteso" - Moretti & Vitali, 2016. Pubblicato il 20/04/2016 04.
Flavio Ermini, “Serata/Evento dedicata a Rainer Maria Rilke, a 90 anni dalla morte”. Pubblicato il 29 dicembre 2016.
ANTEREM 91 apre il 2016 con uno straordinario numero da collezione. Pubblicato il 03/03/2016.
“91 E NON LI DIMOSTRA” ANTEREM RIVISTA DI LETTERATURA E POESIA . Pubblicato il 30/12/2015
“Premio Di Poesia 'Lorenzo Montano' Edizione Del Trentennale”. Pubblicato il 10/02/2016
Sitografia:
ANTEREM – Rivista di Ricerca Letteraria: www.anteremedizioni.it Premio Lorenzo Montano: premio.montano@antermedizioni.it
*
 - Teatro
- Teatro
Atelierspazioperformativo, danza e teatro a Salerno
E’ stata presentata questa mattina presso l’Ente provinciale per il Turismo di Salerno l’ottava edizione di ATELIERspazioperformativo, realizzata da Artestudio e Teatro Grimaldello, in collaborazione con il Teatro Nuovo, concept e coordinamento di Loredana Mutalipassi. La rassegna domenicale è dedicata a danzatori, attori e studenti come spazio alternativo, ma non esclusivo, all’interno del quale approcciare o approfondire l’arte performativa, o meglio la forma rappresentativa risalente agli anni Sessanta, legata alla riscoperta del corpo dell’attore da parte del teatro novecentesco. In particolare, attraverso l’incontro con artisti di rilievo internazionale nell’ambito della danza e del teatro, Atelier si pone l’obiettivo di individuare, potenziare e raffinare le possibilità espressive del corpo sperimentandone la duttilità e migliorandone la qualità.
L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Salerno, si propone di ampliare sempre più l’orizzonte dello spazio teatrale inteso come luogo del corpo dell’attore nella sua totalità; una dimensione nella quale spazio e tempo siano profondamente correlati e traslati dalla sensibilità rappresentativa degli interpreti. Anche quest’anno la proposta è eterogenea ma profondamente univoca proprio nella ricerca, da parte di registi, coreografi e interpreti di mettere in scena “il corpo” sulla scena, corpo che attraverso la sua stessa materialità ri-crea la realtà e la offre al pubblico, sempre più esso stesso interprete e chiamato ad agire e non ad essere agito da ciò che prende vita sulle assi del palcoscenico. La formula organizzativa ripropone una co-direzione artistica – Loredana Mutalipassi e Antonio Grimaldi – e si estende con la creazione di una rete di promotori, tutti operanti a Salerno e in provincia, che hanno messo in comune idee ed energie, non solo in fase di realizzazione dell’evento in senso stretto ma proprio dal punto di vista del progetto culturale di cui Atelier si fa promotore, che è quello della fruizione critica, della formazione non solo dell’attore ma soprattutto del pubblico.
La formazione e l’impegno sociale.
A tale proposito ci piace sottolineare una delle caratteristiche fondamentali di ATELIERspazioperformativo, che ne informa profondamente la struttura da sempre, e cioè la dimensione della formazione: l’atelier, quello dei pittori e degli scultori, ma anche delle sartorie, è il luogo deputato alla “costruzione”, alla creazione del veicolo espressivo attraverso il quale si produce proprio materialmente l’ “opera”. L’idea di fondo è proprio la formazione, il ritorno ad una visione educativa del teatro in senso lato, non soltanto nella fruizione (com’era presso Greci e Romani) ma nel suo stesso processo creativo, nei codici che ne sono alla base, nelle tecniche attraverso le quali si esprime e che costituiscono il “linguaggio non-verbale” o una verbalità che si trascende attraverso il corpo dell’attore stesso.
Da sempre ATELIERspazioperformativo ha avuto una sezione laboratorio che quest’anno assume un rilievo ancora più ampio, di livello internazionale. Infatti il comparto formazione si avvarrà della presenza a Salerno del Maestro Milton Myers, direttore della sezione contemporaneo dello Jacob’s Pillow, docente presso Alvin Ailey American Dance Theatre, di Max Luna III, direttore del Reale Balletto delle Filippine, docente ospite della The Ailey School, già primo ballerino dell’Alvin Ailey American Dance Theatre, con una full immersion nella tecnica di danza contemporanea fondata da Lester Horton, di cui gli artisti summenzionati rappresentano la più diretta testimonianza. Per completare ancora di più un’esperienza squisitamente tersicorea, che vedrà affluire a Salerno danzatori provenienti da tutta Italia, e, ci auguriamo, da tutta Europa, la sezione seminario di ATELIERspazioperformativo edizione 2018 vedrà inoltre la partecipazione di Massimiliano Scardacchi, AND (Accademia Nazionale di Danza), per la danza classica e Roberto D’Urso, RAI e Mediaset, per il genere modern jazz. Il tutto arricchito dalla presenza di maestri accompagnatori alle percussioni quali Paula Jeanine Bennett, dalla Juilliard di New York e il maestro Ruggiero Botta. Per il seminario si è avviata la collaborazione con il Liceo Coreutico Alfano I di Salerno.
L’attenzione alla formazione si traduce, inevitabilmente in un particolare impegno rivolto al territorio, in particolare alla fascia degli adolescenti e dei giovani, ma anche più in generale, ai gruppi sociali più deboli e, quest’anno, si tradurrà nella disponibilità ad offrire 100 posti per assistere alle quattro performance in programma a persone segnalate dal Segretariato Sociale. Puracultura è mediapartener della rassegna.
Programma:
Domenica 28 gennaio
Kollettivo Kairos (1.7)
ENEA WHAT THE HEALTH - uno studio
Coreografie di V. Guarracino e Kollettivo Kairos (1.7)
Domenica 11 febbraio
Scuola Elementare del Teatro diretta da Davide Iodice
R.A.P. - REQUIEM A PULCINELLA,
di Damiano Rossi
Domenica 4 marzo
Compagnia Danza Flux,
REDEMPTION SUITE
coreografia di Fabrizio Varriale/Danza Flux
Domenica 11 marzo
Teatro Grimaldello,
CALIGOLA
di e con Antonio Grimaldi
SEZIONE LABORATORIO: 28-31 marzo 2018
HORTON EXPERIENCE
seminario internazionale con:
MILTON MYERS (New York) – Horton avanzato e repertorio
MAX LUNA III (Manila) – Horton intermedio e principianti
PAULA JEANINE BENNETT (New York) – maestro accompagnatore
RUGGIERO BOTTA – maestro accompagnatore
www.puracultura.it / comunicazione@puracultura.it 339.7099353
*
 - Teatro
- Teatro
Mutaverso Teatro di Salerno presenta..
apre la Stagione 2018 Mutaverso Teatro.
La Stagione 2018 Mutaverso Teatro, giunta alla terza edizione, diretta da Vincenzo Albano/Erre Teatro, in scena all’Auditorium Centro Sociale di Salerno (in via Cantarella 22, quartiere Pastena) ha premiatot il suo pubblico venerdì 19 gennaio alle ore 21, con uno spettacolo che ha al proprio attivo due Premi Ubu 2017 per ‘Miglior progetto sonoro’ e per ‘Miglior attore o performer’ appena conquistati.
Il 'Cantico dei Cantici', della compagnia Fortebraccio Teatro, adattato e interpretato in maniera straordinaria da Roberto Latini, già vincitore nel 2014 di un altro premio Ubu, che ha collazionato anche il Premio Sipario nell’edizione 2011 e il Premio della Critica dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro nel 2015, ha fatto da apripista ad una stagione che si preannuncia ricca di interpretazioni interessanti.
Le note di regia chiariscono che il Cantico "è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza e accudimento, di profumi e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi; un inno alla bellezza, insieme timida e reclamante, un bolero tra ascolto e relazione, astrazioni e concretezza, un balsamo per corpo e spirito".
«Non ho tradotto alla lettera le parole, sebbene abbia cercato di rimanervi il più fedele possibile – ha dichiarato Roberto Latini – ma ho tradotto alla lettera la sensazione, il sentimento che mi ha da sempre procurato leggere queste pagine. Ho cercato di assecondarne il tempo, tempo del respiro, della voce e le sue temperature. Ho cercato di non trattenere le parole, per poterle dire, di andarle poi a cercare in giro con il corpo, di averle lì nei pressi, addosso, intorno. Ho provato a camminarci accanto, a prendergli la mano, ho chiuso gli occhi e, senza peso, a dormirci assieme».
Musiche e suoni di Gianluca Misiti; luci e tecnica Max Mugnai.
Info: info@erreteatro.it - tel. 329 4022021 - 348 0741007.
Informazioni: info@erreteatro.it | 329 4022021 | 348 0741007.
*
 - Cinema
- Cinema
L’Arte di fare Cinema
Backstage / Note di regia.
“La prima cosa che disegno indipendentemente dall’inquadratura è anche la prima cosa sulla quale si posa il nostro sguardo, cioè il volto, la posizione del volto determina l’inquadratura”, si trovò ad affermare Alfred Hitchcock nel corso di un’intervista ai Cahier du Cinéma.
Se con ciò fu allora possibile risolvere l’incognita del primo piano e ci si accorse che era rivolto alla figura umana, nulla vieta oggi di spostare l’attenzione sull’immagine del volto che per primo si definisce entro lo spazio filmico. Il volto è infatti il punto di contatto, di presenza e definizione, eletto a protagonista dell’intero spazio che intercorre tra il prima e il dopo di una sequenza filmica, capace da solo di determinare l’impatto visivo diretto con chi l’osserva. Ed è ancora il volto, soggetto unico e originale in quanto arcano e misterioso, fonte dell’inquadratura primaria, a costituire il perno d’identificazione di questa insolita impresa registica in cui, passato e presente, sono parte integrante di un vuoto temporale, privilegiato e sensibile, che solo casualmente coincide, con lo spazio che lo circonda.
Allo stesso modo la 'sceneggiatura' svolge un ruolo liberatorio dello spazio-tempo che intercorre tra i diversi accadimenti, volutamente narrati in chiave di fiction, per stemperare la tensione fortemente drammatica, vecchia di duemila anni e pur sempre attuale, della tragedia che racchiude. In cui sono raccolti accadimenti che annotano il ripetersi di azioni di guerriglia, di condanne e di assoluzioni, ma anche di persecuzioni nell’ambito di lotte fratricide interminabili, alle quali assistiamo ancora oggi, non solo come sfondo pseudo-storico delle vicende narrate, bensì nel ripetersi della vita reale che viviamo sulle pagine dei giornali e dei notiziari, in cui esseri umani in carne e ossa soccombono e muoiono in nome di una “guerra santa” che non ha alcuna ragione di essere. E che, ancor più, scorgiamo in presa diretta, sui volti sofferenti e negli sguardi di quanti si domandano increduli: “perché?”.
In quanto alla 'location', la dimensione internazionale dei fatti narrati, ampliati in un tutt’uno che abbraccia il passato e il presente, volutamente estesa per infondere alla narrazione la veridicità di cui necessita e nella quale si è voluto riallacciare i fatti di ieri, avvenuti nell’ambito piuttosto ristretto del mondo allora conosciuto, con quelli di un oggi allargato, in cui le comunicazioni occupano un posto prioritario. Le tecnologie, sicuramente più avanzate di quelle di allora, testimoniano lo sperpero di risorse enormi nel dar seguito a guerre che non hanno più alcun senso, se mai lo hanno avuto, mentre si consuma una delle più efferate contraddizioni all’universale senso di sopravvivenza.
Un parallelo che, come nella realtà, non ha ragione di essere consumato, ma che forse rende, pur nella finzione, come vanno le cose del mondo e di quale realtà oggettiva è fatto il genere il umano. Se soltanto ci guardassimo più negli occhi, se solo incrociassimo un po’ più gli sguardi l’uno dell’altro, forse ci accorgeremmo di quanto, tra sfiducia e incredulità, passa sui nostri volti. Donde l’importanza di accedere al cast originario, ovvero alla scelta di quelli che sono stati e sono i protagonisti della vicenda qui di seguito narrata, ripercorrendo i labirinti di un vissuto qua e là forzato quanto ignoto. Andare cioè alla ricerca dei volti della storia come immagini in sequenza, in tempi narrativi diversi e diversificati, in un parallelismo funzionale al soggetto, in cui fisicamente coinvolti, faranno infine da veicolo all’identificazione cinematografica, secondo scelte che possiamo definire razionali o irrazionali a seconda della diversità del caso.
Così come, a loro volta, hanno operato nel cinema, oltre ad Hitchcock (in quasi tutti i suoi film), Welles (in Il Terzo Uomo), Cassavettes (nel film Facies), e Bergman in (in Volti), in cui lo sforzo registico, per l’appunto, sta nel catturare l’essenza delle diverse individualità, non già attraverso il dramma narrato, bensì, nell’espressività dei volti.
Immaginiamo per un momento che qualcuno abbia chiesto al grande regista del brivido Alfred Hitchcock di svelare quali fossero i segreti della sua arte che a distanza di tempo ancora rendono i suoi film così particolarmente coinvolgenti:
“I miei segreti! – avrebbe esclamato con suo sorriso sornione che di per sé sarebbe già una risposta – I miei segreti sono qui, sotto gli occhi di tutti, da anni ho imparato che se desideri celare qualcosa alla stupidità umana, il posto migliore è quello in cui il mondo intero lo possa vedere”.
Ma non lasciamoci ingannare dalla risposta, che invece appartiene a un altro grande maestro, questa volta dell’arte pittorica, Leonardo Da Vinci che la riferisce alla domanda di Agostino di Leyre inviato del Santo Uffizio a supervisionare la sua opera più discussa e ritenuta eretica: il Cenacolo. E quale simbolo a questo scopo è più elettivo del volto umano colto nella sua essenza incomprensibile e misteriosa? Che ci piaccia o no, che lo vogliamo o no, per necessità o per scelta, il volto, isolato in una fotografia o messo in primo piano nel singolo fotogramma di una sequenza filmica, si trasforma in un unico e assoluto atto di creazione, diventa, per così dire, la nostra opera d’arte, che ci accalappia nel vortice dei sentimenti. E solo perché niente di meglio, o forse di peggio, è in quel momento diversamente immaginabile.
Ciò è ancora più evidente in Michelangelo Merisi da Caravaggio, che nelle sue opere si spinge a mettere in luce, con tagli mirati, i volti dei personaggi dei suoi dipinti, facendosi partecipe dell’azione che si sta compiendo sulla tela. È indubbiamente il caso del suo La cattura di Cristo, (utilizzato in copertina), conosciuto anche col nome assai riduttivo Il bacio di Giuda della National Gallery of Ireland di Dublino, in cui il centro visivo del quadro è formato dalle due teste contrapposte dei protagonisti, i cui volti, “..immortalati in uno stupendo notturno, risplendono a incorniciare in un’unica parabola, carica di molteplici valenze, le teste del tradito e quella del traditore”. È ancora il buio del peccato ad avvolgere ogni cosa, lì dove “..pochi fulgidi bagliori rischiarano questa notte senza tempo: il luccichio delle armature dei soldati, il volto presago del Cristo, le sue mani intrecciate, l’urlo di San Giovanni bloccato di tre quarti sulla tela”.
Quel che colpisce è la forza che il quadro emana, la rapidità delle pennellate, l’innegabile forza delle forme, il suo intenso impatto estetico ed emozionale a conferma della tragicità di un evento cruciale, che ancora oggi stupisce per la compiutezza dell’esecuzione tecnica con cui il pittore ha delineato i tratti dei modelli scelti, restituendo la loro immagine come riflessa da specchi segreti. Fatto rilevante ed eccezionale è che per la prima volta il pittore introduce la fonte di luce internamente al quadro stesso. La luce sulla tela è ben più di un semplice elemento della natura che irrompe sulla scena per darle rilevanza sicura, è come una lente puntata prevalentemente sui volti e sulle mani di personaggi che una lanterna innalzata, ma forse anche quella di una invisibile luna che li fa risaltare sul fondo scuro con sorprendente chiarore. Un bagliore che esplicita sui volti i fermi sentimenti dei protagonisti, quasi che il pittore volesse attirare l’attenzione sull’intensa drammaticità dell’azione che si sta svolgendo, al tempo stesso, rimettendo a sé “l’amore che tradisce e l’amore che subisce”, rendendoli contemporanei anche a ciascuno di noi.
Tutto si evolve nel presente in cui si concentra la storia vecchia di duemila anni e più, che in un istante si svolge sulla scena allestita dal grande regista lombardo, in mezzo al clangore di armi di ferro che risuonano corrusche contro lo sfondo di una notte immaginabilmente buia. Una storia senza fine, rischiarata da una luce che non è soltanto bagliore naturale, ma luce di grazia, in cui l’evento narrato si snocciola al pari di una sacra rappresentazione all’interno di una scenografia teatrale, riallestita in uno spazio montano che si annulla. Dove il tempo si ferma nell’istante carico di emozione e le figure dei protagonisti sembrano essere così reali che, addirittura, potrebbero raccontare in prima persona le proprie ‘storie’ e recitare ognuna la propria parte. Ancor più da parte di chi, per propria decisione e per decisione altrui, ha voluto ricostruire quanto realmente è accaduto nell’orto degli ulivi molti secoli prima e che non riesce a comprendere del tutto, benché come spettatore egli ne sia coinvolto, tuttavia non ponendosi dalla parte dello spettatore, poiché si rivela testimone oculare di un ‘fatto’ ed è chiamato ad assolvere il compito di testimoniare.
Che è poi quanto si vuole qui testimoniare, un qualcosa che fa parte della presa diretta e che, in un certo senso, potrebbe far pensare a un fare cinema tendenzialmente motivato dalla spinta emotiva che un regista motivato si porta dentro, appunto come dovette essere per Caravaggio, finalizzata a dare movimento alla tela, all’insieme della scena, quasi da renderla animata. Come di una sequenza che scorre veloce dopo l’altra di quell’arte onirica che matura nei sogni, o forse negli abbagli e nelle allucinazioni, e che prende nome di sequenza filmica. O meglio, come di una ininterrotta trasformazione del latente nel manifesto, del nascosto nel rivelato, paragonabile a un continuo e costante lavoro di realizzazione di ciò che in fondo è l’arte dell’illusione, cioè di quella che per lo più chiamiamo la “grande arte del cinematografo”.
*
 - Società
- Società
Christmas Happiness / 2
In cerca del regalo perfetto da fare agli altri (soprattutto a se stessi): qualche libro, qualche evento cinematografico, quanto basta di poesia, qualche mostra, un concerto, il resto createlo Voi lettori … in fondo Natale è anche Vostro, o no?
‘ikutsure ka sagi no tobi yukyu aki no kure’
‘Piccoli stormi
d’aironi solcano il cielo
crepuscolo d’autunno.’
–
‘shibagaki ni kotori atsumaru yuki no asa’
‘La siepe spoglia
gli uccelli vi si posano
mattina di neve.’
–
‘yuku aki no aware o dare ni takara mashi’
‘L’autunno finisce
a chi poter confidare
la mia malinconia?’
(da “Novantanove Haiku “ di Ryöcan – La vita felice 2012)
Un’introduzione particolarmente cercata questa di usare alcuni‘haiku’ famosi di Ryöcan per fare da cornice alla mostra dedicata a Katsushika Hokusai – Sulle orme del Maestro - al Museo dell’Ara Pacis - Lungotevere in Augusta, a Roma dal 12 ottobre 2017 – 14 gennaio 2018. A cura di Rossella Menegazzo.
Ɣ “HOKUSAI - Sulle orme del Maestro”
L’importante Mostra sul maestro giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849) è visitabile fino al 14 gennaio 2018. Attraverso circa 200 opere (100 per ogni rotazione della mostra per motivi conservativi legati alla fragilità delle silografie policrome) provenienti dal Chiba City Museum of Art e da importanti collezioni giapponesi come Uragami Mitsuru Collection e Kawasaki Isago no Sato Museum, oltre che dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova, la mostra racconta e confronta la produzione del Maestro con quella di alcuni tra gli artisti che hanno seguito le sue orme dando vita a nuove linee, forme ed equilibri di colore all’interno dei classici filoni dell’ukiyoe.
Dal paesaggio alla natura, animali e fiori, dal ritratto di attori kabuki a quello di beltà femminili e di guerrieri, fino alle immagini di fantasmi e spiriti e di esseri e animali semileggendari: questi i soggetti che i visitatori romani troveranno in mostra. Hokusai variava formati e tecniche: dai dipinti a inchiostro e colore su rotolo verticale e orizzontale, alle silografie policrome di ogni misura per il grande mercato, fino ai più raffinati surimono, usati come biglietti augurali, inviti, calendari per eventi e incontri letterari, cerimonie del tè, inviti a teatro.
Il maestro soprattutto deve la sua fama universale all’opera ‘La Grande Onda’ (parte della serie di Trentasei vedute del monte Fuji) ma anche all’influenza che le sue riproduzioni hanno avuto sugli artisti parigini di fine Ottocento, tra i quali Manet, Toulouse Lautrec, Van Gogh e Monet, protagonisti del movimento del Japonisme.
Tra i suoi allievi ci sono Hokuba, Hokkei (1790-1850), Hokumei (1786-1868) che segnano la generazione successiva di artisti, insieme a Keisai Eisen (1790-1848), allievo non diretto di Hokusai, ma che da lui è stato influenzato, che ha determinato gli sviluppi delle stampe di bellezze femminili e paesaggio degli anni 1810-1830.
Proprio a Eisen, presentato in Italia per la prima volta in questa mostra, appartiene la bellissima e imponente figura di cortigiana rappresentata nella silografia che Van Gogh dipinge alle spalle di Père Tanguy e utilizzata anche in copertina del Paris Le Japon Illustré nel 1887.
La mostra si compone di cinque sezioni:
1- MEISHŌ: mete da non perdere
Presenta le serie più famose di Hokusai: le Trentasei vedute del Monte Fuji, le Otto vedute di Ōmi, i tre volumi sulle Cento vedute del Fuji e un dipinto su rotolo del Monte Fuji, presentato per la prima volta in Italia e in anteprima assoluta.
2- Beltà alla moda
Una serie di notevoli dipinti su rotolo e silografie policrome dedicate al ritratto di beltà femminili e cortigiane delle famose case da tè del rinomato quartiere di piacere di Yoshiwara mettono a confronto lo stile del maestro Hokusai con quello di alcuni tra i suoi allievi più famosi tra cui Gessai Utamasa, Ryūryūkyō Shinsai, Hokumei, Teisai Hokuba.
3- Fortuna e buon augurio
Nel formato della silografia, di Eisen in questo caso, e attraverso una serie di undici dipinti su rotolo di Hokusai che rappresentano le divinità popolari della fortuna, si evince uno dei soggetti in voga all’epoca come portafortuna, protezione, augurio per occasioni speciali.
4- Catturare l’essenza della natura
Hokusai e allievi a confronto attraverso una serie di dipinti su rotolo provenienti dal Giappone sul tema della natura e degli animali per sottolineare i motivi classici della pittura di ‘fiori e uccelli’ e la valenza simbolica di alcuni animali quali il drago, la tigre, la carpa, il gallo riproposti nello stile di ciascun artista.
5- Manga e manuali per imparare
La serie completa dei 15 volumi di Manga di Hokusai sono esposti in questa sezione e rimandano ai tratti e alla forza che il maestro sa dare a ogni creatura che decide di rappresentare ma anche alla sua volontà di insegnare le regole della pittura ad artisti e appassionati. A fianco dei volumi di Hokusai, un album dell’allievo Shotei ripercorre i soggetti e le forme del maestro proponendo pagine simili fitte di disegni e schizzi.
Ɣ “HUMAN”
del regista Yann Arthus-Bertrand è un documentario per certi versi sorprendente quanto appassionante che si avvale di una altrettanto eccezionale quanto straordinaria ‘colonna sonora’ del compositore israeliano Armand Amar . Un dittico di storie e di immagini del mondo, per immergerci nella profondità del genere umano, che risalta per la capacità di sintesi che ne fa un'opera sorprendente meritevole di una particolare attenzione. Trasmesso da RAI5 e dalle televisioni di tutto il mondo ‘Human’ passa attraverso testimonianze piene d’amore, di felicità ma anche di odio e violenza, ‘Human’ ci permette di confrontarci con l’altro e riflettere sulla nostra vita con monologhi struggenti e di rara sincerità che si alternano a immagini aeree inedite, accompagnate da musiche particolarmente coinvolgenti.
‘Human, l’amore che salva il mondo’ è un bell’articolo/intervista di Cristina Barbetta – 07/ marzo/2016 apparso in VITA – Cultura:
Il grande fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand ha presentato a Milano il suo ultimo film, ‘Human’, uno straordinario ritratto dell'umanità, un documentario che si interroga sul senso della vita e dell'essere uomini. Attraverso la voce di gente comune di tutto il mondo. 2020 interviste, 2 anni e mezzo di riprese realizzate in 60 Paesi diversi nel mondo e in 63 lingue diverse. Parole, immagini che mostrano la bellezza del mondo e musiche, che ci toccano e ci interrogano ‘per fare emergere l'empatia necessaria per vivere in quest'epoca difficile’.
‘Tutti gli esseri umani sono importanti e hanno qualcosa da dire’. Lo mostra Yann Arthus-Bertrand, fotografo, ambientalista e regista francese di fama internazionale, nel suo ultimo film, Human, uno straordinario ritratto dell'umanità, un documentario che si interroga sul senso della vita e dell'essere uomini.
Attraverso la voce di gente comune di tutto il pianeta. 2020 interviste, 2 anni e mezzo di riprese in 60 Paesi diversi nel mondo e in 63 lingue diverse per realizzare un film (191 minuti), che ci tocca profondamente perché ci riguarda tutti da vicino, perché ‘siamo tutti strumenti che suonano nella gigantesca orchestra della vita’ e queste persone che parlano sono il nostro specchio. Oltre alle persone, immagini della bellezza del mondo e musica, per riflettere e lasciare sedimentare.
Cinque anni dopo il film ‘Home’, prodotto da Luc Besson, che è stato visto da 600 milioni di persone in tutto il mondo, Yann Arthus -Bertrand lancia una nuova sfida con ‘Human’, presentato all'Assemblea Generale dell'ONU e al Festival del Cinema di Venezia del 2015, è stato proiettato già in 50 Paesi nel mondo, ed è destinato a raggiungere il maggior numero di persone grazie a un piano di distribuzione a molti livelli, dal cinema, alla televisione, a internet, dove si può visionare su Youtube.
Intervista a Yann Arthus-Bertrand:
Abbiamo incontrato Yann Arthus-Bertand in occasione della presentazione di Human a Milano, al cinema Anteo, dove il film, che in Italia è distribuito da Academy two, sarà proiettato per tre settimane tutti i giorni, alle ore 13:
Com’è nata l’idea del film?
Mentre realizzavo “La terre vue du ciel” (“La terra vista dal cielo”), un progetto fotografico e un libro che ha venduto più di 3 milioni di copie, sono stato in Mali con i contadini che praticano l'agricoltura di sussistenza, che in tutto il mondo sono un miliardo. Mi hanno parlato delle loro paure: la paura della morte, della malattia, la paura di non sentirsi parte del mondo. E quello che mi hanno detto, guardandomi dritto negli occhi, è stato molto più potente di quello che avrebbero potuto dirmi dei giornalisti o degli scienziati.
Ho iniziato nel 2003 a realizzare il progetto: “7 milliards d'Autres”, sulla gente del mondo. 6000 interviste filmate in 84 Paesi da circa 20 reporter per cercare l'"Altro". Human è ispirato a questo progetto.
Che cosa l'ha spinta a realizzare Human?
Volevo cercare di dare una risposta a tutte quelle domande essenziali che ci poniamo sul senso della vita : perché c’è la guerra, la povertà, la crisi dei rifugiati, l'omofobia... Human è un film politico, che ci fa riflettere sul significato della nostra esistenza attraverso il confronto con l'altro. Ed è un saggio di un regista che vuole parlare d'amore. Nel film le persone parlano anche di felicità, di valori come la famiglia, di amore. Come dice un ragazzino disabile nel film “è solo l'amore che ci salverà”. Human è un film utopistico, ma forse l'utopia è una verità prematura.
Che film è Human?
È un film che parla al cuore della gente. Mostra chi siamo, attraverso le parole di tutte quelle persone che parlano e ti guardano dritto negli occhi, e sono il nostro specchio. Sono tutte quelle persone intervistate che fanno la forza del film. Che deve essere guardato con molta umiltà perché è fatto da tutte quelle persone. È un film molto intimista e spirituale. Ed è sicuramente molto difficile, perché è lungo, è duro, e perché la vita è difficile. È un film che amo molto, che mi arricchisce e mi dà molta felicità. Quando ho fatto il montaggio ho realizzato che nessun attore avrebbe potuto essere più bravo di queste persone, nessuna storia inventata avrebbe potuto essere più forte.
Come avete scelto le persone che hanno parlato nel film?
Le abbiamo selezionate a seconda dei temi che volevamo trattare. Siamo andati in giro per il mondo, nelle strade, nei campi, nelle scuole, nelle carceri... Abbiamo intervistato rifugiati in Marocco, in Sicilia e a Calais.
A ciascuna delle persone intervistate abbiamo fatto 40 domande, sempre le stesse, indipendentemente dalla provenienza, dalla cultura, dall'età, partendo da quelle più semplici fino ad arrivare a quelle più complicate, come “Qual è stato il momento più difficile nella tua vita?” “Che senso ha la vita?”.
Abbiamo detto a queste persone che quello che avrebbero detto sarebbe stato ascoltato da milioni di persone nel mondo e che tutte le cose che avrebbero detto sarebbero state importanti. È stato come fare delle sedute psicanalitiche perché le domande venivano fatte con molta empatia e gentilezza e alla fine le persone si lasciavano andare e moltissime piangevano e abbiamo pianto, riso assieme a loro, siamo diventati amici, è stato bello e difficile.
Cosa vuole fare emergere il film?
Viviamo in un’era molto difficile. E’ la prima volta nella storia della umanità in cui il futuro appare cosi incerto: il riscaldamento globale, la crisi dei rifugiati, il divario crescente tra ricchi e poveri, la crisi economica... L'unica cosa che possiamo fare per affrontare i periodi difficili che stanno arrivando è vivere assieme, accettando il mondo per quello che è e cercando di fare il meglio che possiamo. Perché tutti abbiamo una missione. Come dice un bambino africano nel film” tutti abbiamo una missione che ci ha dato Dio”, il nostro compito è capire qual è la nostra missione. Questo film e il mio lavoro vuole fare emergere l’empatia necessaria per vivere tutti assieme in questo mondo dal futuro così incerto.
Come si è strutturato il documentario?
Si è sviluppato senza una sceneggiatura. Abbiamo fatto due anni e mezzo di riprese e un anno di montaggio, che è stata la parte più impegnativa dal momento che non c'era una storia. Abbiamo creato il film con 2020 interviste di cui abbiamo utilizzato una parte, e molte ore di riprese aeree. La difficoltà è stata nell'armonizzare le parole, la bellezza del mondo e la musica.
Spero che questo film vi cambi, così come ha cambiato me.
‘Human’ è il primo lungometraggio realizzato grazie alla collaborazione di due fondazioni non profit..
Il documentario è stato finanziato dalla Fondazione Bettencourt Schueller, grazie alla quale la visione del film è gratuita in tutte le scuole e in tutte le associazioni del mondo. E' un progetto della Fondation GoodPlanet, che ho fondato nel 2005 e sensibilzza su tematiche di sviluppo sostenibile globale.
Qual è il suo prossimo progetto?
Si chiama ‘WOMAN’ ed è un progetto dedicato alle donne, perché dopo avere girato questo film è stato chiaro che dovessimo parlare di donne.
Il copyright di tutte le immagini pubblicate è: HUMANKIND Production.
Photo of Yann Arthus-Bertrand: ©A. Miquel. Aerial iamges.
Sul web: vita.it/it/interview/2016/03/07/human-lamore-che-salva-il-mondo/43/
La versione di ‘Human’ con sottotitoli in italiano è visibile su Youtube con/anche
la colonna sonora di Armand Amar registrata su etichetta ERATO.
Ɣ “TEORIE DEL CINEMA. Il dibattito contemporaneo”
Un libro antologico di Adriano D’Aloia, Ruggero Eugeni – Raffaello Cortina Editore 2017, dal quale traggo questa ‘Postfazione’ di Francesco Casetti.
Le immagini in movimento continuano a costellare la nostra vita quotidiana, immersa in una miriade di schermi – grandi e piccoli, fissi e mobili, personali e collettivi – e in un flusso ininterrotto di narrazioni audiovisive. Anche i discorsi e le riflessioni sul cinema e sui film non cessano di animare il dibattito culturale contemporaneo coinvolgendo un gran numero di istituzioni (accademiche e non), appassionati di cinema e semplici spettatori. Se, da un lato, i film rappresentano da sempre le tendenze e le tensioni sociali della nostra cultura, dall’altro le teorie del cinema riflettono sempre più l’incontro (e lo scontro) fra differenti visioni del mondo e della conoscenza. Questa antologia presenta per la prima volta in italiano i contributi dei più autorevoli e originali rappresentanti dei film studies degli ultimi quindici anni. L’idea di fondo è che la riflessione sul cinema e sull’audiovisivo non si svolga in un perimetro chiuso e invalicabile, ma in aperto dialogo con altre discipline: con la filosofia, intorno al concetto di esperienza; con le scienze sperimentali, a proposito del concetto di organismo; con la teoria dei media, rispetto al concetto di dispositivo.
Un’articolata introduzione e una postfazione intenzionalmente provocatoria permettono al lettore di comprendere “dal vivo” come il pensiero sul cinema, nei suoi rizomatici mutamenti, sia fondamentale per interpretare la complessità dell’esperienza mediale contemporanea.
Biografia dei curatori:
Adriano D’Aloia è ricercatore all’Università Telematica Internazionale UniNettuno, Roma. Si interessa del rapporto fra teorie dei media, estetica, psicologia e neuroscienze. È autore di La vertigine e il volo. L’esperienza filmica fra estetica e scienze neurocognitive (2013) e curatore del volume di Rudolf Arnheim, I baffi di Charlot. Scritti italiani sul cinema 1932-1938 (2009).
Ruggero Eugeni è professore di Semiotica dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha diretto l’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo. È fra i principali studiosi dell’incontro fra semiotica dei media e scienze neurocognitive. È autore di Semiotica dei media. Le forme dell’esperienza (2010) e La condizione postmediale (2015).
Con Adriano D’Aloia ha curato il numero monografico di Cinéma&Cie sul tema “Neurofilmology. Audiovisual Studies and the Challenge of Neuroscience” (2014).
Ɣ “DIECI FILM ITALIANI VOLANO A BARCELLONA”
di Vittoria Scarpa in collaborazione con Cineuropa
12/12/2017 - Torna dal 15 al 19 dicembre la Mostra de Cinema Italià de Barcelona, l’evento che promuove nella capitale catalana il meglio del cinema italiano dell’anno.
Sempre dalla selezione veneziana provengono altri tre film rappresentativi della new wave partenopea, che abbracciano in vari modi il tema della criminalità: l’opera seconda d’animazione di Alessandro Rak,Gatta Cenerentola (Orizzonti), Il cratere di Silvia Luzi e Luca Bellino (Settimana della Critica, e fresco vincitore del Gran Premio della Giuria al Tokyo Film Festival) e L’Equilibrio di Vincenzo Marra, presentato quest’anno alleGiornate degli Autori, così come Il Contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che esplora invece la criminalità organizzata di Roma.
Arriva dalle Giornate degli Autori anche Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini, ambientato in Svizzera, mentre è stata applaudita all’ultimo Festival di Locarno la commedia Easy di Andrea Magnani, road movie dall’Italia all’Ucraina. Ancora commedia con Amori che non sanno stare al mondo, il nuovo film di Francesca Comencini presentato al Torino Film Festival, e con Moglie e marito di Simone Godano, in proiezione speciale. Da Cannes, infine, approda Fortunata di Sergio Castellitto. Quattro di questi titoli hanno già un distributore spagnolo: Cinemaran per Amori che non sanno stare al mondo e Dove cadono le ombre, Savor Ediciones per Fortunata e Selecta Visión per Moglie e marito.
Ad accompagnare i film a Barcellona ci saranno: Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Simone Godano, Silvia Luzi e Luca Bellino, Andrea Magnani, Marco Manetti, Vincenzo Marra, Lucia Mascino, Valentina Pedicini, Edoardo Pesce e Alessandro Rak.
Spazio inoltre ai cortometraggi presentati alla Settimana della Critica di Venezia quest’anno: Adavede di Alain Parroni, Due di Riccardo Giacconi, Les fantômes de la veille di Manuel Billi, Il legionario di Hleb Papou, Malamènti di Francesco Di Leva, Piccole italiane di Letizia Lamartire e Le visite di Elio Di Pace. I sette cortometraggi concorrono per il Premio Corti di 2.000 euro che verrà assegnato da una giuria composta da Dimas Luis Rodríguez Gallego, Valentina Pedicini e Toni Benages.
La Mostra de Cinema Italià de Barcelona è organizzata da Filmitalia-Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, il Consolato Italiano e il Centro Sperimentale di Cinematografia.
Ɣ “THE SQUARE”
Il film di David González trionfa agli European Film Awards – in collaborazione con Cineuropa.
09/12/2017 - Il film di Ruben Östlund he seguito l’esempio di Toni Erdmann in occasione della serata berlinese che ha celebrato l’identità culturale e politica europea.
Per la seconda volta di fila, un unico film, un commedia per la precisione, ha portato a casa la maggior parte dei premi in occasione della cerimonia degli European Film Awards. Se lo scorso è toccato a ‘Vi presento Toni Erdmann’, quest’anno, nel 30° compleanno dell’evento, è stato ‘The Square ‘ il film che ha fatto piazza pulita di riconoscimenti.
Ruben Östlund, già vincitore della Palma d’Oro a maggio, ha ricevuto, da una giuria presieduta da Pedro Almodóvar, i premi principali della serata: il premio Attore europeo, andato a Claes Bang, i premi Sceneggiatura europea e Regista europeo, assegnati a Östlund, il premio Commedia europea e, ovviamente, il premio Film europeo. È bene notare che il film è stato anche tra i vincitori degli Excellence Awards: Josefin Åsberg ha fatto suo il premio Sceneggiatore europeo.
Östlund, ricevendo uno dei premi, ha affermato: “Volevamo lanciare un messaggio importante, ma volevamo anche intrattenere ed emozionare”. Quando è salito sul palco per ricevere il premio Film europeo, il produttore Erik Hemmendorff ha aggiunto “Non so se ci meritiamo così tanti premi”.
Oltre a ‘The Square’, gli unici film che sono riusciti a ottenere un qualche riconoscimento sono stati ‘Corpo e anima’ di Ildiko Enyedi, la cui protagonista, Alexandra Borbély, ha vinto il premio Attrice europea (ha dovuto trattenere le lacrime per poter pronunciare il suo discorso sul palco), ‘Communion’ di Anna Zamecka, premio Documentario europeo, ‘Loving Vincent’ di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, premio Film d’animazione europeo, ‘Lady Macbeth’ di William Oldroyd, premio Scoperta europea - Premio FIPRESCI e Stefan Zweig: ‘Farewell to Europe’ di Maria Schrader, insignito del People’s Choice Award.
Nel corso di una cerimonia che ha evidenziato il ruolo degli European Film Awards nella creazione di un’identità europea attraverso il cinema negli ultimi trent’anni, il discorso del presidente dell’Accademia del Cinema Europeo Wim Wenders è stato di quelli che lasciano il segno. Un discorso carico di contenuti politici e che ha posto le seguenti domande: “Come è possibile che il nazionalismo stia tornando nelle nostre vite? Perché sta uccidendo i nostri più grandi sogni?”. Quando ha ricevuto il premio alla carriera dalla presidentessa dell’Accademia Agnieszka Holland, Aleksandr Sokurov ha ricordato tutte le difficoltà che ha dovuto superare nella sua carriera. Julie Delpy ha sottolineato il fatto di aver perso i finanziamenti di cui aveva bisogno per il progetto che ha in cantiere ritirando il premio Miglior contributo europeo al cinema mondiale (lasciando spazio anche a un messaggio di Ethan Hawke, che ha ricordato l’indimenticabile coppia che avevano formato nella trilogia Before di Richard Linklater). Ha poi continuato annunciando una lotteria durante la cerimonia con in palio alcuni biglietti per il film per sostenere il progetto, in quanto sta “semplicemente sopravvivendo con questa professione”.
La 30a edizione degli European Film Awards è stata, ancora una volta, un’occasione per celebrare il cinema europeo e l’identità culturale e politica dell’Europa, senza vincitori a sorpresa. Il prossimo anno, la cerimonia si terrà per la prima volta in Spagna, a Siviglia.
Ecco la lista completa dei vincitori:
Film europeo
The Square – Ruben Östlund (Svezia/Germania/Francia/Danimarca)
Documentario europeo
Communion – Anna Zamecka (Polonia)
Regista europeo
Ruben Östlund – The Square
Attrice europea
Alexandra Borbély – Corpo e anima (Ungheria)
Attore europeo
Claes Bang – The Square
Sceneggiatura europea
Ruben Östlund – The Square
Film d’animazione europeo
Loving Vincent – Dorota Kobiela, Hugh Welchman (Polonia/Regno Unito)
Commedia europea
The Square – Ruben Östlund
Scoperta europea - Premio FIPRESCI
Lady Macbeth – William Oldroyd (Regno Unito)
People's Choice Award
Stefan Zweig: Farewell to Europe – Maria Schrader (Germania/Austria/Francia)
Cortometraggio europeo
Timecode - Juanjo Giménez (Spagna)
Premio universitario film europeo (premio parallelo)
Heartstone – Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islanda/Danimarca)
Ɣ “MOMENTI DI FELICITÀ”
di Marc Augé – Raffaello Cortina Editore 2017
Il piacere di incontrare un viso, un paesaggio, un libro, un film, una canzone, l’emozione del ritorno o della prima volta: sono impressioni fugaci, momenti di felicità concessi a tutti, indipendentemente da origini, cultura, sesso. Spesso arrivano improvvisi, in situazioni dove nulla sembrerebbe favorirli: nondimeno esistono e resistono, contro venti e maree, al punto di abitare stabilmente la nostra memoria. Marc Augé esplora questi momenti di felicità, mescolando riflessioni e ricordi personali, con un piccolo cammeo dedicato ai canti e sapori d’Italia, delizioso omaggio ai piaceri dei sensi che il nostro paese gli ha sempre offerto e offre a chiunque sappia intenderli come forma di autentica cultura. Ma lo sguardo dell’antropologo si fissa anche sull’oggi, sui momenti felici che oppongono resistenza all’epoca presente, all’inquietudine e all’angoscia: momenti “di felicità nonostante tutto”, perché nei periodi di incertezza avviene di norma che si vada in cerca di salvagenti.
Biografia dell'autore:
Marc Augé, etnologo e scrittore, è stato presidente dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales dal 1985 al 1995. Nelle nostre edizioni ha pubblicato, fra gli altri, ‘Il tempo senza età’ (2014), ‘Un etnologo al bistrot’ (2015) e ‘Le tre parole che cambiarono il mondo’ (2016).
(continua)
*
 - Società
- Società
Christmas Happiness / 1
In cerca del regalo perfetto da fare agli altri (soprattutto a se stessi): qualche libro, un certo evento, quanto basta di poesia, qualche mostra, forse un concerto, il resto createlo Voi lettori … in fondo il Natale è anche Vostro, o no?
IN MOSTRA A: ‘PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI’ – NUVOLA FUKSAS EUR/ ROMA
(appena terminata)
In-oltre a fare incetta di segnalibri ho fatto scorta di contatti più o meno graditi da parte degli editori che sono lì solo per vendere libri (senza sconti) e incamerare denaro (€), per non dire di tutto quello che si trova sul Web tra nuovo / usato / super-scontato / regalato ecc. Per non parlare poi della fantomatica presenza di certa media e piccola editoria che spesso non si comprende se è presente per promuovere una qualche attività legata alla letteratura e alla cultura più in generale, oppure a cosa? Quando, almeno per alcuni/e, farebbero meglio a produrre erbaggi e alimenti per animali.
In-vece più interessanti sono stati gli incontri (meeting), le convention, la presenza di autori che hanno illustrato le proprie opere e il loro operato scrittorio (molti a proprie spese) talvolta con semplicità e/o l’affabulazione di chi si misura costantemente con la realtà; altre con la prosopopea (vanagloria) di aver superato la soglia della mediocrità. Sarà vero? Solo perché ha scritto uno straccio di libro e fatto qualche apparizione in TV o in qualche trasmissione Radiofonica dicendo la sua pro o contro (V/S) questo o quel politico di turno, tutti destinati, primo o poi al dimenticatoio, quando sarà passata la bufera. Passerà? (Speriamo).
Fatto-accertato è che anche il lavoro dei media come RaiLibri (uno spazio per ogni canale e solo per conoscenza acquisita), Il Libraio, Radiolibri, Lo Scaffale, coi loro verosimili indirizzi e contatti (mai accessibili direttamente) vogliono passare per informatori e mediatori culturali quando invece risultano negoziatori tendenziosi (speculatori) a fini economici-politici con le loro ‘parole in sintonia’ (con chi?); ‘leggiamo insieme’ (a chi?); ‘guida all’uso dello scaffale dei libri’ (ma di chi?), per così dire, quando a scrivere e a pubblicizzare i propri libri sono gli stessi che conducono un programma (più o meno di successo), o che prendono parte a un reality (signori spesso sconosciuti senza arte né parte).
Tutta-via, riprendendo il verso da un noto modo di dire ‘non si può fare di tutta l’erba un fascio’ (scusate la parola che non si dovrebbe neppure pronunciare), c’è sicuramente da fare qualche distinguo, soprattutto se parliamo del ‘Il piacere della lettura’ (laFeltrinelli), come lo intendeva (a suo tempo) Marcel Proust e che qualcuno obietterà che si era nel 1916 e che da allora ‘ne è passata d’acqua sotto i ponti’, un altro modo di dire referente a Roma Ca-(pitale) (ma di che?). Sicuramente di un’Italia che si legge addosso, o che non legge affatto.
Delle-due una, si ma quale? Quella che si perde nella deludente Nuvola di Fuksas diventata per l’occasione della manifestazione libraria ‘piena di smog del falò dei libri da ardere’; oppure quella intelligente (e direi finalmente), della ‘Piccola Biblioteca Di Letteratura Inutile’ ideata e edita da Giovanni Nucci? La scelta non è così scontata se si pensa allo slogan di laFeltrinelli: “I libri raccontano molte più storie di quelle scritte tra le loro pagine”. Bello no? Tant’è che ho pensato a una libreria fatta di soli titoli di copertina (magari bene illustrate) e un interno completamente bianco, dove ogni lettore può leggere (o anche scrivere) ciò che gli pare. Anche perché un siddetto slogan, se pronunciato ad alta voce, ha lo stesso valore dell’inutilità di leggere, o di continuare a leggere.
Ma non è questo il messaggio che voglio qui dare a chi mi legge, (e sembra ormai che siano davvero in molti) piuttosto preferisco citare un forbito articolo che riprendo alla lettera dal blog posted 21/03/2016 di Annamaria Testa in home, idee (sperando nella sua autorizzazione a riprodurlo e che invito tutti a visitare), in cui fa il punto sul significato di leggere:
“LA FATICA DI LEGGERE E IL PIACERE DELLA LETTURA” dal sito di Annamaria Testa.
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi.
L’INNATURALE FATICA DI LEGGERE. Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni.
Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo. Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa.
LA LETTURA SILENZIOSA DI SANT’AMBROGIO. La stessa lettura silenziosa è una conquista recente. Greci e latini leggevano compitando il testo a voce alta, o sussurrando. Quando il giovane Agostino di Ippona va a trovare sant’Ambrogio, che è un gran lettore, resta talmente colpito dal fatto che legga in silenzio da registrarlo, poi, nelle Confessioni: «Nel leggere, i suoi occhi correvano sulle pagine e la mente ne penetrava il concetto, mentre la voce e la lingua riposavano. Sovente, entrando, poiché a nessuno era vietato l’ingresso e non si usava preannunziargli l’arrivo di chicchessia, lo vedemmo leggere tacito, e mai diversamente.»
IMPARARE A LEGGERE. La lettura silenziosa si afferma, secondo gli studiosi, solo nel 1600: appena quattro secoli fa. E la diffusione della reale capacità di leggere è ancora più recente, specie nel nostro paese: nel 1861, anno dell’unità d’Italia, gli analfabeti sono quasi l’80 per cento della popolazione, con punte del 90 per cento e oltre in Sardegna, Calabria e Sicilia. Un’intensa opera di scolarizzazione riduce gli analfabeti totali a meno del 13 per cento della popolazione nel 1951.
TRA DOVERE E VOLER LEGGERE. Ma oggi, e a dirlo è l’Ocse, il 69 per cento degli italiani è ancora sotto il livello minimo di competenza nella lettura necessario per vivere in un paese industrializzato. Se questo è il dato di base, non deve stupire che il 58 per cento degli italiani dai sei anni in su non abbia spontaneamente (cioè non per obbligo scolastico o lavorativo) aperto neanche un libro negli ultimi 12 mesi, manuali di cucina e guide turistiche comprese. Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso.
MOTIVARE A LEGGERE. Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe, credo, farsi un’altra domanda: che cosa può motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? Bene: sapete (ne abbiamo già parlato) che le motivazioni più forti sono quelle interne, o intrinseche (sentirsi bravi, capaci, appagati) Le motivazioni esterne (o estrinseche) come premi e punizioni, voti scolastici compresi, funzionano meno.
LA FATICA DI LEGGERE E IL SUO COMPENSO. C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. È il piacere di sentirsi appagati, o migliori. Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare (non a caso molte campagne in favore delle lettura lasciano il tempo che trovano. Non tutte, però) e impossibile da imporre.
LEGGERE A VOCE ALTA, AI PICCOLI (E NON SOLO). Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno.
Ho però la sensazione che l’assai sottovalutata lettura a voce alta possa conquistare ai libri anche gli studenti più grandi, e perfino qualche adulto. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative. Prometto di tornare a breve sull’argomento.
Leggiamo insieme alcuni commenti:
giacomo 21/03/2016
TORNIAMO AL 1600!
1) Su Radio 3, ogni giorno va in onda il programma ‘Ad alta voce’, durante il quale un attore legge un romanzo o un racconto (adesso stanno trasmettendo i Racconti Ferraresi, di G. Bassani). Non fare scorrere gli occhi su un testo ma aprire le orecchie alla voce di un’altra persona è meraviglioso. Un po’ tornare bambini, un po’ scoprire passo passo (ascoltare richiede più tempo che non leggere) la complessità e la coerenza di un testo. D’altra parte credo che ascoltare letture ad alta voce possa sollecitare curiosità e desideri di letture autonome.
2) C’è poi, dal punto di vista professionale, la necessità di leggere ad alta voce i propri testi prima di congedarli. Su questo AT è tornata in più occasioni, esprimendo pareri totalmente condivisibili.
3) Che ‘il 69 per cento degli italiani è ancora sotto il livello minimo di competenza nella lettura necessario per vivere in un paese industrializzato’ non provoca stupore: basta seguire i quotidiani (anche qui, sempre su Radio 3, alla mattina alle 7,15 c’è la rassegna stampa in cui un giornalista diverso ogni settimana legge le notizie) per rendersene conto… Sigh!!
Margherita 21/03/2016
Il gusto di lasciarsi possedere da una storia, di perdersi, ritrovarsi, identificarsi, arrendersi, bilocarsi, viaggiare nel tempo, provandone contemporaneamente gli effetti fisici. Perchè gli ormoni secreti sono poi gli stessi che produrremmo se i fatti narrati ci succedessero realmente. Trovare nelle storie dei navigatori competenti delle nostre esistenze, ascoltarle per nutrirsi, per connettersi, per trovare risposte, o simulare situazioni di vita senza correrne davvero i rischi. Che meraviglia!
E dato che ognuno di noi vede riflessi di sè nelle storie, desidero prendere queste parole come un augurio speciale. ‘A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.’ Perchè Laura e io, ci stiamo spremendo di fatica e gioia per porgere storie e mondi emozionali letti ad alta voce <3 <3 <3 e in questo pezzo ci sentiamo tanto capite.
Magari 22/03/2016
Aggiungo una nota, sempre ricordando trascorsi attoriali: ovvio che un genitore non ha bisogno di grandi studi per leggere una favola ai figli, ma la lettura ad alta voce è una faccenda difficilissima e che richiede competenze per nulla banali! Italo Svevo non si può leggere ad alta voce, non si capisce niente. Pirandello invece scriveva con gli attori e il palcoscenico e il pubblico in mente, si intuiscono intonazioni e sfumature quasi alla prima lettura. In mezzo ci stanno mille gradazioni, ma chi vuole leggere regolarmente davanti a un pubblico dovrebbe studiarsi un po’ di recitazione, soprattutto se il suo scopo è trasmettere il piacere della lettura.
Sara 13/04/2017
Annamaria, seguo un canale di un tipo in gamba su YouTube che usa la videoclip come formato per trattare efficacemente argomenti complicatissimi. Ad un certo punto fa una riflessione: per comprendere c’è bisogno di tempo e fatica. La nostra parte ‘pigra’ del cervello è in realtà quella che interiorizza i concetti. Per farlo, deve spendere un sacco di energie. Il video sembra velocizzare il processo di apprendimento perché riduce i concetti, li scorpora, e li accompagna con immagini e scene che riassumono o scremano le cose più fitte di dettagli. In realtà, si è accorto, non si consolida una nuova conoscenza, si crea soltanto l’illusione di aver capito.
Mi sembra interessante: non c’è modo di usare scorciatoie, proprio come con la palestra. Non a caso si chiamava ginnasio.
IN MOSTRA AL: MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
02 dicembre 2017 - 29 aprile 2018
'Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein' - Galleria 4
a cura di Luigia Lonardelli, Vincenzo Napolano, Andrea Zanini
consulenza scientifica: Giovanni Amelino-Camelia
Spazio-tempo, crisi, confini: un percorso attraverso questi concetti chiave fra loro dipendenti e interconnessi.
Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.
A cento anni da questa pubblicazione il MAXXI dedica una mostra a una delle figure che più ha influenzato il pensiero contemporaneo.
Il progetto è il risultato di una inedita collaborazione del museo con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la parte scientifica e con l’artista argentino Tomás Saraceno per la parte artistica.
Indagando le connessioni e le profonde analogie tra l’arte e la scienza, Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein racconta gli sviluppi della teoria della relatività nella visione odierna dell’universo e le affascinanti ricadute che essa produce ancora oggi in campo artistico.
Attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali, la mostra rende omaggio allo scienziato che ha cambiato radicalmente le nostre conoscenze, la percezione e l’immaginario dell’universo.
Installazioni artistiche e scientifiche immersive, reperti iconici e simulazioni di esperimenti per avvicinarsi all’essenza delle innovazioni scientifiche introdotte da Einstein e svelare le profondità sottese all’Universo conosciuto, ma anche i meccanismi che legano insieme tutti gli uomini nella ricerca della conoscenza, in un processo collettivo nel quale gli artisti e gli scienziati svolgono un ruolo ugualmente significante e fondamentale per la società.
MEDIATORI SCIENTIFICI
Dal martedì al venerdì, dalle 11:00 alle 17:00, e il sabato e la domenica, dalle 11:00 alle 19:00, sono presenti in galleria dei mediatori scientifici per informazioni e approfondimenti sui temi della mostra. Attività a cura dell’impresa sociale Psiquadro.
Pensato come un grande campus per la cultura, il MAXXI è gestito da una Fondazione costituita nel luglio 2009 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presieduta da Giovanna Melandri. Da dicembre 2013 Hou Hanru è il Direttore Artistico del museo, di cui fanno parte il MAXXI Architettura, diretto da Margherita Guccione, e il MAXXI Arte, diretto da Bartolomeo Pietromarchi.
La programmazione delle attività - mostre, workshop, convegni, laboratori, spettacoli, proiezioni, progetti formativi - rispecchia la vocazione del MAXXI ad essere non solo luogo di conservazione ed esposizione del patrimonio ma anche, e soprattutto, un laboratorio di sperimentazione e innovazione culturale, di studio, ricerca e produzione di contenuti estetici del nostro tempo.
Sede del MAXXI è la grande opera architettonica, dalle forme innovative e spettacolari, progettata da Zaha Hadid nel quartiere Flaminio di Roma.
IL BIGLIETTO D'INGRESSO AL MUSEO CONSENTE LA VISITA ALLE MOSTRE IN CORSO PRESSO IL MUSEO.
MAXXI Architettura
Il MAXXI Architettura è il primo museo nazionale di architettura presente in Italia e il suo radicamento nel contesto culturale e territoriale italiano ne definisce l'identità. Nel Museo di Architettura convivono due anime distinte, quella che procede verso la storicizzazione dell'architettura del XX secolo e quella contemporanea che vuole rispondere agli interrogativi del presente, interpretando le aspettative della società attuale. Museo storico e museo contemporaneo, quindi, in cui passato e attualità si intersecano, adottando di volta in volta le forme e i modi utili a sviluppare un percorso di conoscenza, ad analizzare tendenze e personalità, modelli culturali e comportamenti sociali. Il Museo svolge attività scientifiche e divulgative; tra queste le esposizioni temporanee che offrono ai visitatori opportunità sempre diverse di fruizione e approfondimento: al piano terra, nella Galleria 1, le mostre sul XX secolo, nella Sala Carlo Scarpa le mostre di Fotografia; al primo piano, nella Galleria 2 quelle sull'architettura del XXI secolo. Dal programma culturale discendono le acquisizioni, le attività di produzione e di ricerca promosse direttamente dal museo anche in coproduzione e collaborazione con altre istituzioni.
MAXXI Arte
Il MAXXI Arte è un museo del contemporaneo all'interno di un'architettura fuori dagli schemi, punto di partenza per una nuova pratica museografica che rompe con il passato. Naturalmente orientato alla creatività contemporanea, Il MAXXI Arte vuole essere interprete e portavoce delle sue differenti voci, consapevole che la contemporaneità ha forme diverse, radicate nel XX secolo e talvolta più indietro. Il museo è volto quindi alla promozione dell'arte giovane e alla valorizzazione di quelli che possiamo considerare i suoi maestri, ricerche che hanno mosso i loro passi nel XX secolo ma non per questo non dialogano con il XXI. Con i suoi 13.500 metri quadri di superficie e la sua collezione, il museo di Arte rappresenta, coerentemente all'idea con cui è nato, uno spazio sperimentale che oltre alla sua collezione e all'attività espositiva propone una programmazione culturale multidisciplinare che comprende naturalmente l'arte ma anche il teatro, la danza, la musica, la moda, la grafica, il cinema, la pubblicità.
Una attività, quella del museo, che ben si sposa con la sua struttura a flussi che rende possibile una lettura non condizionata degli spazi e delle opere, un momento unico per il visitatore, invitato a scoprire una contemporaneità – che è anche temporale e spaziale – di eventi, esposizioni, performance.
Seguendo questa vocazione di apertura alla contemporaneità nelle sue diverse forme e nei suoi tempi, il MAXXI Arte ha costruito nel tempo la sua collezione grazie ad acquisti, premi, donazioni e comodati arrivando oggi a circa 300 opere con l’obiettivo di ampliare ancora il suo patrimonio per offrire al proprio pubblico uno sguardo sempre ampio e informato sulla contemporaneità nazionale e internazionale.
Hashtag della mostra
#GravityExhibit
(continua)
*
 - Musica
- Musica
Australia e Italia si fondono nel Jazz
Jazz australiano e italiano si fondono: esce il primo album del trio 'Torrio!' formato da Paul Grabowsky, Mirko Guerrini e Nico Schäuble.
Dopo l'ottima anteprima live dello scorso febbraio alla Casa del Jazz di Roma, il trio australiano ‘Torrio!’ fa il suo ingresso nel mondo discografico con il suo primo e omonimo album, una produzione italiana dell'etichetta Encore Jazz (distr. Egea), già presentata in Australia lo scorso agosto meritandosi la candidatura come ‘Best Jazz Album’ per The Age Music Victoria Awards.
‘Torrio!’ rappresenta un'interessante fusione artistica che nasce a Melbourne cinque anni fa durante un concerto in onore del sassofonista australiano Bernie McGann: il sassofonista italiano Mirko Guerrini incontra due tra gli artisti australiani più importanti, il pianista Paul Grabowsky e il batterista Niko Schäuble, che collaborano insieme da oltre trent'anni. Ne nasce musicalmente una vera e propria conversazione a tre fondata su un costante movimento degli equilibri e dunque da un ottimo interplay, nonché da un approccio al suono molto appassionato che va riferendosi ora alla tradizione, ora al jazz contemporaneo, arrivando a toccare anche musica classica, pop e musiche da film.
Il risultato, racchiuso in questo disco, è una tracklist di dieci brani firmati dai tre musicisti, giocosi, gioiosi e al tempo stesso molto profondi. Paul Grabowsky e Niko Schäuble sono considerati tra le personalità musicali più importanti in Australia. Per i suoi meriti artistici, è stato insignito Cavaliere dell’Ordine d’Australia; ha suonato con nomi del jazz internazionale quali Chet Baker, Art Farmer e Johnny Griffin. E’ fondatore della Australian Art Orchestra, ha vinto 5 ARIA Awards (Australian recording Industry association), 2 Helpmann Awards, diversi APRA e Bell Awards nonchè un Deadly Award. E' stato eletto il Sydney Myer Performing Artist of the Year nel 2000 e ha ricevuto il Melbourne Prize for Music nel 2007.
Niko Schäuble è uno dei batteristi e compositori più affermati d’Australia. Ha vinto numerosi premi tra cui l'Australian Jazz Award/Best Drummer, Honorable MentionJulius Hemphil Awards, New York, Nomination for the 'Leo' Award (music for short film) al Braunschweig Filmfestival, Finalist at Annecy Film Festival. Tra le sue collaborazioni: Sam Rivers, Lee Konitz, Enrico Rava, Trilok Gurtu, Branford Marsalis, Mike Nock, Wynton Marsalis, Dewey Redman, Arthur Blythe, Steve Lacy, Greg Osby. Mirko Guerrini, che in quest'album suona oltre al sax anche il flauto pakistano e l'armeno duduk, è uno dei musicisti di punta della scena italiana.
Poliedrico multistrumentista, produttore e direttore d’orchestra, da qualche anno ha deciso di vivere in Australia, dove è diventato docente alla Monash University di Melbourne ed ha ottenuto in Australia la Permanent Resident per il suo talento e per i titoli artistici di livello internazionale in ambito jazz. In Italia ha collaborato per oltre dieci anni con Stefano Bollani, con cui - insieme a Davide Riondino - ha anche condotto la fortunata trasmissione radiofonica ‘Dottor Djembè’ di Radio3. Ha all’attivo oltre 60 album e collaborazioni illustri tra cui quelle con Billy Cobham, Paul McCandless, Caetano Veloso, Hermeto Pascoal, Brian Auger, Mark Feldman, Dave Douglas, Enrico Rava, Stefano Battaglia, Giorgio Gaber e Ivano Fossati.
Hanno scritto di sé: ‘Desideriamo suonare come se fossimo un solo musicista, sublimando noi stessi nello scorrere degli eventi. Una musica senza frontiere giocosa, gioiosa e molto profonda.’ CONTATTI iTunes: http://bit.ly/torrioITUNES www.encorejazz.it - www.torriojazz.com Ufficio stampa Encore Jazz: Fiorenza Gherardi De Candei Tel. +39 328 1743236 – fiorenzagherardi@gmail.com
*
 - Poesia
- Poesia
Andrea Bassani o l’anima nuda della poesia d’amore
‘Lechitiel’ - Terra d’ulivi Edizioni 2016
“Ma che ne sai tu del pianto di un vetro, quando la luce scompare?..”
… scrive l’autore di questo libro per così dire ‘insolito’ di Andrea Bassani, in cui l’esercitazione nell’arte poetica, nella scrittura così come nella lettura, richiede una pronunciata enfasi drammatica che mette a nudo il senso intrinseco delle parole. Non necessariamente delle frasi compiute o incompiute che siano, quanto il suono racchiuso negli interstizi del ‘senso’ o dell’insensatezza (spazi bianchi, vuoti passati sotto silenzio); così come dell’incongruenza illogica o dell’assurdità tragicomica in cui il suo mondo poetico trova ispirazione. Senso e nonsenso in cui si propaga il suono delle parole, proprio come avviene in musica nel controcanto e nel discanto, contrario all’andamento uniforme del canto:
“La poesia ha questo di brutto (o forse di straordinario?):
ti salva la vita una volta e poi le appartieni.
Ti carica in spalla moribondo
e ti nasconde per curarti, non so dove.
Ma quando ti ha guarito
ti costringe a cantare
tutti i mali del mondo.”
Un ossimoro, se vogliamo, che in musica trova il suo corrispettivo nel cosiddetto ‘canone’, la forma più conosciuta di imitazione contrappuntistica nei canti a più voci, in cui il tema principale può essere tuttavia esposto anche rovesciando specularmente gli intervalli, come ad esempio nel ‘canone inverso’. Un modo di procedere questo, che ritroviamo in ‘Lechitiel’ la silloge poetica che Andrea Bassani ha intitolato all’angelo della pace interiore, invocato dagli scoraggiati caduti nella disperazione e che non hanno la forza di rialzarsi. Ma anche di chi cerca invano di oltrepassare la soglia dell’invisibile assoluto per entrare in quell’universo parallelo dove prevale la mutazione fra ciò ch’è reale e l’effimero visibile, fra l’occulto e l’incomprensibile. Dove infine si amalgamano il segreto palpabile dell’esistenza e ciò che è l’eterno dell’arte, la voce suprema e il verbo, la musica eccelsa e la poesia della parola, utilizzando l’esercizio pratico dell’eloquenza, l’insieme di tecniche, schemi e figure che regolano l’arte poetica ma che, tuttavia, per quanto possa sembrare un controsenso, non appartengono al Bassani poeta di questa raccolta:
“Non cercate di salvare i poeti,
non vi seguiranno:
loro vegliano, giorno e notte,
la salma assente del corpo amato,
nella camera ardente
del vuoto d’amore.”
Scrive l’autore riferendosi ai poeti che nell’estaticità della loro illusione, leccano le ferite della propria anima da essi stessi violentata, uccisa, smembrata, morta di niente, e se ne stanno in solitudine al chiuso della propria torre d’avorio, dominata dalle fiamme dell’inferno (masochista) in cui essi stessi ardono e si bruciano:
“Lascia che il mio sogno continui
Per la follia della mia penna delirante.”
Simile al delirio del ‘nudo’ Adamo che non sa come coprirsi per il freddo che lo incalza, e come ripararsi dallo sconcio immorale di una realtà che lo sovrasta, così, raccolto nel nichilismo adamitico della sua funzione poetica, l’autore mette a nudo la parola nel segreto della propria oscura visione che ha dell’amore. Nel senso che egli ‘denuda’ la poesia spogliandola degli orpelli declamatori, e apre all’esercizio dell’elaborazione minimalista, talvolta ripetitivo e claustrofobico, decisamente peggiorativo dell’arte del dire, interiorizzando tutto quello che ruota intorno al ‘suo’ dramma personale:
“Subisco la bellezza come una violenza inaudita.
Il mistero della bellezza è un’incomprensibile tortura.”
Ogni volta accogliendo e dismettendo le continue metamorfosi della sua anima inquieta, nel modo inedito in cui Paul Celan scompone e cristallizza le figure alla luce della sua attualità retorica, mirando a un contenuto di verità che trascende il loro significato consueto. Allo stesso modo che trasforma la ‘bellezza dell’amore’ (narcisistico) in amore universale, avulso dalle branche della forma poetica per entrare negli interstizi della forma letteraria, e lo fa proprio nel suo “Cantico della bellezza”, in cui dice:
“Ogni desiderio è figlio di una bellezza.
Dunque la bellezza è madre, una madre che non ama.”
Ma se un madre non ama chi altro può dare soccorso a chi è caduto o ripetutamente cade nell’incauto difetto, per debolezza o anche per imperfezione, poiché nulla ci è dato senza laggio, finanche la redenzione richiede un equo riscatto. Né l’espiazione di una colpa avviene senza aver oltrepassato la ‘soglia’ dell’invisibile assoluto:
“Se tu mi avessi amato, (donna, madre, sorella, amante)
nel niente, nel buio, nel vuoto,
non sarei qui a dirti: ‘ti amo’.”
Perché l’autore di questi versi ama davvero, profondamente, e senza mezzi termini si prostra alla passione, fino ad esautorarsi, a dissanguarsi davanti all’inspiegabile presenza della bellezza d’amore che lo consuma. La cui assenza è rivelatrice della bassezza della sua anima primordiale, della sua volgarità e nefandezza per cui, ancor prima, amare significa ‘bruciare tutto cià che è attorno’, come la Fenice che attende di risorgere per poi bruciare di nuovo:
(da ‘Cantico della Bellezza)
“Alzati!
Segretamente mi comando
ogni qual volta malcapitato mi capita d’incontrarla.
Eccola che arriva,radiosa, stupendamente cinica,
impassibile mi passa accanto con l’aria superba
di un angelo mortifero,
impunita,
sempre assolta per mancanza di prove.
Le sue vittime paino tutte suicide!
Alzati!
Eccola che arriva, sediziosa,
lei che di tutte le anime conosce la chimica.
Per questo predilige i tuoi spasimi, poeta!
Alzati!
Eccola che arriva,
e mi coglie impreparato col suo incedere regale.
La sua mano invisibile,
osannata dalla mia povertà,
mai si eleva a benedire il mio capo chinato.
Alzati!
Tacitamente le offro la mia intera esistenza
che puntualmente oltrepassa snobbandola
Alzati!
Perché la mia vita non le interessa.
Alzati!
Si prende gioco del tuo mancato, del tuo mancante.
Alzati!
. . .
È così avara e taccagna,
mostruosamente incaritatevole,
ama soltanto se stessa.”
“Ma la realtà è un’altra …”, scrive ancora Bassani rinvenendo nei sacri testi biblici le ragioni di una sconfitta che brucia.
“Siamo noi a mentire con forza per sopportarne la visione. Siamo noi che ci voltiamo empi giunti alle porte di Sodoma. Noi, come la moglie di Lot, a rimanere di sale.” … Ma non c’è ragione che tenga contro l’abiura a dover essere e di volere, nulla contro il sale (senso) della vita che chiede, che pretende altri sacrifici, come di continuare a soffrire e di proseguire lungo la strada dell’afflizione d’essere uomini tra gli uomini, umani sdraiati sulla terra, polvere da calpestare:
“Oh Cristo, preservami dalla bellezza!
. . .
Che cos’è ch’io non sappia resisterle?
È una bianca colomba adagiata
Sulle spire ipnotiche di un serpente
dall’apparenza gentile?
. . .
Per quanti anni l’ho inseguita,
volevo averla, ne pretendevo il possesso.
Ma ho appreso consumandomi che
chi desidera la bellezza è all’anticamera della follia.
Perché la bellezza non si lascia possedere,
soltanto si contempla.”
Come ‘I borghesi di Calais’, (l’impressionante gruppo statuario di Auguste Rodin), che scalzi vanno verso la morte, o forse restano (aspettando la morte), la cui abnegazione fa virtù, destinati a essere martiri o a diventare eroi (?) di una realtà liquida destinata a scomparire. Anche per questo: “Come un ricordo collettivo di sofferenza e sacrificio”, la figura dello scrittore Andrea Bassani va qui celebrata come un esempio di chiara elettività poetica.
Nota d’autore:
“… A ventitré anni fui abbandonato dalla donna che amavo più di me stesso. Ho trascorso poi tre anni di buio che mi hanno visto cadere nella rete dell'alcolismo. In quei tre anni la poesia mi ha salvato diverse volte ma in molte altre occasioni avrei voluto liberarmene per sempre, perché la poesia era diventata il surrogato della donna che mi aveva condannato alla sofferenza: la schiavitù di quella pesante assenza e la nuova schiavitù di una poesia necessaria a risalire la china talvolta si alleavano e insieme mi torturavano. La poesia non è sempre straordinaria (lo diventa quando riusciamo a gestirla): da qui "la poesia ha questo di brutto, ti salva la vita una volta e poi le appartieni". A ventisei anni, in condizioni disastrose, fui portato da quello che è il mio attuale padre spirituale, un francescano che mi ha riportato alla luce, per il quale ho lasciato l'azienda, famiglia, casa, amici e mi sono trasferito nella comunità in cui tutt'oggi vivo, occupandomi di persone bisognose e della cura dell'anima. La conversione spirituale mi ha aperto gli occhi su un nuovo modo di concepire il mondo e l'amore. Il passaggio dall'amore umano per una donna all'amore universale, la lotta che ne consegue, l'elaborazione del dolore, la nostalgia del passato, la sua rivisitazione, la volontà di ricominciare, la resistenza alla bellezza e alla sensualità, passi necessari per intraprendere la nuova via spirituale/religiosa, costituiscono il mio ‘Lechitiel’, scritto a più riprese: in parte nell'abisso, in parte nel periodo di transizione/metamorfosi, in parte nella luce di una spiritualità rivelata che mi chiedeva di chiudere col passato e di resistere a ciò che un tempo era ragione di vita e ora niente più che tentazione e peccato. ‘Lechitiel’ non è un libro di poesia scritto pensando al lettore: questi versi sono intrisi di lacrime e sangue, concepiti quasi istericamente. Ogni poesia è stata necessaria in un determinato momento di grande difficoltà emotiva. Se non avessi scritto ‘Lechitiel’ molto probabilmente non sarei qui a stendere questa email.”
bassanieco@libero.it
terraduliviedizioni@libero.it
*
 - Cinema
- Cinema
The Place il nuovo film di Paolo Genovese
‘The Place’ il nuovo film di Paolo Genovese presentato alla 12a Festa del cinema di Roma.
‘A Wondefull Place’, mi viene da dire, per la sua originale quanto 'audace' sceneggiatura, benché adattamento cinematografico della serie tv americana del 2010 ‘The Booth At The End’ di Christopher Kubasik, che si avvale della firma, oltre che del regista Paolo Genovese, di quella di Isabella Aguilar, l’ormai nota sceneggiatrice di lungometraggi e fiction per il Cinema e la TV, e scrittrice di successo che ha partecipato al Festival di Venezia, ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento e numerosi altri premi nazionali e internazionali.
Quanto basta per non dubitare della sua bravura, infatti Paolo Genovese che immagino abbia curato massimamente la regia, l’ha voluta al suo fianco per dare a questa ‘piece teatrale’ un notevole risvolto psico-filosofico da non sottovalutare, se non altro perché la Auguilar ha una Laurea e un Dottorato di Ricerca in Filosofi, che non guasta se si vuole raggiungere tale profondità introspettiva. Per quanto la sceneggiutura del film non calchi la mano sulle intemperanze squilibrate dei personaggi, ma lo fa con un linguaggio lineare, direi canonico, giocato sul non detto che richiede una certa intuizione e il coinvolgimento dello spettatore.
Per quanto, sappiamo che l’emotività dello spettatore può fare brutti scherzi come, disorientarlo, metterlo in difficoltà, costringerlo a un esame voluto e, soprattutto, non cercato. Così come, in certi casi, metterlo a nudo davanti allo specchio invisibile che è la sua coscienza, che tutto nega, o se preferite, tutto rimette al ‘libero arbitrio’ (non citato nel film ma che può essermi sfuggito), che altro non è che l’illusione di poter scegliere chi siamo e/o chi vogliamo essere per noi o davanti a quegli altri che non vorremmo essere noi.
Scusate il gioco di parole ma in quanto spettatore è esattamente quello che ho provato dopo i fatidici quindici minuti dall’anizio, per cui infastidito sarei volentieri uscito dal cinema. A fermarmi con forza sono stati i cinque minuti successivi e che mi hanno letteralmente inchiodato alla poltrona, appunto per il risvolto psicologico-negazionista che noi tutti attuiamo per metterci al coperto: protagonisti relativamente umani, piuttosto ‘mostri’ dell’inconscio individuale e collettivo, che ci appropriamo delle vite degli altri solo perché non sono come noi vorremmo che fossero, e/o come noi vorremmo che si svolgessero.
È concettualmente accertato che l’uomo post-moderno, sempre in bilico tra l’uomo arcaico e l’uomo futuro, non riesce a trovare un proprio equilibrio che gli dia stabilità all’interno della sfera evolutiva, in ragione della sua incontenibilità precostituita, dovuta per lo più all’andamento accelerato con cui la società si trasforma e, rispetto alla velocità di assorbimento psico-fisica diversa per alcune tipologie di individui e aree di sviluppo intellettuali. O, almeno, per quanto concerne i comportamenti umani elementari dall’inizio dell’evoluzione naturale delle coscienze ad oggi, in cui è d’obbligo riaprire un proficuo discorso su ‘chi veramente (noi) siamo?, e cosa siamo disposti a fare per ottenere ciò che vogliamo?’.
Che è poi la chiave di lettura del film. La risposta è (ovvia) in noi stessi, il film lo dimostra molto bene, così come altrettanto bene scrisse a suo tempo il noto etologo e linguista Irenäus Eibl-Eibesfeldt: “Se smetteremo di erigere barriere alla comunicazio¬ne fra gli esseri umani e di degradare a mostri coloro che sono umani come noi, anche se aderiscono ad altri sistemi di valori . Ma se, al contrario, accentueremo ciò che a loro ci lega, noi - uomini e donne di coscienza – prepareremo per i nostri nipoti un futuro felice. Le potenzialità del bene sono biologicamente presenti in noi quanto quelle (del male) e dell’autodistruzione”, che convenientemente dobbiamo in ogni modo evitare.
Ciò dunque, per rispondere a una ‘decisione sovrana’ che non trova oggi riscontro nell’ampio spettro dell’universalità umana: per cui ‘ogni uomo è libero’ nell’ambito della globalità dello sviluppo storico-sociale in stretta relazione con il pensiero filosofico dominante, concettualmente paritetico di quel processo di conversione che ha trasformato il ‘positivismo relativo’ del secolo scorso, nel ‘pensiero negazionista’ contemporaneo, in cui il ‘tutto’ è verosimilmente sostituito dal ‘nulla’; che è comunque un ‘nulla’ antropico, cioè relativo all’analisi degli assetti organizzativi umani conseguiti, ovvero allo studio (scientifico) di quei processi che nel corso del ‘tempo’ hanno condotto alla formazione degli assetti evolutivi cui si riferiscono.
Assetti questi indubbiamente inerenti al ‘passato’, che potrebbero dirsi superati se messi a confronto con la rivoluzione socio-economico-politica, nonché filosofica ed esistenziale che la pressante globalizzazione di massa impone al ‘presente’. Qullo stesso presente e che sta trascinando tutto e tutti verso una caduta inarrestabile, difficile da predeterminare. Di fatto l’‘evoluzionismo’ filosofico/scientifico (darwiniano e lamarckiano) sembrerebbe ormai superato e aver lasciato il posto a più attuali problematiche dettate da una ‘sovranità giuridica’ irrevocabile, nonché da una maggiore ‘responsabilità politica’ insormontabile che, in ogni caso, vanno rapportate a quel ‘futuro’ che incombe alle porte della coscienza di noi moderni.
Per quanto tutto ciò possa sembrare astruso stiamo comunque parlando di cinema, di un film molto teatrale, come se ne sono visti tanti in passato, eppure sofisticato a tal punto che alla fine della visione mi sono chiesto se a scriverlo fosse stato Pirandello e il regista un certo Hitchcock. In vero c’è nel film: statico ma equilibrato, sadico e malvagio quanto basta, minimalista per eccellenza, un qualcosa che mi ha ricordato (non so bene perché) ‘Il terzo uomo’ di Orson Wells, per il suo penetrare negli interstizi della trama. Una non trama che, al dunque, preferisce di gran lunga lasciare al contesto filmico il ruolo di definire il significato e allo spettatore, di essere parte attiva di qualcosa che lo riguarda da dentro … il che può anche risultare scioccante!
Ne risulta una fiction ben curata, splendida la fotografia, montaggio strepitoso senza sbavature, ottima l’interpretazione di tutti. Che altro dire? Se non vi sentite preparati o se avete degli scheletri negli armadi, non andatelo a vedere. Altrimenti va visto condiviso e discusso con gli altri. Cosa che ho fatto di proposito, all’uscita dalla sala ho chiesto a qualcuno/a se gli era piaciuto. Risposte: Non saprei? Neanche un po’! Dovrò rivederlo per capire meglio. Decisamente sì, perché in qualche parte mi ci sono ritrovato.
Da Cineuropa News, che ringrazio per la cortese collaborazione, riporto una recensione di Vittoria Scarp datata 09/11/2017:
‘The Place’: cosa sei disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?
Presentato in chiusura alla 12a Festa di Roma, il nuovo film di Paolo Genovese. Un huis clos (‘A porte chiuse’ da Jean Paul Sartre) con dieci personaggi in un bar, davanti alla propria coscienza. Era uno dei film più attesi della stagione. Dopo il successo travolgente di 'Perfetti sconosciuti' , Paolo Genovese poteva osare e così ha fatto, estraendo dal suo cilindro un film ambizioso, metaforico, non per tutti, dove abbandona davvero per la prima volta il registro della commedia. 'The Place' è il titolo del film e il nome del bar con tanto di vistosa insegna luminosa, dove siede un uomo, sempre allo stesso tavolo, e dove entrano ed escono dieci personaggi, tutti i giorni, a tutte le ore, per incontrarlo e parlare con lui.
Un film di dialoghi, una prova di attori, un huis clos concettuale, che pone allo spettatore un’unica sostanziale domanda: cosa sei disposto a fare per ottenere ciò che vuoi? Se 'Perfetti sconosciuti' indagava la parte più oscura delle persone che ci stanno accanto, 'The Place' scandaglia l’anima nera che ognuno porta dentro di sé. L’uomo seduto al bar giorno e notte (incarnato da Valerio Mastandrea) dà indicazioni alle persone che si rivolgono a lui su come esaudire i propri desideri, anzi, stipula con loro un vero e proprio contratto.
Diventare più bella, passare una notte con una pornostar, salvare il proprio figlio, riacquistare la vista, ritrovare Dio, sono alcuni dei desideri che i vari personaggi del film espongono all’uomo del bar. “Si può fare”, risponde lui mentre scrive convulsamente sulla sua grande agenda, fitta di appunti in ogni angolo di ogni pagina. Ma c’è un prezzo da pagare. Un prezzo in alcuni casi molto alto: rubare una grossa somma di denaro, mettere una bomba in un locale, violentare una donna… Se si svolge il compito assegnato, il successo è garantito. Starà a ognuno di loro decidere se accettare o rifiutare l’accordo.
Paolo Genovese adatta con questo film una serie tv americana del 2010, The Booth At The End, vi aggiunge dei personaggi, ne toglie altri, intreccia le storie fra di loro, trova un finale per ognuna. Seguiamo il progredire delle missioni assegnate, i personaggi si presentano puntuali davanti all’uomo per aggiornarlo (“raccontami i dettagli”, ripete lui a ciascuno di loro), assistiamo a esitazioni, ripensamenti, ma c’è anche chi mente, chi va oltre i limiti stabiliti, in un vortice di degenerazione umana da dove però si fa sempre in tempo ad uscire, basta volerlo. Il regista varia le inquadrature il più possibile, riprende i suoi attori da ogni angolo, ma non riesce a evitare una certa ripetitività nei gesti, nei movimenti, nelle dinamiche dei personaggi, che nel formato seriale originale (puntate da 12 minuti) è forse più digeribile che non in un lungometraggio di un’ora e tre quarti.
Il regista Paolo Genovese si conferma tuttavia un autore coraggioso, alla ricerca di strade nuove, e come in 'Perfetti sconosciuti' spinge lo spettatore a mettersi in discussione e lo manda a casa con una domanda in testa: cosa farei io al posto loro?
Il cast all star è composto da Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Silvia d’Amico, Giulia Lazzarini, con Sabrina Ferilli nei panni della cameriera del bar che, a porte chiuse e durante le pulizie serali, cerca di capire chi sia veramente quell’uomo misterioso cui tutti chiedono qualcosa (Dio? Il diavolo? La nostra coscienza?).
Prodotto da Medusa Film con Lotus Production, The Place esce oggi, 9 novembre, in 510 sale con Medusa.
Le vendite internazionali sono affidate a True Colours, che durante il recente MIA di Roma lo ha già venduto per la distribuzione in Russia e CIS, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Bosnia, Croazia, Slovenia, Estonia, Lituania e Taiwan.
Regia: Paolo genovese
Sceneggiatura: Paolo Genovese, Isabella Aguilar
Cast: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Sabrina Ferilli, Silvia D'Amico, Rocco Papaleo, Giulia Lazzarini, Vinicio Marchioni, Marianne Mirage.
Fotografia: Fabrizio Lucci montaggio: Consuelo Catucci costumi: Camilla Giuliani
Musica: Maurizio Filardo
Produttore: Marco Belardi
Produttore esecutivo: Noel Bright, Steven A. Cohen
Produzione: Lotus Production, Leone Film Group
Distributori: Medusa Film, Estinfilm OÜ, Aurora Films, Film Europe s.r.o.
*
 - Turismo
- Turismo
Fogli/e d’Autunno 3
(letteratura, poesia, narrativa, libri, editori, concorsi, con uno sguardo all’arte in fatto di mostre, cinema, teatro, musica, viaggi).
Estratto da “La Piazza Universale” - Catalogo della Mostra a cura di Elisabetta Silvestrini - Mondadori/De Luca - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari - Roma 1988, in 20lines.
C’è gran confusione nella piazza del Vecchio Borgo, un andirivieni di gente arrivata da ogni parte del contado per l’occasione della ‘Fiera delle meraviglie’ come qualcuno la definì nei tempi andati. Un forte richiamo per i venditori che vi accorrono in massa, con carrette e teloni variopinti, mercanzie e oggetti d'artigianato che mettono in bella mostra. Ci sono gli ambulanti che richiamano l'attenzione del ‘gentile’ pubblico a raccolta; i contadini con i prodotti della terra, tuberi e granaglie appena macinate che riempiono cesti e canestri; l’arrotino, il falegname e l’impagliatore di sedie; il ritrattista, il fotografo delle grandi occasioni, lo speziale e anche il ciarlatano, degno parodista della buffonaggine umana che, in piedi sullo sgabello, declama gli ultimi ritrovati della scienza, l’ultima invenzione della tecnica, e commenta gli ultimi ‘sberleffi’ della moda.
Tra le bancarelle c’è chi espone le masserizie per la casa, utensili e pentolame, scarpe e ciabatte, stoffe e preziosi, ed anche chi, alquanto stravagante, da spettacolo di sé, di quel poco che possiede o che sa fare, ammirato e applaudito da un nugolo di bambini che scorazzano in qua e in là, ora incalzando il venditore di palloncini, ora facendo la fila davanti al banco dello zucchero filato e dei pasticcini coi canditi; e chi tra essi conduce un capro per le corna, chi porta del latte appena munto, chi rincorre il ‘cerchio’ e chi, per un soldo, si mette a fare le capriole sopra il prato.
Ed è qui che, alle grida levate dal banditore, tutti accorrono per vedere aprirsi le porte variopinte della ‘Piazza Universale’, felici di assistere a più d’uno spettacolo offerto dalle Macchine da Fiera: del ‘Mostro divoratore’ e delle ‘Montagne russe’, nonché dai congegni meccanici del Luna Park, come la 'Grande Ruota' panoramica, la 'Giostra' che instancabilmente continuava a girare, coinvolgendo tutto e tutti nella fantasmagoria della musica e delle luci colorate.
Non in ultimo, per l'attrattiva di fare i 'giochi' della Tombola e della Lotteria, o per tentare la Ruota della Fortuna e regalarsi un ‘sogno’ che, il più delle volte, si traduce in un innocente momento di svago. Tuttavia lo spettacolo più grande è offerto dai ‘funamboli’ che, sospesi in equilibrio sulla fune tesa attraverso la piazza, fanno salire la tensione al cielo e arrestare il battito del cuore di chi li osserva: dal ‘mangiatore di fuoco’ che s’avvampa nell’incendio dell’immaginario, ai venditori di spezie ed erbe medicinali cosiddetti ‘speziali’ che rifilano 'elisir' ed altri 'aromi' afrodisiaci. Come pure dai Maghi, ideatori di numerosi artifici, e dagli Zingari dai costumi colorati, con i loro tipici strumenti musicali, le danze sfrenate e, soprattutto, coi loro animali ammaestrati, le cui capacità raggiungono talvolta l’inverosimile, tanto sono 'intelligenti'.
Nondimeno lo spettacolo è assicurato da ‘saltimbanchi’ un po’ acrobati e un po’ buffoni che scatenano antiche paure del vuoto e il riso per la burla giocata ai buontemponi; il cui ruolo è riconducibile a quello del ‘trickster’, imbroglione della tradizione inglese, preso poi a soggetto della maschera grottesca del ‘clown’ che tutti quanti abbiamo e continuiamo ad apprezzare. Grazie al quale, ancora oggi, ci appaiono ‘veri’ tutti i personaggi di fondo che esso impersona: dai ‘burattini’ del romano Ghetanaccio, ai ‘mendicanti’ di Giovanni Serodine, ai ‘birbanti’ di Giuseppe Maria Mitelli, fino ai ‘maccaronari’ di Domenico Gargiulo, protagonisti di molte gesta leggendarie e di altrettanti romanzi popolari.
Tutto questo riguarda un passato prossimo non poi così lontano da noi, ma è qui d’obbligo ripercorrere la strada a ritroso per ritrovare quelli che sono i ‘motivi fondanti’ che hanno portato all’origine della tradizione della ‘fiera di piazza’ avente come scopo primario, lo scambio delle mercanzie e dei prodotti dei campi, sia in forma di acquisto diretto che di baratto. Nonché delle forme ludiche imprescindibili della ‘festa popolare’, con i suoi lazzi e giochi, competizioni, svaghi e intrattenimenti: dall’ ‘albero della cuccagna’, alla ‘rottura delle pignatte’, allo ‘scoppio dei petardi’, fino al ‘grande falò’ che veniva acceso, quasi a notte tarda, nella piazza del mercato, in cui venivano bruciate assieme ai rifiuti, le masserizie ormai inservibili.
Avvenimento questo del 'falò', che ancora oggi, lì dove è stato conservato, presenta almeno due aspetti antropologici di grande rilievo: uno mitico, certamente arcaico, con il quale si salutava la fine della passata stagione invernale e l'inizio della primavera; l'altro, più recente a carattere popolare che prevedeva di ‘saltare’ attraverso le fiamme. Un gesto sicuramente catartico atto a recuperare una originaria prova iniziatica di purificazione. L’occasione della Fiera, infatti, cadeva più volte all’anno e solitamente coincideva con il passare delle stagioni, quando la cacciagione o la raccolta permettevano di portare ‘in piazza’ le mercanzie e i prodotti stagionali della terra. Era allora che la ‘piazza’ si animava dei ‘giochi’ e delle ‘attività’, specifiche ed esemplari, che l’hanno vista trasformarsi con successo nella ‘Piazza Universale’.
Tali e tante erano le 'novità' che richiamavano ogni gente, di ogni ceto ed estrazione che si mostrava per quello che era, con le sue disponibilità economiche e le possibilità raffinate dei ricchi, con la povertà e la carenza culturale dei ceti più abbietti, ma anche con l’arguzia degli intelligenti in cerca di fare affari. Certo non sono mai mancati i traffichini, i farabutti, gli arrampicatori sociali o la gente di malaffare che vedeva nella ‘piazza’ l’occasione per arricchirsi rubando o mettendo a segno qualche vendetta personale. Ma era, per così dire, l’umana stortura di una società che s’avviava a confluire in ciò che oggi si chiama ‘collettività’ e che vede nella interazione popolare, una necessaria forma di conservazione e una certa scambievolezza reciproca.
Vanno qui inoltre menzionate le ‘attività comunitarie’: sia religiose, come partecipare alla Messa in Chiesa o sul Sagrato di fronte alle autorità cittadine, le processioni della Settimana Santa o del Santo Patrono, e le Sacre Rappresentazioni che portavano in scena i fatti salienti dei testi biblici; sia laiche come i balli, le mascherate, il teatro burlesco, fino ai più scenografici spettacoli che muovendo dall’interno delle Corti, sfilavano in quella che pubblicamente era considerata “La Piazza di tutte le Professioni del Mondo”, come la definì nel lontano 1500 il canonico Tommaso Garzoni, autore di curiose opere d'erudizione, caotiche e capricciose, nelle quali sono accatastate le notizie e le osservazioni più varie, cose, usi, costumi, vizî, passioni, virtù, miserie dei tempi antichi e moderni.
Opere queste che hanno messo in evidenza come a sua volta, la tradizione si è impossessata di quel ‘meraviglioso’ cui la ‘Piazza’ era legata da fila sotterranee fin dagli esordi della sua esistenza. Unico momento in cui, dopo i mesi di duro lavoro, era possibile conoscere le ultime novità, i fatti salienti della cronaca di altre città, acquistare e scambiare informazioni, ed anche per familiarizzare, per misurarsi con gli altri e mostrarsi in pubblico, il che conferiva ai molti di acquisire una certa ‘identità sociale’. E che, infine, si è rivelato uno dei filoni più ricchi della creatività popolare: l’arte dell’incontro, dello scambio reciproco e quindi del commercio, il cui esito arriva alla concezione della moderna pubblicità e al concetto fondante dell’attuale sviluppo delle Pubbliche Relazioni.
La ‘Piazza Universale’ dunque come banco di prova, luogo iniziatico dove si evincevano le antiche paure del singolo, per affermare noi stessi di fronte agli altri, nel reciproco scambio delle parti di giudici e giudicanti e raccogliere il necessario consenso di fronte alla comunità raccolta. Sebbene quello della Piazza sia stato sempre visto come forma di spettacolo ‘casuale’ o ‘procurato’, con esso si metteva a nudo una indistinguibile verità chiassosa che al ricordo degli avvenimenti anche più recenti, a volte ci da un brivido di inconsistenza che pure mette in azione i moti dell’anima, allorché per soddisfare la vanità che ci rivela, inventiamo il nostro effimero, lasciandoci guidare da ‘burattinai’ politicizzati e sindacalizzati, che nulla hanno a che vedere con lo spirito che in passato ha animato la ‘Piazza Universale’ cui si fa qui riferimento.
E sempre più ci sembra d’essere al tempo stesso ‘attori e spettatori’ di noi stessi, personaggi d’una rappresentazione che non ci appartiene, che ci procura quella strana, caduca sensazione, d’essere in bilico su un palcoscenico che oscilla, che vortica all’interno di un ingranaggio che non riusciamo più a fermare e che ci schiaccia, azionato da un altrui volontà: che sia l’orco affamato delle fiabe che ci rincorre, la divinità infernale del mito che ritorna, il mangiafuoco che ci divora, la globalizzazione che ci cannibalizza, che ci annienta come individui, come popolo, come ‘umani che mangiano altri umani’?, non so dire. Ma forse una risposta sta nel disconoscere il passato, i ricordi e i rimpianti che portiamo dentro di noi, e lasciarci ‘divorare’ dalla realtà di oggi, perché altrimenti finiremo per ridurci al solo ruolo di ‘attori’ della nostra vita, e quindi solo ‘spettatori’ della nostra ‘vanità’.
Anche per questa ragione oggi dobbiamo riprenderci la ‘Piazza Universale’, recuperare la nostra dignità dalle mani di quei ‘burattinai’ che si accordano per sottomettere la ‘piazza’ ai propri interessi economici, ai propri avidi propositi di potere. Allora la risposta non è che una: ‘libertà’ di pensiero, di parola, d’intendimenti, d’incontrarsi, di dialogare, di votare i propri capi elettivi; libertà di contribuzione, di cooperazione, di sopravvivenza; libertà di gestire, di misurarsi con gli altri, di esistere come entità umana pensante e discernente; onde abbattere le differenze sociali, le diversità di genere, le discordanze culturali e razziali, per riaffermare quelli che sono i ‘nostri diritti’, e noi stessi, nell’ambito di quella realtà socio-culturale economico-politica che più ci conviene, rappresentata qui dall’immagine della “Piazza Universale di tutte le Professioni del Mondo” e dell’intera umanità consapevole.
E allora chissà? Magari questa nostra umanità così oltraggiata e offesa, questa nostra vita così vilipesa, questa stessa nostra Terra sfruttata e derubata ritroverà la pace di cui abbisogna, e tornerà ad essere quella ‘giostra’ tante volte sognata, che ‘meraviglia delle meraviglie’ ad ogni Fiera di Piazza continua a girare, col movimento di un argano meccanico che suona, gira e suona, suona e gira, con le sue luci colorate e i cavallucci bianchi e morelli che nel girare oziosi s’alzano e si abbassano in attesa di prendere il volo, per un' 'altra' stagione della vita.
Ɣ – Amicizia, amore, identità, diversità sono i temi ricorrenti nella letteratura di tutto il mondo, nelle diverse lingue e modi di tutte le genti che lo abitano e che lo ‘vivono’, e che sono anche i ‘luoghi comuni’ in cui si ‘perdono’ e si ‘ritrovano’, amano, sperano in un mondo migliore. Oppure che abbia fine, ma quest’ultimo è un discorso ‘altro’ che non rientra nel prospetto di questo articolo e che un giorno vedrò di affrontare. Per adesso mi limito ad onorare l’Autunno, (la stagione che più rinfranca il mio cuore), con alcune proposte di viaggio fra quelle poco conosciute, anche se molto apprezzate, e quasi per così dire, fuori della porta di casa. Con l'arrivo dell'autunno, cosa c’è di meglio, di approfittare di una vacanza all’aria aperta. Spesso in questo periodo il cielo è terso e la vista si apre su panorami spettacolari, anche in lontananza.
Con delle condizioni così, come si può rinunciare ad una vacanza in agriturismo con tante belle escursioni in montagna? Se non l’avete ancora provato, scoprite come la natura in Alto Adige – Südtirol si trasforma in un ‘luogo dell’anima’ di colori dalle tonalità calde e intense, di ‘poesia’ casereccia dal carattere amicale. In più, l'autunno è senza dubbio la stagione ideale per chi ama la buona cucina. Una ricca colazione a base di delizie da gustare in uno dei tanti ‘masi’ sparpagliati sul territorio è sicuramente il modo migliore per affrontare la giornata. Nella stagione colorata sono infatti le delizie del palato a dettare legge: si raccoglie, si vinifica e si preparano le scorte per l'inverno.
La tradizione che meglio rispecchia questa stagione è il Törggelen, un periodo in cui, secondo un'antica usanza contadina, gli agricoltori festeggiano il raccolto ben riuscito nelle osterie contadine "Buschenschank": il momento ideale per assaporare tante delizie fatte in casa, caldarroste fumanti e altre specialità tipiche accompagnate da mosto fresco. I contadini degli oltre 1600 agriturismi "Gallo Rosso" saranno lieti di darvi il benvenuto, allietati da feste e mercatini, coi loro tipici strumenti e musica folkloristica.
Sitografia Gallo Rosso | Südtiroler Bauernbund: info@gallorosso.it, www.gallorosso.it
Ɣ – Immerso nella pace della campagna, circondato dalle dolci colline del Chianti e a pochi chilometri da Siena, sorge Villa Curina Resort, piccolo borgo cinquecentesco ricco di storia e di fascino dove potrete godere di una vacanza di charme e raffinatezza. Le sue camere eleganti, il suo staff sempre disponibile, il suo ristorante con cucina tipica e all’avanguardia nel rispetto della migliore tradizione toscana, il suo bellissimo giardino all’italiana, piccolo gioiello del ‘700, sono il luogo ideale per un soggiorno indimenticabile. La villa risale al XVI secolo e fu trasformata nel corso del Settecento, precisamente tra il 1776 e il 1780. Assunse così il tipico aspetto delle costruzioni del XVIII secolo, a pianta rettangolare con base a scarpata e con sviluppo su tre piani coperti con un tetto a padiglione, come possiamo ammirarla ancora oggi.
A tale data risale anche il bellissimo giardino all’italiana situato di fronte all’ingresso della villa, piccolo gioiello architettonico. A poca distanza dalla villa la piccola Cappella di San Liberato, anch’essa del XVI secolo, affrescata da Arcangelo Salimbeni nel 1573, data che compare nella parete interna dell’archivolto. Gli affreschi al suo interno costituiscono un evento artistico di tutto rispetto per la quantità e l’importanza dei temi trattati. Per tale motivo l’oratorio di Curina viene definito la piccola “Cappella Sistina del Chianti”.
Ma non è solo questo, Villa Curina Resort offre un ricco ventaglio di servizi a disposizioine per gli ospiti, che vanno da una splendida piscina all’aperto e solarium, campi da tennis, ampio parcheggio custodito, transfer service, connessione wifi, Light lunch dalle 12.30 alle 14.00 con vista sulle colline del Chianti, servizio bar in piscina dalle 11.00 alle 20.00, ristorante “Il Convito di Curina” aperto per cena dalle 19.30 alle 22.00. Nonché degustazioni di Champagne e dei migliori vini toscani e di molte altre regioni italiane, Corsi di Cucina, prenotazioni per visite guidate a Musei e città d’arte, trasferimenti ed escursioni nelle più belle realtà della provincia di Siena, prenotazioni per passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera.Tramonti mozzafiato con Siena all’orizzonte faranno da cornice alla vostra vacanza, rendendola un sogno che al vostro ritorno vorrete condividere con chi vi sta vicino.
Inoltre, ecco alcuni piacevoli luoghi da scoprire a Siena e dintorni,. Villa Curina Resort è a soli 20 km, famosa per la sua splendida piazza e il Suo palio, per la sua atmosfera medievale e la sua maestosa cattedrale. Le sue strette vie ricche di fascino e di storia, vi conquisteranno:
Abbazia di S.Galgano, a soli circa 50 Km non molto distante da Siena, la suggestiva e maestosa Abbazia di S.Galgano, famosa per la sua leggendaria spada nella roccia che vi invitiamo a visitare.
San Gimignano e Volterra, a circa 60 Km “Monteriggioni di torri si corona”, come scrive Dante Alighieri nella Divina Commedia. Ma è sempre incantevole questo piccolo castello che sorge dall’alto di una collina, e insieme a San Gimignano e a Volterra.
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, a circa 40 Km, circondata da boschi secolari dove potrete ascoltare gli antichi canti gregoriani dei Monaci Benedettini.
Montalcino, Montepulciano e Pienza, a circa 60 Km, Montalcino, città del vino e del miele, che insieme a Montepulciano, uno dei più importanti centri vitivinicoli del mondo che si erge sopra la Valdichiana, e a Pienza con la sua storia e i suoi prodotti locali, per un itinerario tutto da godere.
Abbazia di S.Antimo, a pochi Km da Montalcino, l’affascinante e antichissima costruzione del lontano 781, voluta da Carlo Magno e ancora oggi retta dai famosi Canonici Bianchi, come ricorda il loro abito. Un paradiso dove natura e architettura si intrecciano e si fondono.
Villa Curina Resort è in Località Curina 53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)
Email: info@villacurinaresort.com
Ɣ – Per chi abbia voglia di evasione totale ma discreta suggerisco di pianificare una vacanza a Malta cardine nella storia dei Cavalieri Crociati, in cui l’autunno si veste di prosperità per via del meraviglioso clima.
Qui la stagione estiva si prolunga piacevolmente nell’Arcipelago, grazie alle temperature miti ed alle correnti marine che rendono l’acqua del mare tiepida e ancora piacevole per i bagni. L’appuntamento per quest’anno è per ottobre, un mese in cui molti grandi eventi vengono organizzati, a incominciare dalla ‘Birgufest’, la ricostruzione storica che è anche un appuntamento romantico. E' questo un evento molto amato dai maltesi e dai turisti che ogni anno per questa occasione si ritrovano a migliaia a Vittoriosa, una delle Tre Città conosciuta anche come Birgu, affacciata sul Grande Porto di Valletta proprio di fronte la capitale.
Nato per offrire ai suoi visitatori la possibilità di vivere la città in un contesto unico, ovvero illuminata esclusivamente con torce e candele, il ‘Birgufest’ nel corso del tempo si è trasformato in un grande happening di eventi culturali. Le strade, le chiese ed i monumenti cittadini prendono vita ospitando cortei storici, rivisitazioni, feste, concerti ed appuntamenti culturali sempre rigorosamente illuminati dalla luce di candele.
Nota per cinefili e cineasti:
negli ultimi cinque anni ad ampliare l’offerta culturale legata al ‘Birgufest’, viene organizzato anche un appuntamento dedicato ai cortometraggi, il BirguFest Short Film Festival a cui è possibile iscrivere i propri film brevi mandando una mail a alancassar4@gmail.com.
Un viaggio quindi tra eventi e cultura che, per questa occasione, si carica di una suggestiva ed avvolgente atmosfera che riporta i visitatori ad un’ambientazione antica e romantica ‘una vacanza al lume di candela’, una perfetta situazione per chi cerca un’occasione speciale e poetica. Tutta la bellezza di Malta è raccontata in un video che potete consultare su Youtube e che in meno di tre minuti illustra la magnificenza del suo mare, delle coste, dei suoi porti, della sua gente, della sua diversità … la sua unicità.
Sitografia: www.malta-vacanze.it, www.visitmalta.com
Ɣ – È appena arrivato in libreria “Basilicata d'autore. Reportage narrativo e guida culturale del territorio” (Manni Editore 2017). Per chi vuole scoprire la Lucania ma anche per chi vuol solo leggere un bel libro. Ne viene fuori una lettura antropologica e allo stesso tempo il documento di una conoscenza reale, approfondita. Non solo un itinerario di percorsi e mete lucani dunque, ma un vero e proprio reportage narrativo, in cui ogni autore guida in un luogo, un'atmosfera:
Potenza e Matera naturalmente, ma anche il Vulture, il Pollino, le valli dell'Agri e del Basento, la salita sul monte sacro di Viggiano, le Dolomiti lucane..., fino al viaggio Basilicata coast to coast, in cui conoscere le bellezze naturali del territorio, attraverso percorsi itineranti, quali: ‘I calanchi’ di Tursi, Policoro, Valsinni, Aliano, Sant'Arcangelo, Craco.
-Venosa: un esempio di convivenza; Acerenza, la città dei vescovi; Matera, la città dei sassi; I carnevali di Tricarico, Lavello, Satriano; I luoghi dei poeti; I due mari di Metaponto e Maratea; Il Pollino. Ed inoltre: i riti arborei di Accettura; i percorsi federiciani a Melfi e Lagopesole o le Piccole Dolomiti lucane e Potenza, la città verticale.
Una guida d'autore, la narrazione dei luoghi, materiali o culturali, più significativi della Basilicata, raccontati dalla penna di intellettuali e personaggi celebri del territorio: Franco Arminio, Giovanni Caserta, Antonio De Rosa, Eliana Di Caro, Andrea Di Consoli, Pasquale Doria, Giuseppe Lupo, Alessandro Musto, Raffaele Nigro, Rocco Papaleo, Antonio Petrocelli, Gilda Policastro, Biagio Russo, Giovanni Russo, Mimmo Sammartino, Giancarlo Tramutoli, Mario Trufelli … per una letturadi viaggio alla scoperta di un intero mondo, in gran parte sconosciuto dai più, che pure è dietro l’angolo,uno dei migliori di questa nostra Italia che risponde a tutte le nostre vicissitudini elettive e che sempre più spesso bistrattiamo alla ricerca di un’evasione senza meta. Un modo come un altro per viaggiare nel nostro splendido paese, o no?
Sitografia: www.mannieditore.com, - e-mail info@mannieditori.it
Ɣ – “Di cosa è fatta la creatività nella narrativa di viaggio, e non solo?” Ce ne parla Piera Rossotti-Pogliano direttore editoriale della EEE-book.
“È la domanda che mi sono posta questa settimana a proposito della creatività nel campo della narrativa, ma credo che gli stessi meccanismi che portano alla stesura di un romanzo o di un racconto valgano anche per altre forme d’arte e non solo: c’è il momento dell’idea di scrivere qualcosa che susciti un certo tipo di emozione o trasmetta un certo messaggio che ci pare importante; poi viene il momento della riflessione razionale e della documentazione, ed infine il momento creativo, quello dell’emozione che deve provare lo scrittore.
Soltanto allora, se davvero prova emozione, lo scrittore saprà di poterla trasmettere ad altri. Poi, per chi scrive, c’è un ulteriore ingrediente ‘segreto’, purtroppo molto trascurato da troppi aspiranti scrittori che potrete scoprire nel video postato su Youtube. Come affermo sempre, le buone letture aiutano tutti: indispensabile per chi vuole scrivere, la lettura fa in ogni caso bene a tutti.
Nei link che seguono e che portano ad Amazon-Kindle e a Kobo, potete trovare la nostra sezione e-book. Tuttavia, prima di acquistarli, suggerisco comunque di scaricate la versione ‘free’ direttamente dal blog di EEE-book. Potrete leggerne gratis una buona parte, per il quale non è richiesta nessuna forma di registrazione. Un cordiale saluto ai lettori de larecherche.it e … buona lettura!”
Ɣ – “L'uomo che sognava le onde” (I Mainstream), Formato Kindle di Milos Hiljada - Editore: Edizioni Esordienti E-book 2017).
Eccone una breve sinossi:
“Camillo Mille, un passato da direttore strategico di una multinazionale e deluso dal mondo degli affari e da una vita priva di ideali e di punti di riferimento, si trova, a cinquant’anni, a insegnare presso un istituto per ragazzi con problemi comportamentali. Due dei suoi allievi lo colpiscono in modo particolare: David, scalmanato ed egocentrico, e Mirta, misteriosa e introversa. Ad entrambi Camillo salverà la vita: a David, in difficoltà per essersi temerariamente tuffato nel mare in tempesta, e a Mirta, finita accidentalmente in un giro perverso di traffico di minorenni. I due ragazzi vivono una situazione familiare difficile: il padre di David è infatti sempre lontano per lavoro, mentre i genitori di Mirta sono separati e vivono entrambi all’estero. Mirta e David mantengono i contatti con il professor Mille e stringono amicizia con Lorenzo, il figlio di Camillo. Le vicissitudini a cui andrà incontro, la capacità di trovare in se stesso il coraggio di agire e la generosità per mettersi in gioco permetteranno a Camillo di acquisire una nuova consapevolezza e di rinsaldare il rapporto con l’ex moglie Bianca e con il figlio Lorenzo.”
Il quotidiano della realtà sociale che giace sul fondo di questo libro per molti aspetti ‘giovane’ ci mette davanti a ciò che siamo, o se preferite, a ciò che siamo diventati per le molteplici ragioni che ogni giorno ci ingiungono di vivere/sopravvivere nella foresta dei problemi che ci troviamo/dobbiamo affrontare. Ma è anche un libro sull’amicizia, sull’amore e sulla speranza che i nostri giovani infine trovino la loro strada, quella migliore che pure sembra essergli negata. Grazie quindi a Piera Rossotti-Pogliano che nel suo pur difficile lavoro di scelte, offre al lettore una selezione di argomenti sempre attuali e di ‘autentica’ sincerità intellettiva.
Sitorafia: www.edizioniesordienti.com, info@edizioniesordienti.com)
Ɣ – Ho qui il piacere di evidenziare una fonte di comunicazione che mi è recapitata da Puracultura, distributrice del bollettino mensile di informazione letteraria Oèdipus: presentazioni, appuntamenti e festival che, puntualmente mi tiene al corrente su Presentazioni, Meeting e Reading che si tengono mensilmente in giro per l’Italia, ai quali haimé pur ringraziando non riesco a partecipare, ma che ritengo siano di primario interesse per quanti, lettori e curiosi di apprendere, letterariamente parlando, e di partecipare agli eventiqui sotto elencati, rifacendomi a quell’ ‘arte dell’incontro’ che ci permette di avallare nuove conoscenze e nuove amicizie:
Faenza, 30 settembre - 1 ottobre, Mei - Meeting etichette indipendenti, Monica Matticoli, L’irripetibile cercare (Oèdipus 2017).
Salerno, giovedì 5 ottobre, ore 17, Palazzo della Provincia, sala giunta, Massimo Corsale, Perdersi o ritrovarsi? navigare (serenamente) nelle nostre angosce quotidiane (Oèdipus 2017), forum con Pino Cantillo (filosofo), Barbara Cangiano (giornalista) Gabriele Pulli (sociologo).
Napoli, venerdì 6, ore 18, Libreria Ubik, via Benedetto Croce, Floriana Coppola, Cambio di stagione ed altre mutazioni poetiche (Oèdipus 2017), intervento critico di Enza Silvestrini, letture di Mena Saracino.
Milano, sabato 7, ore 18,00, Libreria Popolare, via Tadino, Carmine De Falco, Bruno Di Pietro, Emmanuel Di Tommaso, Eugenio Lucrezi, Paola Nasta, Enzo Rega, Marisa Papa Ruggiero discutono intorno a Levania – rivista di poesia alla VI edizione della rassegna Tu se sai dire dillo.
Treviso, sabato 14 ottobre, ore 11,00, Palazzo di Francia, Cartacarbone festival, Laura Liberale, La disponibilità della nostra carne (Oèdipus 2017); Francesca Tini Brunozzi, Il grado zero della buona educa-zione, intervengono Andrea Breda Minello ed Elisabetta Perfumo.
Marina di Massa, domenica 15, ore 18,00, Villa Cuturi, Via A. Vespucci 11 - Adriana Lazzini, Ho dimenticato come si piange (Oèdipus 2017). Con l’autrice, Stefano Carlo Vecoli. Letture di Andrea Grillotti.
Napoli, venerdì 20, ore 19,00, ass. Ricostruttori nella preghiera, via Ponti Rossi, 105, Massimo Corsale, Perdersi o ritrovarsi? navigare (serenamente) nelle nostre angosce quotidiane (Oèdipus 2017), con l’autore interviene Roberto Rondanina.
Agropoli, domenica 22, ore 18,00, libreria l’Argolibri, viale Lazio, 16, Elvira Morena, Domani mi vesto uguale (Oèdipus 2017), intervengono Milena Esposito e Francesco G. Forte.
Salerno, mercoledì 25, ore 18,00, Palazzo Fruscione, vicolo Adelberga, in coll. con Tempi moderni. Idee in movimento, Guido Caserza, I 20 di Auschwitz (Oèdipus 2017), intervento critico di Angelo Petrella. Letture di Attilio Bonadies.
Napoli, giovedì 26, ore 18,30, Evaluna libreria caffè, piazza Bellini, 72, Guido Caserza, I 20 di Auschwitz (Oèdipus 2017), intervento critico di Angelo Petrella. Letture di Attilio Bonadies.
Oèdipus è inoltre Editore di pregevoli pubblicazioni di libri e documenti sonori, come questo “Compendio Jim Grimm - Protocollo Walter Faith”, di Dario Agazz,“I processi di ingrandimento delle immagini, per un’antologia di poeti scomparsi” di Paola Silvia Dolci;
“L’irripetibile cercare” con CD allegato, di Monica Matticoli;
“Milano blues”, di Andrea Carobbio; “Inno Selvaggio” di Claudia Neri; “Ex-voto”, di Alessandra Carnaroli.
Sitografia: www.newsletter.oedipus.it www.infopuraculturacomunicazione.it
Ɣ – Relativamente alla poesia si tiene a Fano 28-29 Ottobre la festa di ‘Nazione Indiana’ 2017 “Una Rete di Storie” - Mediateca Montanari P.za Pier Maria Amiani.
Sulla scia della presentazione avvenuta il 6 Ottobre dell’antologia tematica della poesia novecentesca “Dare tempo al tempo” curata da Alma Gattinoni e Giorgio Marchini (Giulio perone Edit. 2016).
“Nell’intento dei due curatori, che hanno una lunga esperienza d’insegnamento nella scuola secondaria, vi è senza dubbio anche un aspetto pedagogico. E un approccio alla poesia attraverso un tema fondamentale come quello del tempo risulta particolarmente fecondo”. All’occorrenza riporto qui di seguito una interessante recensione/commento di Antonella Anedda:
“Dare tempo al tempo: Variazioni sul tema della poesia italiana del Novecento”, raccoglie, intorno a un grande tema poetico, filosofico e umanissimo, come quello del Tempo, centotrenta autori italiani del Novecento (il più “vecchio è Pascoli, i più “giovani” sono nati oltre la metà degli anni Sessanta), rappresentati ciascuno da un solo testo e proposti in sequenza alfabetica. Il criterio anticronologico, apparentemente burocratico e casuale, produce una rete estesissima di relazioni, di rimandi, di “accoppiamenti giudiziosi”, tra poeti molto diversi per personalità, stili, generazioni.
Nell’approccio al tema e nell’originalità di lettura, poeti così detti ‘minori’, più nel senso della notorietà che della qualità, coesistono con i poeti “laureati” ormai diventati classici, come Bertolucci, Caproni, D’Annunzio, Fortini, Giudici, Gozzano, Luzi, Marin, Montale, Pascoli, Pasolini, Penna, Quasimodo, Raboni, Rebora, Rosselli, Saba, Sereni, Ungaretti, Zanzotto. Poeti della prima metà del secolo convivono con tutti i protagonisti della poesia più recente, e anzi, proprio dal loro incontro, un insieme di voci autonome diventa un ensemble armonico.
Nel labirinto del tempo costruito dalla poesia di un secolo, l’intento dei curatori è stato quello di individuare costanti e piccoli o grandi scarti, ricorrenze con soluzioni via, via, sempre più originali, lontane dagli archetipi di partenza, per tradurre una grande passione e ridare smalto a “quella cosa superflua e necessaria che è la poesia”, alla sua forza conoscitiva. (…) Poesia e tempo si coniugano a partire da una semplice constatazione: la natura metrica del suo linguaggio.
Volendo affrontare l’indagine di questo connubio solo nella campionatura novecentesca, è quasi ovvio verificare l’ipotesi che la frantumazione dell’io dei canzonieri moderni sia rispecchiata dal proliferare abnorme del tema tempo, concettualizzazione attraverso cui si fonda l’identità individuale e collettiva, che nel secolo XX tende a lacerarsi, a parcellizzarsi in una babele cronologica di tempi reali e virtuali. […]
Così, accanto alle prevedibili scansioni del giorno o dell’anno o della vita, si estende una costellazione di immagini metaforiche caricate di senso temporale: la rivelazione epifanica, l’età dell’oro, le nostalgiche “nevi di un tempo”, lo scialo dei giorni, per citare solo qualche esempio. E su tutte, per frequenza e pregnanza, il fluire continuo dell’acqua, l’alveo del fiume nel quale due correnti si mescolano e si fondono, gli eventi sottratti alla nostra volontà e le scelte del nostro agire nel tempo.
A più ampio raggio semantico, ma sempre ascrivibili a questa area, si propagano i corollari della vecchia sorpassata divisione di presente-passato-futuro: il valore del quotidiano; la noia del presente uniforme; la memoria come riscatto del tempo trascorso; la maturazione come abbandono del tempo precedente; il ricordo come prolungamento o traccia del tempo umano; il tempo deformato, rallentato o accelerato dell’attesa, del desiderio, del sogno; il tempo come catalizzatore della passione amorosa; il tempo poetico come antidoto alle discrasie del vissuto; la morte come tempo ultimo”.
Sitografia: www.newsletter.nazioneindiana.org
Numerosi sono i ‘concorsi’ letterari dedicati alla poesia in questo inizio di stagione autunnali e tanti altri se aggiungeranno per l’arrivo dell’inverno e delle festività natalizie. Nell’impossibilità di citarli tutti, mi limito solo ad alcuni ‘gratuiti’ di qualche rilevanza. Anche perché, e insisto, molti più sono quelli a pagamento e a pseudo pagamento, a meno che non si tratti di pochi spiccioli a copertura delle spese di redazione, che sconsiglio vivamente per molteplici ragioni, una fra tutte l’inutilità, vale più il tempo che si spreca a seguirli.
Ɣ – Tra quelli più abbordabili c’è senz’altro c’è il “Premio Letterario Il Giardino di Babuk – Proust en Italie” per opere inedite con scadenza il 15 gennaio 2018. Ideato e conseguito da Giuliano Brenna e Roberto Maggiani, già curatori della rivista-on-line di poesia e letteratura larecherche.it, il Premio è ormai giunto con successo alla sua IV edizione che si prevede sarà entusiasmante per il numero di partecipazioni già pervenute e la presenza di numerosi autori. Il Premio è diviso in due Sezione A: Poesia | Sezione B: Racconto breve.
La partecipazione è completamente gratuita.
Se hai già proposto una tua Opera in concorso, ti verrà mostrata
La premiazione avverrà in data 8 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 a Roma in luogo da decidere: sarà comunicato in questa stessa pagina. Si prega di scaricare il bando di concorso 2018 (pdf).
Ɣ – Premio letterario “Teorema del corpo II – Dire d’eros”
Fusibilia Ass. Cult. in collaborazione con FusibiliaLibri bandisce un concorso per la pubblicazione dell’antologia poetica in scadenza 11 dicembre 2017 sul tema ‘Dire d’eros’:
“L’erotismo è una delle basi di conoscenza di sé, tanto indispensabile quanto la poesia.”
Anaïs Nin – Essere donna e altri saggi, 1977
“In ogni incontro erotico c’è un personaggio invisibile e sempre attivo: l’immaginazione.”
Octavio Paz
Dopo l’ottima riuscita della precedente edizione prosegue l’invito di Fusibilia a sviscerare tematiche di frontiera, come la relazione con il proprio corpo e l’attenzione per ciò che Wilheim Reich definisce “forza vitale”, il fondamento della Natura da lui definita ‘orgone’, ovvero la sessualità. Questo secondo concorso, come il primo si articola in due sezioni, 'Desideranti' e 'Amanti', con l’ambizione di voler coinvolgere le ‘penne’ poetiche contemporanee nelle trame dell’amore il cui spettro erotico-affettivo spazia, secondo la cultura greca, dall’himeros al pothos fino all’anteros.
L’eros, dimensione umana primordiale che da sempre un certo oscurantismo vuole sottaciuta, e violentemente contrastata dall’oppressione, spesso truce, della cultura moralista. L’affrancamento dalla repressione passa soprattutto attraverso il rafforzamento della propria immagine interiore come attrici/ori e soggetti della pulsione erotica, intesa come inclinazione alla vita e accettazione del proprio essere. Riconsiderare l’archetipo erotico, immanente in tutti gli aspetti naturali, preservare il valore della propria sessualità, sentirlo leva e parte integrante della sfera affettiva, questo è ciò che chiediamo alle autrici, agli autori, di esprimere.
Il concorso è aperto alle poete, ai poeti, dai 16 anni in su (per le/i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci). Il concorso “Teorema del corpo” si articola in due sezioni: “Desideranti” e “Amanti”, sui temi del ‘desiderio dell’altro’ (la prima) e della ‘reciprocità con l’altro’ (la seconda).Si può partecipare limitatamente a una sezione, con l’invio di 2 poesie, per un massimo di 30 versi ciascuna,I testi, che devono essere inediti e che non siano stati già premiati, o al momento dell’iscrizione al concorso non siano già inviati in analoghe competizioni, premi, concorsi, pena l’esclusione, vanno inviati in formato testo (no pdf)alla redazione Fusibilia via mail a fusibilia@gmail.com indicando in oggetto “Concorso: Teorema del corpo, sezione…”.
La partecipazione è gratuita;La scadenza per l’invio dei testi è fissata al 11 dicembre 2017;Il giudizio della giuria è insindacabile;Le/i partecipanti i cui testi siano stati selezionati per la pubblicazione saranno informate sui risultati delle selezioni mediante mail personale e segnalazione sul sito dell’associazione www.fusibilia.it.Le poesie selezionate saranno pubblicate nel volume Teorema del corpo-Dire d’eros, per FusibiliaLibri edizioni; il volume sarà portato all’attenzione del pubblico in più presentazioni che verranno in seguito calendarizzate.
Referente concorso: Dona Amati cell: 3460882439 info:www.fusibilia.it
Ɣ – XVII edizione del Premio Massimo Troisi 2017
Bando di concorso e Regolamento - Migliore Scrittura Comica - Opera edita – Racconto inedito.
Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la XVII Edizione del Premio Massimo Troisi. Il Premio è dedicato a opere di genere comi¬co realizzate da autori italiani e stranieri. Il presente bando è relativo alla Migliore Scrittura Comica in lingua italiana, scritta da uno o più autori, e si propone di scoprire, valorizzare e promuovere testi che contribuiscano al rinnovamento espressivo dell’arte di far ridere.
Alla sezione A possono partecipare opere in lingua italiana pubblicate in formato cartaceo da case editrici nazionali o straniere a partire dal 1° gennaio 2015.Alla sezione B possono partecipare racconti inediti aventi una lunghezza massima di 20 pagine formato A4 progressivamente numerate e contenenti non più di 40 righi ciascuna.Per entrambe le sezioni, le opere partecipanti devono avere riconoscibili e prevalenti caratteristiche di genere comico e/o umoristico.
Le opere partecipanti alla sezione A possono essere inviate sia dagli autori sia dalle case editrici che ne hanno curato la pubblicazione. Saranno assegnati premi in denaro per entrambe le sezioni. Inoltre la Giuria si riserva di assegnare Menzioni Speciali per opere particolarmente meritevoli. Pertanto le decisioni della Giuria – i cui componenti saranno resi noti a conclusione delle attività di valutazione delle opere partecipanti – sono insindacabili e inappellabili. I vincitori dei due premi e delle eventuali Menzioni Speciali si impegna¬no a pubblicizzare e a diffondere in ogni forma l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti e il logo del Premio Massimo Troisi, anche nell’eventualità di una auspicabile successiva trasposi¬zione teatrale, cabarettistica, televisiva, artistica o cinemato¬grafica delle loro opere. Ogni autore o gruppo di autori può partecipare a una sola sezione del concorso con un solo lavoro. La partecipazione al concorso è gratuita.
Le opere dovranno pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Ottobre 2017. Esse potranno essere recapitate a mano al Protocollo Generale del Comune di San Giorgio a Cremano o inviate tramite posta (non farà fede la data del timbro postale) o tramite spedizioniere/corriere. Sul plico dovrà essere indicato il seguente indirizzo: Comune di San Giorgio a Cremano - Servizio Patrimonio PREMIO MASSIMO TROISI - Concorso Migliore Scrittura Comica - Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Per informazioni Comune di San Giorgio a Cremano - Servizio Cultura Tel. 081.5654335/356 Fax 081.5654374 - E-mail: maria.benedetto@e-cremano.it - Sito web: www.e-cremano.it
Ɣ – La Città di San Pellegrino Terme promuove per l’anno scolastico 2017-2018 l’ottava edizione del “Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini” con lo scopo di creare occasioni in cui esprimersi, attraverso la lettura e la composizione di poesie, rime e filastrocche, nell’ambito scolastico e familiare. L’organizzazione del Festival è affidata al Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”.
Sono invitati a partecipare, guidati dai loro insegnanti o stimolati da genitori e famigliari, i bambini dalla terza elementare alla prima media e gli adulti che amano leggere e comporre poesie. Alcune classi di dieci scuole del territorio sono state scelte come giuria popolare per la lettura e la selezione delle poesie degli adulti finalisti partecipanti al concorso. Il tema proposto quest’anno è “Guardo fuori di me e vedo… La poesia nasce, più che dall’ispirazione, dall’attenzione; da uno sguardo attento a quello che c’è e a com’è. Uno sguardo così attento da vedere le cose, anche le più consuete, i paesaggi, anche i più noti, i volti, anche i più familiari, come per la prima volta…”
Il SanPellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini si articolerà nelle seguenti fasi:
Ottobre – novembre 2017 (solo per le scuole designate come giuria popolare): – Lettura animata di poesie di autori contemporanei o del passato sul tema del concorso – Corso di formazione per i docenti
Entro sabato 16 dicembre 2017: consegna poesie dei partecipanti al concorso, sia bambini che adulti.
Entro martedì 16 gennaio 2018: selezione dei cinque autori adulti finalisti da parte della giuria qualificata, da proporre alle classi-giuria
A febbraio verrà rappresentato per le scuole-giuria uno spettacolo teatrale. Entro sabato 24 febbraio 2018 la giuria qualificata designerà i vincitori per le categorie bambini-ragazzi. nello stesso giorno le classi-giuria faranno pervenire le loro valutazioni relative alla categoria adulti. Sabato 24 marzo 2018, alle ore 16,00, presso il teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme: conclusione del Festival e premiazioni.
Possono partecipare al concorso:
– i bambini e i ragazzi delle classi 3ª-4ª-5ª di scuola elementare e di 1ª media, che potranno presentare individualmente una o più poesie, rime o filastrocche, che non superino complessivamente i 25 versi. Sono ammesse anche poesie di gruppo o di classe, con una o più composizioni, che non superino complessivamente i 100 versi.
– gli adulti, che potranno presentare proprie composizioni inedite per bambini, in lingua italiana, con una o più poesie, rime o filastrocche, che non superino complessivamente i 25 versi.
Tra i partecipanti in forma individuale verranno premiati i primi 3 classificati per ognuna delle seguenti categorie:
A – bambini delle classi 3ª- 4ª elementare
B – ragazzi delle classi 5ª elementare – 1ª media
Riceveranno in premio una pergamena e una dotazione di libri di poesia.
Tra i partecipanti in gruppo o come classe si individueranno i primi 3 classificati per ognuna delle due categorie, come sopra specificato. Anche a loro verranno assegnati in premio una pergamena per gruppo o per classe e un libro di poesia per ogni componente.
Le classi che verranno segnalate per la qualità del lavoro svolto riceveranno una pergamena e un buono monetario per acquisto di materiale didattico.
La giuria qualificata si riserva inoltre di assegnare premi e menzioni speciali.
Il poeta adulto che si classificherà al primo posto riceverà in premio edizioni pregiate di opere di poesia.
Le poesie vincitrici dei bambini e le cinque finaliste degli adulti saranno pubblicate sul sito internet del Festival e su “Quaderni Brembani”, Annuario del Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”, nell’edizione 2018.
Una giuria qualificata, composta da poeti e lettori esperti e presieduta dalla poetessa Giusi Quarenghi, selezionerà, tra i bambini e i ragazzi, i vincitori per ogni categoria e deciderà eventuali premi e menzioni speciali.
La giuria popolare, composta da alcune classi delle dieci scuole prescelte, voterà le poesie dei 5 adulti finalisti, selezionati dalla giuria tecnica, determinando il vincitore.
L’adesione al Festival è gratuita. Le composizioni presentate dovranno essere inedite e originali, vale a dire che siano frutto di lavoro personale e che non abbiano avuto una pubblicazione editoriale. Ogni autore sarà responsabile del contenuto degli elaborati inviati. Le composizioni dovranno rispettare il tema proposto e la lunghezza prescritta, pena l’esclusione dal concorso. Le poesie, redatte in formato testo e accompagnate dalla relativa scheda di partecipazione, dovranno pervenire esclusivamente come allegato di posta elettronica entro le ore 24 di sabato 16 dicembre 2017, all’indirizzo e-mail della segreteria del Festival: sanpellegrinofestival@culturabrembana.com
Ai finalisti del concorso, contattati dalla stessa segreteria, sarà richiesto di inviare successivamente, prima del giorno della premiazione, la dichiarazione liberatoria, con la firma in originale; per i minori è richiesta la firma del genitore o l’esercente la patria potestà: se si utilizza il mezzo informatico si invii la scheda in formato .jpg o .pdf allo stesso indirizzo e-mail; se si utilizza il supporto cartaceo, si invii la scheda tramite posta o fax all’indirizzo:
Segreteria del Festival di Poesia dei Bambini c/o Biblioteca di San Pellegrino Terme – via S. Carlo 32 – 24016 San Pellegrino Terme (Bg) –fax 0345.22755 – tel. 0345.22141- I relativi moduli sono pubblicati sul sito del Festival.
Organizzazione: Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”
Coordinamento: Bonaventura Foppolo
Per informazioni: www.culturabrembana.com/sanpellegrinofestival
E-mail: sanpellegrinofestival@culturabrembana.com
Ente Promotore: Comune di San Pellegrino Terme
Patrocinio: Provincia di Bergamo – Comunità Montana di Valle Brembana – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Ɣ – Concorso letterario “Il mistero delle cose III” - La Temperino Rosso Edizioni indice per l’anno 2017 il concorso letterario riservato a opere inedite e riguarda esclusivamente: Raccolta di poesie.
Il concorso non ha restrizioni di tema ma è rivolto prevalentemente a quelle persone che hanno necessità d’offrire ai propri pensieri, fluttuanti e misteriosi, la sembianza del segno e del simbolo, affinché altre persone li possano riconoscere e riconoscersi, lanciandosi in un’impresa nella quale coraggio e curiosità prevalgano, al fine di avvicinarsi sempre più all’inebriante sensazione suscitata dal quesito: perché non scrivere quello che mi frulla incessantemente in testa? Ciò per accostarsi maggiormente all’essenza autentica e primordiale delle cose, nel tentativo di svelarne, con l’immaginazione, i suoi molteplici misteri.
Non esistono restrizioni di lunghezza, tuttavia i lavori ritenuti troppo brevi, da non rientrare in una possibile pubblicazione autonoma (in genere 20-30 poesie), non potranno essere considerati. I candidati potranno partecipare al concorso con una sola raccolta di poesie. Premiato sarà il primo classificato. Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera da parte della Casa editrice che indice il concorso, senza spese da sostenere, in qualsiasi forma, dall’autore o dall’autrice, al quale verrà proposto un regolare contratto d’edizione.
Le opere dovranno pervenire in un unico esemplare entro il termine massimo del 18 dicembre 2017. Gli scritti dovranno essere inviati in un unico file, preferibilmente in formato elettronico PDF a segreteria@temperino-rosso-edizioni.com accompagnati dal modulo di adesione compilato in tutte le sue parti, l’assenza di questo documento potrà pregiudicare la partecipazione al concorso. Nel caso non fosse possibile spedire in formato elettronico, si potrà inviare i testi cartacei al seguente indirizzo:
Temperino rosso edizioni, Via dei Musei 14, 25121 Brescia. I manoscritti ricevuti non saranno restituiti. Dei giurati scelti discrezionalmente dalla Casa editrice valuteranno insindacabilmente tutte le opere ricevute e assegneranno le loro preferenze. Il 9 gennaio 2018 sarà comunicato a tutti i partecipanti il risultato del concorso.
(prosegue alla prossima puntata)
*
 - Libri
- Libri
Le parole blu - un libro di Marina Torossi Tevini
‘LE PAROLE BLU’
un libro di Marina Torossi Tevini - Campanotto Editore 2010
‘Le parole blu’ sono quelle che disciogliamo nel nostro parlare quotidiano con le quali cerchiamo di convincere noi stessi, sebbene siano pur degne di considerazione, se non altro perché sottolineano certe nostre attitudini nel relazionarci con gli altri. Parole che verosimilmente abbiamo apprese da letture scolastico-universitarie pregne di letteratura classica ma, anche, dai quotidiani e dalle riviste e, perché no, dai fumetti come dalla cartellonistica pubblicitaria e dall'informazione radio-televisiva.
Quelle stesse parole che usiamo come concessioni fatte al nostro essere e/o sembrare accolturati sotto forma di citazioni, reiterazioni, corrispondenze ecc. e riformulate per ampliare il nostro linguaggio descrittivo-narrativo, e dare così un senso compiuto alle 'frasi' della nostra oralità. Frasi che, fino a un certo tempo (di scolastica memoria), venivano contrassegnate con un segno ‘blu’, contrapposte ad altre invece sottolineate in ‘rosso’ (con la punta opposta della matita), che s’imponevano allo sguardo come catastrofiche del nostro discorso intellettivo-concettuale.
Ciò per quanto ci fossimo impegnati a far capire agli altri (prof giudicanti) dell’esistenza di un ‘inenarrabile’ che pure avremmo voluto esprimere fra le righe della nostra concettualità; ma che di fatto spariva dentro gli spazi lasciati bianchi che solo apparentemente avrebbero dovuto sembrare vuoti. Mentre, al contrario, (e lo scopo era disperatamente spontaneo), promettevano un potenziale conoscitivo e dimostrativo del nostro sapere, in quanto (pensavamo) ci avrebbe permesso di inserirci nel dialogo ‘aperto’ con gli altri.
Il contrasto fra le parti, seppure in qualche modo disgiunto dalla forma colloquiale, sia che fosse narrativo o affermativo, interrogatorio o speculativo, invero serviva ad esprimere una qualche considerazione che, di fatto, ci apparteneva e ci rappresentava, inquanto pur sempre improntato su un potenziale comunicativo. Potenziale che, in qualche modo, andava comunque considerato, sia che fosse qualunquista o nichilista, costruttivo o de-costruttivo; sia che fosse allargato e quindi aperto a nuove ipotesi costruttive.
Del resto ci si rende conto di quanto si abbia bisogno delle parole, soprattutto quando, in mancanza di contatti diretti, si aggiunge l’impossibilità di comunicare con qualcuno, dacché l’ansia della solitudine, il decadere di certezze e del senso di sicurezza interiore. Al contrario, lo scambio di parole diventa di per sé salutare per l’attività cerebrale e, quindi, per lo sviluppo mentale degli individui, (specialmente negli anni della formazione).
Ben sappiamo quanto la nostra esistenza di per sé, necessiti di emozioni per sentirsi ‘viva’, ècco che al dunque le parole, possono avere un effetto apotropaico sul nostro comune ‘sentire’, panacea che allevia ogni male e riempie gli interstizi delle nostre reciproche diversità (di genere), colmando di benessere quei vuoti che noi stessi abbiamo avallato, permettendoci in fine quel compiacimento che, da solo, dà l’essere compresi e in qualche caso sostenuti dalle parole degli altri.
Non in ultimo vanno qui fatte alcune considerazioni di tipo filosofico, onde l’analisi di noi stessi (in particolare dei giovani protagonisti di questo libro), è speculativa del pensiero psicologico, per cui, il quotidiano entrare e uscire dalla formula d’una ipotetica drammatizzazione (tipica dell’azione teatrale), porta con sé il presumere di un dialogare con l’altro/a, nella ricerca costante di parole costruttive, per un interloquire accessibile e di reciproca comprensione.
I personaggi di questo libro, (quei giovani d’oggi che si muovono sulla scena di un teatro senza quinte), somigliano molto a certi Pupi siciliani che, entrati a far parte di un copione costruito sul ‘botta e risposta’ nel quale pur vanno costuendo la propria esistenza, sono chiamati in causa da un dialogo intelligente (talvolta fin troppo colto e zeppo di citazioni sentenziose), che li conduce verso una meta ad essi stessi ignota quanto istintiva, in cui il passato è parte di un retaggio inconscio, e il futuro sembra essere lontano e da 'non prendere in considerazione'.
Tesi questa che l’autrice di buon grado ci trasmette come forma veritiera del nostro tempo’. Si da il caso che abbia ragione lei (l’autrice) dacché il suo libro (pubblicato nel 2010), riferisce di una realtà oggettiva del qualunquismo incombente, ulteriormente trasformato da un nichilismo dialogante già presente nell’ ‘L’ospite inquietante’ (Galimberti), e nel de-costruzionismo sociale di ‘L’animale che dunque sono’ (Derrida). Sì, credo proprio che l’autrice avesse ragione, in quanto prevedeva una realtà assordante pari a quella che sta dilagando in ogni maglia del tessuto socio-culturale in cui i giovani sono chiamati a interloquire e a rispondere.
Ciò ha dello straordinario, perchè l’interlocutore (sia esso scrittore, lettore o ascoltatore), sembra non conoscere le risposte che invece sono sotto gli occhi di tutti e che non lasciano spazio alcuno al dubbio, davanti al catastrofismo cui il mondo intero va incontro. Dietro tutto questo s’affaccia però l’antica ma sempre valida speranza dell’aver compreso, in fine, ‘di quanto poco’ (o forse ‘di quanto meno’) abbiamo bisogno per sopravvivere, per riuscire a raggiungere quel ‘dialogo di pace’ e di ‘comprensione reciproca’, pur costruiti sulle parole, cui tutti in segreto agognamo.
Quel che in questo romanzo-saggio e insieme reportage-di-viaggio, l’autrice tende a rammentare al lettore è che, in fondo, lo spartiacque fra il bene e il male sta nelle scelte che facciamo. Sia che ci conformiamo ai costrutti della società in cui viviamo, sia che ci si costituisca in singolo nucleo o gruppo comunitario, la ragione per continuare a vivere è in quel ‘libero arbitrio’ in cui la nostra ‘essenza/assenza’ si barcamena: «Ancor più – come osserva Galimberti citato nel libro – in cui l’uomo non si accorge neppure, perché curiosamente la non libertà viene vissuta come il massimo della libertà.»
Ma il filosofo non si ferma qui, infatti aggiunge che: «Solo chi si munisce di un approccio sofisticato potrà de-costruire quel fenomeno di vastissime proporzioni che va sotto il nome di ‘mondializzazione’ o ‘globalizzazione’ e che non può essere inquadrato esclusivamente entro limiti tecno-economici’, come se fosse il mondo migliore possibile. (...) Dobbiamo evitare un doppio errore: il nuovismo in base al quale si crede che tutto nasce dal nulla, e il passatismo che si fa schiavo della tradizione. Del resto il mondo non (ri)nasce ogni giorno continuamente e non è senza passato.»
Al tempo stesso non possiamo credere che nulla cambi o che tutto ci sia dato, ogni cosa ha un prezzo. E come dice un altro filosofo (Bodei) citato: «È invece necessario concepire la realtà come qualcosa in movimento. Sono necessarie nuove regole nei confronti dei poteri occulti delle grandi società multinazionali, dei paradisi fiscali. È ora di strappare il velo con nuovi rigorosi controlli. (…) La globalizzazione sta riducendo il ruolo degli Stati nazionali. E tutto ciò riguarda anche la filosofia e l’etica. »
Del resto – come scrive l’autrice Marina Torossi Tevini – ‘quando spalanchi abissi, quando ti annulli per essere tutti e lasciar risuonare dentro di te gli echi del mondo, succede sempre qualcosa di irreparabile’, che traduco volentieri in ‘qualcosa di imprevedibile’ che talvolta ancora ci sorprende. Quel qualcosa che dev’essere di riferimento per ognuno di noi e che va riferito a quella ‘bellezza’ che in-illo-tempore è pur stata mortice di questo nostro mondo, come qualcosa che vorrei rammentare a tutti voi che mi leggete: ‘anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno’.
Marina Torossi Tevini, è nata a Trieste e laureata in lettere classiche, dedicandosi per molti anni all’insegnamento liceale. Oggi fa parte del direttivo di alcune Società culturali triestine e collabora a riviste, tra cui Arte&Cultura, Stilos, Zeta ed alla rivista web Il sottoscritto. Tra i suoi libri più recenti vanno ricordati: ‘Il migliore dei mondi impossibili’ (Campanotto Edit. 2002); ‘Viaggi a due nell’Europa di questi anni’ (ivi 2008); ‘L’Occidente e parole’ (ivi 2012). Alcune sue opere sono reperibili in rete.
*
.jpg) - Sociologia
- Sociologia
Preconcetto e Insostenibilità - Saggio sul libero arbitrio
Dal preconcetto all’insostenibile, dal ‘libero arbitrio’ all’‘arbitrio politico’.
Pubblicato in 'Quaderni' n.6 - Decisioni sovrane. InSchibboleth - 2017
È concettualmente accertato che l’uomo post-moderno, sempre in bilico tra l’uomo arcaico e l’uomo futuro, non riesce a trovare un proprio equilibrio che gli dia stabilità all’interno della sfera evolutiva, in ragione della sua incontenibilità precostituita, dovuta per lo più all’andamento accelerato con cui la società si trasforma, rispetto alla velocità di assorbimento psico-fisica, diversa per alcune tipologie di individui e aree di sviluppo intellettuali. Un ossimoro questo che non prevede una particolare valutazione delle varianti intrinseche del fattore ‘tempo’, in quanto nozione del passato-presente-futuro, connaturato con il concetto evoluzionistico di svolgimento e mutazione, sviluppo progressivo e trasformazione di cui l’uomo post-moderno è a sua volta dominante e subordinato del/al ‘potere' prevalente della medesima società in cui il fattore ‘tempo’ (epoca, periodo, lasso) si evolve.
Ciò che si vuole retaggio di un ordinamento pre-costituito, sancito dal ‘diritto giuridico’ in vigore nelle diverse epoche storiche, le cui leggi comunque redatte da uomini per altri uomini, hanno dato forma a un ‘ordinamento preconcetto’ della società. Per così dire, a una ‘decisione sovrana’ che non trova oggi riscontro nell’ampio spettro dell’universalità umana: per cui ‘ogni uomo è libero’ nell’ambito della globalità dello sviluppo storico-sociale in stretta relazione con il pensiero filosofico dominante. Concettualmente paritetico di quel processo di conversione che ha trasformato il ‘positivismo relativo’ del secolo scorso, nel ‘pensiero negazionista’ contemporaneo, in cui il ‘tutto’ è verosimilmente sostituito dal ‘nulla’; che è comunque un ‘nulla’ antropico, cioè relativo all’analisi degli assetti organizzativi umani conseguiti in illo tempore, ovvero allo studio (scientifico) di quei processi che nel corso del ‘tempo’ hanno condotto alla formazione degli assetti evolutivi.
Assetti indubbiamente inerenti al ‘passato’, al punto che potrebbero dirsi superati se messi a confronto con la rivoluzione socio-economico-politica, nonché filosofica ed esistenziale che la pressante globalizzazione di massa impone al ‘presente’, e che sta trascinando tutto e tutti verso una caduta inarrestabile, difficile da predeterminare. Di fatto l’‘evoluzionismo’ filosofico/scientifico (darwiniano e lamarckiano) sembrerebbe ormai superato e aver lasciato il posto a più attuali problematiche dettate da una ‘sovranità giuridica’ irrevocabile, nonché da una maggiore ‘responsabilità politica’ insormontabile che, in ogni caso, vanno rapportate a quel ‘futuro’ che incombe alle porte della coscienza di noi moderni.
Come ci si rapporta alla situazione politico-giuridica attiva in una realtà democratica, consistente nella possibilità attribuita a un qualsiasi ‘soggetto’ di produrre ‘effetti giuridici’, ossia di costituire, modificare o estinguere un ‘rapporto giuridico’, attraverso un ‘atto’ che non sia al tempo stesso la configurazione di un qualcosa di ‘preconcetto’ e/o ‘insostenibile’ che tuttavia permetta una risoluzione del problema?
Una siffatta domanda, previene Emmanuel Levinas nel suo “Gli imprevisti della storia” (1), è leggittima in linea ideale, tuttavia equivale a un salto nel buio, poiché:
Questo mondo che trascende il mondo in cui siamo immersi, non è anche al di là di questa comprensione specifica che noi abbiamo dell’individuale, dello storico, dell’umano, e in cui il reale si presenta non solo come una concatenazione di proposizioni ma come un’esistenza che vale e che pesa (?).
Una risposta se vogliamo reversibile che si trasforma in una domanda concettuale se l’analizziamo sulla base della storicità socio-politica, in quanto estingue molti di quei ‘valori’ che in passato abbiamo sostenuto essere fondanti. Quegli stessi ‘valori’ che la teoria dell’‘evoluzionismo’ ha conseguentemente inculcato nella mente-scientifica tout-court, a causa o in ragione della quale è progredita la nostra piena conoscenza. Ma tutto questo cos’è, se non la realizzazione di un pre-concetto dato ‘in assoluto’ che, preso a sostegno di un qualcosa in astratto, oggi, a distanza di tempo, si prefigura insostenibile?
L’interrogativo resta sospeso nell’aria, tuttavia lascia comprendere quanto il fattore ‘tempo’, necessariamente introdotto a scandire le età storiche, influenzi il tra¬scorrere degli eventi umani, cui affidiamo la complessità (pre-concetta) delle teorie sul ‘tempo’ presente e futuro che noi, post-moderni, andiamo sostenendo, quand’anche soggette alla simultaneità e alla casualità nozionistica formulate. Per quanto non ci sia errore in tutto questo, ma che è solo un modo di riprodurre il ‘tempo’: “..un modo unico per il tempo di temporalizzarsi”. Un lasso necessario, teologicamente parlando, per darsi il ‘tempo’ di morire e rinascere, (la mitologica fenice, la parabola di Cristo ecc.) in modo di ‘secolarizzarsi’ all’inteno dell’ordinamento religioso e, successivamente, per essere divulgato come parola data, in quanto ‘verbo’ consolidato e riconosciuto giuridicamente, di una ‘decisione sovrana’ religiosa quanto laica.
Questo pre-sentimento del destino nella morte sussiste (nella religione cristiana, come nel paganesimo) – scrive Levinas – basta darsi una durata (di tempo) costituita, per togliere alla morte la potenza (e il dominio), di interromperla. [...] Collocarla nel tempo significa precisamente superarla, trovarsi già sull’altra sponda del precipizio, averla dietro di sé. La morte-nulla è la morte dell’altro, la morte per il sopravvivente. Il tempo stesso del ‘morire’ non può darsi l’altra riva. Ciò che questo istante ha di unico e di straziante riguarda il fatto di non poter passare. Nel ‘morire’, l’orizzonte dell’avvenire in quanto promessa di un presente nuovo è rifiutato: si è nell’intervallo, per sempre intervallo. Intervallo vuoto [...] la cui minaccia è nel suo avvicinamento, non essendo possibile alcun gesto per sottrarsi a questo avvicinamento, ma questo avvicinamento non potendo mai finire.
Tuttavia - come pure accade nell'arte - sussiste una dimensione di evasione proprio nel raggiungimento estetico, in cui l’esistenza umana si rispecchia e, nello specchiarsi, ricrea se stessa nel confronto diretto con la storicità del 'tempo', per cui passato, presente e futuro, rappresentano (nell’arte come nel destino di ognuno) la propria dimensione dinamica. Superata non senza qualche difficoltà, la nozione pre-contestuale di ‘tempo’ torna però ad affacciarsi un concetto pregresso mai venuto meno, sul quale il dibattito è ancora oggi molto acceso: il ‘libero arbitrio’, con implicazioni in campo religioso, etico e scientifico in grado di condizionare sia le scelte individuali, sia di interi gruppi sociali sulla base della responsabilità scientifica ,ancor più di libertà e indipendenza di pensiero. Seppure in entrambe le soluzioni del caso si affermi che quanto accaduto in passato e quanto accade nel presente sia frutto di una certa consequenzialità deduttiva, ciò non rende possibile stabilire quel che sarà in futuro, in ragione di una ‘incompatibilità’ di tipo deterministico/indeterministico – come si è visto – incapaci per contrapposizione, di confermare all’individuo una qualche coerenza, in fatto di libertà, delle proprie scelte (psico-fisiche, culturali e politiche), e non solo delle proprie azioni.
Queste due posizioni esauriscono le possibilità logiche da contemplare. Se il determinismo è vero, noi non siamo liberi. Se l’indeterminismo è vero, le nostre azioni sono casuali e la nostra volontà manca di controllo per essere comunque moralmente responsabili. [...] Tuttavia anche nel caso diametralmente opposto, ovvero nel caso in cui le stesse leggi fisiche fossero interpretate con la fisica classica e quindi risultassero ‘deterministi-che’, si vedrebbe di nuovo venir meno la libertà della ‘scelta’, in quanto conseguenza di una complessa serie di processi psico-fisici, e anche qui il (concetto di) ‘libero arbitrio’ verrebbe a decadere. [...] Dunque, rimangono solamente due possibilità: l’interpretazione deterministica della natura, secondo la quale sono solo le leggi fisiche a dettare i comportamenti umani; e l’interpretazione indeterministica, per cui ogni evento è dettato dal caso e le scelte individuali sono la naturale conseguenza di questi processi casuali. In entrambi i casi non rimarrebbe molto spazio per il ‘libero arbitrio’, se non tramite una ‘teoria del tutto’ che apra la via per differenti interpretazioni. (*)
Di gran lunga il più importante tra i tentativi di risolvere il problema se il ‘libero arbitrio’ sta nella capacità da parte dell’individuo di scegliere da sé le prorpie azioni, scrive Emmanuel Kant: “Se non avessimo il ‘libero arbitrio’ saremmo come robot, o automi, incapaci di scelte autonome” . È quanto dibattuto in seno alla filosofia antica: da Platone ad Aristotele come fondamento della responsabilità morale; da Sant’Agostino a Tommaso d’Aquino nella prospettiva cristiana; nel contrasto tra Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero, per arrivare ai giansenisti, ai calviniani e ovviamente anche dai più recenti filosofi fautori del ‘docostruzionismo morale’, con risultati spesso contrastanti e apologetici. Ma ripartiamo da Emmanuel Kant (2), il quale opponendosi ai fumi di Hobbes e Spinoza distinguendo fra il mondo fenomenico e il mondo noumenico, giunse in fine a dare seguito al dibattito per cui sareb¬be invece possibile l’iniziativa autonoma dell’uomo, per spingerci oltre, fino ad arrivare ai giorni nostri con Nigel Warburton (3) che, nella prospettiva di una possibile elencazione, include il ‘libero arbitrio’ tra i grandi temi della filosofia ancora irrisolti:
“L’assunzione principale dell’argomento in un mondo in cui siano presenti il libero arbitrio e la possibilità del male è preferibile a un mondo di persone simili ad automi che non possono commettere azio¬ni malvagie. [...] Questi esseri pre-programmati potrebbero anche essere stati progettati in modo da credere di possedere il libero arbitrio, anche se di fatto non lo possiedono: potrebbero avere l’illusione del libero arbitrio, con tutti i benefici che seguono dal pensare di essere liberi, ma senza gli svantaggi. [...] Tuttavia si deve osservare, a favore dell’argomento, che la maggior parte dei filosofi ritiene che gli individui lo possiedano davvero, in un senso o nell’altro, e che il libero arbitrio è generalmente considerato un elemento essenziale dell’essere umano.”
Per quanto all’interno di questa argomentazione, si denota una sorta di conoscenza di carattere comunitario desunta dal ‘funzionalismo sociale’ con il compito di formulare giudizi pertinenti alla situazione e, progressivamente, per arrivare fino a quei ‘principi primi’ che ispirano ogni tradizione di ricerca:
“In fine - scrive Marco d'Avenia (4) - nel caso di criteri conflittuali (come quello sopra evidenziato), sarà da mettere in atto una ‘decostruzione’ o genealogia nietzscheana che arrivi a mostrare come ci si inganni nel perseguire i fini preposti (di giungere a una soluzione), in base ai medesimi strumenti di cui si fa uso, in una sorta di confutazione elenchica storicamente consapevole. [...] Non esiste nessuna ricerca che non sia collocata nello spazio e nel tempo, con tutti i suoi limiti, vantaggi e condizionamenti, [...] perché parte inevitabilmente da alcune assunzioni che dovranno risultare valide. Il termine della ricerca, è una conclusione valida so far, cioè: fino a prova contraria.”
“Purtroppo il pregiudizio culturale è – scrive Alasdair MacIntyre (5) – qualcosa che frequentemente separa la percezione che l’uomo d’oggi ha di se stesso dalla sua storia passata. Come se non bastasse, il pregiudizio culturale trova talvolta delle apparenti conferme da parte di alcune teorie fio-sofiche che sarebbero di per sé prive di preconcetti: il modo di strutturare la nostra comprensione del futuro dipende naturalmente in parte dall’uso consolidato [...] e dei modi di programmazione in uso nelle culture nelle quali ci troviamo. Per quanto in grado di immaginare differenti possibili futuri [...] è immaginabile un movimento che dal punto di partenza del presente punti in differenti direzioni. Infatti, progetti futuri differenti o alternativi offrono serie differenti e alternative di beni da raggiungere, in differenti modi possibili del vivere. [...] È importante che si sia in grado di prospettare futuri più prossimi e più lontani e che si sappia calcolare la probabilità dei risultati futuri dell’agire in un modo piuttosto che in altro, anche se solo in modo approssimativo. Per questo sono necessarie sia la conoscenza (l’onniscienza nelle religioni monoteistiche); sia nel caso diametralmente opposto, l’immaginazione indeterministica (per cui ogni evento è dettato dal caso).”
Ora noi ben sappiamo che nella ricerca individuale sussiste tutta una se¬rie di relazioni oppositive spesso nascoste, e ancor più ve ne sono (li dove esse siano accettate) nella ricerca condivisa. Il dualismo intrinseco di questa specifica ricerca sta tuttavia nel ‘compromesso’ che le parti consciamente/inconsciamente sottoscrivono allo scopo di raggiungere la meta della ricerca stessa:
“Allo stesso modo non possiamo replicare a Nietzsche – prosegue MacIntyre – il fatto di per se stesso istruttivo, che ci ricorda quanto (l’individuo razionale) è implicato nell’obbedienza a una concezione del bene comune che richiede sia le virtù dell’agire razionale indipendente, sia le virtù della dipendenza riconosciuta. [...] Nondimeno, all’inizio di ogni ricerca filosofica svolta in questo senso, va fatta una qual¬che puntualizzazione, per quanto non si da nessun punto di partenza che sia privo di presupposti. [...] Ciò che giustifica questo o quel punto di partenza è quanto viene dopo, la ricerca che ne consegue e il risultato raggiunto nella comprensione del problema. Un indice di comprensione adeguata è che essa spieghi retro¬spettivamente perché la ricerca ben concepita per realizzarla avrebbe potuto muovere da certi punti di partenza ma non da altri. Le nostre assunzioni e procedure iniziali sono giustificate soltanto quando alla fine si arriva alla formulazione conveniente di un insieme adeguato di ‘principi primi’. [...] Non sorprende che anche la conoscenza di sé abbia questo medesimo doppio aspetto, dal momento che la conoscenza che abbiamo di noi stessi presuppone ed è presupposta dalle nostre attribuzioni personali (individuali) d’identità.”
Per la teoria fenomenologica di Edmund Husserl (6), la ricerca della 'significazione' in sé è un’astrazione in quanto: “..sfugge all’interpretazione filosofica costruita, portata dal di fuori, tradendone il senso [...] nella convinzione che la significazione filosofica e ultima del ‘fenomeno’ è raggiunta quando il fenomeno si colloca nella vita cosciente, nell’individuale della nostra vita concreta. [...] Resta da sapere se noi comprendiamo veramente questo linguaggio.”
Al quale replica Levinas, dalla cui prospettiva vengono messi in evidenza due temi: lo scetticismo del linguaggio filosofico e il carattere inequivocabilmente giuridico-politico del ‘libero arbitrio’. Sul problema, in questi ultimi anni, abbiamo assistito a prese di posizione alquanto arbitrarie, secondo dove tirava il vento sono stati introdotti rapporti relazionali fra scienza ed economia, come pure fra filosofia e politica inevitabilmente manipolativi.
“Secondo MacIntyre – rileva ancora Marco D’Avenia – è impossibile, senza vivere correttamente all’interno di reti solidali di dare e avere, perché senza di esse lo scambio utiliritaristico e manipolativo viene a soppiantare quel più profondo bisogno di reciproco e incondizionato riconoscimento che è tipico del mondo delle persone. L’alternativa che attraversa tutto il pensiero teologico, filosofico e politico occidentale riferito al ‘libero arbitrio’ è per molti versi ancora presente nelle discussioni contemporanee che si svolgono soprattutto nell’ambito della filosofia analitica, che può essere così riassunta: ‘libero arbitrio’ come assenza di costrizione, ossia libertà di scegliere anche in contrasto con le proprie preferenze, senza essere univocamente determi-nati dal proprio carattere per un verso o per un altro verso le circostanze in cui venga fatta la scelta; [...] ma ed anche la capacità di autodeterminazione della volontà individuale, che viene aggiunta al presupposto indeterministico e giudicata da molti filosofi come una nozione intrinsecamente oscura. [...] Rimane tuttavia un certo scetticismo sulla possibilità attuale per l’individuo/massa di elaborare un progetto politico propositivo improntato a un’etica della relazione sociale e politica che abbia senso logico. Contrariamente parrebbe quasi intravvedersi in questa argomentazione una logica apocalittica del ‘tanto peggio tanto meglio’: si tratta solo di sperare che il mondo corrotto arrivi a una sorta di eucatastrofe, per poi riemergere di nuovo una volta toccato il fondo dell’inautenticità, maggiormente ancorato alla realtà e disposto a riconoscere una volontà trascendente ai propri schemi riduttivi.”
Mi ripeto – questa volta filosoficamente parlando – per darsi il tempo (l’individuo umano) di ‘morire’ e di ‘rinascere’, come la mitologica fenice, e nella parabola del Cristo, dentro la parola data (verbo) e prima d’ora mai venuta meno, in modo di re-incontrare se stesso nel riconoscimento d’una volontà giuridicamente convalidata da una ‘decisione sovrana’ non più in contrasto con un ipotetico ‘altro’: (la società, lo stato, le leggi, ecc.); bensì in piena intesa con la piena libertà acquisita.
Utopia del tempo che rimette in discussione parole ch’erano già desuete almeno trent’anni fa e che sembrano aver perduto ogni ancoraggio con la realtà. O, perlomeno, con quella realtà fittizia, che si esprime in termini di: ‘volontà’, ‘uguaglianza’, ‘libertà’, ‘morale’, ‘senso’, in quanto estremità di un discorso filosofico in¬globato o definitivamente cancellato dal vocabolario moderno soprattutto dal lessico delle giovani generazioni.
Senza tentare di approfondire tematiche che ci condurrebbero troppo lontano sia a ritroso nel passato, che in avanti nel prossimo futuro, basterà osservare nel quotidiano come l’originale apertura esistenziale (spirituale e intellettuale) dell’uomo sia rivolta altrove verso una decadenza irrefrenabile. Decadenza alla quale Walter F. Otto (7):
"..imputa la stessa interpretazione heideggeriana dell’angoscia e della cura come essenza dell’esistenza. [...] Secondo il quale, in un passo importantissimo che richiama il ‘decisio¬nismo’ di Jünger, la possibilità di ‘scegliere’, pur strettamente connessa alla sua visione dello spirito e della soggettività spirituale, va messa a confronto con il pensiero di colui che ha tirato le fila del Novecento, Nietzsche: l’abile ‘distruttore d’ogni certezza’. [...] Del pari, viene respinta l’interpretazione corrente secondo cui la chiave per comprendere (il tempo attuale), risiederebbe esclusivamente nel piano funzionale ‘comunicativo’ del lin¬guaggio stesso” e, in senso lato, nella dimensione ‘linguistica’ elaborata nel discorso ‘decostruttivistico’ nietzschiano.”
Maurizio Ferraris (8), ad esempio, denota una certa difficoltà di fondo della nozione di ‘libertà’: “..in cui si mescolano due elementi, la libertà come principio politico e il ‘libero arbitrio’, ossia l’idea che le nostre azioni siano dipendenti dalla nostra volontà e non dal determinismo naturale di cui ci sfuggono i principi. [...] Di contro, le manifestazioni del potere risultano ben più articolate di quanto non ne lasci supporre la tripartizione di Weber: tradizionale, carismatico e legale-burocratico. [...] La posta in gioco, resa drammaticamente attuale all’incrocio tra economia, media e politica nel mondo contemporaneo, è capire quanto solida sia la realtà sociale, e in particolare quanto la sfera della ‘documentalità’, delle iscrizioni che popo¬lano la nostra vita e riempiono le nostre tasche, i nostri portafogli e i nostri telefonini, possa costituire un baluardo contro la riduzione postmoderna del mondo.”
Riguardo all'applicazione ‘morale’ va detto che c’è molta incoerenza relativamente se applicarla alla società e/o agli individui. Fin qui, qualsiasi affermazione in merito, non ha risolto un dualismo renitente, insito nella possibilità di una ‘critica morale’ dei valori centrali di una società:
“Se i giudizi morali si definiscono in relazione ai valori centrali di una società, nessuna critica di tali valori può servirsi di argomenti morali contro di essi [...] per cui diventa impossibile sostenere che ogni teoria (relativista o no) sia assolutamente vera. [...] Pertanto, attivare una teoria etica (deontologica) alla morale consiste (per l’individuo) nel compiere il proprio dovere (sociale), qualunque conseguenza ne possa derivare. L’idea che alcune azioni siano giuste o sbagliate in modo assoluto, indipendentemente dai risultati che ne conseguono, e che distingue le teorie etiche deontologiche dalle teorie etiche consequenzialiste.”
Il richiamo è ancora una volta all’ ‘l’imperativo categorico’ di Kant, il quale definisce i ‘doveri’ di noi esseri umani razionali come assoluti e incondizionati all’interno di un sistema etico-morale in contrapposizione con i doveri cosiddetti ipotetici relativi a ottenere o evitare un determinato effetto positivo/negativo, economico/politico, culturale/ sociale, individuale/comunitario, fondamentale e universalizzante: “Agisci solo seguendo massime che tu possa al tempo stesso volere come leggi universali”. Una massima questa che ci fornisce una risposta corrispondente alle intuizioni fin qui incontestate della maggior parte degli studiosi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
Personalmente penso che in filosofia e in tutto ciò che riguarda le scienze umane non ci sia nulla di sbagliato quando gli obiettivi sono degni di essere perseguiti; pur tuttavia vanno prese le giuste distanze da ciò che riguarda apertamente e/o direttamente posizioni insostenibili specie nella politica e nell’estensione delle leggi, nei dipartimenti della giustizia, nell’economia reale, nella distribuzione dei beni, nell’accesso alla cultura, nell’uguaglianza delle oppurtinità come di fronte alle necessità, senza discriminazioni di sorta.
Difficile ammettere che l’uguaglianza’ non sia un valore e un diritto assoluto che va riconosciuto e tutelato sopra ogni cosa; se così non fosse, verrebbe a decadere tutto quanto fin qui accettato in fatto di libertà e di quell’unico diritto che ancora resta in piedi che è il ‘libero arbitrio’. Un’ostentazione la mia in difesa di questo principio assoluto che trova nell’uguaglianza la sua fonte primaria perseguita nel ‘diritto/dovere’ conseguibile nella partecipazione di tutti ‘indistintamente’ all’arbitrato politico. Si può notare come fin qui si sia parlato esclusivamente di ‘doveri’ in quanto parlare di ‘diritti’ avrebbe implicato tutta un’altra riflessione e una ricerca forse più corposa, specifica della psicologia-politica e delle sue accezioni, in ambito di competenze che, secondo Julien Freund, trovano nell’istanza statale o governativa, quale le “libértes concrètes”, la loro mediazione; per quanto il potere, la libertà, l’uguaglianza o la disuguaglianza, rimandino tutte all’unico baluardo di cui fino ad oggi ci siamo dotati (o dietro il quale ci siamo barricati) che è la politica, sia in democrazia che nella sovranità dittatoriale o dell’assolutismo popolare.
Ciò che per noi post-moderni equivale alla ‘democrazia rappresentativa’ è di fatto un ‘arbitrio democratico’ che è possibile declinare in forme di governo più o meno simili tra loro, fondata sul principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi che si esprimono innanzitutto esercitando il proprio diritto di voto costituzionale. Cioè sul riconoscimento dell’uguale ‘diritto’ di tutti a scegliersi i propri rappresentanti politici, attraverso l’espressione del ‘voto’, in ugual peso e misura di ognuno che il ‘voto’ ha nella formazione della rappresentanza socio-politica. Va qui comunque riconosciuto che il valore dell’uguaglianza politica nella nostra società non ha un significato univoco, ma trova riscontro nei rapporti all’interno della società e dei gruppi che la compongono, privati e pubblici che siano e per quanto rispondenti a decisioni che di volta in volta vengono prese dalla comunità eletta riunita sotto l’egida di ‘decisioni sovrane’ cui di dovere va il rispetto dei componenti soggetti e di quanti condividono lo status costituzionale di cittadini.
Fin qui la centralità e il paradosso dell’agire politico-democratico che più ci riguarda da vicino, ma in questo contesto, insieme alle grandi emergenze umanitarie ed ecologiche internazionali che hanno motivato la formazione di associazioni non-governative (onlus, no-profit, non violenza ecc.) e di volontariato impegnate nel sociale e in difesa dei diritti a noi consentiti (non si sa bene perché proprio dalle democrazie). Come anche quelli degli animali e dell’ambiente di cui va difesa la sicurezza rispetto alle tensioni politiche tra loro divergenti, trova maggiore affermazione la funzione critica degli aspetti più discutibili dell’azione democratica rispetto ai problemi sociali emergenti e, di dare piena espressione ai bisogni di autorealizzazione di cui è portatore il pensiero liberale giovanile.
Una riflessione tuttavia si pone e, come ormai consueto alla comprensione, è necessario fare un passo indietro, alla domanda sul ‘senso’ formulata da Martin Heidegger nel percorso tracciato in ‘analitica esistenziale’ della condizione particolare in cui si trova l’individuo in quanto essere partecipe della qualità fondamentale di ‘esistere’.
Scrive Gianni Vattimo (10):
“Gli esiti di questa ricera mostrano come l’uomo sia un ‘progetto-gettato’, vale a dire un individuo determinato da una condizione storica, che non ha deciso lui stesso (in ciò consiste la sua gettatezza), ma anche un individuo libero ed essenzialmente in grado di strutturare la propria esistenza (in ciò consiste il suo lato progettuale). Su queste basi, il mondo non può presentarsi all’individuo semplicemente come un insieme di cose, bensì come un numero di possibilità aperte. Il mondo è piuttosto costituito di oggetti che si trovano ‘a portato di mano’ e che sono ‘utilizzabili’, poiché lo sguardo che l’uomo getta su di essi è interessato, rendendoli parte dei suoi progetti e della propria esistenza. [...] Ciò che Heidegger tenta dunque di realizzare, soprattutto con una svolta notevole della sua filosofia, è la ‘progettualità’, in contrapposizione con la ‘società dell’organizzazione totale’ (Adorno e la scuola di Francoforte), in cui l’accadimento e la storicità sono i veri tratti dell’essere dell’uomo, [...] intesi come una risposta a un appello. L’appello a ciò che proviene dalla storia dell’individuo (accadimento), dalle sue aspettative, dalla sua famiglia (storicità), dal suo linguaggio, dal migliorare il mondo intorno a sé (progettualità); e che figura in “Essere e tempo” e nei testi successivi prende il nome di ‘interpretazione’.”
“Esserci, l’essere umano compreso nella sua estrema possibilità d’essere, è il tempo stesso, e non è nel tempo.” (Heidegger)
Proviamo quindi a farci interpreti dell ‘interpretazione’ che Heidegger esprime in questo suo aforisma, nel quale si avalla il pretesto per l’uomo post-moderno del suo ‘stare in bilico’ tra due concetti: ‘essere il tempo’ e non ‘nel tempo’; cioè di affermare la sua ‘presenza nel presente’ e rinuncia¬re definitivamente all’idea della scelta consentita dal ‘libero arbitrio’, per cui, ‘egli è’ prima ancora del suo ‘divenire’ preordinato o successivo. Per meglio dire, (e mi ripeto allo stesso modo del cane che si morde la coda): “..che non prevede una precipua valutazione delle varianti intrinseche del fattore ‘tempo’, in quanto nozione di quel passato, presente, futuro, connaturato con il concetto evoluzionistico di svolgimento e mutazione, progressivo sviluppo e trasformazione di cui l’uomo post-moderno è a sua volta dominante e subordinato del/al ‘potere’ prevalente della società con cui il ‘tempo’ (epoca, periodo, lasso) si evolve.”
Dacché, ne deriva che l’uomo post-moderno preso in assoluto, non è dotato di libertà propria che l’illusione di un sé unitario fa sì che la democrazia ch’egli si è data, rientri nell’utopia di quella democrazia senza etica in cui ci osserviamo. Soprattutto perché “..l’interprete’ è spinto a cercare una relazione causa-effetto e continua a spiegare il mondo usando gli imput che riceve dallo stato cognitivo del momento e gli indizi che provengono dall’esterno. [...] Cominciamo a comprendere l’illusione del ‘libero arbitrio’ quando ci poniamo la seguente domanda: da che cosa vogliono essere liberi gli uomini della terra?” (Michael Gazzaniga) (11). Per quanto, cogliere il nesso di ‘qualcosa che causa cosa’ è sempre rimasto un problema di difficile soluzione, né è servita una buona dose di volontà e di ‘interpretazione’ costruttivista, di tipo filosofico-linguistico: “È probabile che dovremo trovare un linguaggio più appropriato, pittosto che cercare di rientrare in alcune categorie di pensiero decisamente obsolete” (Gazzaniga); o di tipo nichilista.
“Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora” - ci ricorda ancora Heidegger - Acciò, egli avverte in un altro aforisma: “Il nichilismo non serve metterlo alla porta, perché è ovunque, gia da tempo, esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest’ospite e guardarlo bene in viso.”
Che sia “L’ospite inquietante” cui fa riferimento Umberto Galimberti? (12)
Indubbiamente sì. Allora la domanda di Michael Gazzaniga (13): “Siamo macchine, quindi sistemi del tutto deterministici, o siamo liberi di scegliere come vogliamo?” , in realtà non trova il suo corrispettivo nella risposta, perché l’affermazione di Heideggher ci spinge verso la crici determinata dal caos cui andiamo (e lo stiamo vedendo) incontro. Non a caso Stefano Rodotà (14) nel suo “Elogio al moralismo” denuncia:
“..una trasparenza sociale della quale volentieri avremmo fatto a meno: quella minuziosamente, quotidianamente, incarnata da comportamenti (politici) che esibiscono la forza in luogo del diritto, la sopraffazione al posto del rispetto, l’impunità invece della responsabilità. E dunque forza, sopraffazione, impunità diventano regole e indirizzi (della società), di fronte ai quali non può esservi solo frustrazione o acquiescenza.[...] Contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni decise ad applicarle. Ma serve soprattutto una diffusa e costante intransigenza morale, un’azione convinta di cittadini che non abbiano il timore d’essere definiti moralisti, che ricordino in ogni momento che la vita pubblica esige rigore e correttezza”.
Ciò per quanto la libertà, l’uguaglianza, la moralità, il potere politico, le nuove tecnologie della comunicazione, trovano nella democrazia una verità assoluta, per cui dire che esiste un solo (e unico) modo di vivere, non è un ossimoro del decostruzionismo derridiano, bensì il corrispondente dell’ordine cosmico che include e/o esige vincoli e doveri di etica individuale, diritti che diano autorità all’individuo sociale.
Una possibile soluzione al problema ci è suggerita da Bertrand Russell (15):
“Se non vogliamo che la vita umana diventi una cosa polverosa e priva di interesse, è importante convincersi del fatto che vi sono cose che hanno un valore del tutto indipendente dall’utilità. [...] Trovare il giusto equilibrio tra i fini e i mezzi è cosa al tempostesso difficile e importante. [...] È negli individui (sociali), e non nel tutto privato o particolare), che dovranno cercarsi i valori utili. Una società buona è un mezzo per una vita buona di coloro che la compongono, e non è qualcosa che abbia, per proprio conto, una sua specie separata di eccellenza.”
"È dunque giunto il momento di pensare a un sistema di diritti/doveri per il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto – scrive Stefano Rodotà in “Il mondo della rete” - : ai diritti politici della piazza virtuale, alla cittadinanza digitale, alla neutralità e all’anonimato di chi è ‘interprete’ e di chi è ‘rappresentato’, nonché al diritto all’oblio di chi chiede (e può pretenderlo) di non farsi né interprete, né essere rappresentato.” Del resto la ‘rete’, che oggi rappresenta l’orizzonte conoscitivo-significativo da cui tutto si diparte, “..non è un’invenzione felice dell’umanità più o meno antica, e men che meno ‘primitiva’, bensì è una (la) rivelazione originaria dell’essere comunicativo.” “Allora qual è il destino della democrazia nel tempo in cui le tecnologie d’informazione e della comunicazione ridisegnano i luoghi e le aspirazioni della politica, abbattono i confini, negano gli stessi vincoli che fin qui ci hanno guidati dello spazio e del tempo? – si chiede ancora Rodotà – .È forse a portata di mano l’ideale della democrazia ‘continua’? Oppure sta per materializzarsi la società della sorveglianza totale?”
“Seminare dubbi, non già raccogliere certezze”, è stato da sempre il motto di Norberto Bobbio (17), per quanto anch’egli si sia posto alcune domande di estremo interesse sociale, una delle quale va riferita all’ ‘arbitrio politico’ riferito alla sfida della democrazia. “È in atto un irrimediabile deterioramento dei regimi (?) democratici, tale da lasciarne presagire un triste futuro, una fine irreversibile?”, per darsi poi la migliore delle risposte plausibili: “È possibile rendersi conto delle contraddizioni in cui versa una società democratica senza smarrirvisi, riconoscere i suoi vizi congeniti senza scoraggiarsi e senza perdere ogni illusione nella possibilità di migliorarla.”
Scrive Jacques Derrida (18): “Quando ci interroghiamo sull’avvenire della democrazia due grandi orientamenti si offrono alla riflessione. Il primo consiste nell’interrogarsi sulle opportunità della sua estensione, del suo progresso o (più raramente, ma in via del tutto necessaria) sui rischi che minacciano di farla regredire o arretrare? [...] Il secondo, riguarda più da vicino quali sono le sfide che deve raccogliere? [...] Quello che è in gioco nell’avveniresi identifica allora con l’evoluzione dei rapporti di forza tra ognuna delle componenti, (tenendo presenti) gli sconvolgimenti (guerre, rivoluzioni, crisi di regime), violenti e non, che potrebberomodificare la sua fragile partizione. Pensare l’avvenire vuol dire comprendere la natura della forza o della potenza implicate nella complessità dei rapporti (economico, militare-industriale, tecnico-scientifico, spirituale o altro), all’epoca di ciò che chiamiamo la mondializzazione. [...] Questo orientamento riguarda, detto altrimenti, ciò che potrebbe ancora accadere alla democrazia, in meglio o in peggio, che non si lascia né programmare né calcolare nel conforto delle istituzioni, dunque, ancora una volta, indissociabilmente, la sua fortuna e la sua minaccia – ciò che chiameremo la sua perfettibilità”.
Va qui ricordato che tutte le strategie sopra delineate per costruire o decostruire il ‘libero arbitrio’ e trasformarlo in ‘arbitrio politico’ fino a raggiungere lo status di ‘democrazia’ all’esame di questa tesi, queste cominciarono a evolvere molto tempo prima che emergesse una coscienza popolare, (forse non appena iniziarono a fiorire vere e proprie menti), e ciò accadde non appena venne a crearsi un numero sufficiente di comunità autosufficienti a formare un’organizzazione della vita a sfondo socio-culturale. Quindi in un lungo, lunghissimo tempo in termini di esigenze e di gestione efficiente dei processi vitali e di conseguenza, le aumentate probabilità di sopravvivenza. Per cui la ‘coscienza libera’ stabiliva, sulla base della condizione umana e la consapevolezza della propria conoscenza culturale, una con-nessione fra la lotta per l’esistenza e un organismo unificato, identificabile nella socializzazione democratica.
Per quanto, ora più che mai, si rende necessario riprendere il discorso, da quella storia dei comportamenti umani elementari, dall’inizio dell’evoluzione naturale delle coscienze, per cui, come scrive il famoso etologo e linguista Irenäus Eibl-Eibesfeldt (19): “Se smetteremo di erigere barriere alla comunicazio¬ne fra gli esseri umani e di degradare a mostri coloro che sono umani come noi, anche se aderiscono ad altri sistemi di valori . Ma se, al contrario, accentueremo ciò che a loro ci lega, noi - uomini e donne di coscienza – prepareremo per i nostri nipoti un futuro felice. Le potenzialità del bene sono biologicamente presenti in noi quanto quelle dell’autodistruzione”, che convenientemente dobbiamo in ogni modo evitare.
Note e bibliografia:
(*) Wikipedia - Enciclopedia Libera.
1) Emmanuel Levinas, Gli imprevisti della storia, Inschibboleth 1994.
2) Emmanuel Kant, Vita, pensiero, opere scelte, Il Sole 24 Ore 2006.
3) Nigel Warburton, Filosofia: I grandi temi, Il Sole 24Ore Edit. 2007.
4) Marco d’Avenia, «Presentazione» in A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti”, Vita e Pensiero Edit. 2001.
5) Alasdair MacIntyre, Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero Edit. 2001.
6) Edmond Husserl, Vita, pensiero, opere scelte, Il Sole 24 Ore 2006.
7) Walter F.Otto, Il volto degli dèi, Fazi Edit. 2016.
8) Maurizio Ferraris, Derrida e la decostruzione, Gruppo Edit. L’Espresso 2009.
9) Martin Heidegger, Vita, pensiero, opere scelte, Il Sole 24 Ore 2006.
10) Gianni Vattimo, Heidegger e la filosofia della crisi, Gruppo Edit. L’Espresso 2009.
11) Michael Gazzaniga, Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio, Le Scienze 2013.
12) Umberto Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli Edit. 2007.
13) Stefano Rodotà, Elogio al moralismo, Laterza Edit 2011.
14) Bertrand Russell, Autorità e Individuo, Longanesi Edit. 1980.
15) Stefano Rodotà, Il mondo della rete, Laterza Edit. 2014.
16) Stefano Rodotà, Tecnopolitica, Laterza Edit. 1997.
17) Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi Edit. 1995.
18) Jacques Derrida, Luoghi dell’indicibile, a cura di F. Garritano ed E. Sergio, Rubettino 2012.
19) Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Amore e odio, Adelphi 1989
*
 - Poesia
- Poesia
L’arte di essere fragili – un libro ‘ricolmo di stelle’
L’arte di essere fragili – un libro ‘ricolmo di stelle’ di Alessandro D’Avenia – Mondadori 2016.
Cari amici poeti …
all’inizio pensavo di dover leggere un romanzo e invece stavo leggendo una fiaba che, per quanto menzognera, scorreva leggera come impastata di quell'amorevolezza verso l'incredulità che ognuno si porta dentro. In realtà era poesia vestita da fiaba quella che stavo leggendo e di quella più pura, quasi che, a un certo punto, mi sono convinto che qualcuno mi stesse dicendo che le stelle nascono sugli alberi e che, al contrario delle foglie, anziché cadere all’ingiù, salgono verso cielo per perdersi nell’universo infinto, e vi ho creduto. Più avanti ho però mutato opinione, quello che avevo tra le mani non era il frutto di una favola menzognera al pari di un oroscopo, come quello che si va a cercare aulle pagine del quotidiano, era davvero un libro di poesia ricolmo di stelle, delle stelle dei poeti, quelle che invitano a sognare, che elargiscono la speranza, che inebriano e si lasciano afferrare, ma solo se si è capaci di apprendere ‘..l’arte di essere fragili’.
Ecco detto il titolo del libro che non avrei voluto svelare perché preso dalla gelosia morbosa di tenerlo per me, a tenermi compagnia sul comodino o meglio, sotto il cuscino, per poter dare adito a quei sogni di ragazzo che verosimilmente sono stati dell’autore così come i miei e immagino anche di qualcuno di voi. Sì, ‘L’arte di essere fragili’ di Alessandro d’Avenia non è un romanzo, ma neppure un libro qualunque, ci si può innamorare nel leggerlo così come si è sempre innamorati della ‘bellezza’. Finanche nella sua sfuggevole accezione, quando cioè la bellezza trova il suo equivalente nella ‘fragilità’ di ciò che non si può afferrare, che solo è lasciata all’incanto dell’osservatore attento, che la esalta e la celebra su tutte le cose: come il pittore fa con la natura, l’uomo con la donna, quando il sentimento sublima l’amore.
Dopo ‘I libri ti cambiano la vita’ di Romano Montroni (vedi recensione su questo stesso sito) e ‘Le voci dei libri’ di Ezio Raimondi (citato nel testo), che hanno segnato momenti di piacevolezza dove tutto avviene per una sorta di simbiosi, data dalla necessità interiore di interloquire che ci fa stendere la mano verso il libro e le parole ‘scritte’ che in quel momento più necessitiamo, ècco arriva d’Avenia a farci dono di un ‘salvavita’ che molti non stenteranno a riconoscere come il più bel libro mai letto prima. Insieme a tanti altri ovviamente, ma in senso assoluto quello che più asseconda la necessità attuale di riconciliazione con gli altri, col mondo in cui viviamo, con la bellezza della natura che ci circonda e, non in ultimo, con noi stessi. Quei ‘noi’ che forse non conosciamo fino in fondo o che volutamente disconosciamo per scelta, per ansietà o per disamore di quelle cose che pure abbiamo amate, alle quali senza ragione non prestiamo più alcuna attenzione.
“Il libro vero parla sempre al momento giusto. Lo inventa lui, il momento giusto; con il colore della parola, con la singolarità della battuta, con il piacere della scrittura” - scrive Ezio Raimondi. Quante volte abbiamo aperto un libro e scorrendo le sue pagine ci è sembrato di aver trovato proprio quello che volevamo leggere, o magari, solo sentirci dire? Altre volte, rammento, di aver sfogliato un libro e averlo subito riposto, perché non lo sentivo adatto a me; oppure averlo ricevuto in regalo e messo via, nel limbo delle attese. Come dire, in stand-by, aspettando il momento migliore per leggerlo e che talvolta è arrivato dopo anni, che quasi non rammentavo neppure di averlo nello scaffale. Invece era lì, aspettava il momento giusto, per imporsi alla mia attenzione, e accipicchia, quante volte l’ha spuntata Lui, il Libro e devo ammettere che ‘in qualche modo’ mi ha cambiato la vita.
È accaduto con “Pinocchio”, “Cuore”, “Tre uomini in barca”, e con “Bel-Ami” quando ormai avevo l’età giusta, con “La luna e i falò”, “I fratelli Karamazov”, “Il Maestro e Margherita”, e tantissimi altri. Ma il grande libro che più mi ha conquistato, e che è quasi stupido citarlo, è stata “La Divina Commedia”, a seguire “I promessi sposi”, “Iliade” e “L’Odissea”, “Don Chisciotte” e poi “L’interpretazione dei sogni”, “L’idiota”, “La nausea”, “L’odore dell’India”, “Cent’anni di solitudine”, “Memorie di Adriano” e immancabilmente e irrimediabilmente “La Recherche” di Marcel Proust. Quanti altri? Tantissimi, che per uno come me, che legge anche il biglietto del tram, non basterebbe questa recensione per elencarli tutti. Ma forse avrei dovuto citare, oltre quelli degli scrittori, i nomi dei poeti che dopo Dante si sono susseguiti instancabilmente nelle mie letture: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Pasolini, Ungaretti, Neruda, Celan, Hölderlin, Kerouac, Carver, ecc. ecc.
Paul Celan afferma essere “..l’attenzione, la preghiera spontanea dell’anima”, che come in “Francesco (d’Assisi), trae il suo canto dal dolore.” E che d’Avenia giustamente attesta all’immenso Giacomo Leopardi, a quella sua breve vita costellata di stelle, fissate per un così breve scorcio di tempo dentro il cielo oscuro delle sue pene, eppure ‘luminosissimo’ che ha traslato nelle sue opere. Non c’è in questo trattato poetico nulla che sappia di vecchia morale, di nebbiosa credulità, di ingiusta etica, nulla che nel bene e nel male delle faccende umane sappia di stantio, tutto è qui riportato al giorno d’oggi. Così le storie che vi sono riportate, le impressioni che danno lustro alla nostra modernità obsoleta, le esperienze maturate sul campo dal giovane prof d’Avenia calatosi nel raffronto agevole con il poeta, sono tali da riuscire a formulare un epistolario impossibile eppure verosimilmente attestabile ai nostri giorni.
È il caso di questo passaggio dedicato all’insegnamento: «L’uomo superficiale; l’uomo che non sa mettere la sua mente nello stato in cui era quella dell’autore (..) intende materialmente quello che legge, ma non vede (..) il campo che l’autore scopriva, non conosce i rapporti e i legami delle cose ch’egli vedeva.» (Leopardi: Zibaldone 1820) Scrive d’Avenia: «Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra, e ciò che la rallegra è la scoperta dei legami che uniscono cose e persone, che rendono viva la vita. Cogliere quei legami, e ripararli è la felicità del cuore e della mente.» Ed è forse questo il breve lucido resoconto che scaturisce da un dialogo siffatto in cui il termine ‘raffronto’, produce tuttavia una sorta di seduzione che modella l’incanto della lettura, lo scherzo intelligente di esistere e di nascondersi a noi cercatori d’oppio letterario che stanchi, lasciamo talvolta al caso di offrirci le sue leccornie poetico-filosofiche.
Che sia il caso o l’attrazione di una così ‘idilliaca’ quanto delicata copertina, ma ancor più il titolo ‘l’arte di essere fragili’ a suggerirne la lettura? Forse l’una e l’altra delle cose, per quanto è l’aver scoperto che le ‘cose’ davvero «..tornano a reclamare i loro diritti, la loro tenerezza, la loro impurità, la loro ombra luminosa, la loro fragilità. Le cose e le persone, i loro volti, tornano a invocare la nostra misericordia: custoditeci e riparateci, nonostante tutto.(..) Così è la poesia, ci costringe ad abbassare la luce artificiale e tornare a vedere il mondo, mutilato e fragile, ridotto così dalla nostra indifferenza. (..) Se le stelle riuscissero ancora a colpire i nostri occhi, non solo una volta all’anno quando cadono, credo che avremmo più possibilità di costruire la nostra casa su fondamenta celesti, quelle della nostra unicità.» (d’Avenia).
Un libro quindi che consiglio di leggere per la sua ricercatezza e nascosta seduzione; che riapre una discussione sempre in corso e mai conclusa, sulla lettura e sui lettori, nel momento in cui i mezzi, gli scrittori, gli editori, stanno cambiando con il cambiare della società e dei suoi interessi; nel momento in cui la ‘lingua’ sta perdendo e acquisendo connotati talvolta controversi, o quando ormai sembra non si parli d’altro che delle solite cose obsolete, ma che forse torna utile per contrastare la ‘stupidità’ di certi programmi televisivi, improbabili quanto inutili. All'occorrenza trovo molto interessante l’enunciato di Ginevra Bompiani che in “Vari” ipotizza sui libri quanto segue: “Se i libri non ti cambiano la vita, certo la fanno. (..) Direi piuttosto che i libri ti costruiscono la vita, la ondeggiano, la sprofondano e poi la sollevano, come un sentiero in cresta fra le colline. (..) Non c’è difesa da loro, non c’è protezione. L’emozione e la cattura sono totali. (..) L’emozione non ha sempre a che fare con la qualità, piuttosto con la forza. Quando si invecchia, si scopre che l’emozione è una forma di malattia. Non sempre si guarisce, ma quando la malattia si spegne, si rimane svuotati, come in una mattina di ottobre, tersa, pungente, senza veli di nebbia, persi in un orizzonte che non ha segreti”.
Ed è questa malattia che spesso diventa ‘magia’ capace di stravolgere la vita con le parole. Una ‘magia’ che incanta e che lascia spazio ai sogni, alle illusioni, al canto lirico e alla poesia, quando ottimisticamente “credevamo altresì di trovarci all’alba di qualcosa di nuovo”, quel qualcosa che Enrico Brizzi nel parlarci de “Il giovane Holden” di Salinger, ci ha condotti per mano nella sensazione d’incredulità irreligiosità e diffidenza che ci attraversa tutti. E chi meglio di Giacomo Leopardi che non ha avuto il tempo di invecchiare, ha potuto investigare nei sentimenti umani la fragile essenza dell’essere? – si chiede l’autore d’Avenia – Chi ha dato a questa nostra epoca, la dimensione di come davvero "la poesia può salvarci la vita”? «Forse se il nostro lettore, Giacomo, stanotte spegnesse tutte le luci e guardasse il cielo in silenzio, saprebbe che la bellezza e la gratitudine ci salvano dallo smarrimento dovuto alla nostra carenza di destino e destinazione.
Forse se in quel buio luminoso avesse accanto o nel cuore qualcuno, ne scorgerebbe meglio la seducente fragilità, un infinito ferito che chiede cura e riparazione, e capirebbe di esser ‘poeta’, cioè chiamato a fare qualcosa di bello al mondo, costi quel che costi. Forse allora saprebbe che solo uno è il metodo della faticosa ed entusiasmante arte di dare compimento a se stessi e alle cose fragili, per salvarle dalla morte: l’amore. Questo è il segreto per rinascere … questa è l’arte di essere fragili.» Per poi aggiungere in poscritto quanto segue: «I libri, scelti bene, caro Giacomo, possono salvare la vita, soprattutto quella fragile, facendole cogliere il frutto del futuro che si porta dentro. (..) Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a vivere solo se perfetti. Ogni insufficienza, ogni debolezza, ogni fragilità sembra bandita. Ma c’è un altro modo per mettersi in salvo, ed è costruire, come te, Giacomo, un’altra terra, fecondissima, la terra di coloro che sanno essere fragili.»
Grazie Alessandro.
Nota: Alessandro d’Avenia, dottore di ricerca in Lettere classiche, vanno ricordati ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’ (Mondadori 2010) dal quale è stato tratto nel 2013 l’omonimo film; ‘Cose che nessuno sa (2011); ‘Ciò che inferno non è’ (2014) con il quale ha vinto il premio speciale del presidente al premio Mondello 2015. Da questo libro l’autore ha tratto un racconto teatrale che porterà in giro per l’Italia.
*
 - Musica
- Musica
Pasqua di Resurrezione
(ricerca etnologica e musicale per una festa)
«Il nostro Dio è nero.
Nero di eterna bellezza,
con grandi labbra voluttuose,
capelli arruffati e scuri occhi liquidi.
Forma d’armonioso aspetto Egli è,
poiché a Sua immagine siam fatti,
il nostro Dio è nero.»
(poesia di E.E.G. Armattoe – Ghana, tratta da Nuova Poesia Negra – Guanda 1961)
Proiettati nella festitità cristiana d’origine ebraica della Santa Pasqua propongo l’ascolto di composizioni musicali estemporanee alla liturgia ufficializzata dalla Chiesa di Roma, ciò nondimeno qui raccolte a testimonianza di un ‘sentire religioso’ quanto mai ‘vivo’ che accomuna molti popoli da un capo all’altro del mondo.
È ormai ampiamente accettato che le diverse popolazioni che trovano nella comunanza cristiana un’autentica fonte di religiosità unificatrice, vogliano testimoniare ‘a proprio modo e nella loro lingua d’origine’ la vocazione spirituale che l’accompagna nella loro esistenza e, in certi casi dove sopravvivere assume una dimensione pressoché ardua, la loro sentita riconoscenza, con l’offerta di canti di lode e inni penitenziali dedicati, desunti dalle loro più aderenti tradizioni popolari in fatto di musica.
Evolutasi sulle stesse direttrici conformi alla realtà cristiano-cattolica e conforme all’utilizzo dei ‘salmi’, oltre ché suddivisa secondo i ‘canoni’ costitutivi della tradizione liturgica che tutti noi conosciamo, la ‘Messa’ di tipo etnico pone all’evidenza un fare musica di alto contenuto spirituale. Quello stesso che in ‘illo tempore’ deve aver forgiato le singole culture di tipo tribale, sia quelle riferite ad esempio alla cultura africana, che quelle presenti nelle difformi aree del bacino mediterraneo; sia quelle originarie di tradizione spagnola, sia quelle trasferite oltreoceano nel folklore latinoamericano. In ognuna delle quali si avverte il confluire di ‘forme’ di acculturazione tardive, verosimilmente diverse che, in qualche modo, hanno trasformato gli individui, considerati fino allora attori casuali di una vicenda ad essi estranea, in protagonisti di una situazione storica che appartiene ‘in primis’ a noi e alla sacralità del tempo. Il vasto processo di ‘cristianizzazione’ avviato per secoli nei confronti di alcune popolazioni erroneamente ritenute ‘pagane’, ha spesso dato vita, in campo musicale, a simbiosi religiose qua e là caratterizzate da influssi linguistici dialettali-gergali destinati all’uso quotidiano delle Missioni attive nelle aree di riferimento.
Le popolazioni del continente nero, qui prese ad esempio, pur vivendo esse in piccoli gruppi isolati e conoscendo poco o niente una lingua scritta, hanno saputo mantenere quell’equilibrio, quasi perfetto, con la natura circostante delle origini, articolando la propria struttura tribale sulle indicazioni fornite loro dagli antenati, che infine gli ha permesso il ‘riconoscimento’ d’una esistenza spesa alla conservazione dei loro idoli ancestrali. Idoli che il culto cristiano ha spazzato via lasciando al loro posto non più che ‘maschere’ svuotate del loro contenuto sapienzale che hanno ereditato. Tutto ciò che rimane dello ‘spirito’ comune delle popolazioni africane, e che vaga da un continente all’altro, da una religione all’altra nella costante ricerca di un ‘dio’, sia esso cristiano o d’appartenenza ad altro credo o ad altra confessione, purché garantisca loro una qualche forma, seppure coatta, di sopravvivenza.
«. . .
Sono di nuovo con me
-
Spriti del vento,
oltre il riparo delle mani degli déi
vanno a nord ed est e ovest,
guidati dall’istinto.
Ma per volere degli déi
Seduto su questa rupe
Li osservo andare e venire
Dall’alba al tramonto, con
lo spirito che urge di dentro …»
(essai da una poesia di Gabriel Okara – Nigeria, tratta da Nuova Poesia Negra – Guanda 1961)
La necessità spirituale della presenza di un ‘dio’ rientra nelle prime necessità dell’essere umano, da cui la credenza nella stregoneria o l’appartenenza religiosa derivano da una stessa radice clericale; poiché entrambe presuppongono la salvaguardia di quell’equilibrio ‘ideale’ che vede il bene opposto al male. Ne deriva che il ‘dio’ africano acquista rilievo e corposità solo se inquadrato nel contesto antropologico-culturale del continente nero, della sua estensione geografica e delle diversità inerenti alle sue popolazioni. Dove gli ‘déi’ primigeni (pagani) mantengono connotazioni proprie: divine e magiche, superstiziose e animistiche. Lì dove il Cristianesimo, pur in mezzo a tanti contrasti e nello scontro in atto di diverse culture, ha finito per innestare una sua ‘verità’ conciliante di pace.
* Quella stessa che è possibile riscontrare nelle forme prevalse nella liturgia cristiana
della ‘Messa’ africana , dove il ‘fatto’ religioso cattolico non annulla, né sovrasta la ritualità ereditata dalla tradizione (pagana). Anzi, è quest’ultima lo sovraccarica di vigore, onde è l’Africa con i suoi strumenti, i suoi ritmi, le sue voci, i suoi battimani e le sue grida che viene in primo piano, regalando all’ascoltatore un ‘evento’ rigoglioso di selvaggio brio. Proprio come in questo ‘African Sanctus’ elaborato da David Fanshawe (CD Philips 1989), ricco di tamburi africani e percussioni rock; registrazioni dal vivo di cori tipicamente africani e mediterranei e ‘voci’ soliste. Nel disco sono presenti brani liturgici come appunto il ‘Sanctus’ elaborato sulla danza Bwala dell’Uganda; il ‘Kyrie’ sulla ‘chiamata alla preghiera’ e il ‘Gloria’ ripreso dalla ‘musica per matrimonio’, di tradizione islamico-egiziana: il ‘Credo dal Sudan; il ‘Crucifixus’ dalla zona equatoriale; uno ‘Chant sul Qui tuum esr regnum’ da una ninna-nanna Masai; e infine l’Agnus Dei’ da una danza di guerra dei beduini del deserto del Sahara.
* Che dire in proposito, ce n’è da fare un riassunto culturale sulla musica africana; tuttavia in questa carrellata di ascolti non può mancare: ‘Missa Kongo’ abbinata in questo disco alla ‘Missa N’Kaandu’ (LP Philips 1970), comunemente cantate durante le funzioni religiose nella regione del Kisanto a Sud di Kinshasa (Zaire), che testimoniano dell’avvenuta interazione musicale zairota con l’esperienza religiosa cristiana. Le due ‘Messe’, decisamente diverse fra loro, utilizzano i toni ritmici degli strumenti tipici e il necessario impeto delle danze tribali, così come dai canti sorti dall’improvvisazione popolare. L’uso prorompente delle percussioni sulle grida spontanee delle donne Biyeki-yeki nella ‘Missa Kongo’ , interrotte da colpi simili a spari d’arma da fuoco tipiche delle popolazioni Bantu, suscitano, verosimilmente, quella sensazione di ‘paura’ ch’è figlia d’ogni avvenimento trascendentale che scaturisce da un fatto magico , o comunque trasgressivo. Apprezzabile inoltre l’intervento di ‘seconde voci’ in alternanza alla voce solista di ispirazione tradizionale liturgica. La ‘Missa N’Kaandu’ a differenza della precedente propone in alcune parti un effetto melodico di maggiore spessore pur non tralasciando la qualità ritmica accattivante. Ciò è dato dal fatto che si richiama alla drammaticità cerimoniale del sentimento cristiano. In special modo nella ‘Prière Universelle’, una sorta di ‘canto piano’ davvero apprezzabile e molto gradevole all’ascolto.
«L’uragano sradica tutto intorno a me
E l’uragano sradica da me fogli e parole inutili.
Vortici di passione sibilano in silenzio.
Sia pace sul turbine secco, sulla fuga delle bufere!
Tu Vento ardente, Vento puro, Vento di bella stagione,
brucia ogni fiore, ogni pensiero vano
Quando ricade la sabbia sulle dune del cuore.
Donna, sospendi il tuo gesto di statua, e voi bimbi,
i vostri giuochi e le vostre risa d’avorio.
Tu, distrugga la tua voce col tuo corpo,
secchi il profumo della tua carne.
La fiamma che illumina la mia notte come una colonna,
come una palma.
Avvampa le mie labbra di sangue, Spirito,
soffia sulle corde della mia ‘kora’.
S’alzi il mio canto, puro come l’oro di Galam.»
(poesia di L. Sédar Senghor – Senegal - tratta da Nuova Poesia Negra – Guanda 1961)
* La ‘Messa a Youndé’, raccoglie documenti sonori del Camerun, detto per questo anche ‘riassunto dell’Africa’, qui si trovano presenti le varie caratteristiche del Continente Nero: islamismo, animismo e cristianesimo professati da oltre 200 gruppi etnici divesi, due lingue ufficiali, il francese e l’inglese, inoltre ai varie dialetti autoctoni. Le forme melodiche praticate sono molto vicine al modo ‘gregoriano’ per quanto riguarda la liturgia cristiana, anche se sul piano melodico e ritmico, va detto, la musica europea mal corrisponde alle rigorose esigenze toniche, per esempio, del dialetto Ewondo, o alla vitalità africana. Diversamente accade per le influenze orientali portate senza dubbio dalle frange mussulmane del Nord di gran lunga superiori di quella cattolico-cristiana, fatto questo che, già negli anni ’60, alcuni studiosi tra folkloristi, sociologi, musicologi del Camerun si sono posti il problema dell’africanizzazione della liturgia cattolica. Ma infine è stato l’Abate Pie-Claudie Ngumu , già maestro di cappella della cattedrale di Notre Dame a Youndé, fondatore della Scuola Cantori della Croce d’Ebano, a passare dalla teoria alla pratica.
Ispirandosi ai testi biblici Padre Ngumu ha scritto quelli che oggi sono detti i ‘Cantici di Ewondo’, utilizzando una delle prinipali lingue vernacolari del Sud, dove è più influente il cattolicesimo, componendo sia la musica in stile africano; sia utilizzando strumenti originali tipici come il ‘balafon’, anche detto ‘omvek’, sorta di xilofono usato per il ‘canto d’Ingresso’ e la ‘lettura dell’Epistola’, entrambi basati su un movimento di danza tradizionale e fonte di vero divertimento dei fedeli. Nel prosieguo, la lettura del ‘Vangelo’ con relativa predica è invece inprontata sul suono dell’arpa ‘mvet’ tipica del Camerun, spesso mimata per una migliore comprensione dei suoi profondi significati. Lo stesso accade durante il ‘Credo’ in cui l’officiante apre una sorta di dialogo con il Coro con la partecipazione dell’intera comunità. Seguono il ‘Kyrie’ e l’ ‘Offertorio’ , durante il quale la Corale, fino allora limitata a seguire i movimenti ritmici dei tamburi e del tam-tam, si snoda in processione attorno allo spiazzo raccogliendo uomini, donne e fanciulli che, al tipico clangore di ‘campane’ di metallo, recano sulla testa le offerte dei prodotti della natura che depongono davanti all’altare per la benedizione rituale.
Successivamente la processione si scioglie e il Coro riprende il suo posto, mentre alcune donne, piegate su se stesse, lanciano l’ ‘oyenga’ (prerogativa delle sole donne), un urlo stridente che nell’esaltazione generale, riveste molti significati esoterici, ma che, all’occorrenza, è un semplice segno di ovazione, ripetuta in sequenza nell’ ‘Alleluia’ e nel ‘Canto finale’ che, come di consueto, appartengono allo schema latino ma che qui accrescono di colore e forza evocativa dal sapore ‘gospel’, con l’intendimento di creare uno stato di ‘ebbrezza mistica’, coreograficamente assai eloquente: contorsioni, spostamenti repentini di lato, palme volte al cielo, uniscono in uno stesso slancio officiante, musicisti e pubblico. Il tutto raccolto in una registrazione dal vivo e prodotto nella collana Universo Folklore (disco Arion 1975).
* ‘Missa Luba’, più volte riproposta da gruppi africani diversi, trova il suo originale nell’esecuzione dei Les Trobadours du roi Baudouin che ne furono i primi interpreti nel lontano 1958 (disco Philips BL 7592). Trattasi di una ‘Messa latina’ basata su ‘native songs’ in puro stile congolese (ex Congo-Belga), costruita su ritmi percussivi e armonie (ninne-nanna, weddings, ecc.) rituali delle regioni Kasai e Kiluba, da cui il nome. Frutto dell’intuizione del missionario belga padre Guido Haazen, fondatore e arrangiatore del Coro formato da 45 bambini tra i 9 e i 14 anni insieme a 15 insegnati del Kamina School che accompagnò in una lunga tournée iniziata nella Sala Nervi nella Città del Vaticano e prosegita nel resto d’Europa. ‘Missa Luba’ è indubbiamente la più rappresentativa di tutta la produzione ‘liturgica’ africana. Un piccolo capolavoro che ben riproduce l’alto livello di interazione raggiunta tra i diversi popoli e le diverse religioni: tradizione-etnica e cristiano-cattolica.
Musicalmente parlando il senso di influenza reciproca è raggiunto nell’eliquilibrio perfetto che tutto sublima in una stessa ‘delle parti’: ‘Kyrie’, ‘Gloria’ e ‘Credo’ infatti, si svolgono secondo l’andatura inalterata dei canti ‘kasala’ della regione Ngandanjika (Kasai) da cui provengono. Mentre il ‘Sanctus’ e il ‘Gloria’ sono costruiti su ‘canti di addio/arrivederci’ tradizionali ‘Kiluba’; mentre ‘Hosanna’ riprende il tempo di danza ritmica propria del Kasai, l’ ‘Agnus Dei’ si basa su un canto popolare di Luluabourg. Va sottolineato che nessuno di questi canti è stato fin’ora trascritto nelle lingue originali, pertanto la bellezza di questa ‘Missa Luba’ sta anche nel fatto che certi ritmi, armonie e abbellimenti scaturiscono dall’improvvisazione spontanea dei suoi componenti. Salutata come «.. il più significativo inno che le generazioni africane abbiano mai elevato al Dio non soltanto e necessariamente cristiano: un prezioso documento storico da sottolineare e da prendere come esempio, che ravviva la forza mistica di cui è dotata la musica sacra.»
Se quelli qui appena toccati possono essere considerati incredibili esempi di religiosità attiva nel mondo; sottolineare quanta strada si è fatta fin qui nel campo della trasmissione e della conoscenza, ciò non di meno possiamo sentirci forti di un sentimento che, per quanto oggi sia fortemente contrastato, pur ci permette di rinnovare la nostra adesione al ‘fatto’ religioso e di viverlo intensamente. Ed è forse proprio grazie alla spinta della ricerca etnologica che possiamo intraprendere la strada della concertazione e di uno stesso ‘modus vivendi’ con le altre culture; con il
recupero di quelle tradizioni popolari che al giorno d’oggi, e malgrado i contrasti inevitabili, non hanno mai smesso di far sentire il loro altissimo ‘grido’, levato in difesa di una unica identità da salvare, la nostra e quella di tutti quei popoli che giustamente riscattano la propria esistenza.
La liturgia cristiana – come abbiamo avuto modo di leggere – prevede l’offerta dei doni della natura durante la Messa, così come prevede anche la suddivisione dei prodotti della natura, trasformati in cibo, ai più bisognosi affinché possano godere della ‘gloria’ di Cristo con lo spirito colmo di quella gioia che nutre la fame. Questo per dire che alla ‘fame’ va corrisposta un’adeguata dose di sostentamento rigenerante per il corpo e per lo spirito. Allora ben venga la Pasqua che dopo i necessari ‘pianti rituali’ di espiazione, si presta a proponimenti di gioia per la festa di ‘Resurrezione’ e di ritorno alla vita. Questo in vero il senso della spiritualità religiosa proprio dello spirito comunitario della Pasqua affermatasi in Spagna agli albori del Medievo e che verrà ripresa solo al tempo dei Re cattolici avvenuta durante il XV secolo, allorquando Santa Romana Chiesa esercitò il suo pieno potere con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come la Santa Inquisizione. Prima quindi che la religiosità popolare si trasformasse nelle tribolazioni edificanti delle Sacre Rappresentazioni a scopo esclusivamente penitenziale e nelle truculente Processioni per Settimana Santa, ed incendiasse i ‘roghi’ contro la stregoneria, i giudei-sefarditi, gli zingari, i diversi e quant’altri che abbiamo appreso ad elencare dalle insanguinate pagine della storia.
Pagine dalle quali abbiamo anche appreso che una tale ferrea disciplina, per quanto dovesse essere accettata forzatamente da tutti, ciò che avvenne nel lungo termine non senza trovare sul suo cammino molti ostacoli di carattere aconfessionale e quindi laico, riscontrò un certo disaccordo con l’allora potere regnante, di quelle frange dei vecchi cristiani che andavano soto il nome di Mozarabi, grazie ai quali già attorno all’Anno Mille dopo l’abolizione del rito da parte di Papa Gregorio VII nell’ XI secolo, avevano conservato la propria lingua ‘mozarabica’, (un continuum dialettale romanzo parlata nella penisola iberica da parte dei Cristiani nell'XI secolo e nel XII secolo), all’interno della loro secolare liturgia in comunione con lòa chiesa cattolica. In verità non poco si deve a quei a quei padri missionari che, giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, compresi i nomadi zingari e zingaro-gitanos, a misurarsi con i canti cristiano-mozarabici durante le nuove funzioni liturgiche imposte loro.
* La celebrazione della ‘Messa Mozarabe’ nell’interpretazione dei cristiani che l’hanno trasmessa, è caratterizzata dal connubio di elementi ispano-gotici ed elementi di origine spagnola. Ciò è dovuto alla sua cristallizazione nel periodo della calata dei Visigoti in Spagna. In ogni caso è ritenuta la liturgia toledana per eccellenza, essendo Toledo all’epoca il centro di magior forza e vitalità della sua diffusione. Ma mentre nella Cattedrale veniva imposto il rito romano, un saggio compromesso permise al rito mozarabico di essere conservato nelle altre chiese. Gli esperti sono tutti d’accordo sul fatto che lo schema della liturgia morarabe è romano, quantunque essa presenti, come tutte le liturgie occidentali, elementi affini a liturgie orientali (bizantine). Alla liturgia Mozarabe è attribuita la più antica versione del ‘Pater Noster’ nell’uso proprio della ‘cantillazione’, una sorta di recitazione quasi intonata (derivata dalla maniera ebraica di cantare testi in prosa della Bibbia), fatta con voce nasale, usata dai cristiani orientali nella lettura dei testi liturgici. Ancor prima quindi della riforma gregoriana, il testo veniva eseguito nelle chiese spagnole durante l’occupazione dei Mori, facendo in modo che questi non ne comprendessero il senso. Una certa eleganza formale proviene da un altro esempio ripreso dall’antifona ‘In pace’ come preludio corale al Salmo successivo:
«Lumen ad revelationem gentium: et gloriam plebis tuae Istrael.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
Quod parastiante faciem omnium populorum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut era in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.»
Quella registrata in questo disco venne eseguita dal Coro del Seminario di Toledo e del Collegio de Infantes diretto da P. Alfonso Frechel con una orchestra di elementi antichi, direttore José Torregrosa. Nota a parte: dopo aver ascoltato, il 15 Ottobre 1963, la ‘Messa Mozarabe’ nella Sala Conciliare del Vaticano II, uno dei cardinali presenti affermò che era il rito più bello che fosse mai stato celebrato nella Basilica di San Pietro.
* La ‘Misa Flamenca’ costituisce una chiave di lettura di particolare interesse etnico e musicologico all’interno della tradizione liturgica Gitano-Andalusa. Si è spesso detto delle possibili influenze indiane, ebree, arabe e bizantine che avrebbero concorso alla formazione del ‘flamenco’ nel suo insieme. Va detto della profonda trasformazione che molti gruppi ‘minoritari’, che subirono o che tentarono di sottrarsi al terrore dell’Inquisizione con la fuga, o anche nascondendosi nelle ‘cuevas’ (sorta di grotte nascoste fra le montagne), avrebbero apportata all’interno della religione cristiana. Fra questi gli Ebrei-sefarditi, mentre altri, come ad esempio i Gitanos, si convertirono al cattolicesimo ormai imperante, allorché migliaia di maestranze giungevano in pellegrinaggio da tutta Europa per lavorare alla costruzione dei grandi santuari di Montserrat, Barcellona, Toledo e di Santiago de Compostela, avviando quella che sarebbe poi diventata la grande tradizione liturgica della cattolica Spagna.
In quell’epoca, la religiosità consolidata sul territorio, successiva ai primi canti sacri improntati sul gregoriano ed entrati in uso durante le grandi festività stabilite dalla Chiesa Cattolica Romana, fecero la loro apparizione i primi ‘villancicos’ cantati per la Natività di Nostro Signore e ricreati sulle popolari ‘canciones de cuna’ (ninne nanne popolari) e, verosimilmente in contrapposizione lineare con questi, si ebbero le ‘lamentazioni funebri’ legate alla celebrazione della Settimana Santa che si officiava un po’ ovunque in tutta la Spagna con grande solennità, a cui partecipavano le masse con tanto di devozione e partecipazione più o meno sentita. Siviglia in quanto considerata epicentro della tradizione araba e moresca nonché gitana e quindi miscredente, si adeguò lentamente e straordinariamente produsse un’alta espressione liturgica, forse la più alta in assoluto con l’espressione conosciuta della ‘saeta’, un canto religioso fortemente espressivo che in seguito venne accolto nel corpus del ‘Cante grande’, e che possiamo definire una ‘specificazione ‘ dell’animo profondo del ‘Cante jondo’.
A sua volta elaborata nelle scuole di Jerez e di Siviglia sulle salmodie corali dei fedeli cattolici nelle processioni liturgiche. Le più antiche e forse le più belle ‘saetas’ rimangono quelle lanciate, anzi scagliate appunto come una saetta, o anche come frecce in onore della Vergine Maria o al Cristo durante il sostare della processione, quando all’interrompersi della banda musicale che l’accompagna, si crea un spazio liturgico espressamente dedicato al ‘Cante’. L’ambiente è dunque quello trecentesco del Medioevo che troverà il suo completamento alla fine del Cinquecento, ‘tempo’ in cui le celebrazioni per la Settimana Santa conobbero il loro apice nelle rappresentazioni della ‘Passione’. Quello qui sotto riportato è un passo ripreso da una ‘cronaca’ più recente che ben ricrea l’ambientazione e lo svolgersi di una processione:
“Nella mattina degli ultimi giorni stazionano nella Cattedrale (di Siviglia), varie Confraternite e Congregazioni recanti in solenne processione i rispettivi e meravigliosi ‘pasos’. Le Confraternite presenti sono in tutto 49 con complessivi 91 ‘pasos’, distribuite nei 6 giorni che compongono la Settimana Santa. I confratelli indossano ampie cappe e alti cappucci a punta con rispettivo stemma (di appartenenza) sulle spalle e sul petto. Impugnano lunghi ceri o pertiche con lo stesso stemma in cime. I gruppi statuari, montati su enormi palchi sorretti a spalla dai fedeli e stupendamente addobbati, rappresentano le vicende dell’agonia e della morte di Cristo, come è narrata nei Vangeli. L’accompagna la Vergine Maria lussuosamente vestita come persona viva, stringente nelle mani il fazzoletto o la corona, il petto trafitto da una o più spade. Il Venerdì mattina è il turno della Cofradia de los Gitanos con due ‘pasos’ entrati nella tradizione popolare.»
‘Pasos’ che Antonio Machado ha incluso in una sua raccolta poetica:
“Oh la saeta, el cantar / al Cristo de los gitanos, / siempre con sangre en las manos, / siempre por desenclavar! / Cantar de la tierra mia, / que echa flores / al Jesùs de la agonia, / y es la fe de mis mayores! / Oh, no eres tù mi cantar! / No puedo cantar, nì quiero / a ese Jesùs del madero, / sino al que anduvo en el mar!”
“Oh la saeta, il cantare / al Cristo dei gitani, / sempre con il sangue nelle mani, / sempre per dischiodare! / Il cantare del popolo andaluso, / che tutte le primavere / va chiedendo scale / per salire alla croce! / Cantare della terra mia, che lancia fiori ( al Gesù dell’agonia, / ed è la fede dei miei padri! / Oh, non eri tu il mio cantare! / Non posso cantare, né lo voglio / a questo Gesù sulla croce / se non a quello che camminò sul mare.”
Manuel Martinez Torner tuttavia non la include nel genere ‘flamenco’ e la considera a parte come di un genere decisamente religioso per la sua caratteristica spirituale tipicamente occidentale. In pieno accordo con quanto riferisce padre Diego da Valencina che fa risalire la ‘saeta’ alla ‘lauda’ francescana, si tratta qui di un autentico ‘grido’ pari a una frecciata che si leva improvviso e quindi inaspettato sopra la processione ad invocare il mistero che la liturgia contiene:
“Vienes de los remotos paises de la pena.
Viene dal remoti paesi della pena.”
Recita con accorato pianto chi effettua il lancio della ‘saeta’, riportando alla mente il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, per quanto non manchino attribuzioni a più antichi riti pagani. Su questo stesso terreno fortemente impregnato di religiosità si è formata nei primi anni ’60 l’idea di una “Misa flamenca” moderna in stile ‘flamenco’ che rispondesse alle esigenze del popolo andaluso. La sua celebrazione, in quanto avvenimento rituale che esprime un ‘mistero’ ha riscaldato gli animi dei Gitanos che infine ne hanno cristianizzato il senso in una performance di intensa drammaticità. La ‘Misa’ trasposta nell’uso interpretativo del ‘flamenco’, in quanto: “..evocazione di un atto storico unico e manifestazione di un fatto che permane nell’eternità al di là dell’umana capacità di comprendere e rappresentare”; trova la sua originalità nell’utilizzo di elementi d’ispirazione gregoriana e reminiscenze della più antica polifonia spagnola, connessi con temi gitano-andalusi, trascritti per l’occasione da solisti impegnati alla chitarra e cori misti. Ma è stato infine il ricorso fatto alla ‘saeta’ che nel momento più alto dell’ ‘eucarestia’ l’ha accesa di interiorità carnale, quasi da ricondurla alla trascendenza pagano-naturalista (e umana) delle origini.
“Non è stato facile adattare la Messa in spagnolo alla metrica fisica del canto flamenco – scrive Antonio Mairena co-autore di questa suggestiva ‘Misa Flamenca – in quell’occasione: non v’è espressione drammatica più graffiante della seguiriya; non c’è alcun cantico che eguagli la serenità della malagueña; né alcuna spiritualità potrà mai essere comparata a quella della soleà. In questo lavoro di trasposizione della prosa in versi, noi abbiamo cercato di rispettare alla lettera le parole sacre. Il rimanente è venuto da solo e molto è dovuto all’esperienza e alla tradizione del Cante.”
Non è un caso che all’interno della ‘Misa flamenca’ ritroviamo alcuni dei canti che hanno dato forma al corpus del ‘Cante gitano-andaluso’. Ma è ancora e soprattutto la struttura austera e ieratica del ‘Cante jondo’ a sovrastare l’intera partitura della ‘Misa’ pur rispettando l’ordine della sequenza ufficiale: Introito, Gloria, Kirye, Credo, Sanctus, Agnus Dei. In quanto frutto di un’autentica espressione artistico-musicale la ‘Misa flamenca’ trova la sua affermazione nell’ambito della moderna religiosa spagnola la cui salda continuità l’ha accolta nella tradizione, in quanto sintesi di una perfetta fusione del fatto religioso con la tensione drammatica espressiva del ‘Cante’. Esattamente così come l’hanno vissuta i suoi esecutori in prima persona e tutti coloro che assisterono al suo rito, registrata dal vivo il 29 Giugno 1968 nella Chiesa del Barrio ‘A’ del poligono di San Paolo a Siviglia. (presente su disco Philips 843.126 sul lato opposto alla Misa Mozarabe’):
«La piazzetta di Santa Ana era il cuore del flamenco di Triana. Giungeva fin lì il suono metallico del martello sopra l’incudine, e si univa al rintocco della campana che chiamava al tempio. Un gitano, Manuel Cagancho, creò al ritmo di questo suono un canto per seguiryas che ora figura nella Misa Flamenca. Nella preghiera e supplica del Kirye, l’eco profondo della malaguena imprime la sua andatura con reminescenze del canto gregoriano. Il Gloria, cantico di esaltazione e allegria per la presenza di Dio sulla terra, si fa solenne e rispettoso sull’eco del romance gitano. L’andatura grave nel lamento della petenera serve a introdurre il Credo, mentre per il Sanctus è usata la soleà; l’accordo della chitarra introduce la tonà, la debla e il martinete che si fanno preghiera. L’unione sublime del Padre Nostro con il sangue e la carne del Figlio di Dio medesimo nell’atto solenne dell’Agnus Dei è invece affidato alla seguirya gitana nello stile più puro del Cante jondo: ..se ha puesto de rodillas y vibra y reza canta y llora.»
L’eco profondo della malaguena tradizionale è qui trasposta nella forma del ‘Kyrie ‘sulla reminiscenza del canto gregoriano:
«Dime donde ba allegar. / Este querce tuyo y mio. / Dime donde ba allegar. (..) / Yo cada dia te quiero mas. / Que Dios me mande la muerte.»
“Dimmi dove ci porterà. / Questo amore tuo e mio. / Dimmi dove ci porterà. (..) / Mentre io t’amo ogni giorno di più. / Spero che Dio mi mandi la morte.”
Un tema, questo della morte, che ritorna spesso nella letteratura e nella canzone ispirata dei Gitanos, ma qui siamo di fronte a un fatto musicale che esula dalla semplice operazione colta sul folklore che possiamo facilmente abbinare all’impatto della tradizione spagnola come espressione singolare dei Gitanos che ha fatto del ‘flamenco’ e in particolare della ‘Misa’ un momento trainante e accomunante che si è poi imposto sulle diverse culture presenti sul territorio in quanto punto ideale delle diverse culture indiana, ebraica, araba e bizantina ma soprattutto cristiana, qui confluite come per un ‘encuentro’ ormai avvenuto con il popolo gitano-andaluso e il resto del mondo.
* Composta da Ariel Ramirez negli anni che vanno dal ‘50 al ‘63 come un’opera per solisti, coro e orchestra accompagnati da strumenti tipici delle popolazioni latino-americane, la ‘Misa Criolla’ denota con estrema originalità una simbiosi di intenti musicali diversi, realizzati grazie alla perfetta combinazione di temi religiosi ed elementi folkloristici ripresi da ritmi e forme musicali proprie della sua terra di appartenenza: l’Argentina. Forme che riprendono musicalità proprie molte popolari, come ad esempio il ‘carnavalito’, qui utilizzato come forma di esaltazione del fatto liturgico. La ‘Misa’ è a tutti gli effetti una Messa cristiana come la interpretiamo oggi, seppure con inserimenti popolari legati alla tradizione ispano-americana in cui Ariel Ramirez ha saputo conciliare il fervore religioso con l’elemento folklorico dando ad ogni sequenza della messa un elemento di originalità: Il ‘Kyrie’ apre la messa con i ritmi della vidala e della baguala, due forme espressive rappresentative della musica tradizionale creola argentina; il ‘Gloria’ è accompagnato dalla danza argentina del carnavalito, segnato dalle note del charango; il ‘Credo’ invece, è scandito dal ritmo andino della chacarera trunca; il Carnaval de Cochahamba, tipico della tradizione boliviana, fa da contorno al ‘Sanctus’, mentre infine, l’ ‘Agnus Dei’ conclude la messa sullo stile strumentale usato della Pampa argentina.
Bella e gradevole all’ascolto la ‘Misa Criolla’ raccoglie in se il pacato ‘spirito del tempo’ che si aggira sulle Ande. Uno ‘spirito’ stranamente dimesso, quasi sussurrato, che potremmo attribuire al vento, se non fosse che è proprio quest’ultimo a trasportarlo attraverso la Cordigliera che attraversa tutta l’America Latina fino agli estremi della Patagonia.
Quello stesso ‘spirito’ che fa vibrare le corde degli strumenti e ottunde le pelli delle percussioni, così come risveglia i semi contenuti nelle zucche sonore utilizzate per i ritmi-a-ballo durante le numerose feste che si tengono un po’ ovunque, dai piccoli pueblo arrampicati sugli altipiani alle ciudad delle vallate, ai villaggi dei pescatori che coronano le coste. Per quanto, tuttavia, è uno ‘spirito’ allegro, espressione di forme musicali puramente folkloriche caratterizzate dalla presenza di strumenti e ritmi tipici della tradizione popolare latino-americana che s’intrecciano con i temi della tradizionale messa religiosa.
Racconto sulla nascita di "Misa Crolla" di Ariel Ramirez – 1964.
«Nel 1950 presi una nave che, dal porto di Buenos Aires mi avrebbe portato nel continente europeo. Genova fu il luogo in cui, per la prima volta, posi i piedi su quelle terre. Il mio proposito era quello di lasciare un messaggio sulla nostra musica per mezzo del mio piano e aspiravo a porre al centro di quella illusione la città di Parigi. Però un invito da parte di un amico di infanzia, Fernando Birri, mi deviò a Roma nell’ottobre dello stesso anno. Da qui iniziò una serie interminabile di avventure con diversi pianoforti… diversi nuovi amici ed un’infinità di nuovo pubblico. Nei quattro anni in cui restai a quelle latitudini il mio domicilio fu Via della Lungara 229, nel cuore trasteverino di Roma.In quel periodo, con la mia musica, percorsi in lungo e in largo l'Italia, l'Austria, la Svizzera, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, ecc. in un costante andare e venire, che mi riportava comunque e sempre a Roma. In dignitosa povertà alloggiavo in alberghetti, collegi religiosi, conventi, ospedali, case di amici, Università, dove cento mani cattoliche si tendevano per aiutarmi.
Dal secondo anno in avanti il mio lavoro cominciò ad avere una certa continuità ed il numero di città interessate a conoscere la mia musica si ampliò notevolmente. Ripetutamente tornai in molte di queste città come Londra, dove stipulai contratti con la BBC, interessata affinché un mio programma radiofonico si diffondesse nel Latinoamerica. Alla stessa maniera stipulai contratti con Università come quella di Cambridge, di Utrech, di Delf, di Santander oltra a società concertistiche e di teatro. A poco a poco stavo convertendomi a questo mondo che lentamente si andava ricostruendo dopo la guerra. Tutti i miei profitti furono resi possibili grazie all'aiuto ricevuto da esseri umani straordinari che contribuirono non solo alla mia formazione culturale, ma anche alla mia crescita spirituale. Sapevo di dover trovare una forma di ringraziamento per tutto questo.
Un giorno del 1954, più o meno nel mese di maggio, a Liverpool, non potei resistere alla tentazione di prendere un’altra nave: la Highland Chefstein, questa volta diretto a Buenos Aires dove mi attendeva mia figlia di cinque anni ed i miei genitori che superavano la settantina. Ero convinto che in due mesi sarei tornato nei luoghi dove avevo deciso di stabilirmi per sempre, però il destino mi avrebbe riservato tutto un altro percorso. Su quella nave che attraversava l'atlantico verso il sud, non potei fare a meno di ricordare tutta la solidarietà umana, tutto l,amore che avevo ricevuto da parte di persone sconosciute con cui potevo appena comunicare per l,ignoranza reciproca della lingua. Mi commuoveva il pensare che quello che avevo ricevuto era esclusivamente dovuto all,amore di queste persone per la mia musica e per la mia persona, finché compresi che l'unico modo che avevo per ricambiare quelle persone era quello di scrivere in omaggio a loro un opera religiosa. Però non sapevo in alcun modo come realizzarla.
All'arrivo in Argentina tutto mutò nella mia vita: la mia carriera si andava affermando e le mie canzoni a diventare molto popolari; con il tempo l'Europa si allontanò, però il mio pensiero continuava ad essere concentrato su quell'idea sorta in mezzo all'Atlantico. A questo scopo cominciai a cercare e raccogliere informazioni e fu così che, in prima istanza, conobbi Padre Mayol, che mi passò una serie di poemi di carattere religioso di un religioso del Nord dell’Argentina perché li musicassi. In seguito incontrai Padre Antonio Osvaldo Catena, mio amico di gioventù a Santa Fe, la mia città natale. Padre Catena contribuiì realmente a trasformare il mio iniziale proposito, una canzone religiosa, in un idea che aveva dell'incredibile: la realizzazione di una messa con ritmi e forme musicali della nostra terra. Padre Catena, nel 1963, era Presidente della Comisión Episcopal Para Sudamérica, incaricata di realizzare in spagnolo la traduzione del testo latino della messa, secondo le direttive del Concilio Vaticano del 1963 presieduto da SS Paolo VI.
Quando ebbi terminato i bozzetti e le forme dello spartito della messa, lo stesso Catena mi presento a chi, con straordinaria erudizione avrebbe realizzato gli arrangiamenti corali dell'opera: Padre Jesú Gabriel Segade. Quest'anno, insieme, abbiamo celebrato, i 30 anni di Misa Crolla: tre decadi di amicizia. Questo è il racconto della nascita della Misa Crolla. Quando la sua composizione fu conclusa ci sentimmo di dedicarla ad otto amici, i cui nomi rappresentano in qualche maniera tutta la serie di care persone che mi avevano aiutato generosamente durante quegli anni cruciali della mia gioventù. Queste persone sono: Padre Avelino Antuńa (Argentina), Hnas, Elisabeth e Regina Bruckner (Germania), Ruth Hope (Germania), Herbert Koch (Germania), Maya Hoojvel (Olanda), Padre Wenceslao Van Lui (Olanda), Mauricio Sillivan (EE.UU.)
Un'opera musicale richiede - per essere conosciuta - una trasposizione concreta. Con questo sentimento noi possiamo già dare la giusta dimensione al nome del Direttore della Philips, Massimo Wijngaard colui che rese concretizzò il mio suono e contribuì alla sua realizzazione con un entusiasmo fuori dal comune, una volta superato il suo più forte interrogativo: "Maestro, chi comprerà mai una Misa Criolla?" (n.d.r. di quella Misa Criolla furono vendute 12 milioni di copie).»
Nello spito della lingua latino-americana utilizzata nella ‘sequenza’ della ‘Misa’ mi piace qui chiudere con un testo in ‘lengua’ del poeta spagnolo Pedro Salinas:
«Los cielos son iguales.
Azules, grises, negros,
Se repiten encima
del naranjo o la piedra:
nos acerca mirarlos.
Las estrellas suprimen,
de lejanas que son,
las distancia del mundo.
Si queremos juntarnos,
nunca mires delante:
todo lleno de abismos,
de fechas y de leguas.
Déjate bien flotar
sobre el mar o la hierba,
inmóvil, cara al cielo.
Te sentirás hundir
despacio, hacia lo alto,
en la vida del aire.
Y nos encontraremos
sobre las diferencias
invencibles, arenas,
rocas, años, ya solos,
nadadores celestes,
naufragos de los cielos.
(poesia tratta dalla raccolta ‘La voce a te dovuta’ – Einaudi 1979).
BUONA PASQUA a Tutti Voi.
*
 - Antropologia
- Antropologia
Maschere Rituali / 3
Folkoncerto: Maschere Rituali.
(Ricerca filologica e musicale di Giorgio Mancinelli dal programma radiofonico RAI Radio3 del 1984).
Richiamo qui l’attenzione su una importante ‘mostra’ realizzata nel lontano 1980 dal titolo “Oggetti e Ritmi: Strumenti Musicali dell’Africa” (Catalogo DE Luca) dalla Soprintendenza speciale al Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini a Roma, in cui erano messe a fuoco alcune peculiarità degli strumenti utilizzati dai popoli africani nei riti religiosi e nelle manifestazioni a carattere sociale all’interno delle singole realtà tribali. Il gruppo di ‘strumenti-oggetti’, più conosciuti o meno, sui quali si richiamava l’attenzione, e che documentavano un aspetto strettamente legato a espressioni della musica e della danza fermamente compiuti nella loro essenzialità, in quanto ‘capolavori’ della raffinata arte della creatività popolare, pur nell’accezione antica artigianale di questo termine.
Per questo motivo i realizzatori della mostra avevano voluto che la musica fosse immediatamente fruibile, sia come esegesi compiuta di ogni singolo strumento, sia come risultanza d’insieme che vivificasse l’impressione visiva. In modo tale che oltre alla forza visiva degli oggetti potesse scaturirne l’alto valore musicale, non meno importante, che permettesse, nella conoscenza delle culture etnologiche, un modo di intendere meglio alcuni aspetti delle diverse culture, alcune delle quali, va qui ricordato, hanno origini preistoriche. La scelta era stata stimolata principalmente da due motivi: dalla cospicua raccolta di strumenti musicali in possesso del Museo, di alto valore qualitativo, e dalla importanza che lo strumento musicale riveste in tutte le culture a livello etnologico, e particolarmente in Africa dove era diffuso largamente sotto varie specie, a seconda del tipo di cultura dei diversi popoli.
La mostra inoltre, presentava una buona esemplicazione tipologica e puntualizzata sulle diverse aree di raccolta e di sviluppo delle varie classi di strumenti, come si è detto quasi sempre connessi con la danza, perché i suoni e la musica erano un mezzo per comunicare e per esprimere, un elemento indispensabile per vivere comunitario come l’aria e il cibo. Infatti la danza accompagnava ogni tappa del ciclo della vita individuale: la nascita, l’imposizione del nome, le iniziazioni puberali, il fidanzamento, il matrimonio, così come la battuta di caccia, la guerra e la morte. Così come ogni danza era accompagnata dalla musica, anche il canto, spesso corale, era associato alla narrazione di fiabe e leggende e alla ‘poesia’ relazionale, per lo più individuale indirizzata all’amore e agli affetti del focolare domestico. Acciò voglio qui leggere insieme a voi una leggenda raccolta presso il popolo Wala o Wla del Ghana, in cui si narra dei Tamburi-parlanti:
‘LA SCOPERTA DEI TAMBURI PARLANTI’
Essai da “Leggende della Madre Africa” a cura di Roger D. Abrahams – Arcana Editore 1987.
«Ecco qua una storia!
Il miglior amico della gallina faraona era lo sparviero. Il nome dello sparviero era Setu, o Risata, mentre la gallina era chiamata Nmengu (a quel tempo gli animali avevano ciascuno il suo nome, come noi). Ma qualche cosa avvenne fra i due. Lo sparviero decise di costruire per loro dei tamburi parlanti, per poter danzare il ‘dogho’, e la faraona accettò di aiutarlo. Andarono nella boscaglia e tagliarono una grande quercia. Quindi fecero i tamburi e li misero ad essiccare al sole.
La faraona chiese allo sparviero di sorvegliarli. Ma lo sparviero aveva fame e voleva andarsene – una distanza come fra qui e Danko – voleva andare a mangiare e poi tornare. E disse alla faraona: “Quando i tamburi saranno asciugati, tu non batterli finché non sarò di ritorno. Se batti i tamburi prima del mio ritorno, finiremo per litigare.” La faraona disse: “Benissimo!”. Lo sparviero andò a Danko e trovò cibo da mangiare. I tamburi asciugarono. La faraona andò a ispezionarli per vedere se erano asciutti. E colpì i tamburi, e batté i tamburi “gben-gben-gben”. Quel suono le piaceva. E così cominciò davvero a battere di gusto e il suono era molto bello:
Setu, Setu, Setu, Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Dzaan, dzaan, dzaan
Dzaan, dzaan, dzaan
Lo sparviero era a Danko, quando sentì il suono dei tamburi ne fu molto dispiaciuto e volò molto alto per tornare. La faraona continuava a suonare, non sapendo che più lei suonava, più lo sparviero si infuriava. Continuò a battere i tamburi e cantò tre volte:
Setu, Setu, Setu, Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Dzaan, dzaan, dzaan
Dzaan, dzaan, dzaan
Lo sparviero volava velocissimo per raggiungere la faraona che a sua volta pensava che lo sparviero fosse contento di ascoltare il suono dei tamburi parlanti, e così suonò di nuovo i tamburi:
Setu, Setu, Setu, Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Setu yee Setu
Dzaan, dzaan, dzaan
Dzaan, dzaan, dzaan
Lo sparviero si precipitò a capofitto per staccare la testa della faraona dal collo. Quando vide arrivare lo sparviero, la faraona cominciò a correre, “pi, pi, pi”. Ecco come finì l’amicizia fra lo sparviero e la faraona, che anche oggi sono nemici, Né la faraona né lo sparviero presero i tamburi parlanti. Ma li presero gli abitanti del villaggio che da quel giorno li usarono per danzare il ‘dogho’.»
Scrive Eugenio Trìas in “Il canto delle sirene”(Tropea Edit. 2009):
«La musica non è soltanto un fenomeno estetico, (e forse non lo è mai stato fino alla nascita della sinfonia), né si riduce a una delle forme di quel sistema delle ‘belle arti’ che si è costituito a metà del Diciottesimo secolo: la musica è una forma di gnosi sensoriale, è conoscenza sensibile, emozionale, capace di offrire salvezza. La musica è ‘conoscenza salvifica’ – in questo coincide con il significato originario di gnosis – e per questa ragione è in grado di produrre effetti determinati sulla nostra natura e sul nostro destino.»
Ecco, la musica africana rientra perfettamente in questa cornice ‘mistico-sensoriale’ che è all’origine dei tempi, ed influisce su tutti gli aspetti della vita anche in coloro che si professano avulsi dall’ascoltare qualsiasi tipo di musica, o di quanti professano una sola religione per la musica sinfonica. Premetto che vi sono esempi straordinari di musica ‘non scritta’ che potrebbero meravigliare anche l’orecchio più sofisticato, basta trovare il tempo e avere l’occasione di ascoltarla. Gli esempi potrebbero non finire mai e non solo nella musica etnica occidentale, quanto anche in quella orientale e non in ultima quella africana. È così che sulla scia de “Il canto delle sirene” di Eugenio Trìas, riscopriamo come «‘in principio era il suono’, un’appassionata e vibrante ricerca filosofica che si immerge nella musica come fenomeno originario per riconoscere, attraverso la sua storia e le sue vette toccate dai grandi compositori che l’hanno scritta nel tempo, la sua pulsazione più autentica.»
È questo il pensare la musica come pensiero dell’origine – scrive ancora Trìas: «..La potenza allusiva, la sua capacità di suggerire la via d’accesso a un ordine nascosto, che sa mettere fra parentesi il piano illusorio della rappresentazione, diventa essenziale per entrare nel mondo della volontà, per farne propria la pulsazione più intima e nascosta, in una contrapposizione metafisica fra il mondo della rappresentazione (illusionistica) e del visibile (oggettivo), che si contrappone alla dimensione elusiva dell’udire.» Esattamente ciò che andavo cercando per affermare il concetto evoluzionistico intrinseco della musica africana, che dalla originaria e intimistica forma iniziale ha trovato la strada per imporsi a livello comunitario all’interno del proprio gruppo di appartenenza, assumendo aspetti cerimoniali e fattezze divinatorie.
Al pari della ‘poesia’ ciò rispecchia in pieno la vocazione ‘inconscia’ dei popoli africani in grado di articolare la realtà come una gigantesca azione coreutica nella danza e, allo stesso tempo corale nella ‘poesia’ e nella narrativa di tradizione orale. Ma la prevalenza dell’una o dell’altra attitudine non reca danno al mezzo espressivo. Anche il più modesto artefice della poesia africana esemplifica da un punto di vista analitico le condizioni di un mondo particolare, molto diverso dal nostro, non per questo ‘inferiore’ come si è spesso tentato di etichettare. Alla stregua di molti poeti di lingua, i poeti africani rappresntano un fenomeno singolare, soprattutto il loro fare ‘poesia’ non segue l’analogo svolgimento della cultura occidentale, ma germina dal patos stesso dell’esistenza.
Già secondo Jean Paul Sartre, il poeta africano era il simbolico custode di un linguaggio universale e la sua ricettività cosmica ai ritmi esprimeva la voce primordiale della poesia. Soggettivo, questo giudizio che spiegava la ‘negritudine’ come un segno distintivo non del colore della pelle, ma dello spirito africano, la cui liricità si articolava, come creazione polimorfa di cui era (ed è) automatico fermento. ‘Negritudine’ quindi come insieme dei valori propri della tradizione culturale nera nelle sue diverse affermazioni ed espressioni che lo studioso francese aveva a suo tempo espresso nella prefazione alla ‘Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache’ (1948), nel cercare di analizzare l’essenza della spiritualità dei ‘neri’, in particolare rivelandone i caratteri di originalità e di rivendicazione della propria dignità e del proprio valore, in confronto alla civiltà e alla tradizione dei ‘bianchi’.
Il concetto di ‘negritudine’ una volta entrato nell’uso comune come movimento filosofico, culturale, letterario e ideologico del mondo nero francofono, esaltava l’unicità e l’essenza della natura e spiritualità africane (o negre) rivendicandone il valore intrinseco della cultura e delle tradizioni autoctone, con senso di fierezza, come ‘proprio originale patrimonio spirituale’ delle popolazioni africane. Purtroppo al termine ‘negritudine’ corrispondeva più spesso il rifiuto della politica di ‘assimilazione’ perseguita, almeno sino al 1956, dai rispettivi governi occidentali. Ciò, malgrado numerosi poeti, letterati e pensatori africani, fra i quali: L. S. Senghor ex presidente del Senegal, A. Césaire, David Diop, Cheik Anta Diop, principalmente raggruppati intorno alla rivista Présence africaine (fondata a Parigi nel 1947 da Alioune Diop), recarono propri contributi positivistici all’analisi della negritudine.
Di Birago Diop “Respiri”:
«Ascolta più sovente
le cose che gli esseri.
La voce del fuoco s’intende.
Intendi la voce dell’acqua,
ascolta nel vento
il cespuglio e i singulti.
È il respiro degli antenati …
Coloro che sono morti non sono mai partiti,
sono nell’ombra che si rischiara
e nell’ombra che s’addensa,
i morti non sono sotto la terra:
sono nell’albero che freme,
sono nel bosco che geme.
Sono nell’acqua che scorre,
sono nell’acqua che dorme,
sono negli antri sono nella folla:
i morti non sono morti.
Ascolta più sovente
le cose che gli esseri.
La voce del fuoco s’intende,
intendi la voce dell’acqua,
ascolta nel vento
il cespuglio in singulti.
È il respiro degli antenati,
il respiro degli antenati morti,
che non sono partiti,
che non sono sotto la terra,
che non sono morti.
Coloro che sono morti non sono mai partiti,
sono nel grembo della donna,
sono nel bimbo che vagisce
e nel tizzone che s’infiamma.
I morti non sono sotto la terra,
sono nel fuoco che si spegne,
sono nell’erba che piange,
sono nella roccia che geme,
sono nella foresta, sono nella dimora:
I morti non sono mai morti.»
Inoltre a ripetere le sembianze degli ‘antenati’ i soggetti più frequentemente raffigurati nelle ‘maschere rituali’ sono gli elementi della natura floreale e faunistica come appunto fiori e alberi, animali stilizzati e simboli astrali per entrare nel vivo di quel ‘mondo naturalistico-magico’ che più spesso rappresenta la volontà di sentirsi/farsi parte del proprio habitat ed anche dell’universo con transizioni difficilmente classificabili. Nell’immaginifico rituale il nativo africano ama diversificare il suo stato in modo da non essere riconosciuto dagli spiriti maligni, vuoi per motivi di iniziazione, vuoi per l’appartenenza a società segrete ecc.; o anche per il semplice piacere del gioco di cambiare se stesso sul filo della fantasia, con un senso di compiacimento estetico che spesso ha dato luogo a veri e propri ‘travestimenti’ facendo uso abbondante di ‘maschere cosmetiche’ pari ad altrettante originali opere pittoriche.
Di Léopold Sédar Senghor “Donna Nera”:
«Donna nuda, donna nera!
Vestita del tuo colore che è vita, della tua forma che è beltà!
Crebbi alla tua ombra, la dolcezza delle tue mani blandiva i miei occhi.
Ed ecco che nel cuore dell’estate e del meriggio ti scopro
terra promessa dall’alto d’un alto colle calcinato.
E la tua beltà mi folgora in pieno cuore come il fulmine l’aquila.
Donna nuda, donna scura!
Frutto maturo della carne soda, altre estasi del vino nero,
bocca che rendi lirica la mia bocca.
Savana dai puri orizzonti, savana che fremi alle carezze ferventi del
Vento dell’est.
Tam-tam scolpito, tam-tam teso che risuoni sotto le dita del Vincitore
La tua voce grave di contralto è il canto spirituale dell’Amata.
Donna nuda, donna scura!
Olio che nessun vento increspa, olio calmo dai fianchi d’atleta,
dai fianchi dei principi del Mali
Gazzella dalle giunture celesti, le perle sono stelle sulla notte della
tua epidermide.
Delizie di giuochi dello spirito, i riflessi dell’oro rosso
sulla tua pelle marezzante.
All’ombra dei tuoi capelli, si rischiara la mia angoscia
al vicino brillare dei tuoi occhi.
«Donna nuda, donna nera!
Io canto la tua beltà che passa, forma che fisso nell’eterno
Prima che il destino geloso non ti riduca in cenere per
nutrire le radici della vita.»
In tutto il mondo il desiderio istintivo di mascherarsi sembrerebbe nato spontaneamente nei diversi popoli, ma per nessuno di essi le ‘maschere rituali’ hanno raggiunto una concentrazione, una icasticità, una espressività così profonde sul piano estetico come nei ‘primitivi’ africani, fra i quali inoltre ha mantenuto la sua preminenza di oggetto di culto, di riverenza e di timore. Al tempo stesso depositaria della capacità di metamorfosi e autosuggestione cui è soggetto colui che la indossa e al quale la ‘maschera’ trsasmette la virtù segreta che custodisce. Ma come si è detto la maschera può essere anche il semplice ornaramento cosmetico a cui si sottopone il soggetto, diverso dal tatuaggio che prevede l’intervento di tipo chirurgico sulla pelle e quindi di tipo durevole se non definitivo.
Il dipingersi la pelle con cosmesi ricavate da materie naturali è molto meno impegnativo del tatuaggio e viene diffusamente usato per il trucco del viso e in alcune parti del corpo con tinte semplici che vanno dal bianco, al rosso e al nero; che però si complica in figurazioni diversissime nella cosmesi dell’intero corpo che prevede l’utilizzo di terre o cortecce bruciate degli alberi. I materiali usati sono costituiti per lo più da pigmenti minerali impastati dopo fine macinazione con lacche adesive e olio di palma o di semi oleosi o di termiti. La decorazione viene eseguita su disegno preventivamente delineato sulle zone interessate, oppure in modo estemporaneo, di getto da ‘artisti’ che hanno appreso questo tipo di arte, oggi per l’appunto definita ‘body-art’.
La pittura del corpo ormai compresa nei trattati di etnologia dell’abbigliamento viene fissata direttamente sul corpo, mentre altre volte invece è ‘miniata’, cioè eseguita con aggiunta di pietruzze colorate macinate, o vetrini e conchiglie, e occupa solo parti di superficie epidermica. Questa è praticata solo da alcune tribù e solo in occasioni speciali. In alcuni casi è riservata a capi e sacerdoti con effetto simbolico-distintivo, in altri solo alle divinità e agli sciamani con effetto totemico.
Di grande effetto coreografico per il magnifico costume di piume colorate e che raggiunge nel corpicapo un’eleganza davvero ricercata è la maschera detta di ‘Ouénilégagui’ più conosciuto come ‘uomo uccello’ presso i Bobo dell’Alto Volta. Colui che la indossa si dipinge le parti che rimangono scoperte come il viso e gli arti di bianco a rappresentare lo spirito ammonitore. Ciò accade solo in occasione della morte di un alto dignitario tribale o di un sacerdote addetto al culto. La sua danza è accompagnata dal rullare ininterrotto di un piccolo tamburo battuto con una stecca da entrambi i lati. Nel mentre il ‘tam-tam’ annuncia l’inizio del rito alla comunità, il suo ritmo indica ai danzatori le figure da eseguire nella danza. Sul finire di questa l’uomo-uccello, avanzando con passo cadenzato, indica la via al feretro attraverso la foresta, quindi scompare.
Di Roland T. Dempster “Rullano i Tam-tam” – Liberia
«Odo, odo i tam-tam
D’Africa ridestare le giungle
Rullano lontano, recandomi il saluto
Di nuove regioni e regni.
Rullano i tam-tam
Rullano nelle giungle d’Africa
Riccche d’oro e di diamanti
Di coccodrilli nei laghi
Di liberi leopardi e serpenti
E abitanti delle foreste armati di frecce
Che rapide colpiscono la preda.
Delicate carezzevoli melodie
Dalle selvagge giungle d’Africa
Venite , venite gentili, blande al mio orecchio
Tenere nine-nanne che destate alla vita.
Tam-tam, rullano i tam-tam
Scuotendo dal sonno i figli d’Africa
Affinché vedano la natura meravigliosa
Che hanno ricevuta in dono.»
Ma già il suono arcano del tam-tam dice che è tempo di porci in ascolto dei ritmi talvolta sfrenati dei tamburi per la danza, o addormentarci sulle dolcissime note delle cantilene per flauti di canna che arrivano dal Cameroun dove le maschere sono altrettanto numerose, anche se ancora molte se ne trovano in Gabon, in Benin e in Congo; altresì in Malì da dove provengono le famosissime maschere Dogon, ma ci vorrebbe un capitolo a parte e uno maggiore spazio per descriverle tutte. Nell’impossibilità di proseguire, vengo a dire che le maschere sono spesso conservate in luoghi sicuri e protetti se non addirittura segreti. Quando sopravviene la morte del possessore di una maschera, questa passa a un suo erede oppure al diretto successore per via patriarcale nell’ambito della stessa tribù o a un membro della società segreta d’appartenenza. L’invecchiamento conferisce alla maschera un valore aggiunto dato dalla maggiore forza sacrale proveniente dalle generazioni che l’hanno posseduta e che le hanno trasmesse le loro migliori qualità.
Gelosamente tenute nascoste agli sguardi degli iniziandi le maschere in quanto oggetti di culto vengono nutrite come esserei viventi e ricevono offerte da parte della tribù fra cui molto frequente è l’aspersione con sangue animale ed anche, in caso di guerra, con quello dei nemici. Il legame ‘magico’ che intercorre tra la ‘maschera’ e la tribù di appartenenza va ricercato nei legami uomo-divinità proprie delle ‘società segrete’ che hanno imposto alla maschera la sua funzione primaria costituita all’origine della loro realtà tribale. Così come, nell’identificazione con le forze divine o demoniache, quegli spiriti degli antenati attraverso i quali l’uomo è entrato in contatto, per purificarsi e trarre profitto dalla loro ‘esemplare’ saggezza mitica.
Ancora dalla liberia ascoltiamo/leggiamo insieme questa breve “Canzone delle foglie di bambù” di Bai T. Moore:
«Che cosa esprime questo dolce canto nel vento
Delle piccole foglie di bamb§?
È un dolce canto che soltanto le foglie possono cantare
Le piccole foglie di bambù.»
*
 - Teatro
- Teatro
La tradizione in Italia - Maschere popolari
(Ricerca filologica di Giorgio Mancinelli tratto da ’Cantarballando’ un programma radiofonico RAI Radio3 del 1982).
Storie di Cantastorie: la battaglia.
La tradizione più antica in Italia è indubbiamente quella cavalleresca che rivive nei testi degli spettacoli dei Burattini e del Teatro dei Pupi, nei dipinti dei carretti e nella recitazione dei poemi medievali, rappresentati in questi luoghi o sulla pubblica piazza dove il Cantastorie, seduto in mezzo a un cerchio di vecchi e bambini, gesticola con in mano una spada di legno e racconta le interminabili avventure o disavventure di questo o quell’eroe del tempo passato.
Ma anche di altri relativamente più vicini a noi, come ad esempio le guerre di Carlo Magno, le cruente battaglie contro gli infedeli, le storie di Rolando e di Ruggero, di Astolfo sulla Luna ecc. che ha imparato a memoria e che sono, in parte, basate su poemi dell’Ariosto, del Boiardo, del Tassoni e molte di riferimento religioso desunte dalla Bibbia e dai Vangeli, e dalla vita di santi.
Tutti, ma davvero tutti, attendono però con impazienza le scene di battaglia, nelle quali il Cantastorie, il viso distorto dalla furia del combattimento, taglia l’aria con la spada e spezza le parole in modo da accrescere l’interesse dello spettatore. Nella scena qui presentata molto nota in Sicilia, ripresa dal Teatro dei Pupi, il Conte Gano, il fellone, sfida e combatte Rinaldo:
«Ma se tu vuoi fare la pace, io sono pronto, / ma se tu vuoi il mio sangue, sangue avrai. / perché tu ben sai che Fusberta (spada) / non ha mai avuto paura del taglio di / Durlindana (spada). / Quindi disse : Se vuoi venire a paragone / delle armi / e vuoi vendicare zio Carlo e quel patrigno / il Conte Cane di Magonza, prenditi la distanza / disse / chew son pronto ad affrontarti. / Come Carlo di Magonza vede Orlando / digrignare i denti / e lo bestemmia la sua sorte appellandolo / traditore vigliacco / e come si prende la distanza / lo stesso fece lo Conte Rinaldo. / Ma quando fussero a grande distanza / i due cavalieri in nome delle alte mura / guardavano attentamente / dei due terribili figlioli.»
È fuor di dubbio che stiamo parlando di ‘leggende’ sorte dalla fantasia degli scrittori del tempo ma ancor più di una tradizione orale che più spesso era re-interpretata da
cantastorie ambulanti e da quei cantori che talvolta le mettevano in musica con inserimenti di villanelle e strambotti, e gagliarde a ballo onde far divertire il pubblico che accorreva numeroso alle loro rappresentazioni.
La fantasia popolare, in quanto essenza di credenze magico-religiose entrate nei costumi tradizionali, ha in origine contribuito all’affermarsi di un Teatro Popolare Regionale di cui le ‘maschere’ e i ‘mascheramenti’ rappresentavano la più espressiva delle forme d’arte. Ogni regione, almeno per quelle riferite all’Italia, ne possiede di proprie che mettono in risalto i caratteri dei suoi abitanti ed è rappresentativa dell’eredità di una più antica arte ludico-rituale.
Molte delle ‘maschere’ qui di seguito presentate sono native di regioni diverse e relative a epoche più o meno recenti, tra il ‘500 e il ‘700. Addirittura alcune non nascono neppure come maschere a se stanti, quanto invece sono‘caratterizzazioni’ di personaggi veramente esistiti, per così dire messi ‘alla berlina’, entrate in seguito nelle rappresentazioni di piazza e nel teatro dei saltimbanchi.
Un teatro fatto di scherzi e lazzi, di burle salaci e di trovate in cui venivano presi di mira gli autori inconsapevoli di pettegolezzi cittadini; le deformazioni fisiche e i tic professionali di personaggi pubblici; come pure i rappresentanti di questo o quel mestiere e ovviamente i chierici e i prelati, tutti visti, neppure a dirlo, atttraverso la lente caricaturale.
Ma se il teatro o comunque la scena rappresenta il luogo deputato per la rappresentazione in maschera, la piazza (quella piazza universale di cui si è già parlato in altro articolo), e indubbiamente la stada cittadina comprensiva dell’intero ‘paese’, è al dunque il prototipo umano forgiato dalle chiacchiere della gente che vi abita. La tradizione, infatti, riconosce in questa o quella maschera il personaggio archetipo della singola regione.
È così che con ‘Geppin e Nena’, due maschere contadine genovesi risalenti al XVI secolo, approdiamo In Liguria, terra di marinai ma anche di coltivazioni terriere di cui entrambi sono rappresentativi e che ritroviamo durante il Carnevale a passeggio per i paesini liguri accompagnati dal suono della ‘piva’ (sorta di zampogna) e che recitino filastrocche satiriche indirizzate ora a questo ora a quel cittadino più o meno noto.
‘Geppin’ indossa un corpetto scarlatto sotto la giacchetta di fustagno color nocciola o di velluto verde; calzoni corti di velluto ner, le uose (scarpe) alla contadinesca e in testa un cappello di feltro a falda larga. ‘Nena’ vestita secondo l’uso contadino ama adornarsi di molti monili d’oro e d’argento e, durante il Carnevale completa il suo abbigliamento con un parapioggia.
D’origine ligure-piemontese è un ‘canto narrativo’ dal titolo ‘Ghe n’ea de tre figette’ conosciuto anche come ‘La pesca dell’anello’ desunta da quella raccolta ben più lunga del Nigra:
«Ghe n’ea de tre figette inscia riva du mar. / A ciù bella l’è a ciù picina s’è missa a navegà. / In to mentre ch’a navegava, gh’è cheitu l’anello in mà. / O pescator dell’onda, vegnilu in po’ a pescà. / Quando l’avrò pescato, che cosa lei mi darà?/ Darò trecento scudi, e una borsa ricamà.»
Con ‘Meneghino e Cecca’, due maschere milanesi del Seicento siamo invece in Lombardia. Per la tradizione Meneghino è ‘povero ma con il cuore in mano’. Si vuole che il suo nome derivi da Domenichino, nome dato alla servitù in servizio la domenica ma, più probabilmente, dal più antico Omeneghino. Indossa una casacca verde orlata di rosso, pantaloni e scarpe nere, calze a righe bianche e rosse, parrucca e tricorno.
Secondo Amina Andreola studiosa del nostro teatro regionale: “La sua comicissima maschera un tempo indicava il contadino inurbato, ignorante, bonario e pieno di buon senso ma ancor prima il servitore devoto, prudente, con un pizzico di spavalderia.” Ma che, rivisitato al giorno d’oggi è riscontrabile nel franco e dinamico tipo del milanese ‘faço tuto mi’.
L’affianca di solito la moglie ‘Cecca’ ,sorta di popolana irosa e linguacciuta che lo mette spesso in difficoltà davanti agli altri e, non in ultimo, lo rincorre spesso con il matterello da cucina per picchiarlo. Tuttavia Meneghino, con il suo buon carattere, in fine riesce a domare non senza qualche lamentela da parte di Cecca, finché la pace comune non è ristabilita.
Con ‘La cansiun busiarda’ si intende qui dare un tipico esempio della popolarità di certe maschere che in realtà sono più ‘costumi’ che mascheramenti in quanto esse non indossano una vera e propria maschera facciale ma il loro lato comico sta nella frivolezza dei loro costumi multicolori, nei modi del loro parlare desunti dalgli usi dialettali, nella gestualità tipica del teatro della Commedia dell’Arte, in cui la ‘bugia’ era di rigore, all’origine di tutta la confusione proverbiale che ne derivava sulla scena:
«E chi vol sentì, canté, sentì canté / l’è la cansun busiarda / larilalalà, larilalalà / l’è la cansun busiarda. / Sun pasà ‘nt un pais ‘nt un pais / viviju a la gruséra / larilalalà, larilalalà. / J’éra ‘l fèn ent i butai ent i butai/ e ‘l vin su la finéra / larilalalà, larilalalà. / E le fje j’eru sel giuch / e le galine filavu / larilalalà, larilalalà. / L’àn butaje la ruca al béch / e ‘l fus en més le gambe / larilalalà, larilalalà. / J’éra ‘l prèivi ‘nt el pursil ‘nt el pursil / e ‘l crin cantava messa / larilalalà, larilalalà.»
In Piemonte troviamo i noti ‘Gianduia e Giacometta’ nativi di Caglianetto (Asti), inizialmente noti come burattini. Trasferiti nella cittadina Torino diventano maschere del Carnevale. Conosciuto nell’uso dialettale come ‘Givan d’la donja’ ovvero Giovanni del boccale è così detto perché gli piace il vino, e che qualcuno dice: ‘anche un po’ troppo’, per dire che è un ubriacone.
Gianduia dal viso aperto, pienotto, ridanciano, col naso volto all’insù, veste il costume originale di Caglianetto consistente in un giubbino di panno marrone orlato di rosso, calzoni al polpaccio di panno verde e calze rosse. In testa ha la parrucca nera tirata all’indietro che finisce col codino, sotto al tricorno verde, il cappello indossato nel torinese alla fine del Settecento.
Caratterizzazione del galantuomo tutto cuore, integerrimo ma generoso, difensore dei deboli e degli oppressi, talvolta un po’ stordito e linguacciuto ma bonario. Esempio tipico del robusto contadino piemontese, ingenuo quel tanto che basta, amante dello scherzo, dello scherno a fin di bene, come del buon vino e delle ragazzotte.
È qui in Piemonte che si tramandano canzoni e filastrocche note fin dal secolo XV°, come quella riportata qui sotto dal titolo ‘La bergera’:
«A l’ombretta del bussòn bela bergera l’è andurmija, / j’è da lì passò ‘n très joll franssè / a l’ha dije: Bela bergera vòi l’eve la frev. / E se vòi la frev farai fè na cuvertura, / còn al mè mantel ch’a l’è còsì bel, / farai fè na cuvertura passerà le frev. / E la bela l’ha rispòndù:/ Gentil galant fè ‘l vostr viagi, / e lasseme ste còn al mè bergè, / con al sòn dla sòa viola ‘n farà danssè.»
Ed ecco giungiamo nella ridente Toscana dove incontriamo ‘Stenterello’ un po’ narciso un po’ giocherello di se stesso. Maschera del teatro popolare fiorentino conosciuta appena nel XIX° secolo , rappresenta il popolano piccolo borghese, tra il furbo e lo sciocco, ma buono e incredibilmente giusto. Sua principale caratteristica è l’agile e colorito uso della lingua fiorentina infiorata di frizzi e frasi boccaccesche.
Così ad esempio egli definisce le donne:
«Donna ciarliera e bizzosa, è peggio d’ogni cosa./ Donna che parla poco, nasconde in seno il foco. / Donna che parla assai, non ti fidar giammai. / Donna muta e silente, peggio di un accidente.»
Stenterello ha fronte spaziosa, volto biaccato con sopracciglia allungate col nero di sughero bruciato che le rende arcuate e folte, al pari delle maschere più antiche. Indossa una zimarra di stoffa blu, un panciotto verde o giallo canarino, braghe nere e calze diverse, una turchina e una gialla, oppure una a tinta unita e una a righe, scarpe basse con grande fibbia e il tricorno sulla parrucca bianca.
Alla Toscana è legata uno stornello amoroso dal titolo ‘La mamma ‘un vole’:
«Ho seminato un campo d’accidenti / se la stagione me gli tira avanti / ce n’è per te e per tutti li tu’ parenti. / La mamma ‘un vole, ‘un vole, ‘un vole / che io faccia l’amor con te / ma vieni amore quando la mamma ‘un c’è. / Ho seminato un campo di carciofi / giovanottino mi son bell’e nati / carciofi come te ‘un so venuti. / So’ nata per i baci e voglio quegli / come l’innamorati se gli danno / gli voglio sulla bocca e sui capelli / poi chiudo gli occhi, dove vanno, vanno. / E a me mi piace ‘l fischio del motore / perché il mio amore gli era macchinista / mi buggerava e ‘un me ne ero avvista. / E a me mi piaccion gli uomini biondini / perché biondino è l’amore mio / biondino lui moretta io / che bella coppia che ha creato Iddio. / E a me mi piaccion gli uomini fustini / perché fustino è l’amore mio / fustino lui piccina son io / che bella coppia che ha creato Iddio.»
Fra le maschere legate ai costumi popolari del Lazio spicca il romano ‘Rugantino’, una sorta di bravaccio di rione intelligente e coraggioso, sincero e patriottico, si vuole discendente da quel Miles Gloriousus di Plauto già entrato nella commedia antica, forse anche dal grottesco Manducus, a tratti sprovveduto e nullafacente, innamorato della popolana ‘Nina’ alla quale più spesso dedica la sua serenata.
‘Nina si voi dormite’ conosciuta come canzone d’autore è forse quella rimasta nel repertorio più a lungo di tutte le altre:
«'Nde 'sta serata piena de dorcezza / pare che nun esisteno dolori. / Un venticello come 'na carezza / smove le piante e fa' bacià li fiori. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / L'odore de li fiori che se confonne, / cor canto mio se sperde fra le fronne. / Chissà che ber sorriso appassionato, / state facenno mo' ch'ariposate. / Chissà, luccica mia, che v'insognate? / Forse, chi canta che v'ha innamorato. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / Però, si co' 'sto canto, io v'ho svejato, / m'aricommanno che me perdonate. / L'amore nun se frena, o Nina, amate, / che a vole' bene, no, nun è peccato. / Nina, si voi dormite, sognate che ve bacio, / ch'io v'addorcisco er sogno / cantanno adacio, adacio. / L'odore de li fiori che se confonne, / cor canto mio se sperde fra le fronne. »
Il costume di Rugantino ha però origini settecentesche, tipico dei carrettieri a vino, costituito da un farsetto rosso sulla camicia bianca, calzoni corti allacciati sotto il ginocchio, calze bianche a righe orizzontali, fascia ai fianchi e coltello alla cintola. Sua compagna è ‘Nina’ o anche Ninetta, una popolana orgogliosa di essere tresteverina e spendacciona; porta lo spadino fra i capelli che all’occorrenza usa contro i numerosi ammiratori che si rivelassero troppo arditi.
Un po’ smargiasso e attaccabrighe ma schietto e simpatico ‘Rugantino’ rappresenta il romano più autentico, un po’ millantatore di bravate ma di buon cuore, sempre pronto quando si tratta di bevute in compagnia, sia che si tratti di una ‘morra’ giocata all’ ‘Osteria del tempo perso’; sia che si tratti di stornellate in comitiva con tanto di sberleffi e narrazioni salaci.
Non a caso in epoca moderna il duo Garinei e Giovannini ha potuto costruire sulla sua leggendaria maschera il noto musical dal titolo omonimo: ‘Rugantino’, che tanto successo ha riportato nel mondo e del quale bene lo rappresenta questa ‘Ballata di Rugantino’:
«Ma pensa che bellezza / nun c'ho niente da fa' / porcaccia la miseria / nientissimo da fa' / e rompo li stivali a tutta quanta la città / perché 'n c'ho niente da fa'. /
Rugantinì... Rugantinà... nemmeno è giorno e già vòi ruga'
Rugantinì... Rugantinà... tranquillo e bono non ce poi sta'
Sto proprio come un Papa / anzi mejo, Santità / perché Lei, gira, gira, / quarche vorta ha da sgobba'. / Io, viceversa, sgobbo solamente si me va / perché 'n c'ho niente da fa'./
Rugantinì... Rugantinà... c'hai sempre voglia de sta' a scherza'
Rugantinì... Rugantinà... ma non c'hai voja de lavora'
Voja de lavora' sarteme addosso / ma famme lavora' meno che posso. / Non posso perde tempo / nun c'ho niente da fa' / levateve de mezzo / fate largo a Sua Maestà /
ariva Rugantino che c'ha voja de ruga' / perché 'n c'ha niente da fa'.
Rugantinà... Rugantiné... che vai cercando, se po' sapé?
Rugantinì... Rugantinà... 'sta smania in corpo chi te la dà?»
Gli fa coro una lista incredibilmente variegata di personaggi: Marco Pepe, Meo Patacca, Mastro Titta, Cassandrino, Mezzetino, Sora Menica, Ghetanaccio il burattinaio e finanche la Befana, figura questa tra le più complesse della tradizione arcaica, tra il magico e il religioso, entrata di traverso sia nel teatro popolare che in quello più specifico dei burattini. Alla Befana è legata più d’una filastrocca e conta fanciullesca che bene ne illustrano il personaggio, come questa dal titolo significativo ‘La Befana’ ripresa dalla tradizione umbro-laziale:
«La Befana gli è arivata / di colore d’arcobaleno / e le porta le puppe in seno / che gli fanno balla balla. / Massaina e Capoccino sem venuti a casa vosra / ci darete del quattrino / se l’avete nella borsa. / Noi vogliamo delle ova / o mia cara Massaina / e per far bòna figura / ce ne date una dozzina. / Noi si piglia anche dell’agli / o cipolle o sian capretti / empiremo queste balle / di coniglioli o galletti. / Poi si da la bonanotte / a ‘i segnore benedette / questa vorta non si sorte / ci farete anche ‘l rinfresco. / Se vi avremo contentati / con la mia grande squadriglia / sémo meglio noi de’ frati / fora de la porta / benediciamo tutta la famiglia.»
Ma era la maschera facciale infine che più d’ogni altra cosa trasformava la fisionomia del personaggio ch’era preso di mira e che lo rendeva immediatamente riconoscibile al folto pubblico che presenziava a detti spettacoli popolari. Era la maschera infatti, più del travestimento, ad esporre nell’immediato il carattere tipico dell’incongruenza d’ogni personaggio che si affacciava sulla scena. Che fosse una risata subito trasformata in una smorfia sarcastica, oppure una lamentazione amorosa, o ona constatazione di morte, la maschera facciale determinava la conseguente gestualità dell’attore al quale era richiesta grande maestria d’improvvisazione; tale che già nell’antichità il termine ‘maschera’ si dava come sinonimo di ‘persona’.
L’ambiguità e la varietà che il termine ha assunto sono esplicite in numerose citazioni di autori latini, nelle quali ricorre, oltre che con il principale significato di maschera teatrale, anche quello di attore o parte rappresentata sulla scena, ed ancora quello di carattere, personalità, che più si avvicina al valore che noi oggi gli attribuiamo.
Il significato tradizionale rituale-magico e religioso della maschera trova una sua precisa spiegazione proprio in ambito teatrale in quanto le maschere venivano indossate dai partecipanti in primis nelle cerimonie religiose in cui la ‘persona’ letteralmente si travestiva da qualcosa d’altro: satiri, animali, uomini/donne divinità. L’uso della maschera dunque per assolvere a esigenze pratiche.
Come i partecipanti del rito, attraverso la maschera che copriva il volto, gli attori venivano trasferiti in una diversa realtà che li possedeva completamente, annullando la realer individualità di ciascuno, così nella scena, l’attore si calava completamente nella situazione di cui era protagonista e la maschera era il mezzo essenziale per il trasferimento in una realtà ‘altra’ che si voleva rappresentare.
Ed ecco che come per incanto o per magia sotto il ritratto un po’ burlone, un po’ grottesco delle maschere popolari troviamo infine quelle relegate a personaggi che pur facendo riferimento a questa o quella regione, indossano la ‘maschera facciale’ propria della Commedia dell’Arte. Figure queste forse più note al grande pubblico e per certi aspetti forse più care.
“Ogni regione – scriveva Sergio Tofano – si è impadronita di una maschera venuta fuori non si sa bene da dove, ma vecchia quanto il mondo e destinata a non morire, che ha dato ad essa un’appropriata cittadinanza. Fatta sua, l’ha riforgiata, l’ha ripulita, l’ha rimpastata, arricchendola di pregi e difetti, modellandola come un monumento vivo sui suoi vizi e sulle sue virtù”.
Bologna, ad esempio, città universitaria per eccellenza, sembra sia la più antica università al mondo, ha il ‘Dottore’, profondo e pedante come solo sa essere un dotto. La città lagunare di Venezia, sede di traffici e luogo di avventurieri ha il suo bel ‘Capitano’ che, stando a quanti sono gli attori che l’hanno interpretato ha spalancato i confini d’Europa.
Bergamo così detta ‘soprana e sottana’ per via dei molti baciapile religiosi, ha il suo ‘Arlecchino’ che, con ‘Brighella’ forma il duo comico più famoso e ‘scassato’ che si sia visto al mondo. A Milano troviamo invece ‘Beltrame e Scopone’ fratelli di Meneghino che li rappresenta bene entrambi. A Napoli … beh, a Napoli quella che è la maschera più complessa e straordinaria che si possa immaginare: ‘Pulcinella’, per quanto accompagnato da altre notevoli maschere come Scaramuccia e Tartaglia.
“Ciò che ne è venuta fuori - scrive ancora Tofano – una girandola, e che girandola! Dai colori più smaglianti, tutta nostra, che ha dato tanto spesso al nostro paese e ha fatto ridere il mondo intero”. Come in questa ‘Canzone di Niccolò’ d’epoca medievale, attribuita a Niccolò Macchiavelli ed entrata nell’uso popolare tosco-emiliano:
«Perché la vita è breve / e molte son le pene / che vivendo e stentando ognun sostiene / dietro alle nostre voglie / andiam passando e consumando gli anni / ché chi il piacer si toglie / per viver con angoscia e con affanni / non conosce gli inganni / del mondo, o da quai mali / o da che strani casi / oppressi quasi sian tutti i mortali. / Per fuggir questa noia / eletta solitaria vita abbiamo / e sempre in festa e in gioia / giovin leggiadri e liete ninfe stiamo. / Or qui venuti siamo / con la nostra armonia / sol per onorar questa / sì lieta e dolce compagnia.»
Il bergamasco ‘Arlecchino’ figura tra le maschere italiane più antiche e fa la sua apparizione già nelle composizioni improvvisate dei ‘mimi’ attori della cultura latina. Ricoedata in un primo manoscritto di Bartolomeo Rossi risalente al 1584, successivamente passato dalla scena italiana ai teatri di tutta Europa grazie a Carlo Goldoni che lo scelse come protagonista di alcune sue commedie famose.
È il tipico esempio del servitore, semplice, ignorante e credulone, al tempo stesso arguto e malizioso. La sua figura piena di grazia ma anche di sveltezza e agilità ha sempre destato simpatia fra gli spettatori di ogni età data, forse, dal suo vestito fatto di tanti pezzi ‘rombi’ di stoffe e colorazioni diverse che lo rendono molto gradevole allo sguardo, quasi una figura ‘sfuggevole’ alla presa.
Va qui ricordato uno dei più grandi esempi del teatro italiano allorché l’eclettico regista Giorgio Strehler che negli anni ’60 lo riportò in auge nella goldoniana commedia: ‘Arlecchino servitore di due padroni’ interpretato dal pur grande Ferruccio Soleri che ha fatto il giro del mondo. Per quanto vadano qui ricordati gli storici anni della prima esecuzione del 1947, Marcello Moretti, Franco Parenti e Checco Rissone.
Non a caso ci troviamo a Venezia in casa di ‘Messer Pantalone’, un tempo chiamato ‘il Magnifico’ poi anche ‘de’ Bisognosi’, forse per il fatto che fosse così avaro e brontolone da rifiutare qualsiasi aiuto ad alcuno. Lo si vuole desunto dalle antiche Atellane del V° secolo a. C: farse romane caratterizzate da un linguaggio popolare e contadinesco e da maschere fiss il cui nome trae origini proprio dalla città di Atella, fra le popolazioni osche della Campania.
Rappresenta un anziano mercante all’antica, tutto sommato un buon vecchio astuto e grave, onesto ed onorato, spesso ingannato dai suoi servitori dei quali ne paga sempre le spese. Padre incline a tiranneggiare le proprie ‘putele’ quali Rosaura e Colombina che vuole a tutti i costi maritare a chi vuole lui, ma anche senza spendere un baiocco.
Vecchio e grasso con il naso adunco e la barba a punta, veste secondo la foggia dei veneziani benestanti del tempo antico, una zimarra lunga fino ai piedi che lo rende riconoscibile e figura di tutto rispetto. Carlo Goldoni lo ritrasse così nella figura di Lunardo in ‘I Rusteghi’ di cui è qui riportato il ‘Contratto di matrimonio’:
«Margarita - (A Lunardo) Via, caro mario, ve compatisso. Conosso el vostro temperamento: sè un galantomo, sè amoroso, sè de bon cuor; ma, figurarse, sè un pocheto sutilo (48) . Sta volta gh'avè anca rason: ma finalmente tanto vostra fia, quanto mi, v'avemo domandà perdonanza. Credème, che a redur una donna a sto passo, ghe vol assae. Ma lo fazzo, perché ve voggio ben, perché voggio ben a sta puta, benché no la 'l conossa o no la lo voggia conosser. Per ela, per vu, me caverave tuto quelo che gh'ho; sparzerave el sangue per la pase de sta fameggia; contentè sta puta, quieteve vu, salvè la reputazion della casa, e se mi no merito el vostro amor, pazenzia, sarà de mi quel che destinerà mio mario, la mia sorte, o la mia cativa desgrazia.
Lucietta - (Piangendo) Cara siora madre, sìela benedeta, ghe domando perdon anca a ela de quel che gh'ho dito, e de quel che gh'ho fato.
Filippetto - (La me fa da pianzer anca mi).
Lunardo - (Si asciuga gli occhi)
Canciano - (A Lunardo) Vedeu, sior Lunardo? Co le fa cusì, no se se pol tegnir.
Simon - In suma (49) , co le bone, o co le cative, le fa tuto quel che le vol.
Felice - E cusì, sior Lunardo?...
Lunardo - (Con isdegno) Aspetè.
Felice - (Mo che zoggia!)
Lunardo - (Amorosamente) Lucieta.
Lucietta - Sior.
Lunardo - Vien qua.
Lucietta - (Si accosta bel bello) Vegno.
Lunardo - Te vustu maridar?
Lucietta - (Si vergogna, e non risponde)
Lunardo - (Con isdegno) Via, respondi, te vustu maridar?
Lucietta - (Forte, tremando) Sior sì, sior sì.
Lunardo - Ti l'ha visto ah, el novizzo?
Lucietta - Sior sì.
Lunardo - Sior Maurizio.
Maurizio - (Ruvido) Cossa gh'è?
Lunardo - Via, caro vecchio, no me respondè, vegnimo a dir el merito, cusì rustego.
Maurizio - Disè pur su quel che volevi dir.
Lunardo - Se no gh'avè gnente in contrario, mia fia xè per vostro fio. (I due sposi si rallegrano).
Maurizio - Sto baron no lo merita.
Filippetto - (In aria di raccomandarsi) Sior padre...
Maurizio - (Senza guardar Filippetto) Farme un'azion de sta sorte?
Filippetto - (Come sopra) Sior padre...
Maurizio - No lo vòi maridar.
Filippetto - (Traballando mezzo svenuto) Oh, povereto mi!
Lucietta - Tegnìlo, tegnìlo (50) .
Felice - (A Maurizio) Mo via, che cuor gh'aveu (51) ?
Lunardo - El fa ben a mortificarlo.
Maurizio - (A Filippetto) Vien qua.
Filippetto - Son qua.
Maurizio - Xèstu pentìo de quel che ti ha fato?
Filippetto - Sior sì, dasseno, sior padre.
Maurizio - Varda ben, che anca se ti te maridi, voggio che ti me usi l'istessa ubbidienza, e che ti dipendi da mi.
Filippetto - Sior sì, ghe lo prometo.
Maurizio - Vegnì qua, siora Lucieta, ve acceto per fia; e ti, el cielo te benedissa; daghe la man.
Filippetto - (A Simon) Come se fa?
Felice - Via, deghe la man; cusì.
Margarita - (Poverazzo!)
Lunardo - (Si asciuga gli occhi)
Margarita - Sior Simon, sior Cancian, sarè vu i compari (52) .
Canciano - Siora sì semo qua, semo testimoni.
Simon - E co la gh'averà un putelo?
Filippetto - (Ride e salta)
Lucietta - (Si vergogna)
Lunardo - O via, puti, stè aliegri. Xè ora, che andémo a disnar.
Felice - Disè, caro sior Lunardo, quel forestier che per amor mio xè de là che aspeta, ve par convenienza de mandarlo via? El xè stà a parlar co sior Maurizio, el l'ha fato vegnir qua elo. La civiltà non insegna a tratar cusì.
Lunardo - Adesso andemo a disnar.
Felice - Invidèlo anca elo.
Lunardo - Siora no.
Felice - Vedeu? Sta rusteghezza, sto salvadegume che gh'avè intorno, xè stà causa de tuti i desordeni che xè nati ancuo (53) , e ve farà esser... Tuti tre, saveu? Parlo con tuti tre: ve farà esser rabbiosi, odiosi, malcontenti e universalmente burlai. Siè un poco più civili, tratabili, umani. Esaminè le azion de le vostre muggier, e co le xè oneste, donè qualcossa, soportè qualcossa. Quel Conte forestier xè una persona propria, onesta, civil; a tratarlo no fazzo gnente de mal; lo sa mio mario, el vien con elo; la xè una pura e mera conversazion. Circa al vestir, co no se va drio a tute le mode, co no se ruvina la casa, la pulizia sta ben, la par bon. In soma, se volè viver quieti, se volè star in bona co le muggier, fè da omeni, ma no da salvadeghi; comandè, no tiraneggiè, e amè, se volè esser amai.
Canciano - Bisogna po dirla: gran mia muggier!
Simon - Seu persuaso, sior Lunardo?
Lunardo - E vu?
Simon - Mi sì.
Lunardo - (A Margarita) Diseghe a quel sior forestier, che el resta a disnar con nu.
Margarita - Manco mal. Vogia el cielo che sta lizion abia profità.
Marina - (A Filippetto) E vu, nevodo, come la tratereu la vostra novizza?
Filippetto - Cusì; su l'ordene che ha dito siora Felice.
Lucietta - Oh, mi me contento de tuto.
Margarita - Ghe despiase solamente co le cascate xè fiape.
Lucietta - Mo via, no la m'ha gnancora perdonà?
Felice - A monte tuto. Andemo a disnar, che xè ora. E se el cuogo de sior Lunardo non ha provisto salvadeghi, a tola (54) no ghe n'ha da esser, e no ghe ne sarà. Semo tuti desmesteghi (55) , tuti boni amici, con tanto de cuor. Stemo aliegri, magnemo, bevemo, e femo un prindese alla salute de tuti queli, che con tanta bontà e cortesia n'ha ascoltà, n'ha sofferto e n'ha compatio.»
Quella del ‘Capitano’ è un’altra figura assai comune in ogni tempo, nella cui maschera sono confluiti personaggi nativi di luoghi ed epoche diverse, finché – scrive Vittorio Gleijeses – con l’instaurazione del predominio spagnolo in Italia, il suo aspetto tipologico si identifica con il ‘soldato sbruffone’, fanfarone e brutale, feroce ma anche ridicolo, oggetto di avversione e di odio per le angherie e ruberie di cui è capace e che ne fanno l’oggetto di una pietà sprezzante a causa della sua miseria materiale e morale.
Pur conservando in ogni sua rappresentazione la foggia militare del costume, la sua maschera seguì i tempi cambiando foggia. Una delle maschere indossate poi divenuta famosa soprattutto in Francia è certamente quella dello ‘Scaramuccia’ napoletano, amante delle belle donne e delle bottiglie di vino, divenuta celebre nel ‘600 grazie a un interprete d’eccezionale bravura, di uno : Tiberio Fiorilli, uno dei maestri di Molière, sempre agilissimo e spiritoso fino all’età di 83 anni.
Nota anche in Calabria col nome di ‘Giangurgolo’ diventa un soldato ancora più fanfarone e allo stesso modo fifone degli altri più famosi di lui, quali ‘Capitan Fracassa’ o quel ‘Capitan Spaventa’ i cui nomignoli fanno già pensare ai soggetti che vanno a interpretare. Con Giangurgolo eccoci proiettati nell’estreme Sud della nostra penisola. Lo testimoniano di già le musiche e le canzoni narrative tipiche della tradizione.
Come in questa Carnascialata dal titolo significativo ‘zza Marianna’:
«Zza Marianna, zza Marianna / lu campaneddu vostru cu’ vi lu ‘ntinna? / Ca vi lu ‘ntinnu jeu: / Zza Marianna, cori meu …/ Ha d’èssiri di Patti la pignata, / pe’ fari la minestra sapurita! …/ Zza Marianna, ciuri di bellizzi / non vidi ca ti pennunu ‘ssi lazzi! .../ Ti dicu ‘mi t’i pettini e t’i ‘ntrizzi, / ca L’ò mini pè tia nèsciunu pazzi …/ Lu cori di la donna estì ‘na canna …/ ma l’omu è forti comu ‘na culonna! …/ Zza Marianna , zza Marianna ‘na vota …/ jeu fari non la pozzu cchiù ‘sta vita! …/ La testa mi firria comu a ‘na rota: / Zza Marianna , figghia sapurita ! …/ Mangia carni di pinna, e m’è corbacchia; / dormi cu’ ‘na signura , e puro vecchia! …»
Con ‘Peppe Nappa’ maschera del servo pigro e sbadato approdiamo in Sicilia in rappresentanza dei prototipo dei ‘citrulli’, cioè lo sciocco degli sciocchi di questo mondo, tale che tutti i citrulli di questo mondo messi assieme non potrebbero combinare i pasticci che questi combina, al punto che viene da chiedersi se il Nappa sia davvero stupido o finga di esserlo. Peppe Nappa non porta maschera né s’infarina o si trucca in volto, è agilissimo nella danza, maestro nell’eseguire le più comiche e burlesche piroette. È riconoscibile per le sue ‘nappe’, cioè le toppe che ha nei calzoni, da ricordare la figura del più moderno ‘pagliaccio’ da Circo che, pur prendendo calci e bastonate riesce infine a far ridere e a farsi amare.
A Peppe Nappa dedichiamo questa ‘Terra ca nun senti’:
«Maledittu ddu mumento / ca raprivi l’occhi ‘nterra / ‘nta stu ‘nfernu / sti vint’anni di turmentu / cu lu cori sempre ‘nguerra / notti e juorno. / Terra ca nun senti / ca nun voi capiri / ca nun dici nenti / vidennumi muriri! / T / Terra ca nun teni / cu vole partiri, / e nenti ci duni / pi falli turnari. / E chianci, chianci / ninna oh! / E chianci, chianci / ninna oh! / maledittu ‘sta cunnanna, ca ti ‘nchiova / supra ‘a cruci d’a speranza! Maliditti cu t’inganna / prumittennuti la luci e fratillanza.»
Maschere di una certa rilevanza sono note in Sardegna, diverse se presenti al Nord o al Sud dell’isola dove rappresentano figure più o meno legate alla natura dei luoghi; come ad esempio quelle di sughero dell’Iglesiente e quelle invece di legno ‘più dure’ della Gallura. Ancora più arcaiche, forse d’origine pastorale magico-religiose risultano essere quelle dei ‘Mamuttones’ tipiche del Carnevale Barbaricino di Mamoiada.
Ricco di atmosfere suggestive, impreziosito da eventi come la sfilata appunto dei Mamuthones, personaggi arcaici rivestiti di pellicce d’animale e maschere sul volto, cadenzata dal cupo suono ritmato dei campanacci, portati a spalla in gran numero dalle maschere che conferiscono ai danzatori un significato per niente casuale e tantomeno effimero:
«Le maschere cupe, le loro movenze, i suoni lugubri che ne fanno da contrappunto, incutono rispetto e, al tempo stesso, metteno a disagio. Assistendo a una loro esibizione non è difficile immedesimasi in quel lembo di antiche tradizioni che le stesse intendono e riescono ad evocare. (..) Le maschere a loro volta sono attorniate dagli ‘Issokadores’, questi sfilano senza campanacci indossando il costume tradizionale sardo e recano in mano una fune detta ‘sa soca’ , con la quale riescono a catturare gli spettatori che a un certo punto vengono tirati al cospetto ravvicinato delle maschere, tra lo spavento e talvolta la paura che incombono.» (F. S. Ruiu)
Recenti studi, coralmente recepiti, collocano l’origine delle maschere del Carnevale barbaricino nel tempo delle religioni misteriche e dei riti dionisiaci. Logico pensare che i riruali proposti siano quanto rimane di antiche manifestazioni propriziatorie sopravvissute nel tempo, legate alla fertilità e all’alternanza delle stagioni.
Anche ‘Sa Sartiglia’ di Oristano, un tempo chiamata ‘sortija’, è la giostra equestre più affascinante della Sardegna tra cultura e tradizioni.
Menzionata per la prima volta in documenti che risalgono al 1547, così come è giunta sino ai nostri giorni, è da considerarsi come un pubblico spettacolo, organizzato allo scopo di intrattenere e divertire gli spettatori che ogni anno vi prendono parte sempre più numerosi. La particolarità di questa ‘sfida’, che si differenzia da tutte le altre conosciute, è racchiusa nella vestizione e infine nell’indossare la ‘maschera’ bianca che nasconde il ‘vero’ volto di chi la indossa: ‘su Componidori’.
L'espressione profonda di questa maschera trasforma ‘su Cumponidori’, lo rende inavvicinabile, inarrivabile. Da quel momento in poi, sino alla fine della corsa, il Cavaliere diventa un ‘semidio’ sceso tra i mortali per dare loro buona fortuna e mandare via gli spiriti maligni. Alla fine su Cumponidori, vestito con in capo un cilindro nero, la mantiglia, una camicia ricca di sbuffi e pizzi, il gilet e il cinturone di pelle, sale sul cavallo che è stato fatto entrare in una sala disposta a religioso silenzio per non innervosire la bestia, gli viene consegnata ‘sa pipia de maju’ e, completamente sdraiato sul cavallo, esegue ‘sa remada’ per passare sotto la porta ed uscire all'esterno, dove lo attendono gli altri cavalieri e una folla plaudente che subito inizia a benedire.
Con ‘Pulecenella’ si dovrebbe aprire qui un capitolo a parte per la sua complessità storico-sociologica e filosofica del popolo napoletano. Cosa questa che rimando ad altra occasione non solo per ragioni di lungaggine dell’articolo, soprattutto perché con essa si entra prepotentemente nella ‘storia del teatro popolare di piazza’ e non solo. Legata a origini più antiche la maschera di Pulicenella è un miscuglio di coraggio e cialtroneria, vanità e astuzia, all’occorrenza alterigia e ciarletaneria che ne fanno un esempio, o forse un ‘modello’ della complessità umana. Ghiotto e insolente, arguto e gioioso, piacevole e impertinente, pazzerello e ciarliero, Pulecenella accoglie in sé il sentimento più profondo e oscuro dell’allegria e della tristezza dell’animo partenopeo, misero e arguto al tempo stesso, che non conosce cattiveria infame e che pure, riesce a impietosire per un piatto di maccheroni:
«Pè tutte so nu principe / pè tutte no signore. / Solo per il mio pubblico / fedele servitore.»
Ed ecco infine abbiamo ritrovato il nostro buonumore, come per incanto o per magia sotto il ritratto un po’ grottesco e un po’ burlone delle maschere popolari della tradizione italiana, siamo giunti alla fine di questo ‘incontro’ con quei personaggi più o meno noti e per certi versi cari. Alla fine altro non mi rimane che ringraziare e come un Arlecchino … di fare a tutti voi (che mi avete seguito) l’inchino.
*
 - Cultura
- Cultura
La tradizione in Italia Il Carnevale 2
(Testo di Giorgio Mancinelli con la collaborazione di Landa Ketoff, desunto da Folkoncerto: ‘Maschere rituali’, un programma radiofonico di RAI Radio3 del 1980/81, prodotto da Pierluigi Tabasso).
“Noi ventagli e voi amanti / tra di noi ci somigliamo. / Or mutati, or scordati, / or dimessi, or cercati, / capovolti, raggirati,/ or di moda ed or nol siamo,/ come piace alle belle a cui serviamo.
Il tuo bene, il tuo bel foco / fa all’amore in altro loco. / E tu intanto che farai, / per passar questo momento? / Fatti vento.
De le belle il capo a nuoto / va in turbin di capricci. / Io movendomi do moto / a quel turbin di capricci: / e così con l’opra mia / impedisco che corrotti / non divengano pazzia.” (“Scherzi per ventagli” – elab. da G.Parini – N. Gargano)
A Venezia nei giorni del Carnevale.
In questo mese di Febbraio la Serenissima diventa il palcoscenico di sfilate in maschera e rievocazioni storiche con almeno cinquanta eventi sparsi per le calli e i campielli, in cui ‘vivere’ assume il più alto significato ludico che mai sia stato raggiunto e dal quale hanno preso spunto tutti i carnevali sparsi per il mondo. Perché ‘vivere’ non vuol dire soltanto affidarsi al ritmo biologico dell’esistenza, ma trovare le ragioni per continuare a farlo. Malgrado le tante avversità che si incontrano sul proprio cammino, la cosa più naturale da farsi, vuoi per neutralizzare le forze negative che si agitano nel mondo, vuoi per rigenerare la dose necessaria di saggezza che necessita, è pertanto l’apprendimento di una sola arte: quella di ‘vivere’. I filosofi antichi ne erano convinti, sia che puntassero, come gli epicurei sul piacere di ‘vivere’, o che raccomandassero l’accettazione del mondo, come gli stoici. Le religioni in genere, e il cristianesimo in particolare, contengono molti elementi ‘consolatori’ che hanno consentito per millenni a fedeli e non di affrontare con speranza le sfide del male e della morte.
Molte volte dall’antichità ad oggi, come abbiamo appurato nella prima parte di questo articolo, la religione ha cercato in vari modi di contrastare gli aspetti ludici del Carnevale che la vedevano coinvolta in prima persona, con esiti più o meno coercitivi, tuttavia senza riuscire ad estirparne del tutto l’essenza e pur nella coscienza di sé nell’azione e nello scambio comunitario. A Venezia nel Settecento, sia pure in contrasto con il ‘tempo del sacro’, si scontrano e si ritrovano allo stesso tempo, in quello che tutti chiamiamo il ‘Tempo di Carnevale’, nuove forme ludiche a sostegno dei sentimenti regressi in cui la gente cerca di esternare la propria ‘gioia di vivere’. Pertanto ‘vivere’ Venezia o semplicemente gioire del suo raffinato entourage di maschere e vezzi, significava riappropriarsi dei propri sentimenti, per quanto la breve durata del Carnevale lo consentiva.
Sarà il Volo dell’Angelo o come è meglio conosciuto ‘della colombina’, con la spettacolare discesa della fanciulla prescelta per l’occasione che, assicurata a una fune dall’alto del campanile di San Marco verso il Palazzo Ducale allo scoccare di mezzogiorno, a decretare ufficialmente l’inizio del così detto ‘Carnevale di Venezia’; allorché il Rio di Cannareggio si trasforma in palcoscenico per eventi acquatici e performance di artisti di strada, cortei e remiere di voga, spettacoli di saltimbanchi e di teatro con spirito godereccio e goliardico ...
Ed ecco che al suono di un tamburino è annunciata la rappresentazione nel campiello più vicino, dove una compagnia di ‘commedianti’ ha montato un paclco rimediato: la scena è disegnata con il carboncino perché la tela dipinta dev’essersi rovinata durante i continui trasferimenti. E già s’ode il brusio delle voci e dei rumori tra risa e lazzi degli spettatori accorsi numerosi …
- Entra Arlecchino in sella a un asino di legno che, con la maschera sotto il braccio, legge da un canovaccio quale scena dovrà rappresentare tra un momento: “Arlecchino cerca l’asino sul quale è salito.”
Immaginiamoci per un momento d’essere in uno dei molti campielli che s’aprono all’improvviso ‘come per magia’ fra ponti e calli, finestre aperte e balconi di antichi palazzi, canali d’acqua dove le gondole sforano le brume e i mille riflessi della laguna, dove l’arrivo di un ‘torototela’ (cantastorie) richiama l’attenzione degli abitanti a uscire di casa e unirsi alla sfilata tra suoni e canti, ciprie e ventagli, maschere e costumi rinnovando l’usanza di abbellirsi per la festa ...
“Xé ‘rivà el torototela.
Son tri giorni che camino / par venirla a ritrovar / o parona me fafaso avanti / par venirla a domandar / son el povaro torototela / son el povaro torototà / che domanda la carità.
Se la varda ne la credenza / che calcossa la trovarà / se polenta o pur farina / la me daga presto qua / che calcossa me darà.
Son el povaro torototela / la sachetina go preparà / e la ringrassio tanto / che ‘n’altr’ano so ancora qua.
Son el povaro torototela / che ‘gni ano arrivà per el Carnevà / son el povaro torototela / son el povaro torototà .”
Una ‘festa’ brillante d’incontri mondani, ghiotta di moda e di raffinatezze, di pettegolezzi e arguzia, incipriata di frivolezza e di veneziana malizia. Sono ormai migliaia i turisti e i curiosi che ogni anno si riversano nella città in festa per il Carnevale, ma non tutti sanno che la sua origine è molto antica, derivata dalla trasformazione di manifestazioni popolari arcaiche, ancor prima delle antiche Sacre Rappresentazioni che si tenevano sul sagrato delle chiese durante il medioevo.
È documentato che feste e divertimenti d’ogni genere si tenevano in Venezia in molte occasioni e invadeva la vita di tutti i giorni, fino a far dire di questa città ‘che vivesse in un carnevale infinito’.
Sembra che la popolazione si lasciasse trascinare da una sorta di ‘follia’ collettiva che oltrepassava i limiti e i confini della ricorrenza cui era legata, subito addentrandosi in quella successiva. Dovunque nei palazzi signorili e nelle strade, un pubblico numeroso composto non solo da veneziani ma anche da genti di passaggio e turisti, si riversasse nella Serenissima non solo per ammirarne le meraviglie, quanto per prendere parte a spettacoli teatrali, concerti strumentali, banchetti lussuriosi, ai quali l’intervento (mai casuale) del Doge e dei Senatori della Repubblica conferiva una maggiore solennità. Si vuole che a Venezia l’interesse maggiore consista nel fatto che il Carnevale sia fatto oggetto di vero e proprio ‘culto’ inteso come esibizione di maschere, lungi quindi dall’essere considerato un breve periodo di festa della durata di qualche giorno appena, bensì che riempie tutta una stagione di preparativi costanti.
Si pensi che in passato aveva inizio il giorno della ricorrenza di Santo Stefano fino alla Quaresima, per riprendere poi, dopo la Pasqua con l’inizio della primavera fino all’autunno inoltrato. Or sono più di mille anni, esattamente nel 979, che il Doge Orseolo I, al momento di ritirarsi a vita spirituale all’interno di un convento, lasciò una somma cospicua per i suoi tempi, al Governo della città da destinarsi alle feste pubbliche. Addirittura si narra che la morte improvvisa del penultimo Doge della Serenissima sia stata dissimulata (ritardata) per non turbare i festeggiamenti del Carnevale in corso.
Nel XVII° secolo quello di Venezia era già un carnevale cosmopolita, quale sarebbe stato più tardi, il carnevale di altre città europee. Per l’occasione confluivano nella Serenissima diplomatici da molti paesi stranieri e personaggi famosi del teatro e non solo la cui fama aveva oltrepassato i confini della penisola. Nelle molte sale adibite agli spettacoli nei palazzi patrizi, dei albeghi più lussuosi come nei teatri e nei casinò, si svolgevano spettacoli ‘unici al mondo’, come appunto li definivano le cronache dell’epoca. Una folla eterogenea e capricciosa assisteva alle commedie di Chiari e Gozzi o di Goldoni decretandone il trionfo o l’insuccesso nonostante le assoldate ‘claque’ dei gondolieri che venivano fatte entrare in sala dagli autori all’ultimo momento …
“Ostreghe, capetonde e caragoi / Oh issa! oh issa eh! / ma isselo in alto oh! / e in alto bene oh! / poiché conviene oh! / Te dago segno eh! / ma sarà de segno oh! / poi dimendemo eh! / ma vago i madri oh!”
Ai concerti strumentali e talvolta corali prendeva parte un pubblico ovviamente più raffinato che ascoltava musiche e madrigali dei compositori più in voga, come Marcello, Vivaldi, Tartini, Galluppi eseguite da vere e proprie orchestre e cori di madrigalisti. Per quanto non mancassero intermezzi di ‘villotte’ e ‘canzoni da battello’ eseguite da popolani virtuosi. Ciò per quanto la vera magnificenza del Carnevale di Venezia era e continua ad essere l’indossare la ‘maschera’ in ogni sua espressione, che sia semplicemente popolare o incredibilmente lussuosa, accessibile alle fasce più facoltose della società o dei ricchissimi imprenditori che qui misurano la loro creatività e la loro esuberanza, ma forse solo la loro ‘follia’ d’essere per un giorno, e perché no, ciò che non potrebbero essere mai.
L’assenza di carri e carrozze ad esempio è una delle ragioni per cui il Carnevale di Venezia è pressoché sentito, in quanto mette in scena proprio quella velleità personale di esibizionismo diretto della persona e del proprio corpo, concedendo ad essa piena libertà di espressione e di movimento. Alle maschere infatti è concesso di invadere calli e piazze, di entrare ed uscire dalla case o i palazzi dove si tengono feste, formare capannelli, di sciogliersi e rincorresi l’una con l’altra il cui fine è quello dell’incontro, del vicendevole riconoscimento, dell’intrattenimento. Benché il ‘Domino’ sia stato in passato il costume più diffuso, maschere di tutte le fogge e colori invadono oggi i campielli e le calli mescolandosi a una moltitudine di altre ed a quelle della tradizione della Commedia dell’Arte.
Accanto alla classica e nobilissima ‘bautta’ spesso indossata con un ‘tabarro’ che ricopriva l’intera figura, scrive ancora il Dazzi nel lontano …..: «Venezia schierava una folla di maschere e di travestimenti, dei quali i più celebri erano: il Mattaccino, il Magnifico o Pantalon, i due Zanni, Brighella e Arlecchino, il dott. Graziano e il dott. Balanzon; oltre a chiozoti, gnaghe, calabresi, pastori, cocchieri, ninfe, diavoli. I luoghi più frequentati erano la piazzetta, il molo, Riva degli Schiavoni, dove si tenevano anche lotterie, teatri dei burattini, di cantanti e di comici popolari; c’erano le ‘strologhe’, i venditori di profumi e cerotti, e non in ultimo, i cavadenti.» Inutile aggiungere che si stesse parlando di maschere e mascheramenti del Carnevale popolare. Oggi, per quanto una certa tradizione venga ancora osservata da sparuti esemplari veneti e limitrofi che giungono da fuori, ciò che si svolge è pressoché attribuibile alla ‘meraviglia estasiata’ dei nostri occhi.
Ma la maschera, come sappiamo, non costituisce solo un camuffamento della persona; essere in maschera significa essere in incognito e dunque, potersi abbandonare a lazzi e scherzi d’ogni genere. Ed è proprio a questa possibilità di ‘vivere’ in incognita costituiva il senso segreto del mascherarsi. Scrive a sua volta Pino Correnti: «La maschera assumeva in Venezia un’importanza mai riscontrata altrove, (…) tanto che ‘mettersi in maschera’ era diventata un’abitudine e la si indossava per evitare di fare incontri che dovevano permettere l’anonimato a chi la indossava. Tuttavia sussisteva un cosi detto ‘segno di maschera’, consistente in una sorta di distintivo, di un piccolo ‘domino’ in miniatura appuntato sul cappello. Chiunque lo portava era considerato come mascherato e non andava salutato, anche se, come accadeva sovente, chi lo portava era un personaggio importante. (…) In altre parolebastava il simbolo del ‘mascherarsi’ per fare tabula rasa delle gerarchie sociali.»
La libertà che l’indossare la maschera concedeva nella vita privata faceva tutt’uno con la possibilità di fare e ricevere scherzi o battite di scherno, come anche di dare sfogo alla naturale arguzia veneziana di «‘ndar ala Sensa» che in gergo significava e significa ancor oggi ‘perdere la testa’. Curioso a dirsi la Sensa è anche il nome di una festa marinara perdurata fino a tutto l’Ottocento il cui fulcro era ‘lo sposalizio del mare’, dacché Venezia ogni anno sposava simbolicamente il mare gettando in esso l’anello d’oro donato da Papa Alessandro III al Doge Ziani, per celebrare la vittoria sulla flotta dalmata, avvenuta nel 1177, che la rese dominatrice assoluta sul mare. Che fosse una propaggine del Carnevale? Sembrerebbe di no, anche se per l’occasione tutta la città si lanciava in festeggiamenti in maschera fastosi e straordinariamente regali. Ogni tipo d’imbarcazione in grado di galleggiare seguiva il Bucintoro, l’imbarcazione dorata del Doge che sfilava lungo il Canal Grande in un tripudio di gondole e balotine adorne di broccati, zendali, corone di fiori, tra spari di mortaretti e fuochi d’artificio …
“No gh’è ne la storia
del mondo una festa
più bela, più splendida
a Venezia de questa:
incanto de popolo,
de re e imperadori
delizia martirio
de artisti e scritori.
Superba memoria
de un tempo pasà
de cento città …”.
Inizia così la descrizione di uno spettacolo rimasto famoso e ripreso da una lirica riferita alla ‘regata’ che si tiene prima del Carnevale, di Riccardo Selvatico, commediografo veneziano del secolo scorso che scriveva in versi dialettali. La festa legata alla ‘regata’ che si svolge con un percorso rimasto sempre uguale nel corso dei secoli, si rinnova ogni anno sulle gondole e, come tutte le feste popolari veneziane richiama un gran numero di turisti che si mescolano all’allegria generale in cui Venezia, brulicante e multicolore, si trova a essere la sede naturale d’una gioia infinita che si diffonde per tutta la città. Festa che raccoglie attorno a sé giostre e tornei, assieme a gare di giocolieri, ‘caccde dei tori’, tra suoni, canti e saltimbanchi che si esibiscono nelle famose ‘forze d’Ercole’ in cui i più giovani si esibiscono nel dare forma ad alte piramidi umane.
Molte altre ‘feste’ si svolgevano in Venezia prima, durante e dopo il Carnevale di cui si rende impossibile riportare in questo breve articolo, ma che è possibile leggere in “Le feste e le maschere veneziane” di Giulio Lorenzetti ed anche in “Feste e Costumi di Venezia” di Manlio Dazzi. Di fatto c’è che ogni notte a Venezia può sempre accadere qualcosa di straordinario o quanto meno d‘inconsueto, come spesso narrato nelle avventurose ‘memorie’ di Casanova, e nelle ancor più accessibili ‘comedie’ di Carlo Goldoni: «Si trovano a Venezia, a mezzanotte come a mezzogiorno i commestibili messi in vendita, le osterie aperte, e cene pronte negli alberghi e nelle locande; perché i pranzi e le cene di società non sono comuni a Venezia, ma le partite di piacere e gli spuntini danno occasione a radunate con maggior libertà e allegria.»
A notte inoltrata poi, la folla si frantumava in piccoli gruppi e si avventurava per le calli illuminate dalle lanterne e addobbate con drappi e festoni. A bordo non mancavano i ‘fritoleri’ che ammannivano ciambelle e pesce fritto, mentre lungo le rive la gente affollava i caffè, le finestre delle bettole e delle cucine ambulanti per godersi lo spettacolo dato dai burattinai, dai ciarlatani e i cantastorie, ma nei canali, sui battelli pavesati di frasche e rischiarati da lampioncini di carta colorata, suonatori e cantanti accompagnavano le allegre comitive con canzonette popolari dal gusto satirico o quantomeno salace, come in questa ‘canzone da battello’ del Settecento veneziano …
“Premi o stali”
“Premi, via! Premi o stali! Se premar no ti vol, / a far el barcariol, dime, chi t’ha insegna? / Oh quanti carnevali che avèmo in sto mistier / senza un principio aver … / senza un principio aver de quel mister che i fa!
Ciò, varda come i va, / i va de qua e de là … / Sia! Topa, i ve dà drento! / Via, premi I vol stalir! / Stali se ghe pol dir, che alora i premarà! / I premarà!
Quando fa un po’ de vento quelo no i sa mai tor, / co i voga un poco i mor … / co i voga un poco i mor, sti corpi senza fià!
Ciò varda come i va … / Assae de sti paroni no i vol i boni, no! / La mazor parte se che i cerca el bon marcà …/ el vbon marcà.
Vien fora sti mincioni, un còdega, un vilan, / Ciò, varda come i va … / Miracolo xe intanto che co sti grezi alfin / in testa, un gondolin no s’abia rebaltà …/ rebaltà.
No ‘l xe picolo vanto, se ‘l crede qualchedun, / che gnanca mai nissun … / che gnanca mai nissun se n’abia sfracassà. / Ciò, varda come i va.”
Stando alle cronache del tempo, Piazza San Marco era ed è ancora oggi, il principale luogo di convegno delle maschere che si mettevano e si mettono in mostra nel corso di quello che è comunemente chiamato il ‘liston’, durante il quale tutti continuano a d avere l’opportunità di ammirare gli altri. Vi si raccoglievano un numero esorbitante di maschere da superare le quarantamila che poi si sparpagliavano nei teatri, nelle sale da ballo, nei caffè alla moda e, ovviamente, nei ‘festini’, quei balli pubblici in cui l’entrata era libera per ogni persona che indossasse una maschera, oggi non più. Ed ai quali Carlo Goldoni intitolò una sua commedia, ‘Il festino’ appunto, che portava in scena quello spettacolo ininterrotto che era il Carnevale.
Durante le ore notturne poi, si frequentavano i cosiddetti ‘ridotti’ e i ‘casini’ adibiti massimamente al gioco, dove la nobiltà veneziana teneva banco aperto a tutti coloro che si presentavano con l’intenzione di giocare. Sembra infatti che nel Ridotto di San Moisé, nell’antico Palazzo Dandolo, furono dissipate ingenti fortune dalla nobiltà dell’epoca in cui Giacomo Casanova ‘spogliava’ – per così dire – le Dame della migliore società: «Vi erano molti tavoli disposti in fila, innanzia ai quali stava un gentiluomo con davanti mucchi di zecchini e ducati, prontissimo a tener banco con chiunque portasse la maschera, nonostante un editto del 1703 ne proibiva l’uso nelle case da gioco, o che appartenesse al ceto patrizio e, ovviamente, avesse contanti da scambiare.
Le maschere della Commedia dell’Arte attinsero a piene mani nell’ironico mondo del Carnevale di Venezia dando un impulso straordinario al teatro che da allora in poi poté dirsi: ‘che vivevano recitando e recitavano vivendo’. In proposito Paolo Toschi a riguardo scriveva: “Il teatro comico italiano nasce dal clima festoso del Carnevale proprio come la Commedia dell’Arte e ne conserva lo spirito tripudiante, irriverente e licenzioso. Uno stretto legame confermato dall’elemento folkloristico più caratteristico, cioè la maschera. Ma sarebbe un errore credere che le maschere in Venezia fossero tutte colorate e pazze come gli Arlecchini figli di zanni, discesi in città dall’alta Val brembana; o i Pantaloni in zimarra nere e brache rosse che dovevano rappresentare l’espressione più intima vis comica popolare. A Venezia le maschere erano per lo più silenziose, gravi, quasi tristi. Il piacere di mascherarsi era qualcosa di sottile, di intimo: una delle libertà più care ai veneziani.”
Cronista instancabile del costume di una società ‘sopra le righe’ Carlo Goldoni rappresentò nelle sue commedie gli svaghi e i costumi della borghesia mercantile veneziana facendo uso di un linguaggio ricco di grande sensibilità. Ogni momento del vivere quotidiano trovava in esse la sua giusta collocazione, dai sorrisi agli sguardi, alle mosse affettate, alle moine adulatrici, alle leziosaggini preziose; dalle riverenze alle riverenze, alle chiacchiere delle cameriere e dei servitori; dal pettegolezzo del barbiere imparruccato alle ‘Smanie per la villeggiatura’ della ragazza per bene; dalle ‘Baruffe chiozzote’ ai ‘Preparativi per il Carnevale’. In ogni sua commedia troviamo un amabile realismo e un inimitabile colore che ci permette qui, di scoprire un neo provocante o uno sguardo insistente dietro un occhialino; là una confidenza sussurrata dietro un ventaglio o un paravento per signore. E perché no, il propagarsi sommesso ‘di voce in voce’ di uno scandalo accolto da risa soffocate; come anche il modo tutto veneziano di presentarsi e congedarsi in società, o come apprendere la cadenza misurata e aggraziata di un passo di minuetto.
La Commedia dell’Arte fu, secondo una calzante definizione, un teatro antiletterario, nel senso che veniva messa in scena non già sulla scorta di un testo redatto in ogni sua parte, bensì su di un ‘canovaccio’ che serviva da trama di base su cui di volta in volta costruire i costrutti comici o drammatici, e sul quale gli attori erano chiamati ad improvvisare e a costruire il dialogo, le gag e gli sproloqui che tanto raccoglievano gli applausi del pubblico. Pertanto la rappresentazione scenica non era mai la stessa, che si potrebbe dire unica, un’autentica creazione collettiva. Il bravo attore/attrice era di per sé il perno della commedia rappresentata, il cui successo dipendeva dalla sua capacità verbale, dalla loquacità e spesso dalla proverbialità delle sue battute scelte di volta in volta a seconda del pubblico che si trovava di fronte. Occorreva però che nessuno degli attori in scena rovinasse goffamente l‘effetto ‘botta e risposta’ richiesto dal protagonista. Ognuno doveva sapersi tirare in disparte o intervenire prontamente e aiutare chi di loro si trovasse in difficoltà o venisse meno l’ispirazione.
Come pure osservava un contemporaneo: “Il risvolto comico di questo fare teatro consiste negli aspetti ridicoli o talvolta mostruosi della natura; deriva da volti deformi e nasi caricaturali, da fronti a bauletto e crani calvi, orecchie a sventola e gambe storte”, più spesso ottenuti artificiosamente mediante maschere e trucchi particolari. Il tutto risiedeva dunque nel gioco e nella sottigliezza caricaturale popolaresca rintracciabile nella variegata fauna che è l’umanità, colta nelle sue espressioni naturali e popolari. Scrive George Sand: “La Commedia dell’Arte non è solo lo studio del grottesco e del faceto, è soprattutto lo studio dei caratteri reali dall’antichità a oggi, con una tradizione ininterrotta di fantasie umoristiche, con un fondo però anche molto serio, tale che si potrebbe dire anche molto malinconico, come tutto ciò che mette a nudo le miserie umane”.
Una usanza popolare molto diffusa durante il Carnevale è il processo burlesco con il quale alcune figure vengono condannate al pubblico scherno finanche ad essere messe ‘a morte’. “La vecchia” ad esempio viene spesso bruciata o segata in pezzi come effige del Carnevale. In questa tragicommedia popolare, tanto amata dai veneziani, dal rogo si vedono apparire alcune maschere comiche, tra le quali appunto ‘la vecchia’ che fa testamento mentre gli attori che vi prendono parte infieriscono contro di lei, come in questa ‘vilotta a ballo’ …
“La la la la / A gera in orto che colgea fenoci / alzo la testa e vedo i bei oci / da tanto che ‘sti oci me sluseva / note che gera giorno me parea.
La la la la / Xè tanto tempo che no vedo el sole / e stamatina l’ò visto levare / xè tanto tempo che no vedo lo mio amore / ma stamatina l’ho visto pasare.
La la la la / Sonè ‘sto cimbanin, sonèlo forte / sonèlo ch’el se senta a la lontana / e se ghe fusse qualche bel sogeto / sonè lo forte, per farghe dispeto.”
A tutto questo va aggiunto che la Commedia dell’Arte rispecchiava, esagerandoli, gli aspetti ridicoli e le caratteristiche locali che tanta importanza hanno avuto in ogni paese in cui il teatro popolare trovava terreno fertile per ogni sua rappresentazione.
In Italia ad esempio, fu in particolare e in parte lo è ancora, l’uso dei dialetti regionali a fare la differenza proponendosi come mezzo di distinzione e oggetto di scherno tra città e città; così se a Firenze si rideva dell’accento veneto, a Venezia lo si faceva del bolognese, come del bergamasco o del siciliano che figurassero in maschera o senza. A tal proposito lo studioso della materia Gleijeses scrive: “la maschera rappresenta sostanzialmente la vita del secolo in cui si vive e di volta in volta cambia necessariamente sulla scena le sue caratteristiche in quanto deve uniformarsi ai tempi”. Pur tuttavia la Commedia dell’Arte in special modo a Venezia conservò i suoi tipi tradizionali per molti secoli ancora dalla sua origine popolare, restando per lo più immutata nei suoi gesti e nell’improvvisazione. Soprattutto non perdette la sua vivacità, la battuta pronta capace di colpire nel segno con i suoi strali comici e satirici riferiti alla società Ciò a voler dire che la Commedia dell’Arte non è mai stata fine a se stessa, bensì trovava una sua precipua collocazione nel tempo in cui essa era funzionale all’aspetto sociale che andava affrontando.
Va anche detto che vis comica era molto varia, la comicità non sempre di facile definizione perché peculiare di un certo territorio. Tale varietà di caratteri o caratterizzazioni derivava dal fatto che ogni città italiana, ogni regione o addirittura ogni singolo paese, aveva una sua versione dello stesso personaggio, finanche della stessa maschera. Così, ad esempio, il ‘vecchio’ che a Bologna città universitaria, riassume i tratti del dottor Balanzone, a Venezia diviene il mercante Pantalone, a Napoli veste i panni di Tartaglia ma anche di quel Pulcinella, maschera però assai più complessa di cui spero di poter parlare in un altro articolo dedicato. Di fondo il personaggio è lo stesso ma differiscono per l’abito indossato, la maschera, i tic della voce e nelle espressioni del volto, così come negli aspetti della singola comicità; di quel fare il ‘vezzo di se stessi’ tipico di certi personaggi che oggigiorno possiamo vedere soprattutto al cinema.
Va qui fatto un appunto alla mancanza di figure femminili nella Commedia dell’Arte se si esclude la risma tuttavia numerosissima di servette, fidanzate, mogli e amanti che per lungo tempo sono state escluse dall’apparire sulla scena ma delle quali conosciamo parecchi risvolti perché sostituite da attori uomini che ne rifacevano i vezzi. Duchartre azzarda due ipotesi per questa mancanza di maschere femminili: la prima è che la vera maschera è la stlizzazione di un carattere ben definito, non riscontrabile nelle donne della Commedia dell’Arte in quanto sì pieno di sfumature e di varianti, ma estremamente vago. L’altra è che nessuna maschera femminile riesce a rendere l’effetto prodotto da un bel viso, e questo perché le prescelte erano sempre molto belle e ciò bastava a renderle ‘sublimi’. Tuttavia una certa caratterizzazione venne attribuita anche a loro; le ‘innamorate’ ad esempio variavano dalla fanciulla casta e di animo nobile ‘da sposare’; alla civetta furba pettegola e bugiarda, alla cortigiana vera e propria, cioè colei che ‘non è da sposare’ e tuttavia sempre fedele all’uomo cui concede i favori.
Ma ecco che infine, mentre le note del “Carnevale di Venezia” di Giovanni Bottesini già invita alla danza, gli intervenuti fan sentire il loro chiassoso andirivieni lungo le calli e nei campielli. Il ‘tempo’ è quello della festa e per l’occasione qualcuno fa esplodere i mortaretti dando luogo a un fuggi fuggi generale che si sparpaglia in tutta la città: “..e qui s’ode un gondoliere che canta un antico ritornello, più in là una lavandaia che s’accora; una compagnia che leva il suo teatro improvvisato, un giocoliere che fa il suo numero davanti a una folla rimediata per caso lungo la via, e sotto gli archi uno zanni che prova l’abito di scena dell’anno passato che non gli va più … mentre un Goldoni di marmo dall’alto dello scranno che lo tiene sollevato dalla piazzetta a lui dedicata, passa in rassegna gli ‘innamorati’ di sempre, la ‘locandiera’ che accoglie gli ospiti sull’uscio, la gente seduta al caffè che chiacchiera e sparla ora di questo ora di quella, un gondoliere che passa e si balocca, una servetta che bighellona con lo sguardo nell’aria, di questa città unica al mondo, persa negli effluvi di un Carnevale che egli sa non poter durare in eterno, ma che a tutto c’è rimedio, come in questa canzone popolare raccolta a Venezia ancora nel 1965 da Luisa Ronchini del Canzoniere Popolare Veneto …
“El Carneval xe ‘nda”
El carneval xe ‘nda go perso la morosa
come gogio da far par ‘ndarla ritrovar
vestio da capucin mi me vogio ‘ndar.
Vestio de capucin el ga bussà la porta
el fassa piano pian el fassa pian pianin
che go la fia in leto che la xe par morir.
Se la xe par morir bisogna confessarla
e voi che siete padre padre confessor
monté su par le scale e confessela vu.
E sera ben le porte e spensi su i balconi
che no’ senta nissuni far la confession.
Col padre ha finito si leva e poi va via
la figlia vien da baso e dice ‘mama mia’
e dice ‘mama mia’ il frate m’à guarì.
Sia benedetto el frate e anca el cordon ch’el porta
e anca el cordon ch’el ga
che m’à guario la figlia in leto amalà.”
Quand’ecco già un ‘galante’ consegna un biglietto alla servetta, è una lettera d’amore per la sua padroncina. Un segreto da conservare di un presunto incontro, o cosa? – si chiede. Intanto fra il pubblico cresce l’attenzione. Suvvia! È questa una delle tante trovate del teatro che si costruisce giorno dopo giorno come per magia sulle tavole del palcoscenico della Commedia dell’Arte, così senza un copione ben definito, per quanto frutto di quotidiana fatica di chi ogni sera ricrea l’evento gioioso e talvolta amaro, che segue a ogni levarsi del sipario e che precede gli applausi di rito.
*
 - Musica
- Musica
La tradizione in Italia Il Carnevale
(Testo di Giorgio Mancinelli con la collaborazione di Landa Ketoff, desunto da Folkoncerto: ‘Maschere rituali’, un programma radiofonico di RAI Radio3 del 1980/81, prodotto da Pierluigi Tabasso).
“Ciascun suoni, balli, canti
arda di dolcezza il core
non fatica, non dolore:
ciò c’ha esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto … sia.”
Sui versi del ‘magnifico’ Lorenzo de’ Medici diamo inizio ai festeggiamenti che, nel rispetto dell’etimo mediovale prende il nome di ‘Carnovale’ coniato sulla perifrasi ‘carne-levare’, ossia quel ‘togliere la carne’ che nel calendario cristiano coincide con il primo giorno di Quaresima e la successiva astinenza ‘dalla carne’ per la durata fissata di ‘quaranta giorni’ che precedono la Pasqua.
In origine, si vuole, sostituisse un ciclo di festeggiamenti per l’inizio d’anno, i cui riti celebravano il ritorno della luce del sole che una cupa superstizione riteneva fosse prigioniera di alcune divinità ctonie legate al sottosuolo, al risveglio dei morti e alla venuta degli spiriti maligni che si presentavano sulla terra in forma di demoni mostruosi, in grado di infliggere le peggiori pene corporali.
Un chiaro esempio di tradizioni più antiche si svolge ancora oggi a Mamoiada in Sardegna, al centro delle celebrazioni del Carnevale, nella tradizionale processione detta dei ‘Mamutònes’, sorta di maschere rituali che hanno l’aspetto di vero e proprio travestimento di tutto il corpo, la cui origine risale ad epoca remota. La processione, ordinata secondo canoni secolari, esce dalla casa detta della vestizione nelle prime ore del pomeriggio e procede assai lentamente fino a notte inoltrata per le strade del paese. Legati ad una grossa fune dagli ‘Issaccadòres’, i Mamutònes rivestiti di pesanti pellicce di capra, procedono a piccoli saltelli ripetuti di volta in volta nel numero di tre, facendo risuonare il pesante fardello di campanacci che portano addosso attorno alla vita e alle caviglie, il cui suono incute una sorta di terrore mistico che si rinnova, per quanto suggestivo e solenne, come uscito dall’antro misterioso del ‘caos’.
Il Carnevale dunque in quanto una ‘festa’ che possiamo definire rappresentativa di un insieme di tradizioni religiose arcaiche che secondo le diverse credenze popolari, hanno rivelato a un tempo un carattere propriamente ‘magico’, fondato sulla presenza di esseri fantastici, come maghi e streghe, gnomi, folletti e altre creature fantastiche abitanti di un mondo estremo, animatori di sogni, di favole e di narrazioni mitiche, entrate poi nella tradizione culturale di molti popoli.
Ne parliamo oggi in occasione della sua ‘ricorrenza calendariale’ che si vuole desunta da più antichi riti apotropaici, la cui origine si fa risalire a un nucleo di ricorrenze pagane legate alla cultura agricola e contadina, governata dal susseguirsi delle stagioni, di cui l’avvento della primavera, dopo il periodo di sterilità dell’inverno, costituiva il momento focale dei festeggiamenti.
Canti e danze propiziatorie venivano improvvisati per l’occasione negli spazi all’aperto, sulle aie e nei campi con riti diversi, il cui intento era quelo di risvegliare e accattivarsi la simpatia i folletti dei boschi, le buone fate e gli gnomi animatori favolistici della natura. Bisognava però non farsi riconoscere e quindi rallegrarli con mascherate e giaculatorie. La prima manifestazione d’origine pagana riferita alla forma ‘carnevalesca’ che si ricordi risale all’antichità ed era dedicata al dio greco Dionissos, trasformata in epoca imperiale romana nel ciclo dei festeggiamenti detti Saturnalia che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, periodo in cui si festeggiava il Solstizio d’Inverno, fissato da Domiziano per l'insediamento nel tempio del dio dell’abbondanza Saturno.
I Saturnalia erano vere e proprie orge liberatorie, si aprivano con un sacrificio a cui seguiva un grande banchetto pubblico, in un crescendo che assumeva talvolta caratteri orgiastici, in cui i partecipanti inoltre usavano ‘maschere’ per non essere riconosciuti durante lo scambio degli auguri, quell’ ‘io Saturnalia’, accompagnato da piccoli doni simbolici, detti anche strenne. Avveniva che durante tutta la settimana, si nominasse un re burla detto ‘princeps saturnalicius’ al quale era concesso il potere di comandare l’andamento dei festeggiamenti. Per l’occasione si permetteva il capovolgimento di ogni forma di stato sociale, come quello dello scambio dei ruoli, finanche agli schiavi di essere serviti dai padroni.
A questi facevano seguito i Lupercalia, che si celebravano dal 13 al 15 di febbraio, in onore del dio Fauno, nella sua accezione di Luperco (in latino Lupercus), cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi, con i quali si festeggiava in Roma il ritorno della fertilità dei campi con cerimonie di purificazione e rituali di propriziazione della fecondità. Considerati diretti progenitori del Carnevale, in quanto prevedevano inoltre manifestazioni collettive comprensive di mascheramenti, travestimenti e mimetizzazioni, i Lupercalia erano portatori di promesse e speranze di ‘ricongiungimento’ delle genti con la parte oscura della natura e si collocavano all’origine dell’amore pagano. Di fatto in essi si promulgava la negazione dei ‘principi fondanti l’ordine morale costituito’ che assumeva così l’aspetto di un mondo alla rovescia, inclusivo di esternazioni e ambiguità sessuali in cui, per così dire, si doveva ‘fecondare’ la natura stessa.
Un ‘fare estremo’ questo che in età medievale avrebbe dato luogo al corteo fragoroso e burlesco della ‘Festa dei Folli. “I cronisti dell’epoca e poi gli storici, si raccapezzano male fra le varie ‘Feste dei folli’ poiché non tutte si svolgevano nello stesso giorno”. Jean-Baptiste Thiers, uno dei primissimi studiosi di queste feste, scrive: “A volte gli ecclesiastici si facevano merito davanti a Dio e agli uomini di danzare in chiesa … così come all’interno di cattedrali e collegiate dove si svolgeva tutta una serie di feste, sottolineate da rituali d’eccezione e da danze liturgiche; una serie quasi ininterrotta che aveva spesso un’appendice nei giorni che seguono l’Epifania, fino all’ottavario incluso in gennaio. Si trattava dunque di un lasso di tempo superiore al mese contraddistinto da alcuni momenti focali, ognuno dei quali con una diversa origine e una forma di devozione particolare, limitata dapprima a un solo giorno e a una sola cerimnia, poi estesa a più giorni. In effetti, tutti questi motivi ispiratori, tutti questi temmi liturgici finivano col confondersi e ogni gruppo di chierici negli stessi monasteri celebrava una sola grande festa d’inverno, nel giorno imposto da una tradizione sempre molto antica, oppure da una innovazione del tutto arbitraria che nasceva dall’imitazione dei vicini o addirittura dal desiderio di superarli.” (J. Hers)
Malgrado tutto questo, la vicinanza calendariale con il Solstizio d’Inverno il Carnevale s’impose prepotentemente nel tessuto popolare ed è facile sentir parlare di ‘feste delle calende’. Da qui nasce evidentemente la tentazione di vedere in esse una semplice eredità dei famosi Saturnali romani, tanto spesso citati dai censori e dai più eruditi ma mai dimenticati del tutto. In effetti sembra che fra la festa pagana consacrata nel basso Impero al dio Saturno e quella dei primi secoli del Cristianesimo vi sia stata solo una brevissima frattura, ciò per quanto la rivoluzione dei ‘valori pregnanti’ dell’epoca, nata come per gioco, si trasformò ben presto in satira, aspra o divertita che sia, a secondo dei casi, in qualcosa di diverso, tra il cinico e l’infernale.
Così, nella cornice ristretta del coro e del chiostro canonicale, nasceva una efferata critica dei costumi che, sotto toni umoristici, sorprende per i suoi accenti liberi e irriverenti: “Capitava di vedere sacerdoti e chierici mascherati e travestiti da donna che intonavano canzoni oscene, che giocavano ai dadi e mangiavano pasticci di carne nei luoghi sacri. Negli stessi luoghi venivano bruciate vecchie scarpe maleodoranti, nel frattempo che alcuni uomini mascherati da ‘pazzarielli’ e schizzati di mosto, per così dire ‘pazziavano’ per le strade delle città, mettendo alla ‘berlina’ i chierici e i nobili della società. Tutti danzavano in girotondi nel mezzo della chiesa saltando e correndo per le navate contorcendosi e urlando parolacce blasfeme tra le risa degli spettatori, intanto che altri con indosso maschere di bestie mostruose, di donnacce lussuriose e saltimbanchi d’ogni specie, occupavano le navate processionali.” (M. Colangeli)
In riferimento alla tradizione più remota, il Carnevale costituiva, e probabilmente lo è ancora, la rivincita popolare sulla rigida disciplina imposta dagli innumerevoli tabù religiosi di allora, rispettare i quali non era soltanto una questione di salvezza o dannazione, ma sempre più spesso di vita o di morte. Va ricordato che in quel tempo di persecuzioni religiose le persone venivano messe al rogo anche per cose di poco conto che delatori, appositamente istruiti dalle gendarmerie locali, mettevano a frutto. Tuttavia la ‘Festa dei Folli’ ma anche altre, come ad esempio la ‘Danza Macabra’ e la ‘Festa dell’Asino’, tra quelle più conosciute, oltre a superare ogni eccesso dei ‘tabu’ costituzionali, assumevano il carattere parodistico della burla farsesca, per meglio dire, della ‘carnevalata’ volgare quanto blasfema, pesante da sostenersi da parte dei governanti e dei rappresentanti religiosi che di volta in volta venivano presi di mira.
Del resto ogni aspetto della religione era fatta oggetto di scherno, a cominciare dall’altare maggiore sul quale si banchettava come sul tavolo dell’osteria; come pure di mettere in ridicolo i costumi stessi dei prelati spesso derisi nelle loro funzioni; o di re-interpretare i Libri Sacri con sottintesi volgari e osceni. Si arrivò finanche a ridicolizzare il rituale stesso della ‘Messa’, re-interpretata con ragli d’asino al posto dei responsori apertamente trasformati in canti osceni, seguiti da danze impudiche che spesso si trasformavano in orgie collettive all’uso pagano. Ma come è facile intuire sebbene le autorità preposte non vedevano di buon occhio il grossolano darsi alla ‘pazza gioia’ del popolo, in realtà non potevano impedirlo in quanto ormai era parte della tradizione popolare.
Usanze così profondamente radicate che s’imponevano agli occhi di tutti come diritti acquisiti e inalienabili, almeno fino a prima dei riformatori del XVI° secolo, tale che risultava estremamente difficile poter sopprimere. È in questa tendenza che si inserisce in modo logico la famosa ‘Festa dell’Asino’, di cui tanti autori hanno così spesso parlato, forzandone a volte l’immagine e il significato. Pretesto per festeggiamenti di dubbio gusto, per eccessi e irriverenze nel momento stesso in cui la processione che l’accompagnava usciva dalla navata centrale e dilagava in strada. Ciò per quanto anche la ‘Festa dell’Asino’, come inevitabile conseguenza di un rovesciamento delle gerarchie, resta però all’interno della chiesa medievale, una celebrazione cristiana, rituale e liturgica, ammessa e riconosciuta dalle autorità religiose e spesso preparata con la massima serietà. Come il brano che segue, tratto dalla ‘sequenza’ che, per ragioni diverse, non è qui riportato interamente.
Da ‘La fête de l’âne’, Orientis partibus:
« Orientis partibus
adventavit asinus,
pulcher et fortissimus,
sarcinis aptissimus.
Hez ! Hez Sire Asnes, hez!
. . .
Hez va, hez va, hez va, hez !
Biaux sire asnes, car alez,
Bele bouche, car chantez!»
Si può non essere d’accordo con questa argomentazione, ma tutto ciò finora detto è il riflesso di civiltà e culture che il ‘Carnevale’ in particolar modo mette in mostra nei suoi risvolti politico-sociali, incluse le sue stravaganze, i suoi giochi burleschi, gli scherzi e i lazzi con i quali si attestavano le cure e le ambizioni, nonché le identità e i rapporti di forza che attraversavano le diverse sfere del potere politico-religioso. Ne sono un esempio i ‘Carmina Burana’ desunti da manoscritti sacri redatti in latino risalenti alla metà del secolo XIII° che, durante il Medioevo furono accorpati e trasformati in parodie gogliardiche in volgare, rappresentati e più o meno tollerati all’interno delle celebrazioni religiose.
Da ‘Carmina Burana’: Tempus est iocundum.
“Tempus est iocundum, o virgines!
modo congaudete, vos iuvenes !
o! o! totus floreo!
Iam amore virginali totus ardeo;
novus, novus amore est, quo pereo!
Cantat philomena sic dulciter,
et modulans auditur; intus caleo:
o! o! totus floreo!
Iam amore …
Flos est puellarum, quam diligo,
Et rosa rosarum, quam sepe video :
o! o! totus floreo!
Iam amore …
Veni, domicella, cum gaudio !
veni, veni, pulchra! Iam pereo!
o! o! totus floreo!”
Parodie di Sante in forma di rappresentazioni venivano allestite sui sagrati delle chiese e all’interno di esse, e più o meno tollerate dalla Chiesa dominante, a seconda dei governanti che fossero cattolici o protestanti, italiani, francesi o tedeschi. Trascrizioni di ‘inni sacri’ e ‘preghiere’ in volgare divennero così popolari da entrare a far parte di ‘messe profane’ intitolate agli stessi figuranti che le rappresentavano, come ad esempio la ‘Missa gulatorum’ ossia dei ghiottoni; la ‘Missa potatorum’ ossia dei beoni e la ‘Missa de’ villani’ ecc. spesso accompagnate da strumenti tipici come tamburelli e zufoli ed eseguite in forma ‘a ballo’, in girotondi e sfilate processionali.
All’occorrenza la ‘Festa dei Folli’ costituiva la provvisoria emancipazione dei subalterni, ai quali si lasciava di celebrare la loro breve sovranità mediante eccessi tanto più insensati in quanto destinati a durare per brevissimo tempo. Il rovesciamento dei ruoli sociali trovava quindi nuova espressione nella cerimonia dell’intronizzazione di un ‘papa’ o ‘vescovo dei pazzi’ che, issato su di un carro, era trascinato in corteo fra urla, lanci di uova e ortaggi, cui faceva seguito una folla euforica di chierici, giovani coristi e diaconi danzanti. Erano gli stessi ‘folli’ a custodire le chiavi del manicomio; addirittura potevano entrare nelle case e permettersi licenziosità più o meno piacevoli, e se avevano il volto coperto da una maschera non erano obbligati a rivelare la propria identità. Si ripeteva così l’inversione dei ruoli consuetudinari e il rovesciamento delle gerarchie conosciute fin dall’antichità e mai scomparse dalla memoria popolare.
Ma leggiamo insieme almeno due filastrocche tradizionali legate al Carnevale nei testi trasmessi da Dodi Moscati, interprete dell’area umbro-laziale che li ha ripresi dalla viva voce degli abitanti dei luoghi di riferimento regionale:
E qui passa il Carnevale.
“Qui passa il Carnevale
e tra suoni balli e canti
gli è la scena degli amanti
ne succede in quantità.
Carnevale non te ne andare
Carnevale non te ne andare
io ti ho fatto un bel mantello
ogni punto un fegatello
Carnevale non te ne andar.
E more, e more, e more lariciunferarillallero
E more, e more, e more il Carneval.”
Tuttavia, lungi dall’essere considerata una ricorrenza straordinaria per quanto pagana, una volta entrata a far parte del costume popolare e nel patrimonio culturale di molte regioni italiane e di gran parte d’Europa, la ‘Festa dei folli’ fu portatrice di notevoli cambiamenti nelle consuetudini musicali canore e strumentali all’interno della ‘musica sacra’ secolarizzata dalla Chiesa nel Canto Gregoriano.
Ciò che aprì la strada a un certo modo di interpretare il canto profano propriamente detto, nella forma dello ‘stornello a contrasto’, della ‘serenata’ ecc. entrati in seguito nelle esibizioni tipiche del Carnevale , come appunto si legge in numerose e particolareggiate descrizioni lasciate dai contemporanei e, successivamente, in molte manifestazioni regionali entrate nel patrimonio tradizionale popolare.
Ne è un tipico esempio il ‘Ballo delle fornaccine’ tratto dal ‘Carnevale di Bibbiena’ risalente al 1300, in cui si narra che “..nell’ultimo giorno di Carnevale due gruppi di suonatori erano soliti sfidarsi per le vie e le piazze del paese a raccogliere denari. Al termine della raccolta i gruppi si riunivano in Piazza Grande e davano avvio ai balli. La banda musicale raccolta presso la fonte, veniva circondata dalla folla che su un motivo uniforme si metteva a cantare alcune strofe di ballate molto conosciute. Nel frattempo, in un’altra piazza era stato organizzato un grande falò di ginepro, attorno al quale alcuni tra quanti giunti dalle campagne vicine, sempre assai numerosi, traevano gli auspici per la raccolta, dalla buona o la cattiva riuscita del falò.” (M. Colangeli)
Quella detta ‘delle fornaccine’ riproposta in tempi più recenti dalla viva voce di Caterina Bueno è forse la ballata più conosciuta giunta fino a noi di questa tradizione:
“Eran le Fondaccine che han fatto un ballo
bello ballo per amor
eran le Fondaccine che han fatto un ballo.
In mezzo di quel ballo c’è nato un pomo,
bello pomo per amor
in mezzo di quel ballo c’è nato un pomo.
Di là ne vien un uomo padron del pomo,
bello pomo per amor
di là ne viene un uomo padron del pomo.
Cavasi le scarpette s’alza nel pomo.
Bello pomo per amor.
Cavasi le scarpette s’alza nel pomo.
Sale di rama in rama fino alla cima,
bella cima per amor
sala di rama in rama fino alla cima.
Colse le tre ramelle delle più belle,
belle, belle per amor
colse le tre ramelle delle più belle.
A ognuno ne dié una salvo alla bruna,
bella bruna per amor
a ognuna ne dié una salvo alla bruna.
E benché son brunella son la più bella,
bella balla per amor
e benché son brunella son la più bella.”
Fondaccini erano chiamati gli abitanti del rione Fondaccio. Il ‘padron del pomo’ è riferito a Marco Tarlati che nel 1359 ebbe il dominio di Bibbiena. Il continuo riferimento allusivo si pone maggiormente in evidenza, allorché i partecipanti danno inizio al testo tradizionale della ‘Mea’, mostrando all’occorrenza con applausi scroscianti la loro gioia per i più bravi improvvisatori di rime.
La fuga della Mea.
“La Mea la fa ‘l bucato
per conquistar su’ amor;
la Mea la lo lava
alla fonte dell’amor;
la Mea la lo rasciuga
alla spera del sol;
la Mea la lo ripiega
all’ombra dell’allor;
l’alloro l’era verde
la Mea s’addormentò;
di lì passò ‘l su’ amor
la Mea lo sospirò;
non so sospirar più Mea
ch’io ti voglio sposar.
Le vie le son sassose
cavalli son sferà;
suo padre alla finestra:
‘lasciatela pure andar’.
Trovò un barcarolo
‘mi vuoi tu imbarcar,
cento zecchini d’oro e borsa ricamà’;
suo padre alla finestra:
‘lasciatela pure andar’.
‘Amor se sei Giulietta,
amor senza danar’;
suo padre alla finestra:
‘lasciatela pure andar’.”
Di riferimento alle celebrazioni canore propriamente dette che, al tempo stesso, sono la testimonianza viva della presenza magica di un mondo indubbiamente superstizioso di cui è impregnato tutto il nostro territorio, dal nord al sud, sono le ‘ballate a tema’ e le ‘canzoni amorose’ a scopo liberatorio e d’intrattenimento, strettamente legate alle tradizioni orali-narrative successivamente trasferite nei racconti e nelle leggende popolari delle nostre regioni. È così che giungiamo sulle montagne del bresciano in quel di Bagolino dove, in occasione del ‘martedì grasso’ le ragazze da marito si barricano in casa, mentre gli uomini, travestiti con sfarzosi costumi, s’improvvisano ballerini per conquistarle, al ritmo di ‘ariose’ e ‘polesane’. L’elemento caratterizzante del loro ricco costume è il cappello e la maschera di tela dipinta di bianco che li rende tutti indistintamente uguali e al tempo stesso dona loro un carattere leggiadro e arcano. Qui, nel mezzo degli scherzi ci si insegue per colpirsi nelle ‘glorie maschili’ e si rinnova il detto: “di carnevale ogni scherzo vale e, peggio per lui se dopo fa male”.
A Napoli, ad esempio, oltre allo scambio dei ruoli, assumeva aspetti quanto mai spettacolari l’orgia mangereccia, in cui l’ossessione della ‘scorpacciata’ era giustificata dalla prossimità della Quaresima, tipica di una cultura in cui la fame era la regola. Infatti già nel XVIII° secolo, si costruiva un teatro detto ‘della cuccagna’ con un mucchio di vivande d’ogni sorta, in cima al quale troneggiava il dio Saturno dell’abbondanza. Quindi, all’ora prestabilita lo sparo di un cannone tuonava e una folla immensa dava l’assalto alla montagna di cibo. Ne seguiva un’orgia immane di cui si trovano riferimenti in molta letteratura giunta fino a noi. Del Carnevale campano, più esattamente a Montemiletto in provincia di Avellino, ancora oggi si possono rintracciare testimonianze nelle rappresentazioni pubbliche dei cantastorie eseguite in occasione della festa. Ne è un tipico esempio ‘La canzone di Zeza’, dedicata appunto a Zeza, personaggio della tradizione popolare tratto da un vezzeggiativo napoletano del nome Lucrezia.
La canzone di Zeza – ovvero “redeculuso contrasto de matrimonio tra Pollecenella, Zeza e lo studente Nicola Pacchesicco”. Canto carnevalesco ancora vivo nella provincia napoletana, che alcuni studiosi vogliono derivato per la particolare struttura teatrale, da antiche ‘atellane’:
“Pollecenella – Zeza vi ca j mo jesco,
statte attienta a ‘sta fegliola
tu ca si mamma dalle bona scola.
Nu la fa prattecare
cu tutte ‘ste ffegliole
ca chello ca non sape se po ‘imparare.
Zeza – Non ce pensare a chesto
marito bello mio
ca ‘sta fegliola l’aggio ‘mparatt’io!
Io sempre le sto a dire:
‘na femmena ‘nnorata
È cchiù de no tesoro assai stemmato.”
. . .
“ I protagonisti della rappresentazione – scrive R. De Simone – sono cinque vecchie glorie tra i 50 e i 60 anni di età che, chiamate a impersonificare altrettante figure del passato, tra cui Zeza, Pulcinella, la loro figlia Tolla, il Dottore e lo studente/marinaio, danno luogo a un ‘contrasto’ di genere faceto, nel corso del quale sorgono contrasti e litigi fino ad arrivare agli insulti e alle fucilate. Alla fine però la ragazza sposa il suo amato e la festa si conclude con una grande ‘quadriglia’ ballata dalle coppie, alle quali si aggiunge tutto il vicinato.” La riuscita di questa rappresentazione che solitamente si svolgeva nelle piazze infatti era legata alla partecipazione del pubblico che vi prendeva parte. L’ultima di cui si ha ricordo è avvenuta a Napoli in Galleria, organizzata e diretta da Roberto De Simone ed eseguita dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare che, in seguito, la trasformò in un evento di portata ‘storica’, la cui eco ha varcato i confini regionali per protrarsi a livelli nazionali e internazionali, grazie anche al successo strepitoso in quegli anni della NCCP che ne realizzò un Lp per l’etichetta Rare.
Nei giorni di Carnevale, siamo ancora a Napoli, si svolgevano spettacoli di un certo rigore coreografico detti ‘balli di sfessania’, una tipica danza cinquecentesca napoletana alla quale si fa risalire la forma più antica della ‘tarantella’ danzata in chiave coreutica. Secondo alcuni questa era rappresentata da personaggi portatori di maschere successivamente assimilate ed utilizzate dagli attori della Commedia dell’Arte come segmenti comici dei loro spettacoli. Attualmente denominata ‘Vecchia del Carnevale’ viene eseguita, in forma musicalmente assai corrotta da uomini travestiti da donna, sebbene siano associati e studiati come facenti parte del repertorio teatrale piuttosto che come forma coreutica. Questi rivestono una grande importanza dal punto di vista etnografico in quanto vanno collocati al centro di un lungo processo evolutivo che dal tarantismo, grazie alla contaminazione del fandango spagnolo, ha originato la tarantella come danza di corteggiamento basata sull’affermazione del binomio maschio-femmina.
Ballo di Sfessania.
“O Lucia ah Lucia,
Lucia, Lucia mia,
stiennete accostate ‘nzeccate cca, Lucià
vide ‘sto core ca ride e ca sguazza
ausa sto pede ca zompo canazza.
Cuccurucù
zompa mo su
veco ca sauto ca giro ca zompo
nnante che scompo
zompa Lucia ch’ addanzo
io da ccà
tuba catubba e nania nà.
O Lucia ah Lucia
Lucia, Lucia mia.
Cotogni, cotogni cotognà, Lucià
vide chest’arna
ca scola ca squaglia
tiente ca passo sautanno ‘na quaglia.
Cuccurucù
sauta mo su
veco ca sauto ca torno ca roto
vi ca me voto
sauta Lucia ca zompo io da ccà
uh che te squosse e persovallà.
O Lucia ah Lucia
Lucia ah Lucia
Lucia, Lucia mia
cocozza de vino me sa, Lucià.
Vide cannella ca tutto me scolo
tiente ca corro ca roto ca volo.
Cuccurucù
rota mo su
veco ca roto ca corro ca giro
vi ca sospiro
rota Lucia ca scampo mo ccà.
‘ngritta ccà ‘ngritta e cuccurusà
O Lucia ah Lucia
Lucia, Lucia mia.”
A gettare nuova luce su questa antica forma coreutica è il saggio “I Balli di Sfessania Fra Tarantismo e Tarantella” del ricercatore isernino Rino Capone, già autore di vari saggi e studi sulle danze antiche e moderne. Si tratta di uno studio che raccoglie le risultanze di un lungo e rigoroso percorso di ricerca, che ha visto l’autore prendere in esame una corposa mole di documenti storici, provenienti da diversi circuiti internazionali, che spaziano dalle opere di Del Tufo e Andreini fino a Salvator Rosa, senza dimenticare le ventiquattro incisioni (foto di copertina) realizzate dal manierista francese Jacques Callot (1592-1635), che descrivono e documentano in modo magistrale non solo le precipue modalità coreutiche ma anche le maschere della commedia dell’arte italiana ad essa collegate.
All’insegna delle primitive feste agrarie contadine e delle medievali ‘Feste dei Folli’, il Carnevale a Napoli tendeva a mescolare in un delirio illimitato ogni singolo aspetto dell’intrattenimento, dalla parodia a giuoco, dal mascheramento alla frenesia del ballo, dallo spettacolo alla baldoria da osteria. Vi erano per così dire riassunti tutti gli aspetti, tra i più eclatanti della tradizione meridionale riversati all’interno di quel ‘mondo magico’ più volte annunciato che affonda le sue radici nel fanatismo religioso e per questo assai vivace. La più grande attrattiva di questo connubio è pienamente riassunta nella figura di Pulecenella, l’antica maschera sannita, bitorzoluta e cupa, che al di là dei suoi lazzi e scherzi, rappresenta la parte più oscura dell’anima umana, ma anche quella amaramente sollazzevole dello ‘scherno’ che la natura lancia all’umanità tutta, sollecitandola alla ‘vita’ sopra ogni cosa e, dalla quale, imparare ha significato di eternità. E che per questo lancia i suoi strali e i suoi strazianti lamenti d’amore.
Serenata di Pulecenella.
“Ué, ué, ué s’affaccia
ca sta Pulecenella, Pulecenella…
le caccia la linguella
e dice i’ sto cca, i’ sto cca…
Ué, ué, co sta resella
co st’uocchie e co sti vinoccole
comme a spruoccole
me staje a strazià, a strazià…
Gioia de st’alma mia jesce a’mmalora
si craje tu truove ‘nfosa sta chiazza
so llacreme d’ammore e no sputazza.”
Stando allo studioso Harvey Cox, “La scomparsa della ‘Festa dei Folli’ ha segnato una svolta nella storia della nostra civiltà, un segno del profondo mutamento in cui sono andati perduti certi valori culturali come la fantasia, l’immaginazione, il gusto per la satira e la beffa con cui si cercava (e talvolta si riusciva) a mascherare la paura delle tenebre e della morte.” Dallo storico Roland August apprendiamo invece quanto segue: “La cosa più sorprendente è l’esistenza nell’uomo di un bisogno profondo di negare le credenze e le istituzioni più serie, riducendole a livello di buffonerie. Un atteggiamento, forse, tuttavia la festa è la negazione dell’ordine e, non potendo eliminare l’anarchia che è dentro di noi, la società la organizza, la incanala nella festa, conferendole così le caratteristiche di una istituzione. La derisione cessa così dall’avere conseguenze pratiche, in quanto isolata dalla verità quotidiana : il giorno successivo alla ‘festa dei folli’ i partecipanti tornavano ad essere buoni cristiani senza che in loro fossero rimasti strascichi, nel senso che non si sognavano neppure di mettere veramente in discussione l’ordine della società. La festa era insomma una parentesi di ‘follia’.”
Come accade in tutti i Carnevali di qualche rispetto che si celebrano in molte città e piccoli centri della nostra Italia, in ognuno è mantenuto un certo riguardo per le tradizioni più antiche all’interno di manifestazioni folcloristiche organizzate all’insegna di una socializzazione pià recentemente andata smarrita. Come ad esempio a Cento, in provincia di Ferrara, dove ogni anno si tiene l’ormai famosa rappresentazione del ‘Testamento di Tasi’, in cui si confeziona un mascherone di cartapesta avvolto in un mantello nero, appunto il Tasi che impersona il Carnevale. Dapprima si prepara un rogo di fascine al centro della pubblica piazza, dove, prima che venga messo sul rogo e finire bruciato, il Tasi leggerà il suo testamento riferito al lascito che intende fare ai cittadini e basato sugli avvenimenti locali ed anche nazionali o internazionali con aggiunta di una buona dose di satira. Scritto appositamente per l’occasione in forma di ‘zirudela’, una forma tipica della poesia dialettale centense, viene rinnovato da poeti e scrittori locali che partecipano alla sua stesura.
Una grande ‘fagiolata’, a base di salsicce e carne di maiale, ed ovviamente di fagioli, si svolge ogni anno a Biella durante il ‘lunedì grasso’ nel rione S. Pietro parato a festa per l’occasione in cui si ingaggia una vera e propria battaglia con lancio di coriandoli. Intanto, nel resto della città si svolgono balli e brevi manifestazioni di carattere popolare come ‘la cuccagna’, la ‘corsa dei sacchi’ e ‘la pentolaccia’, ma è comunque la ‘fagiolata’ che infine riscuote il maggior successo, per il suo contributo mangereccio. Questa ha luogo in un ampio cortile dove diversi cuochi vestiti nel costume che li distingue, preparano tra i cinque e i nove quintali di minestra di fagioli che poi viene distribuita a tutti i partecipanti. Non prima però che siano arrivati il ‘Gipin’ con sua moglie ‘Catlina’ e il loro figlio ‘Gipinot’ a dare il via all’abbuffata generale. La ‘festa’ continua fino al fatidico ‘martedì grasso’, ultimo giorno di Carnevale, con ‘Il processo al Babi’, un grande rospo appositamente allevato che viene portato in gabbia , processato per le sue ‘malefatte’ verbalmente oscene, rivolte in chiave satirica alle istituzioni e ai personaggi più in vista della città. Ma è quando il ‘Babi’ viene messo simbolicamente al rogo, a rappresentare la morte del Carnevale, ecco che la campana maggiore scocca la mezzanotte e tutto ha fine.
Famosi tuttavia restano i carnevali che si svolgevano nelle grandi città e nelle corti dove assumevano forma spettacolari di gare pubbliche di canto, di recitazione e di eleganza, così come di estro della parodia e della satira, assecondando le forme preesistenti di spettacolo e festeggiamento pubblico nelle sfilate e nelle processioni, nelle giostre e nei palii così come nelle ‘quintane’, alla cui base stava il divertimento ma, spesso, anche il rischio intrinseco del gioco d’azzardo che prende la mano e più spesso l’intraprendenza accecante della vita. In ogni spettacolo popolare comunque, e ancor più nel Carnevale, è ancor sempre la musica a svolgere la parte più accattivante e culturalmente più interessante della festa, con l’accompagnamento di canti e balli da parte delle allegre brigate che vi prendono parte. Fin dal XVIII° secolo i festeggiamenti per il Carnevale divennero talmente sofisticati da rientrare nei termini del costume così come nel linguaggio, cioè nei canoni dell’estetica e della ricercatezza delle grandi corti europee che facevano a gara per fastosità e splendore, facendo mostra di sé nelle rappresentazioni pubbliche di piazza e in teatro.
Un esempio eclatante nel suo genere era il Carnevale Romano che, a suo tempo, conobbe un grande momento di splendore, in cui si portavano in piazza le ‘corse dei cavalli’, numerosi ‘carri allegorici’, nonché ‘giostre barocche’ e lo spettacolo dei ‘funamboli’ che più di altri raccoglieva il plauso del pubblico che riempiva le piazze. Come riportato in un annale risalente al XVI° secolo, durante il Carnevale Romano era in uso tra il pubblico festante bombardarsi ‘per ischerzo’ con uova preventivamente svuotate e riempite in parte di sabbia e pepe, successivamente sostituite dal lancio di rape a causa degli alti costi da sostenere. Una costumanza che venne ripresa più tardi introducendo l’usanza del lancio di confetti dolci, poi sostituiti con palline di gesso più leggere e colorate, in seguito trasformate nelle palline di carta che si vuole siano le antenate dei comuni coriandoli.
Ma va qui ricordata la ‘Festa delle lanterne’ così detta per le candele accese che venivano regolarmente spente l’un l’altra, allorché s’inconrava la persona che stava al gioco sottile e penetrante dello scambio amoroso che si concludeva quasi sempre, a notte inoltrata, con lo scambio di baci e regali, e spesso di accoppiamenti amorosi sotto un cielo illuminato da uno scenografico spettacolo pirotecnico.
Tutte le notti in sogno.
“Tutte le notti in sogno me venite
diteme, bella mia perché lo fate?
E chi ce vié da voi quanno dormite?
Vola, vola l’aritornello
core mio bello nun me scordà.
Pe’ volé bene a voi ce n’ho passate
de pene e patimenti e lo sapete
e adesso bella mia così me fate.
Vola, vola l’aritornello
core mio bello nun me scordà.
Le stelle su ner cielo so’ millanta
ar marinaro disse: conta, conta
quella che cerchi tu sempre ce manca.
Vola, vola l’aritornello
core mio bello nun me scordà.”
Del Carnevale Romano si ricordano figure celebri quali: Ghetanaccio, Rugantino, Meo Patacca, Mastro Titta, Marco Pepe, Gigi er Bullo, tutti personaggi reali divenuti in seguito ‘maschere’ del teatro popolare. Ognuno dei quali ama la propria donna e ne è riamato, che sia la marchesa di turno o la duchessa di qualcosa, ma anche, e soprattutto, la popolana Nina, o Nuccia o Ninetta. A ognuna era dedicata almeno una ‘serenata’ che in particolare assumeva forme diverse: a dispetto, lasciva o d’invito che, per quanto si volesse, preservava comunque una prerogativa appassionata.
La treccia bionda.
“Bella regazza dalla treccia bionda
per nome vi chiamate Veneranda
li giovani per voi fanno la ronda.
Papà non vole
mamma nemmeno
come faremo a fare l’amor?
Ciavete du’ bellissime pupille
a ‘gni gueriero fate abbassà l’arme
la fija sete der guerrieo Achille.
Papà non vole
mamma nemmeno
come faremo a fare l’amor?
Ciavete l’occhi neri e ‘r petto bianco
de qua e de là du’ lampene d’argento
chi ve vò bene a voi diventa santo.
Papà non vole
mamma nemmeno
come faremo a fare l’amor?”
Per quanto alcuni elementi preminenti siano ormai comuni ad ogni carnevale indistintamente, molti sono tuttora quelli che si celebrano in gran pompa, nei luoghi in cui il tempo del Carnevale si colorava di luci, di lustrini e di costumi sfarzosi, fruscianti sui selciati delle piazze e dei teatri e la cui fama che perdura ancora oggi. Fama che ha solcato i confini della licenziosità da divenire, più semplicemente, un fatto di costume che si ricollega alla storia del territorio, e comunque contrassegnato da un termine, come si vuole nel rispetto calendariale delle ‘Ceneri’ che precedono la Quaresima, il cui significato va oltre la messa al rogo dell’inverno ce preannuncia la morte simbolica di Cristo.
Usanza viva ancora oggi in molte altre regioni della nostra penisola e che riassume il carattere primitivo del sacrificio rituale, e come questo coincide con la fine della stagione invernale. L’inverno infatti, è spesso rappresentato dallo spauracchio della sua ‘morte’, qui fatto oggetto di insulti, lì dato alle fiamme, in altro luogo annegato, altrove impalato e via dicendo. Il perché di tanta crudeltà – dicono i teorici – costituisce da sempre il ‘capro espiatorio’ di tutti i mali sul quale vengono scaricati i peccati della comunità, quegli eccessi ai quali l’umanità si è abbandonata durante le feste e, forse, durante tutto l’anno appena trascorso.
Oggi che il ritmo del lavoro si è andato modificando profondamente, lasciando all’individuo spazi sempre più ampi di tempo libero, la voglia del divertimento impresso dal vecchio ‘carnevale’ potrebbe anche non conoscere fine. Ma non è così, il tempo della ‘festa’ come lo si intendeva nelle comunità contadine o nelle corti medievali ha perso il suo significato e anche il suo fascino; il ‘divertimento’ è vissuto a un diverso livello, indubbiamente astratto, privo di partecipazione e attrattiva e, soprattutto, privo del fervore che l’animava.
Il Carnevale ha per così dire assunto nuove forme di svago, tuttavia manca della sua parte creativa data dall’immaginazione e dal ‘mascheramento’ di un tempo, in breve ‘..l’uomo moderno è prigioniero della logica, della serietà che lo condiziona’. (H. Cox)
Oggi più che mai c’è bisogno di ritornare alle feste collettive di piazza e di costume a cui tutti possano partecipare con spirito di solidarietà. Soprattutto in ragione di quella solitudine che è tornata a farsi sentire in modo così preminente, a causa della perdita del proprio intrinseco significato di compartecipazione alla solidarietà. Quella che era la creatività e la fantasia di un epoca, sembra oggi aver ceduto il posto alla logica, lo scherno e il lazzo sacrificati alla ragione, il fantasma del Carnevale aver assunto il volto del passare del tempo dietro una smorfia, un bernoccolo, un naso, nell’espressione crucciata di una ‘maschera’ che non sembra avere alcun domani.
Resta da vedere se la nostalgia del ‘carnevale che verrà’ potrà assumere quella forza tale da creare e preservare le nuove forme di svago che andranno a sostituire le antiche tradizioni che, se abbandonate o quanto meno dimenticate, resteranno mute dentro lo specchio della storia, che è poi la nostra storia. Ma che cos’è il Carnevale se non lo svolgimento di una defezione dello spirito che ritrova nel tempo della festa la sua dimensione arcana e la sua sconsiderata allegrezza?
Meditate gente, meditate … nel frattempo:
“Ciascun suoni, balli e canti //
Ciò c’ha esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto sia.
Di doman non v’è certezza!” (Lorenzo de’ Medici)
(continua sul ‘Carnevale di Venezia’)
*
.jpg) - Poesia
- Poesia
Cristiana Fischer … o la forma ’poetica’ del levare
“Finalmente non ho altro da fare che scrivere poesie…”,
annuncia l’autrice di un certo numero di liriche inviate e pubblicate sulle pagine di larecherche .it , la rivista letteraria intitolata all’opera magistrale di Marcel Proust che nelle sue pagine annovera, oltre a una sezione specifica dedicata alla poesia, anche un Premio annuale “Il Giardino di Babuk”, quest’anno giunto alla sua IV edizione. In realtà non conosco se la poetessa le abbia mai inserite in una raccolta o se abbia mai partecipato al suddetto Premio, al quale altresì le rinnovo l’invito. Tuttavia, poiché in alcune sporadiche occasioni ha rivolto la sua attenzione con particolare sensibilità e profondità a testi pubblicati da altri poeti presenti nella rivista, e nello specifico ai miei, ho pensato di rivolgere uno sguardo attento alla sua produzione letteraria, seppur riferita alle sole poesie, non tantissime, che mi è dato leggere, nella speranza di farle cosa gradita.
Inutile dire che non conosco di persona l'autrice e che quindi non so nulla di lei, l’unico fatto rilevante della sua scrittura è contenuto in quell’incipit cui ella affida la sua esistenza poetica, quasi fosse nebbia notturna di una memoria antica, nella quale si smarrisce e si ritrova, barricata o forse protetta, dietro un argine che divide due sponde: l’amore cosmico fervido e instabile per tutto ciò che ruota attorno al creato, con particolare attenzione alla natura arborea e floreale in cui ha scelto di vivere; e la mite animalità corporale che si scioglie nell’ascolto di echi deliranti e perduti come per un convito di adescamenti dentro lo specchio imfranto del tempo …
‘Ma la morte non ha cuore se il cuore non muore’ - scrive la penna della poesia universale. È allora che nella vana ricerca della propria esistenza l’eco che dal bosco profondo sale, sollecita l’orecchio all’ascolto interiore dei propri ‘spazi frattali’, di quegli interstizi ‘transgenici e transcorporei’ che danno forma al soggetto impersonale che s’agita nell’anima corporale del suo essere ‘perdutamente umana’:
“ah non sono io né qui né lì, né viva né mai più io.. (...)
brava! brava! mi dicono
è così difficile capire che amo
e si capisce se si ascoltano
parole dell’amore tra parole
che d’amore non parlano
se non per amore
rivolte e indirizzate (...)
che nel campo d’onde collegato
non entra in risonanza né in interferenza
piane virtuose verdeggianti infiorate
che l’aria non impregnano (...)
l’infinito sentire del reale
chiamare domandare il mio cieco
amore incapace di dare”
Non siamo ancora alla ‘forma poetica del levare’, abbiamo solo sfiorato lo specchio infranto dell’acqua amniotica in cui la vita conosce la sua germinazione, e ne trascrive le ‘note’ sul pentagramma della futura esistenza:
“…è la poesia che scrive me, (...)
ballando leggerezza sulle punte"
(...)
‘ma accoglie la memoria altrui
cercando la bellezza nel creato’ (nota d’autore)
(...)
"metti il tono del verso dove vuoi..”
Quel ‘levare’ che in musica anticipa e segue il ‘battere’ determinando l’andamento ‘lento’ o ‘presto’ del tempo, qui espresso come tempo assoluto: ‘afferente e discendente’ che s’intende perseguire nella vita e che, a mio parere, è la chiave di lettura del connubio musica-poesia di Cristiana Fischer, per quanto frutto di una rivisitazione che la rapporta a un presente mai definitivamente accettato. E, tuttavia ricca di una scrittura paritetica tipica del ‘canto e controcanto’ nell’uso che ne facevano gli antichi aedi, con la quale evocavano gli déi, gli spiriti dei boschi e le ombre dei defunti o, anche, la turgida fertilità dell’inverno davanti al rigenerarsi del creato:
“siamo gli spiriti dell’aria
ci distingue fogliolina all’ascella
del ramo siamo ospiti
invisibili in corpi penetrabili
siamo incontri e influssi
di sostanze viventi siamo rari
natanti in vortice vitale
ci incalza la tempesta infernale
e scorrendo memoria rendiamo
tributo al Maestoso tremore
siamo come i viventi nel liquore
della profondità in densità oscura
corpi di marea colonie di organi
radici e architetture di ingegno in misure
di conoscenze vere
che certezza chiama in vari modo
primario riconoscimento
relazione ai vivi orientamento
figurale in intrico d’ampiezza”
C’è una sorta di verità sottesa in ciò che la poetessa Cristiana Fischer scrive ma che non riesce ad esternare appieno in una compiuta ‘simmetria concettuale’, causa la quale il suo linguaggio si scompone in ‘incertezza simbologica’, pur nella volontà “di ampliare la distanza del rapporto” e nello “sforzo di nominare la differenza dove sembra esserci in-differenza”. Un’incertezza questa che, riflessa nello specchio-magico dell’alterità, è inevitabilmente soggetta alle più diverse interpretazioni, quasi le molteplici immagini in essa sollecitate trasfondano in una unica identità … come appunto nella lirica qui riportata:
“guardami e guardati allo specchio
io profondità del tempo
tu segno invertito in simmetria
io misura tu i meandri del tratto
io trasparenza tu il riflesso
e sia lucemateria o gibigianna
io invisibile nella distanza
tu immagine cieca in lontananza
apri un varco alla mia figura
e fissa la mutevole sembianza
ferma le danze del pensiero
in forma artiglio del vero”
Tanto basta a descrivere l’addivenire di ‘viaggi interiori’, di un superamento di ‘soglie’ che, oltrepassato il muro del silenzio, introducono alla musica delle sfere, vicine a quel ‘levare’ che s’apre alla creazione, in cui cede l’incertezza di essere alla prerogativa del sapere, onde la conoscenza si trasforma in luce, dove finanche la morte diventa spoglia vivente:
“..ascolta – mi dice – il silenzio
ascolta l’eterno
il vuoto che insidia i tuoi sensi
(...)
..mi concentrerò per non morire
non in meditazione che condensa
la mente e il corpo in materia densa
secca e imbalsamata
in materia abbandonata al suo scadere
in sostanza naturale trasformata
a sola essenza spirituale
(...)
..mi solleverò per non morire
sarà beato lasciare
le spoglie viventi alla materia inerte
e volare
in trasformato ente
spirituale”
Ma all’assenza invocata fa riscontro la presenza cosciente d’essere qui ed ora a confrontarsi col quotidiano, con la cronaca dei giorni che infligge frequentazioni e continue domande sulla perplessità del vivere: “memoria da creare … allevare ricordi?”. Come un grido levato a chiedere perché?, che pure è scritto tra le righe delle sue poesie ma che non leggiamo e forse non leggeremo mai, perché la sua forza (o forse la sua debolezza) ricade nell’incapacità di quel ‘levare’ la voce a sostegno o al diniego di una qualche affermazione che la poesia non richiede e non concede ad alcuno:
“prima cadranno le foglie dei frassini
colore d’arancio e di vino
e gli aceri color di mora
e il sorbo rosso trionfale
un solo giorno spoglierà di vento
l’ulivo resta nei suoi fumi
grigi versanti. Intorno la foresta
di rami all’aria bianca
(...)
attesa d’inverno che asciuga
nuovi succhi di carne
artiglio d’ignoto sulle vesti
in fila i migranti respinti
come antichi popoli che hanno
perso la terra
le luci e il freddo in una morsa
(...)
che stringe gente libera alla fatica
a obbedire e servire perfino”
‘fratelli di una schiavitù nuova’ (nota d’autore)
Sul levare * (C. Fischer)
“..se seguito a sottrarre – nel comporre poesia / resterà un testo di premesse / di avvertimenti e rimandi … all’inespresso / allusioni al senso del tutto / illusione che sia sostanza (del) reale / non fiato e finzioni … di parole / nel sacchetto di pelle gusci secchi / ai confini dell’intonazione / segno l’accento dove tu / l’intento: è sempre ‘forma del levare’ sul rumore …”
Il ‘lavoro’ del poeta:
“.. una grande stanza / un musicista d’avanguardia con le iridi blu // e un’ampia pupilla / soffice come un cuscino / in effetti stavo dormendo / e nessuno guardava fuori / (…)
tutto avveniva in un vecchio appartamento /(…)
lavoro sullo schermo con cinque finestre / la posta una conversazione (anche due) / i testi poetici e un articolo / di scienza o di filosofia / splendidamente si intrecciano / scherzo sorprese e fantasia / e quel trasporto mentale / che la realtà virtuale dispone / nella contemporanea fruizione / di affetti ragione e armonia /(…)
la poesia è scrittura concentrata / in cui le parole si concertano non solo / si rinforzano di significato / si contraddicono si innamorano / l’una dell’altra e cercano parentele / e lontane amicizie e procreano / succedanei curiosi o progettano / cattedrali e teorie /(…)
se rinasco divento musicista / non parlo più / scompongo inseguo afferro / mi arrendo mi confonde mi consuma / il tempo /(...)
ah la poesia, che eterna, / felicità del parlare del pensare / e del ragionare! /(…)
segno l’accento dove tu … / metti il tono del verso dove vuoi / (…)
ma io rido e vedo conflitti / aspetto paziente sfortuna e malanni / e scherzo sul tempo che mangia la vita /(…)
ma ora da sveglia c’è solo il presente / e un anchilosante futuro /(…)
non oggi non ho fantasia / solo tragici avvertimenti di follia /(…)
ma un dio inconoscibile e muto / ascolta!, mi dice nell’anima mia”
Cristiana Fischer ha scelto di vivere in un bellissimo bosco delle montagne abruzzesi, “dove finalmente – come lei stessa scrive – non ho altro da fare che scrivere poesie “, che pubblica in rete sul sito Poliscritture, su Facebook e sulle pagine di La Recherche.it , sezione ‘poesia’.
*
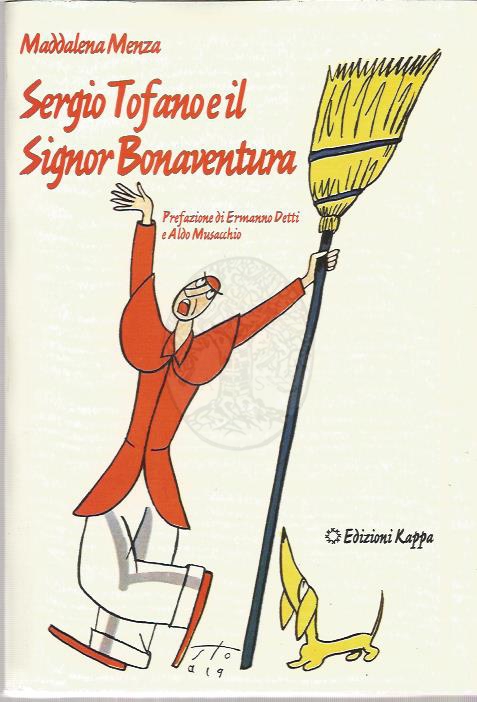 - Libri
- Libri
Auguri al Signor Bonaventura di Sto
Quella volta, nel Giugno del 1988, mi ritrovai a Bari per la Fiera del Levante, nei giorni in cui si apriva la mostra mercato nazionale di cartoline d’epoca, stampe, libri e oggetti antichi: “Expo Bari Collezionismo”. Fu in quell’occasione che mi trovai a tu per tu con un prezioso cofanetto tutto giallo in tre volumi contenente teatro, novelle, poesie, scritte e illustrate da Sto, alias Sergio Tofano, uno dei più grandi attori del Teatro italiano, capocomico, regista, scenografo e costumista, che la Rizzoli aveva appena editato un anno dopo la sua dipartita, nel 1974. Mettendo così un ‘punto fermo’ da cui partire nella valutazione di un ‘grande del Novecento’.
Dipartita sì, perché Sto in realtà ha continuato ad essere con noi per tantissimi decenni e ha lasciato numerosi scritti e illustrazioni da riempire tomi per “Il Corriere dei Piccoli”.
Mi chiedo chissà quanti di voi si sono trovati a leggere le sue ‘novelle brevi’ come “I cavoli a merenda” o le sue “Storie di Cantastorie” e quel breve capolavoro “Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura”, la breve commedia magistralmente introdotta da Oreste Del Buono. E quanti ancora hanno ferme nella memoria le sue mirabolanti illustrazioni e i suoi bozzetti per il teatro.
Chi mai l’avrebbe detto che un bel giorno, siamo a Dicembre del 2016, incontrassi casualmente Sto per la strada, nelle mani di Maddalena Menza, giornalista, scrittrice e docente, che a Sergio Tofano ha dedicato un prezioso libro di ricerca sull’autore e sul suo personaggio, quel Signor Bonaventura d’infantile memoria che, a ben dire, ha coinvolto l’Italia intera col suo modo di dire ‘più vero del vero’ facendola sognare di potersi guadagnare ad ogni piè sospinto un fatidico ‘milione’ (di Lire). Specialmente per coloro, che negli anni della guerra, e successivamente del dopoguerra, si trovavano a rinverdire speranze di bontà e di futuro benessere.
Nel suo “Sergio Tofano e Il Signor Bonaventura” (Edizioni Kappa 2014) – Maddalena Menza scrive – essere «..uno dei personaggi del fumetto d’epoca più popolare tra gli italiani, tanto da potersi inserire nella storia del costume nazionale con la sua avventura ‘..che comincia male e si conclude sempre bene’ è (indubbiamente) la forza dirompente di Sto, come scrittore per l’infanzia, non tanto nella scelta delle storie quanto nella capacità di offrire al suo pubblico (di bambini e non) una via d’evasione in un linguaggio non allineato, in cui dalla selezione e dall’accoppiamento delle parole nascono sorprendenti e imprevedibili invenzioni verbali.»
D’altra parte è proprio la sua scelta orientativo-pedagogica indirizzata al rispetto dei valori educativi che Sto si pone in una sorta di ‘campo neutro’ nei confronti delle correnti letterarie dell’epoca anche di quelle più avanguardistiche come il ‘Futurismo’ in auge negli anni in cui egli scriveva. O, forse, e potremmo anche dirlo, generato dallo stesso, cioè quando il Futurismo non aveva ancora affrontato i virtuosismi più estremi.
Il ‘segno’ e la ‘forma’ così essenziali delle sue illustrazioni non ci ricordano in qualche modo nei colori un certo Depero?
Le sue storie dedicate al Signor Bonaventura nascono nel lontano 1917, quindi a 100 anni precisi dalle prime stringhe pubblicate sul Corriere dei Piccoli e ancora sorprendentemente vitali, sebbene al confronto con l’Euro, la Lira di quegli anni avesse un potere d’acquisto decisamente superiore, tale da divenire una sorta di filosofia del sano vivere:
«Non mi perdonerò mai di aver rivalutato il ‘milione’, trasformandolo in ‘miliardo’. Insomma , il miliardo sono mille milioni, è un numero vero, mentre il milione è un’entità irreale, eterea.» (Sto)
«Queste semplici parole pronunciate da Sto – scrive ancora Maddalena Menza – forniscono la chiave per capire quella che con un parolone potremmo chiamare ‘la filosofia del milione’. D’altro canto come è possibile pensare a Bonaventura senza associarlo al milione (come se fosse un riflesso condizionato) ed è naturale interrogarsi su cosa ci sia dietro quel fatidico pezzo di carta, con cui è premiata (astronomicamente) la bontà (spesso involontaria, a dire il vero)» … che, in una visione ampliata forse a dismisura, rappresenta il paradosso della povertà.
Scrive Oreste Del Buono nella ‘Introduzione’ alla Commedia scritta e illustrata da Sergio Tofano: «Oggi, giorno in cui scrivo queste righe, trovo scritto sul calendario: San Bonaventura. Chi fu costui? È inevitabile: se penso San Bonaventura, vedo immediatamente l’ometto dal cappelluccio rosso, la redingotta rossa, i pantaloni bianchi le scarpe rosse. Un ometto, dinamico più per forza di eventi che per forza propria, rimbalzante di avventura in avventura, anzi, a prestar fede all’incipit della prima puntata, di sciagura in sciagura, la maggior parte delle volte con soddisfazione generale, a lieto fine.»
Non c’è che dire, sembrerebbe l’annuncio di una moda che sta tornando o che forse non è mai passata e l’ometto di cui Sto parla, non può che essere uscito dalla fantasia bambinesca di un adulto che suo malgrado avrebbe fatto volentieri a meno di consacrarsi alla filosofia. Tuttavia chi abbia avuto in sorte di leggerlo può, in certo qual modo, addurre di aver ricevuto un certo insegnamento filosofico di tipo ‘pratico’, oggi comunemente trasferito negativamente nel ‘buonismo’ che tutti ostentano ma che nessuno davvero applica con sincerità d’intenti.
Almeno non come a suo tempo e secondo l’insegnamento di Sto faceva il Signor Buonaventura dalle pagine del “Corriere dei Piccoli”: «..un giornale per i piccoli che quasi riusciva più gradito ai grandi. Probabilmente senza quasi.» (Del Buono), e il perché lo si sapeva fin dall’inizio, in quell’incipit “Quì comincia la sventura …”, allorché giunti all’ultimo quadretto, si tramutava in promessa, la garanzia che la sciagura prima o poi, prima comunque e non poi il penultimo quadretto, sarebbe finità con la ricompensa della cambiale da un milione di lire.
Può sembrare pleonastico elencare qui i prosecutori di questo ‘genere’ che dal fumetto sfocia nella rarità letteraria, dalla novellaria arguta nella satira di costume, dalla caricatura alla pantomima teatrale. Si è qui messi di fronte all’originalità indiscussa, alla ‘nemesi creativa’ in cui la riuscita della bontà sull’esito negativo della cattiveria umana, pur restando nell’ambito della favolistica narrativa, vengono esaminate per contrasto con le controparti di un dialogo fondato sulla riscrittura orale, da teatrino delle marionette.
Se ben pochi sono i protagonisti della scena letteraria che hanno affondato le mani in Sto, una schiera di scrittori a loro modo ‘originali’ possiamo comunque elencarli senza offesa per alcuno, anzi, a incominciare da Achille Campanile, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista italiano, celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole nonché inventore delle “Tragedie in due battute” (1925); Italo Calvino scrittore e intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento, autore tra l’altro di “Le cosmicomiche” (1965).
E inoltre: Stefano Benni scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo italiano, autore di “Bar Sport ” (1976) e “Il bar sotto il mare” (1987), considerati classici della narrativa umoristica italiana, e caratterizzato dalla particolare comicità; oltre e moltissimi altri di grande successo. Daniel Pennac, pseudonimo di Daniel Pennacchioni, è uno scrittore italo-francese autore di molti libri per ragazzi, tra i quali “Il paradiso degli orchi” (1985), “The rights of the reader” (2006), “Lone Riders” (2012).
Nel suo completo vademecum Maddalena Menza ci accompagna attraverso quelle che sono le ‘tappe artistiche’ di Sto, alias Sergio Tofano, nonché le tappe formative del personaggio del Signor Bonaventura, visti attraverso l’occhio critico ma anche amorevole d’una scrittrice che ama il mondo del teatro (laurea in Storia dello Spettacolo e Dottore in di Ricerca Pedagogica), con afflato qua e là poetico che non guasta. In Indice troviamo infatti oltre a ricordi di attori famosi come Milena Vukotich, Paolo Poli e Monica Vitti, anche una nbota registica di Carlo Ludovico Bragaglia. Ampio è l’apparato critico, inoltre a un’ampia biografia corredata da bibliografia e filmografia dell’autore e notizie riguardanti Tofano illustratore, del quale sono riportate nel libro numerose tavole a colori; nonché del Tofano attore di cinema e di TV e Tofano comico e poeta.
«Parlando con suo figlio Gilberto Tofano – scrive ancora l’autrice del libro – che tanto ha contribuito alla memoria paterna con la realizzazione tra l’altro di un cartone multimediale, ho avuto la conferma di un entusiasmo vivo non solo tra gli studenti universitari (talvolta obbligati a studiarlo), bensì anche tra le giovani generazioni, e, cosa altrettanto straordinaria, proprio tra i destinatari per eccellenza delle storie fantastiche quali sono i bambini, a dimostrazione della proposta ‘narrativa’ del “milionario”. (..) Nel presente lavoro è stata analizzata soprattutto l’attività di Sergio Tofano scrittore, illustratore e regista nell’ambito della letteratura per ragazzi a cui si è avvicinato con l’eleganza, ancor più nella pulizia del segno che lo ha contraddistinto in ogni sua attività espressiva; nonché da una scrittura lontana da ogni prescrizione moralistica e da valori precostituiti, soprattutto nei racconti e nelle poesie, dove è riuscito a portare una ventata di rinnovamento (..) lontana dal provincialismo italiano e ispirata alle avanguardie artistiche del tempo.»
Nella ricorrenza della nascita dell’ormai mitico Signor Bonaventura, noi de larecherche.it a nome di tutti i poeti che si affacciano sulle pagine del web auguriamo a Sergio Tofano ‘Buon Centenario’ anche per tutti i prossimi a venire, ricordandolo con sincero affetto.
Note:
“Sergio Tofano e il Signor Bonaventura” di Maddalena Menza per Edizioni Kappa 2014 - Via Silvio Benco, 2 – 00177 Roma.
Autrice inoltre di “Parole e cartoons. Il linguaggio delle fiabe e il cinema d'animazione” – Arbor Sapientiae Editore 2015 - Via Bernardo Barbiellini Amidei, 80 – 00168 Roma.
“STO: Teatro, novelle, poesie scritte e illustrate da Sergio Tofano”, cof. 3 volumi. Rizzoli Editore 1974.
*
 - Musica
- Musica
Stelle di Carta e Strenne di Natale - terza parte
(poesia, libri, arte, musica)
(terza parte)
“..Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine..” (Giacomo Leopardi – ‘Le ricordanze’)
“..E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono …” (Giacomo Leopardi – ‘Canto di un pastore..’)
¶ «Tutti gli esseri umani per natura amano guardare il cielo stellato. Lo considerano uno degli spettacoli più belli e commoventi che si possano contemplare e in effetti, l’osservano estasiati da migliaia e migliaia di anni, forse da quando la specie si è eretta sulle sue gambe. (..) Filosofia, scienza e poesia provengono dal medesimo impulso, la ‘meraviglia’: è una fede che condividono, millenni dopo, il persiano al-Qazwini, Dante, Kant ed Eisenstein, (..) parlando di ‘stupore’ come stordimento d’animo, di ‘rapimento’» (Pietro Boitani, “Il Grande Racconto delle Stelle” - Il Mulino 2012).
È forse giunto il tempo per noi di tornare a scrutare la volta stellata alla ricerca d’una qualche cometa di passaggio che sia messaggera di ‘pace’, o anche solo di una speranza nuova che sia foriera di solidarietà e di fiducia, portatrice di una maggiore convinzione nella fratellanza e nella pace fra i popoli tutti, nell’affermazione di quella “Pacem in Terris” auspicata nell’Enciclica di P.P. Giovanni XXIII nel 1963, il cui messaggio non mi stancherò mai di ribadire:
«Ogni essere umano ha diritto alla libertà di movimento e di dimora all’interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consigliano, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi con esse. Per il fatto di essere cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l’appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale.»
Pur non essendo questo un articolo di astronomia ed ancor meno di astrologia, come è detto nel titolo, rivolgo qui lo sguardo alle stelle, benché di carta, cartonate o in brossura che siano, in breve, ai molti libri che pur nel loro distinto silenzio, offrono al lettore attento qualche istante di luminosità. Nello specifico ai libri di ‘poesia’ sempre più bistrattati e tenuti in disparte, nel luogo più recondito delle librerie, mentre dovrebbero far bella mostra di sé addirittura sui tavolini nei salotti delle case, in ragione dell’essere portatori di luce e più spesso di verità …
“La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole. Vita che vive al di fuori di un corpo, e quindi anche al di fuori del tempo”. (Sebastiano Vassalli “Amore lontano - 2005).
Quanti di noi sfogliando un qualsiasi libro (romanzo o saggio che sia), hanno trovato una frase che nella sua essenza ha colpito la sua sensibilità? Quanti hanno trovato nella ‘poesia’ un rifugio sicuro alla propria emotività, o che, talvolta senza accorgersene, hanno trovato quelle parole che mai avrebbero pronunciato, e che gli hanno permesso di esprimere un sentimento come l’amore, ad esempio? Quanti hanno trovato nella ‘poesia’ una frase che fosse di conforto alla loro solitudine o, alla loro incertezza di vivere cui neppure la filosofia ha saputo dare una risposta? La filosofia in sé non da risposte ma aiuta, mentre la ‘poesia’ sprona a cercare nel marasma dei silenzi, come nelle parole e nei suoni, ma anche nei colori e nelle linee dell’arte, quel quid necessario ad addolcire l’amaro che s’accumula nel tempo, nei giorni e negli anni del quotidiano vivere e che, inesorabilmente, segnano la vita di ognuno. Acciò anche desiderare, sperare, illudersi, finanche sognare e amare, altro non sono che i segni tangenti di un fare ‘poesia’ che travalica le soglie di quell’ ‘infinito’ cui tendiamo; quell’eternità cui l’essere umano da sempre anela, solo perché non gli è data. Sta nel principio effimero delle cose il destreggiarsi umano nel mare della follia che lo coglie, allora anche nella vaga luminosità delle stelle può mostrarsi la ‘soglia’ che induce alla fede in un aldilà di serenità e di pace. L’anelito è di bellezza cui solo la poesia sa come rendere omaggio.
¶ Come in questo ‘canto’ in cui la poetessa Amina Narimi recupera l’ancestrale pulsante essenza del nascere alla vita:
“Eravamo lievi,
accovacciati sui nostri sessi primitivi
come giovani fiori verso l’alba
illuminando l’intorno di erba verde
del rosso acceso dalle nostre ombre,
nella lingua semplice di uccelli,
e tanta rena nei palmi delle mani,
di tutto un cielo su, verso la vita.
Adesso che respiro, ora che salti
dentro ogni più piccola voce,
adesso che siamo fradici di luce
come fanno i caprioli quasi in cima,
stiamo nascendo, Noi ? Con le tue dita
se alzi il bordo sotto i fili d’erba
le ali ripiegate intorno al seno
si levano davanti ai nostri occhi
così a lungo. E silenziosamente,
candidi, nel buio
ripeteremo insieme ogni poesia,
con ogni gesto immaginato negli stretti
un largo d’aria disegnerà una promessa,
fra l’oro della polvere e il salgemma.
. . .
Più di ogni altra cosa
ci saremo inginocchiati,
pronunciando grazie, lucidi d’amore,
e, sottilissimi, sapendo di pregare
uno spazio per il fiato,
benedetto.”
Tratta da ‘Nel bosco senza radici’ –raccolta di Amina Narimi, Terra d’Ulivi Editore 2015.
Ma che ne è della ‘poesia’, dov’è finita? – mi chiedono in molti, alcune delle molte risposte giunte sono qui di seguito riportate:
¶ “Leggiamo poco la poesia, come mai? A mio parere è così perché la poesia è difficile, richiede impegno da parte del lettore. Eppure, può essere molto gratificante…” – scrive Piera Rossotti Pogliano editrice - che ha deciso di offrire tutti i titoli della collana ‘Poësis’ a solo 99 centesimi. “È il nostro piccolo regalo di Natale” – aggiunge, avvertendo che l'offerta degli ebook di poesia insieme a molte edizioni in formato cartaceo, è valida su tutti i webstore, sia sul sito specifico (EEE per gli amici) www.edizioniesordienti.com , dal quale è spedita senza spese aggiuntive”:
“Leggendo un romanzo, possiamo anche distrarci, interrompere la lettura, c'è una storia con una trama da seguire, è più facile e rilassante. Non è così per la poesia: il lettore deve essere attivo, esercitare tutte le sue capacità di penetrazione, di analisi, e nello stesso tempo essere pronto a lasciarsi andare all'emozione. In un'intervista del giornalista Jules Huret, del 1891, Mallarmé, accusato di essere "oscuro", risponde che esiste sempre il rischio che l'oscurità derivi dal lettore o dal poeta, ma che non si può barare, ci vuole impegno nel poetare e nel leggere poesia.
Se un lettore di media intelligenza e preparazione letteraria apre a caso un libro di poesia e pretende di goderne, c'è un malinteso di fondo: deve esserci sempre enigma in poesia - ed è questo, del resto, l'unico scopo della letteratura - ossia quello di "evocare". Certo, Mallarmé aveva un sogno penso irrangiungibile, ossia quello di voler isolare l'essenza della poesia, di scrivere poesia allo stato puro, l'utopia di voler scrivere poesia che non contenesse altro che poesia, ma questo porta verso il nulla estetico. Il fatto che il lettore debba mettersi in gioco quando legge poesia, è una profonda verità, ed è un impegno che ha la sua ricompensa. Fare poesia è usare il linguaggio verbale come materia, come un pittore usa il colore, uno scultore la creta o il marmo, un orafo l'oro. Il linguaggio è la materia più difficile, senza alcun dubbio. Oro, tubo di colore, marmo ecc. sono oggetti puramente materiali, attraverso i quali esercitare la propria creatività. Il linguaggio è una materia molto più complicata, porta con sé migliaia di anni di evoluzione dell'uomo, se ci pensiamo è qualcosa di davvero affascinante.”
“Si, la poesia richiede impegno, risponde Andrea Leonelli un assiduo navigatore del web, è difficile da leggere ed è come la magia, evoca, a volte evoca sogni, altre volte i demoni interiori che ognuno ha. E, come la magia, usa le parole per l'incantesimo: incanta. La poesia è la formula magica che il poeta-mago utilizza per risvegliare, tramite simboli vestiti di parole, quanto è nascosto nel lettore.” Quanto di più vero se nella prefazione al suo libro (op.cit.) Pietro Boitani inoltre avverte il lettore di essere “..stato guidato attraverso la ricerca d’una «poesia cosmica» del bello e del sublime, (..) articolato ma non infinito, del grande racconto che il cielo fa di se stesso, dei suoi moti e colori, delle forme e dei miti, del suo canto e della sua musica”...
“E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica”. (Friederich Nietzsche)
Cos'è la poesia noi tutti crediamo di saperlo: la poesia è parola, verso, musica, canto, danza, bellezza, ecc. tuttavia volendo speculare sul significato intrinseco del 'fare poesia', mi sento di assecondarla nel 'fare violenza', verbale s'intende, (ma non solo), poiché in fondo è questo che la rende 'viva' o quanto meno 'sentita', come dire, maggiormente 'vissuta', straordinariamente 'oltre' il senso della parola, così come va oltre il verso che la contiene, la musica che la diffonde, il canto e la danza che le danno forma, fino a raggiungere (quando la raggiunge) quella 'bellezza' che la rende sublime. Scrive in proposito sulle pagine de larecherche.it il poeta e critico Lorenzo Mullon:
“Per me la poesia, per come la vivo, è una tecnica per avvicinarsi alla realtà così tanto da poter saltare dall’altra parte. Avevo scritto un aforisma su questo, è esattamente quello che sento. Credo che noi tutti (quasi tutti, insomma...) la poesia non la sappiamo utilizzare pienamente, rimaniamo troppo spesso all’involucro delle parole, all’aspetto intellettuale. C’è qualcosa che non riesce a realizzarsi, e si riflette negativamente nelle nostre vite concrete. Un parto che non avviene, un parto senza partenza. Restiamo dalla parte meno interessante della scrivania. Da qui una certa noia, di cui parlano molti poeti, che mi sembra davvero incomprensibile, se non in questo inceppo esistenziale. Gravissima la perdita della tradizione orale, aver staccato la parola dal corpo è un crimine forse non del tutto inconsapevole. Ahhh, il progresso..”
¶ “Presente ed eternità stanno l’uno nell’altro, che è quello poi che Dante ci ha mostrato” - scrive il giovanissimo Alessandro D’Avenia in “L’arte di essere fragili” (Mondadori 2016), che consiglio vivamente di leggere così come di frequentare il suo blog ufficiale: alessandrodavenia@profduepuntozero.it – “La vita eterna prende forza dentro il tempo, comincia dal presente, è un futuro che si fa presente, è una qualità dell’esistenza. Dante lo mostra con le stelle. La fine di ogni cantica dantesca parla di stelle, a dimostrazione del fatto che il suo viaggio non riguarda l’aldilà e basta, ma l’aldilà nell’aldiqua, uno dentro l’altro. Il suo viaggio è un viaggio nel cuore di ogni uomo che ha i suoi inferni, purgatori e paradisi.”
Che è poi quanto di più concerne l’intento esplicito di questo articolo che con l’avvicinarsi del Natale vuole offrire ai lettori una selezione di ‘letture’ e di ‘ascolti’, con il solo scopo di favorire il vicendevole scambio di doni, come da sempre avviene in segno di amicizia e auspicio di fratellanza, quale simbolo augurale, significativo nei rapporti conviviali, di unione, di lieta dipendenza, o come segno di affabilità e di felicità reciproca, ed anche di stretta intimità che da sempre caratterizza il ‘tempo della festa’.
Non a caso l’Inferno del nostro massimo poeta si chiude con questo verso: “E quindi uscimmo a riveder le stelle.” (Dante ‘Commedia’ 34, 139 )
¶ Alla Commedia dantesca è dedicato il non trascurabile saggio “La Commedia senza Dio: Dante e la creazione di una realtà virtuale”, libro di Teodolinda Barolini (Saggi Feltrinelli 2013). La ‘Commedia’ è qui rivisitata in quanto fiction-letteraria come una geniale costruzione artistica in cui l’autrice esamina le strutture fondamentali della Commedia, scegliendo di illustrare ora alcune tecniche della manipolazione dantesca della narrativa per creare prospettive dialettiche entro il testo, ora le capacità di coinvolgimento del lettore, ora le modalità di rappresentazione dell’ineffabile. In questa lettura Dante, fabbro, artefice, poeta, è visto come creatore di ‘realtà virtuali’ piuttosto che di armonie fittizie.
“Questa la tesi dell’autrice che, proponendo una lettura deteologizzata, mette in luce i meccanismi narrativi, formali ed espressivi che contribuiscono a dare all’opera l’illusione della verità. Un percorso affascinante quanto rigoroso, sorretto da una solida informazione e da una conoscenza della Commedia fondata sulla concretezza del testo.” Assolutamente imperdibile è il capitolo 9 sull’ “Agiografia dantesca: la meditazione narrativa del cielo del Sole” per l’inerenza con l’articolo qui proposto. “Il progetto tematico del cielo del sole - scrive l’autrice in apertura del capitolo - è una riproposta in chiave di sapienza di ciò che Dante cerca di rappresentare e promuovere nel corso dell’intero Paradiso: un paradiso in cui la differenza è sufficientemente amalgamata all’uno da raggiungere pace e armonia, ma non abbastanza da perdere ciò che la rende tale, ciò che la rende differente..”
Teodolinda Barolini è una eccellenza della critica etteraria italiana, direttrice del dipartimento di Italiano della Columbia University di New York dove insegna Letteratura Italiana. È autrice di numerosi saggi e articoli sui massimi poeti e scrittori del Duecento e Trecento. Risale al 1993 la traduzione in italiano del suo primo libro “Il miglior fabbro2 (Bollati Boringhieri), uno studio sull’autobiografia poetica di Dante.
Propongo qui di seguito una 'poesia' di Flavio Ermini - Anterem Edizioni:
“Il cielo disabitato
diviene la propria negazione a in pari tempo se stesso
l’essere umano che nella caduta è divorato dalle ombre
quando accede al presente sui limiti di un precipizio
non essendo che un albero cresciuto su poca terra
connesso strettamente com’è alla fragilità di un’efflorescenza
che di carne e argilla è fatta nell’opaco fondo animale.”
¶ Con “Cieli celesti” (Fazi Editore 2016) Claudio Damiani ha scritto un libro in cui il suo pensiero filosofico si apre all’orizzonte della scienza. La chiarezza espressiva e la forma contemplativa dei versi, però, sono le stesse dei libri precedenti, quelle apprese dalla lezione dei latini e di Petrarca. Così come il ritmo continua a essere dialogante: il suo rivolgersi agli uomini, agli animali, alla natura, all’intera creazione come fossero tutti parte di una “comunità” – che poi significa capire quanto ogni cosa è indispensabile all’altra e che proprio questo è il “miracolo” di cui facciamo quotidianamente esperienza. Nel tempo della nostra vita, all’interno di un universo tanto vasto e tanto misterioso da sovrastarci e spesso spaventarci, Damiani percepisce un disegno – la rivelazione di un’intelligenza universale che illumina la mente – come una linea che scorre inesorabile lungo i secoli e i millenni. Di quella linea, l’essere umano, l’individuo, non è solamente un punto tra gli infiniti altri, ma è un nucleo di energia, un «quanto di tempo», scrive il poeta servendosi dei termini della fisica: è la possibilità che il disegno – un disegno che Dio, o qualcuno a cui abbiamo attribuito questo nome, ha pensato – si compia.
Come l’anello infinitamente piccolo di una catena infinitamente grande, la sua stessa esistenza determina il passato, il presente e il futuro dell’universo. Allora, il tempo dell’uomo non è mai veramente finito, e pure la morte è parte del disegno. Ed è necessario viverci, nel tempo, al massimo delle nostre possibilità, come il sole, che ogni giorno e ora «ha scaldato e illuminato / i corpi intorno, senza mai fermarsi». Cioè viverci anche in comunione con tutte le cose viventi – che in virtù di questo sono sacre –, scoprendo che siamo parte di una “continuità”, e che il nostro presente sarà il passato e la ragione di vita per chi verrà, così come noi siamo il futuro di quelli che sono stati, e che tutto il tempo è l’ “essere” stesso, cioè il senso del nostro stare e compierci nel mondo.
Damiani è tra le voci poetiche più originali e vere del nostro tempo, e in questo libro ci regala la più alta sintesi di un pensiero e di una forma espressiva che si vanno definendo nella perfezione raggiunta, ancor più fedele a se stesso, di una grande personalità letteraria a tutto tondo. «La sua voce ha un’autorità che supera i confini della letteratura… Senza essere per questo meno poeta, Damiani ci appare, in tutta naturalezza, come un segreto Maestro, qualcuno che indica una Via»- ha scritto di lui Giovanni Mariotti (Corriere della Sera).
¶ “Conoscere il carattere dell'oscillazione ... la lacerazione e la sofferenza, impone di rendere lieve tutto ciò che esiste, alleggerire il peso di vivere ... il carattere poetico dell'esistenza ...il sapere della bellezza.” – scrive Flavio Ermini direttore della rivista letteraria Entherem che ci propone una poesia di Stefania Negro tratta da 'Oscillazioni' - Collana Limina:
“Lo so di non essere immortale,
per questo divento il mare che spumeggia e incanta
nei suoi moti e s'infrange sulla riva,
il soleche è anelito di vita e illumina
i giorni e fiorisce sui nostri vasti
volti e sulle nostre labbra,
il vento che risuona
tra le fronde e spinge i flutti e crea le maree,
ogni carezza sulla mia pelle e ogni parola che
sappia ricordarmi di esistere e di esserci stata.”
Tuttavia c’è qualcosa che mi sfugge in questo Natale, che non riesco ancora a definire, come una lucida apprensione che mi fa levare con affanno lo sguardo verso il cielo, a ‘quella stella’ di cui vi ho parlato fin dall’inizio; un desiderio che mi fa cercare le piccole emozioni di sempre, quel sentimento di speranza che pure affronta ‘l’infinito’ e che come il poeta Leopardi …”sempre caro mi fu … e mi sovvien l’eterno”, e che ritrovo nella poesia che vi ripropongo:
“Dagli albori dei tempi, nascondi la verità,
con ingannevoli lusinghe e sfaccettature.
Non udisti, non vedesti, ma inaspettata giunse la tempesta.
Non è la tenebra, ma la luce, quella sottile attrazione che ti spinge
a gaurdare oltre il sipario.
Svuotiamoci dal torpore che inibisce il nostro risveglio.
Oltre le vesti il cuore, donando, amando.
Dentro quel silenzio che nulla toglie alla bellezza che noi tutti,
nel confronto visuale delle Sue opere, ci portiamo dentro.”
(Vittoria Marziari-Donati 'Catalogo delle opere' 2015)
¶ “Giacomo Leopardi: L’incanto e il disincanto” di E. Boncinelli e G. Giorello – Guanda 2016. Dalle liner notes de “Il Libraio” Dicembre 2016 www.illibraio.it sulle novità editoriali degli editori che vi aderiscono, apprendo dell’uscita in libreria di questo interessante lavoro di Edoardo Boncinelli e Giulio Gioriello, i quali indagano la vita e le opere di Giacomo Leopardi da una prospettiva anticonformista e vi: “scoprono un uomo malinconico, ‘scontroso’ e ‘ribelle’, dotato di raffinata ironia, appassionato sin da ragazzo alla conoscenza e affascinato dalle scoperte di Galileo e Newton. Ma, soprattutto, emerge il filosofo coraggioso, capace di una visione del mondo scevra di ogni aspetto consolatorio, libera dall’ossessione di Dio e del senso di colpa; un filosofo così rivoluzionari da intuire che la pretesa umana di essere al centro del creato è un inganno e la sua supremazia sulla natura un arbitrio. Una figura che smaschera le illusioni della politica e individua nella Storia le radici dei mali che ancora oggi affliggono l’Europa”. Si tratta di un ennesimo riscontro dell’adeguatezza al presente di Leopardi che amplia la sua già corposa biografia e ne fa un precursore della modernità cui attendiamo.
Giulio Giorello è ordinario di Filosofia della scienza all’Università degli Studi di Milano, e collabora con il Corriere della Sera. Edoardo Boncinelli, genetista, è professore di Biologia e Genetica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, collabora a Le Scienze e al Corriere della Sera.
¶ Se è vero che nei libri passa la modernità della vita, nella ‘poesia’ passano tutte le vie di fuga che abbiamo escogitato nella ricerca di quella realtà che la ‘filosofia’ spesso nega. In “La poesia del Novecento: dalla fuga alla ricerca della realtà” (Giuliano Ladolfi Editore 2015) guarda alla tutela del patrimonio socio-culturale con particolare attenzione, principalmente – come l’editore stesso afferma – “..di fronte all’attuale emarginazione della poesia contemporanea dal mondo della scuola, delle università, della distribuzione e del circuito massmediatico, nel tentativo di restituire dignità a quest’arte che per quattro millenni è stata strumento di civiltà e cibo di umanità”. L’intera raccolta poetica si presenta come il primo tentativo, dopo più di vent’anni di studio, di raggruppare in un’opera organica i numerosi ‘saggi’ pubblicati sulla rivista «Atelier – pubblicazione trimestrale di letteratura, poesia e critica» e dedicati alla Poesia Italiana dal Novecento ai nostri giorni, suddivisa in 5 volumi ordinati per categorie nell’intento di conferire al lettore linee di comprensione di un fenomeno sfuggente a causa della difficoltà ad essere inquadrato in categorie.
L’edittore infatti, avverte la necessità che la sua interpretazione venga supportata da due elementi fondanti: “..una personale concezione estetica e una visione che dallo sviluppo della civiltà trovi linfa e motivazioni; (..) come pure da una militanza in grado di attivare energie giovanili e di coinvolgerle in un progetto di rinnovamento della poesia, della narrativa e della critica italiana, (..) la concezione autoreferenziale e ludica della poesia, nel rifiuto dello scetticismo, nella concezione della poesia come originale interpretazione del reale, nella consapevolezza della fine del ‘novecento’ e nel rapporto con i maestri della tradizione che stanno compiendo una vera e propria rivoluzione mediante una serie di raccolte di versi destinate a tramandare ai posteri il volto della nostra martoriata epoca. In questa raccolta infatti, sono inseriti gli studi su un gruppo di poeti che hanno pubblicato dagli anni ‘70 fino al 2014, i quali, nel superamento delle maniere avanguardiste e sperimentaliste, hanno cercato e stanno cercando nuovi approdi che inducono a sperare in una prossima fiorente stagione della poesia italiana.” L’intera collana è reperibile presso l’editore g.ladolfi@alice.it
“Capire i linguaggi umani, imperfetti e capaci nello stesso tempo di realizzare quella suprema imperfezione che chiamiamo poesia, rappresenta l’unica conclusione di ogni ricerca della perfezione”. (Umberto Eco)
¶ A comprendere i linguaggi umani ci aiutano Stephanie Marango e Rebecca Gordon rispettivamente medico olistico e astrologa, nel loro “Il Corpo e le Stelle” – (Corbaccio 2016) con questo manuale che utilizza i segni zodiacali come una mappa del benessere psico-fisico, con un approccio rivoluzionario basato appunto sulle costellazioni. E che mostra la connessione che ciascuno di noi ha con il cosmo. Aiuta a ‘sentire’ in modo corretto il proprio corpo in un contesto più ampio e favorisce i processi di guarizione. Dopo aver spiegato in termini generali le stelle in rapportosia all’astrologia sia al corpo umano, ogni capitolo si sofferma su una zona particolare del corpo in associazione a un segno zodiacale. È, a ogni parte del corpo, dedica un programma specifico da seguire per mantenersi in buona salute da tutti i punti di vista: fisico, mentale, emotivo. (Il Libraio Dicembre 2016). www.illibraio.it
Ma ècco giunto il momento di salutarci, mi sono dilungato molto lo so, ma chissà, forse qualcuno mi dirà se ne è valsa la pena. Se in fine sono riuscito a tenervi informati e, soprattutto, ad impigliarvi nella matassa delle suggestioni, poiché questo era l’intento.
“Forse il tempo a disposizione mi è parso troppo breve non a causa della mia ormai veneranda età, ma perché quanto più vecchi si diventa tanto più si impara che, per quanto grandi i pensieri possano sembrare, non lo saranno mai abbastanza da inglobare, e tanto meno trattenere, la munifica prodigalità dell'esperienza umana. Non è forse vero che una volta che è stato detto tutto sulle più importanti questioni della vita umana, rimangono ancora da dire le cose più importanti?” (ZYGMUNT BAUMAN - ‘L’ARTE DELLA VITA’ ).
Tempo in cui si esprime il ‘senso’ del quotidiano vivere comunitario, e del ‘meraviglioso’ reciproco scambio augurale di ‘pace’ e rinnovata ‘speranza’. Lo so, posso essere sembrato un buonista dell’ultima ora, per quanto credo fermamente che volersi bene alleggerisce e in qualche caso annienta voler fare del male a noi stessi e agli altri. Che volete, io sono fatto così, credo inoltre ad un “Meraviglioso quotidiano” che, nel bene e nel male, illumina la starda che insieme percorreremo:
“Meraviglioso quotidiano”
(Carlos Sanchez da “La poesia, le nuvole, e l’aglio”, Edizioni Librati 2009):
“In questa vita dove tutto sembra così reale
il tuo canto si accumula nella materia grigia
nella punta delle dita delle tue mani
e questo sembra ugualmente molto normale.
Il vento che non muove una foglia
il cielo incerto con le sue nuvole
l’orologio che ha perso l’equilibrio
la gatta partoriente che geme
la mia signora che legge un libro di filosofia
il figlio che brilla per la sua assenza
la televisione che non si accende
il rubinetto col suo irritante sgocciolare
l’uccello e le briciole di pane
la vicina col suo tappeto sul balcone.
Tutto sembra così normale dicevo
in questo meraviglioso quotidiano.”
Ed ecco! Il dono che avevo in serbo per tutti Voi è giunto appena in tempo: facciamo anche noi in modo di poter cantare un giorno che ‘la guerra è finita e che la pace è ristabilita nel mondo’. Uniamoci dunque al coro, in ossequio al grande poeta scomparso Leonard Cohen, con questo straordinario “Hallelujah”:
"Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah , Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah!"
“Ho sentito che c’era un accordo segreto / Che David suonava, e piaceva al Signore/ Ma non è che ti interessa la musica, vero? / Fa così / La quarta, la quinta / Minore diminuita, maggiore aumentata / L’imperscrutabile re compone l’Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
La tua fede era forte / ma avevi bisogno di prove / L’hai vista farsi il bagno sul tetto / la sua bellezza e la luce della luna ti sconfissero / Ti ha legato / alla sedia d’una cucina / Ruppe il tuo trono, / e tagliò i tuoi capelli / E dalle tue labbra delineò l’Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Dici che ho preso il nome invano / Non lo conosco neanche il nome / Ma se lo conoscessi, bè, davvero, / cosa significa per te? / C’è un incendio di luce / In ogni parola / Non importa quale hai sentito / L’Hallelujah santo o quello stentato
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Ho fatto del mio meglio, non è stato molto / Non riuscivo a “sentire”, / così ho provato a toccare / Ho detto la verità, / Non sono venuto a raggirarti / E anche se / Fosse stato tutto sbagliato / Starò dritto davanti al Signore della canzone / Solo con l’Hallelujah nella mia bocca
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah!”
Termina qui il nostro excursus nella ‘musica per una festa’ che ho avuto il piacere di regalare a tutti voi ‘Poeti’ de larecherche.it per questo Natale, nella speranza che il messaggio, solo apparentemente banale, d’un pur semplice cantare, possa fare qualcosa per alleggerire il peso in un momento di recessione come quello che stiamo vivendo, e che le difficoltà non esistono per chi sa cantarle o interpretarle con un verso. La ‘poesia’ non porta gli allori ma indubbiamente può far molto per alleviare la pena di questa esistenza straordinaria che ha del ‘meraviglioso’ solo per il fatto che c’è.
Auguri vivissimi dunque per un Felice Natale e un migliore Anno Nuovo.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Fabrizio Casu e il suo ..lungo viaggio di una chemise
Fabrizio Casu e il suo …
“Il lungo viaggio di una chemise. Un’epoca attraverso un abito” – Europa Edizioni 2014 / ristampa 2016.
Costantemente aperta a ogni influenza, grata a ogni ispirazione, la moda ha sempre accettato suggerimenti e nuove tendenze nel suo scorrere lungimirante, ciò per quanto la storia dell’abbigliamento in realtà non sia mai stata scritta per intero o, comunque, ancora non abbia potuto misurarsi con l’evoluzione del ‘costume’ nelle sue accezioni di utilità, di praticità e perché no di abbellimento, riferito al quotidiano adornarsi. E chissà che non debba ancora passare del tempo prima che una tale storia possa essere scritta.
Più spesso le aree periferiche rispetto ai centri tradizionali della moda hanno dato originali contributi alla trasformazione dell’abbigliamento. Seppure, è indubbio, che la ‘moda’ tout court sia da considerarsi un prodotto privilegiato di una società elitaria, proprio di «..un fenomeno collettivo che nel modo più immediato ci fornisce la rivelazione che vi è del sociale nei nostri comportamenti» (Stoetzel), e che presenti «una dialettica del conformismo e del cambiamento spiegabile solo sociologicamente» (Barthes).
Questo il quantum del raffinato libro di Fabrizio Casu che va a colmare un ‘vuoto editoriale' specifico dei manuali enciclopedici ove la specialistica richiede maggiore approfondimento di ciò che all’apparenza può sembrare soltanto interstiziale, nell’evoluzione di un’ ‘epoca illuminata’, fiorita tra il XVIII e il XIX secolo, che ha visto, in assoluto, i maggiori cambiamenti culturali e sociali, nonché le prime avvisaglie del progresso industriale.
In ciò la scelta del singolo capo d'abbigliamento femminile, la ‘chemise’ per l’appunto, in quanto parte integrante della ‘specialistica’ dell’autore, tesa a superare la dicotomia del pretesto storico elitario/popolare qui delineato. Se non altro per alimentare in modo organico il fenomeno poliedrico, per fare il punto su un tema vastissimo, squisitamente futile e rigidamente serio che è la ‘moda’: «Nello stesso tempo imprevedibile e sistematico, regolare e sconosciuto, aleatorio e strutturato», (Barthes), e che ha richiamato l’interesse degli studiosi di estetica e degli storici dell’arte, ma anche di psicologi, sociologi ed etnologi, e soggetto a tutt’oggi di interpretazioni spesso contrastanti.
La moda dunque vi appare come fenomeno di processi evolutivi tendenzialmente collegabili a questo o a quell’ordine di idee estetico-psicologiche nonché sociologiche ed etnologiche, che va registrata come tendenza nella continua invenzione ‘fantasiosa e arbitraria’ della quotidianità, per quanto sia entrata a far parte del patrimonio ereditario delle diverse culture dei popoli.
Pretesto questo che ci permette di leggere, o forse andare a ri-leggere, gli appunti che Francesco Alziator scrisse a fronte de “La collezione Luzzietti”, (libro illustrato De Luca Editore 1963): «Per una storia dell’abbigliamento popolare in Sardegna», in cui l'autore altresì rende manifesta una prerogativa assoluta della moda: "..per cui la singolarità delle fogge si è sempre distinta in quanto motivo di curiosità e attenzione da parte di studiosi di filologia linguistica, mito, fiaba, narrativa, folklore".
Non di meno vanno tenute in conto la manualità artigianale, la merceologia, la chimica e via via la tecnologia dei tessuti, la sartoria, progettazione e design, che trova nell’originalità dell’arte, così come nell’immaginazione, proprie linee ‘poetico-strutturali’, tipiche della cultura popolare. Per quanto è ancora oggi riscontrabile nei musei, nelle raccolte private e quantaltro; ricostruibile attraverso le varie fonti a disposizione, a incominciare dalle Biblioteche Universitarie di Cagliari e di Sassari, solo per citarne alcune.
Non sembri quindi azzardato supporre che la moda, nei fondamentali aspetti che la caratterizzano, è di fatto nata con l’uomo storico, sebbene è con l’avvento della società capitalistica che si fa coincidere l’insorgere di quella specie di ossessione per il nuovo o ‘neomania’ di cui l’abbigliamento rappresenta uno degli aspetti più eclatanti. È interessante ricordare come lo storico del costume Jules Quicherat abbia fissato intorno al 1750 i canbiamenti più rilevanti della moda, nella prospettiva storica più ampia, evolutisi secondo un ordine proprio tendenzialmente autonomo, a conferma di come le ragioni attraverso le quali ogni novità s’impone, siano da ricercarsi sul piano dei significati sociali necessariamente insiti al fenomeno collettivo.
È a questo punto che la ‘ricerca’ di Fabrizio Casu s’innesta, soffermandosi sugli aspetti più nascosti e segreti del fenomeno, sollecitando in chi legge la curiosità e il mistero intrinseco in un elemento personale così ‘intimo’ da stimolare le più recondite sollecitazioni: «Semplice e sciolta come una tunica, la ‘chemise’, con la sua immacolata innocenza, affronta la modernità più radicale, promuovendo la simbiosi fra corpo e abito, concellando gli artifici e le costrizioni della moda.» (scrive l’autore) Affermazione questa che rende possibile ripercorrere a grandi linee la storia di almeno un secolo di intima ‘fashionable’ eloquenza della moda, quella simbolica e luminosa di ‘essere’, ma anche quella imperfetta e misteriosa del ‘l’apparire’, inscindibili l’una dall’altra, e che pure permette a noi post-moderni, di conoscere meglio chi siamo. Di porci - per così dire - davanti allo specchio coperti del candore della nostra intima nudità, prima di rivelarci all’amore e di lasciarci andare ai turbamenti del sesso.
Parlo ovviamente di immagini ricorrenti, relative al contesto quotidiano e che, in qualche modo, il solo il pensarle spinge alla libidinosa fragranza degli eccessi. Ma non aspettatevi tutto questo che silente pur si annida nelle pagine di questo libro, nell'eloquenza del non detto, nelle frasi còlte utilizzate dall’autore, benché i capitoli siano allettanti: ‘La Regina è nuda’, ‘La familia delle robes de fantasie’, ‘Merveilleuse!’, ‘La chemise come travestimento’. C’è tanto di femminilità che improvvisamente, e sotto i nostri occhi attoniti, è qui recuperata per intero una certa ‘grazia’ dell’essere donna e che - in certo qual senso - sembra andata perduta. Soprattutto recentemente, allorché la globalizzazione ha portato sulla scena metropolitana qualcosa che di ‘femminilità’ ha davvero poco, anzi niente.
Tuttavia in questo ipotetico viaggio nella moda l'autore mette in evidenza una sua particolare chiave di lettura che va oltre le avvenute variazioni del semplice vestire, annotando come la 'chemise' si sia adattata a tutte le varianti possibili e le molte interpretazioni che di volta in volta si sono succedute fino a noi contemporanei. Come, ad esempio, che si può essere diverse/i conservando la propria femminilità/mascolinità in concomitanza con quella dei propri partners. Infatti sempre più spesso l'utilizzo e il dichiarato scambio dei ruoli, così come appare sulle pagine dei rotocalchi e ancor più nel cinema, permette ormai di dire che c’è più motivo di nascondere o mistificare chi si è, travestirsi da ciò che non si è, mistificando che il lesbismo e l’omosessualità esistono da sempre, solo per fare un esempio inerente alla 'chemise' e alla 'chemiserie'.
Non che le donne o gli uomini, prima e dopo il Settecento, non conoscessero e frequentassero le piacevolezze delle letterarie “amicizie particolari”, o “pericolose” che dir si voglia. Nel suo libro ‘Système de la Mode’ Roland Barthes analizza secondo i canoni dello strutturalismo il linguaggio usato da un campione di stampa femminile (strumento senza il quale la moda sarebbe ormai inconcepibile) e ciò gli permette di ravvisare nella moda un «sistema» indipendente a tutti gli effetti. A promuovere questo sistema e la sua annessa retorica è ovviamente l’esigenza di trasformare gli oggetti dell’abbigliamento, in beni di consumo originariamente durevoli, in prodotti di rapida usura, alquanto psicologica.
Non a caso si dice 'a ognuno la propria scelta' per avallare il sottile piacere di ognuno di seguire la moda a modo suo e 'perché no?', darsi la possibilità di eccepire il superfluo, fare le proprie esperienze, adattarsi alle convenienze concettuali, riconoscersi nella realtà che ci circonda, perché – va detto – la moda è dentro e fuori di noi e ci consegna a quell’effervescenza della modernità in cui – volenti o nolenti – ci conduciamo. L’importante è mantenere una certa ‘identità nella dignità' che serve alla conservazione della specie, nella continuità che ci vede umani allo stesso modo, con le nostre defiance, i nostri dubbi, la nostra diversità (talvolta negata), pur nella somiglianza e nella similitudine, al di dentro dei mutamenti sociali e delle mode.
Ciò che induce qualcuno a credere che il passaggio dalla moda storica a quella attuale rappresenti il progresso da un sistema di rigida codificazione sociale a uno stato di «emancipazione», in armonia con l’attenuarsi di talune disuguaglianze sociali, non più strumentalizzato a fini classisti; che l’abbigliamento moderno avrebbe insomma acquistato la libertà di svilupparsi a livello estetico-funzionale diventando sempre più bello e più razionale. O almeno così sembrerebbe, ma è vero semmai il contrario: la moda contemporanea determina, sia pure a livelli nuovi e diversi, una costrizione tanto più rigorosa quanto meno dichiarata, spinta dalla sua stessa dinamica ad aumentare costantemente l’ampiezza della scelta e ad accelerare i tempi del consumo.
L’industria dell’abbigliamento sembra oggi annunciare il passaggio a una produzione coordinata su nuove basi techiche e ispirata ad altri significati sociali, a una moda sostanzialmente diversa da quella che conosciamo. C’è da chiedersi se – alla stessa stregua del fazzoletto di carta sostituitosi a quello di stoffa senza assumerne il carattere di moda – il vestito non riuscirà così a liberarsi dell’attuale tirannia. Se un giorno l’abito dovesse rispondere anzitutto ai naturali criteri di protezione, pudore, economicità, non potrebbe non guadagnarne anche in ogni altro senso.
Va anche detto che il libro, questa mini-enciclopedia del 'senso' sulla moda della ‘chemise’ ci regala inoltre pagine profumate di fascino settecentesco intorno alla figura immortale di una déa della femminilità: Maria Antonietta Regina di Francia, un personaggio complesso capace di vivere fino in fondo le contraddizioni del suo tempo. Una figura eclettica che trasformò Versailles nella culla dell’ ‘eleganza’ per eccellenza, e un’intera Corte in un inno alla ‘bellezza’ eccentrica.
Ma nel leggere il libro non rifugiatevi nella grettezza di coloro che vi riconoscono solo i lati fortemente negativi di una impresa che a suo tempo ha dilaniato un paese portandolo alla Rivoluzione civile; bensì godete dell’idea profumata di una fiaba, o di un bel sogno altrimenti possibili: "Che la bellezza insita nella moda è per sua definizione l'essenza stessa della vita, che forse vale la pena di rincorrere".
Come è qui riportato da Fabrizio Casu introducendoci ai versi di H. Tayne:
“Da tutte le parti, nel momento in cui questo mondo sta per finire, una compiacenza reciproca, una dolcezza affettuosa vengono come un soffio tiepido e molle d’autunno a fondere quel che di duro c’era nella sua aridità , e ad avvolgere in un profumo di rose morenti le eleganze dei suoi ultimi istanti. Si incontrano allora parole e azioni di una grazia suprema, uniche nel loro genere come una piccola e adorabile figurina di vecchio Sévres… Quando il cuore e lo spirito riuniscono le loro delicatezze, producono dei capolavori che, come l’arte, la cortesia e la società che li circonda, hanno un fascino che niente può superare, se non la loro fragilità”…
Mi domando se non sembra anche a voi lettori di sentire l’effervescenza di quella vanità che fuoriuscire dalle pagine di questo libro e che si lascia leggere come un intimo romanzo d’amore? Di percepire l'effluvio soporoso di una 'chemise' appena tolta, promessa in sé di un corpo che si svela? Beh, provate di tanto in tanto a chiudere gli occhi per un istante e ben presto il suo profumo presto vi ammalierà.
Fabrizio Casu è nato a Sassari nel 1980, ha frequentato il corso di fashion design alla NABA di Milano e si è laureato nel 2005 con qualifica di “esperto e creativo del settore moda”. Dopo aver intrapreso un corso di cool hunting e uno di texile design, ha lavoratp presso la Mantero Seta di Como, operando nel “La Tessitura”. Inoltre, ha svolto docenza di Storia del Costume e Progettazione Moda in scuole pubbliche e private di Sassari. Nel maggio 2013 ha pubblicato due saggi per la casa editrice EDES: “Novecento: il secolo della moda” e “Madonnna, vampira postmoderna”.
*
 - Sociologia
- Sociologia
Rispetto una questione metodologica per l’equilibrio sociale
Una questione metodologica basata sul riconoscimento dell’uguaglianza, sul consenso individuale alla reciproca fiducia e all’equilibrio sociale.
Nel dibattito su quelli che definiamo ‘valori morali’ e se questi sono relativi o assoluti (?), la risposta di gran lunga più motivata è ‘che sono relativi’: “Se molti sono i modi ragionevoli in cui gli esseri umani possono organizzare la loro vita – scrive Maurizio Ferraris (1) – resta che ce ne sono alcuni che sono sicuramente inaccettabili.” Ma se è altrettanto scontato che il ‘relativismo’ presenta dei limiti, la cui soglia oggi è stata abbondantemente superata, è altresì realistico che persi nei meandri dell’attuale complessità sociale, multietnica e multiculturale, ci si pongano alcuni interrogativi fondamentali. Uno dei quali riguarda il ‘senso del proprio agire’ nell’ambito della proprie scelte, che non può più essere solo individuale ma riguarda la società nella sua percezione globale o comunque comunitaria, che va esaminata nel suo insieme.
Un’analisi approfondita diviene pertanto necessaria se, come in questo breve saggio, si vogliono individuare gli strumenti di una possibile ricognizione del ‘rispetto’ in seno all’etica morale e l’intrinseca criticità di merito che l’accompagna. Acciò, e nel migliore dei casi, è necessario tornare al passato e rileggere il crtesiano “Discorso del metodo” (René Descartes 1596-1650) (2), lo strumento per eccellenza che più ci aiuta a comprendere i termini e i limiti, pur nella logica della scoperta scientifica, vuoi filosofica che sociologica, del pensiero libero concettuale, ancora oggi considerato un caposaldo della liberalità civile. Un testo tra i “..più rivoluzionari su cui meditare, in quanto il suo autore aveva perfettamente compreso che le vere rivoluzioni cominciano nel proprio intimo e non nel cambiamento delle cose, ma nella riforma di se stessi” – scrive Giovanni Reale nella Prefazione al testo. (3).
Una ‘questione di metodo’ dunque, la cui applicazione restituisce al ‘rispetto’ una sua posizione prioritaria all’interno delle ‘virtù etico-morali’, qui individuata in tre passaggi essenziali che ben definiscono la relativa prova scientifica: ‘Metodo del riconoscimento dell’uguaglianza’, ‘Metodo del rispetto civile’, ‘Metodo del consenso basato sulla fiducia e la temperanza’.
1) Metodo del riconoscimento dell’uguaglianza
Volendo significare l’insieme delle varianti insite in una probabile ‘anatomia del rispetto’ qui presa a soggetto, è obbligo avvalersi di discipline diverse (antropologia, sociologia, psicologia, etica e filosofia) che, in qualche modo ed entro i limiti consentiti, permettono di individuare quegli elementi sostanziali alla metodologia della ricerca, da osservare nell’ottica della ‘volontà’ più volte espressa dalla società, di risolvere quelle che sono oggi considerate ‘problematiche sociali’. Una volontà attualmente evasiva se esaminata nella prospettiva pragmatica delle politiche giuridiche (pari opportunità, coppie di fatto ecc.) ad essa inerenti.
Alla luce dei mutamenti sopravvenuti nella società e delle nuove realtà ideologiche, la costruzione etico-morale del ‘rispetto’, pur impostata sulle basi antropologiche dei ‘riti di riferimento’ come la tradizione e la cultura, la religiosità e la sacralità degli affetti, si è rivelata da qualche tempo a questa parte, inaspettatamente anacronistica, mostrando le sue crepe profonde. Segni di una erosione che non l’ha risparmiata da risentimenti diffusi e punti di criticità, sia per i suoi aspetti discordanti (quanto inevitabili), che ne hanno limitato il ‘riconoscimento’ configurativo all’interno di una specifica ‘tipologia virtuosa’; sia in ambito famigliare che educazionale, formativa ecc., che da sempre vieicolano le cosiddette ‘differenze di genere’.
In qualità di ‘soggetto sociale’, infatti, la rilevanza delle ‘differenze di genere’ ha dato luogo a un fenomeno collettivo d’interesse antropico che un ‘liberalismo’ metodologicamente preconcetto, attribuisce a forme di ‘società’ e di ‘economia’ migliori di sempre, neppure fosse l’‘archetipo’ di una modernità immaginaria quanto inafferrabile e tuttavia possibile; nonostante i ‘comportamenti umani’, si siano gradualmente integrati con le nuove problematiche introdotte nella società, secondo le ripartizioni attuate dalla ‘psicologia sociale’ all’interno di discipline meglio diversificate come: ‘individuali’, ‘collettive’ e ‘comunitarie’ che comunque rimangono universali.
Ciò, per quanto l’esperienza esistenziale dell’individuo sociale (umano), pur nella sua identificazione e la sua irriducibile complessità, sia ancora oggi tutt’altro che scontata e in antitesi con una completa istituzionalizzazione, a causa dell’ ‘assenza o mancanza’ (anomia) di norme sociali specifiche che, entro certi limiti, risultino appropriate al comportamento dell’individuo stesso nei confronti degli altri e, pertanto, volte a costituire una specifica ‘identità’ nel processo educativo e di ‘socializzazione’ (paideia) in atto. Onde per cui, il ‘riconoscimento’ è il primo passo necessario per il superamento relativo alle ‘differenze di genere’ e la definitiva attuazione del processo di uniformazione dell’ ‘ethos politico’ nell’ambito della riorganizzazione sociale.
Se vogliamo, è a partire dalla ricerca dinamica del ‘riconoscimento’ che prende il via la giustificazione metodologica che si vuole qui perseguire: cioè, nell’individuare quei fattori relativi, intrinsechi della sfera della ‘personalità individuale’ e dell’ ‘identità collettiva’ in quanto ‘soggetti’ delle ‘differenze di genere’, ai quali pur ineriscono esperienze di rifiuto di ‘legittimazione’ e ‘approvazione’ di diritti più spesso negati. “Il riconoscimento dunque - scrive Mario Manfredi (4) – come obiettivo di un processo di piena responsabilità radicale verso i soggetti di ‘genere’ (umani e non), specialmente quando si confrontano posizioni di potere da una parte, e di vulnerabilità dall’altra. Soprattutto perché la responsabilità che ne deriva, si fa carico anche di realtà remote nello spazio (uomini e territori lontani) e, nel tempo (l’umanità futura)”.
Certamente la modernizzazione dei costumi e delle idee non è approdata a un risultato integrale ed esaustivo perché si è dovuta misurare con fattori limitanti, con istanze individuali e sociali di tipo politico, economico e imprenditoriale non sempre confacenti al ‘rispetto sociale’. Non a caso il sociologo Zigmunt Bauman (5) ha molto insistito nella ricerca instancabile di quell’ ‘identità’ che è poi “..divenuta precaria come tutto nella nostra vita”, essendo venuto meno il vincolo temporale nei rapporti interpersonali a causa di dialoghi preferibilmente a distanza, pause troppo lunghe di riflessione, richieste di chiarimenti mai espletate e sconfinamenti in territori diversi.
Sconfinamenti che hanno dato seguito al senso di smarrimento, incapacità di introspezione, inconsapevolezza dell’attenzione, che ha colpito tutti, uomini e donne indistintamente, trascinandoli in un processo di sterilizzazione dell’immagine sedimentata di “ciò che è stato” (assenza di memoria storica), per approntare una domanda tipo: “chi sono io oggi?” (mancanza di identità futura), che ha portato l’individuo a discernere nella “paura liquida” che affligge l’intera comunità umana, segno evidente di una collettività in dissolvimento che non contempla in sé alcuna risposta propositiva. Sebbene si metta ancor più in evidenza il sorgere di un nuovo ‘problema’ – individuato da Bauman – che va ad aggiungersi ai tanti altri che una ‘società liquida’ quale è quella in cui viviamo, che all’apparenza sembra impossibile contestualizzare, se non andando a “...ricercare un modello ‘ultimo’, migliore di tutti gli altri, perfetto, da non poter essere ulteriormente migliorato, perché niente di meglio esiste né è immaginabile”.
“Ma non basta ‘concettualizzare’ una identità qualsiasi – ha inoltre asserito Bauman – bisogna puntare sulla ‘identità sociale’, radicale e irreversibile, che coinvolga gli ordinamenti statali, la condizione lavorativa, i rapporti interstatali, le soggettività collettive, il rapporto tra l’io e l’altro, la produzione culturale e la vita quotidiana di uomini e donne”. Quasi si fosse davanti a una catastrofe considerata inevitabile; conforme cioè all’intraprendenza della ‘natura umana’ di fronte a una forzata convivenza democratica e alla mancanza di un comportamento ‘etico’ austero che non lascia comprendere e non giustifica le proprie e le altrui convinzioni.
Immersi in questo modello di società fin troppo ‘individualistica’ e solo astrattamente ‘egualitaria’, assistiamo al perseguimento di sommovimenti socio-economici (ipertecnologia, globalizzazione, squilibri geografici, nazionalismo, razzismo, fondamentalismo), che segnano il punto focale di una svolta ‘retroattiva’ dei limiti dello ‘status quo’ secolarizzato, accettato e difeso un tempo da un ‘rispetto’ imperante che, seppure ieri consentiva una sicurezza interiore e una apparente possibilità collaborativa, oggi più non appaga, minacciando una catastrofe imminente sul piano del ‘rispetto’ interpersonale e quindi comunitario. Se altresì osservato, in quanto paradigma di un ‘fare’ più libero e aperto, il più ampio possibile a noi assuefacente, rivela invece una “...propria autonomia che inneggia alla rottura della coazione, come condizione sine qua non per sostenere un dialogo franco con il futuro” (Bauman), che comunque non da garanzia di un’autonomia certa.
Una chiave di investigazione su base teorica questa, che non consente qui di considerare la “trasformazione del presente” in atto, cui volenti o nolenti assistiamo, in quanto “costruzione di senso” attraverso l’utopia di un agire solo apparentemente incondizionato, anche se spesso utilizzato come interfaccia di nuove aggregazioni dell’esperienza fenomenologica che, si vuole, portino a una “ridefinizione critica del reale”. Un argomentazione che a sua volta aveva appassionato Alberto Melucci (6), ritenuto il ‘sociologo dell’ascolto’, aperto ai temi della pace, delle mobilitazioni giovanili, dei movimenti delle donne, delle questioni ecologiche, delle forme di solidarietà e del lavoro psicoterapeutico. Il quale, in anticipo sui tempi, aveva già esplorato il mutamento culturale dell’ ‘identità’, in funzione della domanda di cambiamento proveniente dalla sfera lavorativa, affrontando i temi dell’esperienza individuale e dell’azione collettiva nella loro ricaduta sulla vita quotidiana e sulle relazioni di gruppo; non di meno riconfermando la validità dell’interazione scientifica tra le diverse discipline, e apportando innovativi contributi alla ricerca sociologica.
“Sono convinto – scrive Melucci – che il mondo contemporaneo abbia bisogno di una sociologia dell’ascolto. Non una conoscenza fredda, che si ferma al livello delle facoltà razionali, ma una conoscenza che considera gli altri dei soggetti. Non una conoscenza che crea una distanza, una separazione fra osservatore e osservato, bensì una conoscenza capace di ascoltare, che riesce a riconoscere i bisogni, le domande e gli interrogativi di chi osserva, ma anche capace, allo stesso tempo, di mettersi davvero in contatto, con gli altri. Gli altri che non sono solo degli oggetti, ma sono dei soggetti, delle persone come noi, che hanno spesso i nostri stessi interrogativi, si pongono le stesse domande e hanno le stesse debolezze, e le stesse paure”.
2) Metodo del consenso individuale alla fiducia
La consapevolezza del ‘rispetto’ è quindi una questione metodologica basata sul riconoscimento dell’uguaglianza che, ai fini di una valida prerogativa di senso è tuttavia carente di un supporto solido che lo sostenga e che solo una certa dose di altruistico ‘consenso’ può, in certo qual modo, convalidare. Cioè l’accettazione di una fattiva ‘uguaglianza nella diversità’ necessaria per una convivenza senza conflitti, in cui vengano riconosciute e accettate le differenze di razza, di colore, le diversità di status sociale, i comportamentali degli individui e i diversi ruoli che ognuno si trova ad occupare, in ragione di favorire le relazioni interpersonali e intergovernative, in una società sempre più rivolta alla cooperazione tra i popoli e gli stati, dedita agli scambi reciproci di idee, informazioni, conoscenza, tecnologia ecc..
Altresì nel ‘rispetto’ individuale e nel confronto fattivo con le diverse posizioni dell’altro/a, e cioè nell’investire il proprio ‘consenso’ nelle scelte della/e partnership individuata come consone alla qualità della vita che si vuole o si vorrebbe attuare, ponderata sulla ‘fiducia’ e comunque nel ‘rispetto’ delle ‘differenze individuali’ (genetiche, pedagogiche, psicologiche), dell’estrazione pedagogico-socio-culturale, formativa, nonché delle diverse disposizioni comportamentali acquisite, senza cercare di manipolarle; così come di non giudicare le scelte e le opinioni dell’altro/a in modo sommario perché considerate minoritarie che rasentino una qualche forma di razzismo.
Per quanto, in ambito giuridico il ‘rispetto’ si affacci alla soglia del ‘diritto’ di ogni individuo di avere un suo modo di pensare, di esprimere la propria opinione, di sentire, di agire e persino di scegliere i suoi gusti e le sue preferenze di vita, di pretendere che nessun altro possa permettersi di obiettare o decidere al suo posto; nella specifica tipologia delle ‘scienze umane’ si tratta di offrire/accordare una relazione consensuale basata sul ‘consenso’ che porti all’ascolto non valutativo, dove si concentra la comprensione dei sentimenti nel rapporto emozionale e/o intellettuale di merito e di partecipazione ai bisogni fondamentali degli altri.
Nell’uso comune è detta ‘empatia’ l’attitudine ad essere completamente e/o parzialmente disponibili verso gli altri, mettendo da parte le preoccupazioni e i pensieri individuali, pronti ad offrire la piena attenzione al processo di comunicazione, accesso all’informazione e partecipazione alla cooperazione attiva ‘non coercitiva’ che, secondo il ‘metodo del consenso’, non significa ‘unanimità’ di intenti e di voleri di singoli individui o del gruppo di appartenenza, bensì di funzione espletata democraticamente cui la maggioranza dei soggetti avrà acconsentito secondo la propria onestà intellettuale. Se non c’è l’onesta volontà di venirsi incontro, il metodo del consenso non funziona, bensì si rende più che mai necessario anche nella difesa di quella ‘privacy’ che ostinatamente promulghiamo come visione utopistica di una realtà che non è più tale, se mai lo sia stata.
Acciò, dare oggi il ‘consenso’ all’utilizzo dei propri dati personali che diventano così di pubblico dominio può essere un modo (facendo attenzione) di aprirsi al mondo degli scambi e della collaborazione reciproca a livello internazionale; così come mettersi in gioco sul web significa la ‘volontà’ di ampliare la propria cerchia di conoscenze, e perché no di fare nuove amicizie e così abbassare il tasso dilagante di sentirsi abbandonati, sotto l’egida del “non siamo soli”, necessaria ai fini della reciprocità sociale che ci vede sempre più affetti dalla solitudine.
3) Metodo del consenso alla temperanza comunitaria
L’approccio qui espletato equivale a ‘farsi un’opinione’ sul merito se oggi il ‘rispetto’ sia o no essenziale nei rapporti umani (?) Se la domanda serve di fatto a chiarificare un problema etico-teorico, la risposta non può che essere: «sì, è essenziale», ma è come asserire l’esistenza di un 'dualismo’ insopprimibile per cui la risposta non è affatto univoca. Gli ultimi avvenimenti di cronaca ben lo evidenziano ponendoci di fronte situazioni insostenibili quanto sconvolgenti, riferite all’assoluta mancanza di tolleranza, reciprocità, liberalità e democracità che superano ogni limite di sopportazione e comprensione umana. Per quanto intraprendere guerre fratricide e stermini di massa, privazioni e allontanamenti dagli originari territori di appartenenza, innalzare muri ai confini e barriere di chiusura al libero accesso, più spesso eretti in nome di questa o quella ‘supremazia’ territoriale-supernazionale in cui domina l’intransigenza e la severità di giochi di potere, non sembra portare a una risoluzione dei problemi.
Tanto meno risultano determinanti i molti tentativi di ‘risoluzioni di pace’ affatto conciliabili e, sempre più spesso, avanzati in nome di una diversità etico-morale del tutto confutabile, di cui sono andate perdute quelle che sono le ‘ragioni primarie’ di una possibile convivenza fra i più deboli e i diseredati, venendo così a mancare quel ‘rispetto’ e quell’indulgenza necessaria che mettono a rischio la sopravvivenza. Ma non è già il falso ‘moralismo intelluale’ dei pochi ad erigere le barriere che oggi delimitano le frontiere degli stati e i campi d’azione dei politici del malaffare, quanto la mancanza di ‘temperanza’ e l’indifferenza fraudolenta dei molti a derubricare il sistema economico-produttivo e la convivenza dell’illegalità giuridica e l’illegittimazione sociale.
“Di che cosa sia il moralismo si può certo discutere – scrive Stefano Rodotà (7) – ma la critica non può trasformarsi in pretesto per espellere dal dibattito pubblico ogni barlume di etica civile. (..) Contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni decise ad applicarle. Ma serve soprattutto una difusa e costante intransigenza morale, un’azione convinta di cittadini che non abbiano il timore d’essere definiti moralisti, che ricordino in ogni momento che la vita pubblica esige rigore e correttezza.”
Il merito di una tale affermazione si gioca su quei comportamenti resi affidabili dal rapporto fiduciario che in illo tempore è stato stabilito con la natura e successivamente tra le diverse comunità interessate a limitare i rischi delle carestie e della fame, quantomeno coinvolte nella volenterosa sopravvivenza della specie. In una società complessa come quella in cui siamo chiamati a vivere (o sopravvivere dipende dai punti di vista), la crisi nella ‘fiducia’ non riguarda solo chi viola la legge o non si adegua agli standard di vita diffusa, ma investe ogni ambito della vita socialee comunitaria.
“Di fatto – scrive Umberto Galimberti (8) – non possiamo prescindere dal ricorrervi (alla fiducia), perché degli altri, piaccia o non piaccia, non possiamo fare a meno. (..) Nei nostri comportamenti accordiamo di continuo una fiducia che intimamente non (sempre) nutriamo, perché non abbiamo alternative. Infatti, laddove le abbiamo, non esitiamo ad adottarle, affidandoci a tecnologie sempre più complesse”. D’altro canto “Il mercato indotto dalla sfiducia ha assunto proporzioni notevoli, sforzi e costi sono cresciuti in proporzioni, ma i risultati sono tutt’altro che esaltanti. Quanto più la nostra società si fa complessa, quanto più diventiamo gli uni estranei agli altri, tanto più siamo costretti a muoverci e a vivere tra attività, organizzazioni e istituzioni le cui procedure e i cui effetti non riusciamo a controllare e a capire. E perciò siamo inclini a crederci esposti a pericoli invisibili e indecifrabili, con conseguente perenne stato d’ansia facilmente leggibile nei tratti tirati e circospetti dei volti di ciasscuno di noi, (..) caratterizzati dalla precarietà dell’esistenza.”
“Allo stesso modo – conclude Galimberti – questa nostra ‘società del rischio’ è percorsa per intero da una sospettosità diffusa, dovuta ad un tasso troppo elevato di estraneità degli individui che compongono il sociale. A meno che non si debba pensare che la cultura dell’individualismo, tipica dell’Occidente, e la fruizione delle libertà individuali, che vantiamo nei confronti del resto del mondo, abbiano passato a tal punto il segno da rendere ciascuno di noi una singolarità così precaria che, oltre a fare esclusivamente i propri interessi, o forse proprio per questo, non sa più muoversi nel mondo se non all’interno di una cultura del sospetto. Questo mi pare il punto dove le nostre società sono le più vulnerabili, più di quanto vulnerabili le renda il terrorismo”.
In conclusione il dibattito è ancora aperto, una risposta alla domanda “che cos’è il rispetto?”, è tuttavia possibile: cos’e se non un principio etico che ci restituisce la libertà di scegliere (libero arbitrio). Cos’altro, se non quella virtù morale che più d’ogni altra ci rende ‘umani’ (?).
Cioè ‘animali razionali dipendenti’ (9) e così poco sociali (?)
Bibliografia di riferimento:
(1)Maurizio Ferraris, ‘Introduzione’ a “Morale” ed a “Uguaglianza” in Le domande della Filosofia - Gruppo Edit. L’Espresso 2012 ,
(2)René Descartes, “Discorso del metodo”, RCS Libri 2010
(3)Giovanni Reale, ‘Prefazione’ a “Discorso del metodo”, op.cit.
(4)Mario Manfredi, “Teoria del riconoscimento”, Le Lettere 2004
(5)Zigmunt Bauman, “Intervista sull’identità”, Editori Laterza 2008 e “Modernità liquida”, Editori Laterza 2011
(6)Alberto Melucci, "Rassegna italiana di sociologia", n.43 (2002), e in “Identita e movimenti sociali in una societa planetaria: in ricordo di Alberto Melucci”, Milano, Guerini Studio, 2003.
(7)Stefano Rodotà, “Il diritto di avere diritti”, Editori Laterza 2012
(8)Umberto Galimberti, “Fiducia”, in ‘Le grandi parole’ – Polizia Moderna 2010
(9) Alasdair MacIntyre, “Animali razionali dipendenti” – Vita e Pensiero Edit. 2001
*
 - Musica
- Musica
Il Jazz a Roma con Voi
28Divino Jazz - via Mirandola, 21 - Roma - www.28divino.com
Prenotazioni 340 82 49 718
Il Jazz a Roma con Voi.
VENERDI 18 NOVEMBRE
ore 22.00
ANTONIO RAGOSTA
"Back to the Trio"
Antonio Ragosta: Chitarra
Stefano Napoli: Basso
Mattia Di Cretico: Batteria
Dopo l'esordio discografico con “Il mare e l'incanto a Roma est” edito dalla Slam (UK) Antonio Ragosta torna in studio per un nuovo lavoro discografico che vedrà la
luce a breve, con una formazione inedita. Un sound contemporaneo che attraversajazz, blues, rock, musica classica ed atmosfere mediterranee, per approdare in un
linguaggio autentico e spontaneo. Nei nuovi brani continua il viaggio iniziato nelprimo disco, ma con un orizzonte che si amplia includendo nuove possibilità.
Antonio Ragosta è un chitarrista compositore di origini napoletane, trapiantato aRoma. Tra le sue collaborazioni: Sandro Joyeux, Pape Siriman Kanoutè, Gerardo
Casiello, Alessio Bonomo, Paolo Zanardi, Titti Smeriglio, Pilar, Paolo Damiani, Moni Ovadia, Alessandro Haber.
-------------------------------
SABATO 19 NOVEMBRE
ore 22.00
STOCKHOLM vs NAPOLI
Imparato Hedberg Duo
Giovanni Imparato, percussioni, voce
Mats Hedberg, chitarra, ebow, voce
Un duo "patafisico" dove l'improvvisazione è fatta con i fiocchi. E' un piacere ricevere nuovamente questi due artisti sul palco del "28".
l Duo si incontra e suona insieme per la prima volta nell 2006 all Auditorium Parco della musica Roma con il progetto "Roma Caput Music"
entrambi invitati come ospiti solisti per la serata! Nasce in seguito all’inevitabile feeling riscontrato vicendevolmente l ́idea del progetto Stockholm vs Napoli
che stimola i due artisti a confrontarsi con le rispettive tradizioni di origine. Un mix tra musica folk tradizionale/Moderna svedese& Napoletana
inserito in un contesto musicale dove confluiscono molteplici generi, da influenze Progressive ad Afrocubane, in un mix di musica totale! …il tutto
privilegiato da un approccio di estemporaneità ispirata, adottando i moduli della"nobile"musica improvvisativa. nel 2011 Mats realizza un disco proprio
( con Morgan Ågren (Frank Zappa…..) dal titolo VargtonProjekt & invita giovanni a suonare sul CD.
2016 i due artisti maturano finalmente l’idea di entrare in studio realizzando 11 brani, con lo smalto compositivo ed estemporaneo che li
rappresenta, meravigliando e compiacendo le personali aspettative vicendevoli, registrato a roma mixato e masterizzato da Roberto Barillari
(Lucio Dalla/Andrea Boccelli/Glenn Gould) da uscire.. "lo stile del duo è coinvolgente e minimale, fortemente evocativo, il risultato all’ascolto
suscita solarità ed apertura di spirito, si adatta a performance d’arte, a festival jazz, blues, rock, folk , progressive e world music, nonché
contesti di avanguardia innovativa, avendo un repertorio molto versatile stilisticamente."
*
 - Musica
- Musica
Il jazz va al cinema al Palladium di Roma
Al Teatro Palladium torna la rassegna
'Il Jazz va al Cinema' con la New Talents Jazz Orchestra
Dopo il successo del primo concerto dedicato alla commedia italiana, domenica 13 novembre alle ore 18, al Teatro Palladium di Roma, si terrà il secondo appuntamento della rassegna "Il jazz va al cinema", manifestazione che celebra il grande legame che da sempre intercorre tra musica jazz e cinema, realizzata in collaborazione con il corso di laurea DAMS dell’Università Roma Tre coordinato dal prof. Luca Aversano.
Protagonista, come sempre, la brillante New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, formata da talentuosi e giovani esponenti del jazz italiano che interpreteranno, con lo scorrimento delle immagini sullo schermo, alcuni brani resi celebri dalle colonne sonore del film proposti raccontandone trame, attori, registi, passioni.
Il concerto del 13 novembre è dedicato a “I grandi del jazz raccontati dal cinema”, con ospite il pianista Santi Scarcella. In "scena" saranno infatti rievocati i film biografici sui grandi jazzisti tra cui “Bird” di Clint Eastwood, dedicato alla vita di Charlie Parker, a “Round Midnight” con protagonista Dexter Gordon (e la colonna sonora originaria coordinata da Herbie Hancock) o la commovente pellicola su Chet Baker “Let’s Get Lost”.
I prossimi appuntamenti della rassegna, sempre al Teatro Palladium: domenica 4 dicembre “Il Jazz e il cinema noir” che farà rivivere “Ascensore per il Patibolo” - la cui colonna sonora, affidata alle note di Miles Davis con improvvisazione estemporanea sul filmato, fece storia -, “Anatomia di un Omicidio”, con il titolo originale “Anatomy of a Murder" musicato da Duke Ellington e diretto da Otto Preminger, e altri titoli tra cui “Taxi Driver”, “Mission Impossible”, “Vertigo”; domenica 15 gennaio “Hollywood e i classici del Jazz”: dalla celebre “My favorite things” dal musical “The Sound of music” a “Smile di “Tempi Moderni” a “Over the Rainbow” da “Il Mago di Oz”, al dramma de “I Giorni del Vino e delle Rose” con Jack Lemmon da cui il famosissimo standard “The Days of Wine and Roses”.
INFO MANIFESTAZIONE
9 ottobre 2016, 13 novembre 2016, 4 dicembre 2016, 15 gennaio 2017 - ore 18
Teatro Palladium - Università Roma Tre
Biglietto intero € 15 - ridotto studenti e over 65 €10.
Sito web: http://teatropalladium.uniroma3.it/
Prevendite: biglietteria.palladium@uniroma3.it; tel. 327 2463456
CONTATTI
Ufficio Stampa New Talents Jazz Orchestra: Fiorenza Gherardi De Candei
Tel.: 328.1743236 Email: fiorenzagherardi@gmail.com
Ufficio Stampa Stagione Artistica 2016-2017 Teatro Palladium: Elisabetta Castiglioni
Tel.: 06.3225044 – 328.4112014 E-mail info@elisabettacastiglioni.com
*
 - Poesia
- Poesia
Gianmaria Ferrante un poeta nel labirinto specchiato delle p
«Corrono i monatti, alla nuova pestilenza metropolitana … cadono tamburi, striscioni, fantasmi anneriti dal tempo … un cieco testimone batte i pugni, sotto i portici del Duomo … è Sabato» - scrive il poeta, traducendo dall’ebraico Shabbat, il giorno del riposo, ma che è anche il ‘giorno delle streghe’.
Voler conoscere Gianmaria Ferrante attraverso la sua poesia da la sensazione di riflettersi nello specchio del tempo e trovarsi, o forse solo ritrovarsi, dentro la dimensione onirica della conoscenza, in quella spazialità incommensurabile tra passato e presente che ottunde ogni riflessione razionale che si completa nel labirinto del presente. Lì dove, al dunque, ogni dimensione è resa possibile in divenbire esercizio mentale che dal realistico penetra nel fantastico e viceversa, dando luogo a una sequenza connettiva di emozioni, caleidoscopiche visualizzazioni e sentimenti fluidi di cui quasi si disconosce l’appartenenza. E dire che curiosando tra le righe (interconnessione di linee e spazi) si denota nel poeta, in quanto uomo del nostro tempo, una certa solidità di pensiero che mette in luce un’eredità agreste riconducibile a un’indubbia appartenenza secolare, consolidata nel tempo della sua formazione (crescita, maturità, affermazione sociale).
«Io dissi (loro), e tutti si girarono per colpirmi … vecchi guerrieri a caccia nella palude terrena … non riuscirete a sottrarre il manto prezioso (il vello), costruito nell’infanzia (dei miei giorni).»
Una testimonianza congruente questa solo se ci si sofferma a ponderare il ‘messaggio culturale’ costitutivo del suo fare poesia, «..estremamente profondo e complesso, che va affrontato con particolare attenzione», e aggiungo ‘particolare interesse’ nel voler conoscere il suo pensiero: cioè la sublimazione del sapere in tutte le sue accezioni significative, i pieni valori esponenziali, il senso che si vuole dare alla propria vita, per cui: «La poesia intesa come espressione sublime del linguaggio, può diventare un santuario dove rifugiarsi per una sosta rigeneratrice. Aiuta a ‘sentire’ la vita, fa riscoprire valori, amicizie perdute, incontri dimenticati tra le pieghe nebbiose dell’esistenza. Possiede una insospettata capacità evocatrice; può annullare il tempo e, nelle mani sensibili dell’artistsa, diventare uno scalpello. Crea figure dal nulla, scolpisce episodi, cristallizza sensazioni. Riempie il vuoto senza l’uso del marmo.»
La poesia quindi, intesa come espiazione di un passato che ci sospinge tutti verso quel futuro ‘futuribile’, in quanto concezione lineare del tempo, in base a una previsione razionale del possibile. Ecco che il ‘medioevo futuro’ concepito nella poesia di Gianmaria Ferrante trova la sua ragione d’essere in quanto riferimento allo spazio temporale di ‘infinito’, e non già che si oppone al passato quanto, invece, di avanzamento di quanto deve ancora accadere.
Una presa di posizione questa che definirei stoica in quanto coraggiosa, impertubabile di fronte agli accadimenti della storia, e se vogliamo eroica, che si scontra con la variabilità e la mancanza di senso della poesia dei nostri giorni. È questa una posizione forte, che vede abbandonare l’efferatezza della barbarie per rivendicare una contiguità che pure c’è stata, più che in letteratura e in filosofia, proprio nella poesia che, nel sostenere le emozioni, restituisce vitalità alle esperienze umane, al tempo stesso, offrendosi come opportunità dotata di dignità e individualità relazionale.
«Voi maledetti, lasciate sempre una traccia indelebile, al vostro passaggio … violenti demoni sbucati dai sotterranei, in fiume tumultuoso che tutto rovina al suo passaggio. … Era un giorno di Gennaio, il bosco intatto piangeva agli spari di un armigero calato dal grande freddo, con una maschera d’acciaio … venne il grido del figlio sconvolto, in ginocchio accanto al padre ucciso da un topo sotterraneo. Un moto di rivolta dopo tanta follia, raggiunse il Padrone del Creato … spiegò le mani al cielo madido, chiedendo aiuto … venne un alito leggero, il canto di un bimbo appena nato, il pianto di un corvo chiamato a testimonio.»
Ciò a dimostrazione di come il solo mero accordo morale, fine a se stesso, avvalori oggi come ieri e in futuro, lo scambio reciproco; quel donarsi astratto e indistinguibile che pur ci rende grandi. I sentimenti giocano un ruolo essenziale nella genesi e nella costituzione del principio di ‘poesia’, cioè: «..la capacità di ‘empatia’ come presupposto emozionale per un’assunzione di ruolo ideale. (..) Di immedesimarsi e di accettare la prospettiva degli altri, sia con individui socializzati in una forma di vita estranea o dissonante. (..) Si tratta di una disposizione cognitiva che ci rende sensibili alla ‘diversità’, cioè alla singolarità e alla particolarità dell’altro che rimane aggrappato alla sua alterità rispetto alla tradizione.» (Martha Nussbaum).
Per il resto, l’immaginazione narrativo-poetica di Gianmaria Ferrante è solo una parte di quanto egli riesce a trasmettere attraverso i suoi scritti, trasmessi in questo libro nel linguaggio degli haiku, quella caratteristica scrittura giapponese i cui segni, trasmissione di immagini, portano a decifrare sentimenti sensoriali ispirati da elementi naturali, un momento di bellezza o un’esperienza subliminale, pari a quella dei veri artisti e dei poeti, anche se non è di loro escluviva padronanza. Nasce da questa esperienza di scrittura per immagini: «..il parallelo tra il medioevo propriamente detto, quello curtense, e il medioevo metropolitano moderno, cioè delle metropoli, che si fa evidente nella commistione fra manifestazioni di popolo antiche e attuali, in un gioco volutamente allusivo e sognante, di sovrapposizione, di dissolvenza incrociata tra la naturale rappresentazione immaginifica del centro urbano medievale e la puntualizzazione di carattere attuale.» (dalla nota introduttiva la testo).
D’altro canto una scrittura siffatta, rappresenta una fonte di ispirazione per le emozioni del lettore (per me che scrivo in particolare), di richiamarsi al migliore impiego possibile dell’immaginazione letteraria in generale e, nella poetica (oralmente trasmessa) in particolare. Ma veniamo ad alcuni esempi ‘sonori’ insiti nell’utilizzo della parola ‘a se stante’ tenendo presente che le pause (i bianchi o i vuoti che siano) offrono un ampio spettro di forme ‘etiche’ del comunicare, proprie di chi legge in silenzio, o che emetta il suono delle parole. Così l’artista della materia che può essere la pittura o la scultura «..può farci comprendere come la vita sia dipingere un quadro, o dare forma a una scultura, non fare una somma di tutta un’esistenza.», (in M. Nussbaum). Da cui il ‘senso’ delle cose nella realtà/irrealtà dei sentimenti e delle emozioni che forgiano la nostra cultura.
In ciò Gianmaria Ferrante riveste i panni smessi del tempo per dedicarsi ai ‘suoni’ arcani delle parole, alle sospensioni diversificate dalle pause, dei contenuti aspersivi delle note musicali in essi contenute, così come negli accostamenti degli ossimori che riverberano l’ampiezza acustica aggettivante dei suoi concetti, talvolta inespressi, e che pure sono pregni dell’efficacia dell’esperienza ridondante di tutta una vita, la sua vita (?), che quasi viene da chiedersi, quanto di essa rientri nell’autodeterminazione agiografica dell’individuo; e quanto nella divulgazione futuribile di ciò che si è stati; e che preclude la ricerca di un’equilibrio irraggiungibile, che oscilla tra ciò che si è e ciò che si è cercato di essere nel corso dell’intera esistenza di un uomo. Senza considerare i confini (limiti e soglie) fra il vissuto e l’irrealtà filosofico-culturale d’indirizzo, come particolarmente significativi ai fini della scelta.
«L’acqua di cristallo, risplende nella nebbia mattutina che dirada leggera, nell’incanto di una valle nascosta … mormoro una preghiera sommessa, mentre scendo leggiadro la tua china … la stupenda pineta rinsce alla mia vista, mi avvolge un effluvio inebriante. Palpita serena l’anima mia … la vita fluisce libera come il frullo di un passero solitario, il canto del galo cedrone, nascosto nel bosco inviolato … il guizzo della trota salmonata che risale il torrente scosceso.»
Sebbene l’immergersi nel labirinto interstiziale della città/mente da cui prende forma ‘Metropolis’, dopo un inizio di cercata storicità, è qui abbandonato al fine di aprirsi a una visione ‘spalancata’ su un mondo che non gli appartiene, del quale il poeta vuole/cerca le linee intersecanti che gli restituiscano il ‘senso’ di un più sano vivere cui prestare attenzione, in quanto parte essenziale di un’educazione civica almeno accettabile e alla razionalità pubblica della giustizia che l’utilitarismo ha finito col soggiocare. Ma questo che potrebbe sembrare un parlare d’altri tempi non riguarda la vivida scrittura del poeta, tutto è sottinteso e resta nella sfera di quel sentimentalismo di disapprovazione interiore che talvolta lo sovrasta.
«Attendo, nel cristallo immobile del mattino, il tempo concesso al magico sortilegio … giocano luci opali a rimpiattino, stolte figure vagano minacciose sui binari d’acciaio … è un pallido giorno questo, dai vagoni ammassati nel deposito ferroviario s’aprono voragini oscure, risorte … nell’ultimo (mio) viaggio.»
Gianmaria Ferrante risponde con veemenza alla consuetudine dell’accettazione, a suo modo si ribella alla fatate sottomissione degli antichi, e invoca il sempiterno Iddio d’incedere senza clemenza su quei moderni che ‘a parer suo’ pur conoscendo i propri limiti attuano politiche di esclusivi interessi individuali, perdendo nel processo economico-utilitaristico, tanto l’identità quanto la dignità d’esseri umani. È forse il passato che ritorna? Proprio così, è il nostro passato che, anche dopo l’accurato rimaneggiamento e la necessaria quanto inevitabile evoluzione, sovrasta il presente e s’inoltra nel futuro d’una città (Milano), a ricreare tensioni e paure che da sempre ci poprtiamo dietro. Questi in sintesi i contenuti aperti, anzi spalancati, di un fare poesia d’attualità che, pur nella sua ‘liquida’ essenza d’intenti, non lascia spazio ad alcuna promessa di facile riscatto.
«..Il quadro dell’orologio ruota instancabile, l’indice tremante al soffitto plasticato … è l’ora tredicesima questa, l’attimo della sosta, in basso … gli uomini macchina.»
«..è un giorno strano questo … l’ultimo arrivato prepara il giaciglio, stende per terra cartoni sfatti e un sacco … nero di condominio.»
«..dai muri sorge un avviso imperioso, il dito puntato contro il randagio cittadino … lo scalpiccio continuo di piedi ansanti che grufola sotto il porticato.»
È allora che la città metropolitana che viaggia nel sottosuolo diventa la megalopoli di superficie, si popola di individui ‘pallidi’ come fantasmi, ‘scuri’ come la notte, ‘plumbei’ e spaventosi come la morte; i palazzi, le gallerie, i viali, le arcate, i portici, i semafori, l’asfalto che ricopre il tutto; gli strilloni di giornali, i Titoli di Borsa, i tram, le auto, le grida, gli spari, le sirene impazzite, i camminanti, i viandanti, gli impiegati che varcano i tornelli, i telefoni, le stampanti, gli orologi cristallizzati sotto la neve, ma basta una sferzata di forte vento per smascherare il tutto, si tratta di una finzione, di una sosta-pausa scritta, che solo il poeta-principe della regia riesce a far agire sulla scena. Il titolo? Metropolis: «Un rombo indistinto, compressori, fischiano idrovore, ventole arrochite … fruscianti filobus stracciano nel cielo violenti riverberi elettrici, sferragliano i tram sui binari, si bloccano stridendo vicino a grappoli di uomini …» ossessionati da una ricerca di fuga, da ‘uno strappo improvviso’ che li riporti alla ragione, o forse che li consegni alla definitiva pazzia.
«La gente, scivola lontano dal Metrò, portando il vuoto pauroso, fisso nello sguardo … Il mattino scende, in lavacro nelle strade polverose, ramazzando gli scarti della notte, presenta solenne un proclama al popolo in disarmo, il monatto dell’ultima pestilenza (di moda), schizza da un muro dipinto di bianco, il fagotto dell’Inverno si stringe, nelle spalle rattrappite dal gelo, scambierà l’abito grigio, per un tiepido intruglio.»
Quella gente che, come tutti noi e voi, possono dirsi monatti, o forse ‘migranti’ di pestilenze bugiarde, che di città in città si portano dietro il vuoto pauroso fisso nello sguardo. Quelli siamo noi, come voi, amorfi impiegati che sognano la fuga dal mondo: «..non sai decidere tra la prigione dorata che ha reso anonimo il tuo passo … e il grande spazio oltre le guglie del Duomo. Corri amico imbelle, vola sulle ali del sogno, la quinta stagione è questa … nessuno conosce la fine, nemmno il finto santone vestito d’arancio che agita il campanello … al tuo passaggio.»
Ed eccolo al dunque dall’angolo più remoto, affacciarsi sul nostro quotidiano, il ‘medioevo futuro’ di cui stavamo appena blaterando, i cui protagonisti non possiamo che essere noi, quei monatti imbrattati sulle pareti del tempo, fuoriusciti dalle figure graffite sui muri, nelle scritte d’una lingua misconosciuta dedotta da antichi libri esoterici che hanno dato sembiante ai simboli della trasformazione e dell’immaginazione mitica, agli animali e ai mostri fantastici, alle maschere rituali e agli Arcani maggiori, ai segni dello Zodiaco e agli oroscopi, alle fattucchiere e alle cartomanti che s’aggirano di notte in Galleria a Milano, come a Roma, a Napoli e Torino; a quei gargoiles che s’affacciano dalle guglie delle cattedrali, quei doccioni che tanto spaventavano le genti medievali con la promessa di mondarli d’ogni colpa contro la reiterata assenza di una fede certa.
«Cento guglie di marmo, forano il cielo nevoso, ringhia livore il passaggio dell’ultimo raduno … volano striscioni vermigli negli occhi puntati sul Duomo, corrono macchine e sirene attorno … sollevano bardature guerresche, caroselli impazziti sbucati dal passato, lo squillo di una sirena urlante … seguito da uno sparo.»
Uno sparo, un sussulto nel buio mentre… «Questa notte, le pareti oscillano curiose mentre viaggio oltre i confini del noto … la mente libera riordina il passato … affastella parole e suoni di morte raccolti dal tuo cuore malvagio … fra poco, lasciando a terra questo mio fardello, spiccherò il volo … per l’ultimo viaggio.»
C’è un ché di ‘nero’ che coinvolge il lettore di queste pagine, come di un desiderio regresso di giungere alla fine, una lunga infinita lettera di richiesta di perdono, verosimilmente mai spedita a un fratello sognatore, scomparso in illo tempore e amato oltre misura … ma chi può dirlo non è certo il lettore, se non il poeta chi?, in cui è detto: «..la vita è pastura di uccelli affamati, una pozza striata nel ghiaccio rigato di grigio … il viso impresso in un lago d’asfalto, il sogno temuto che irrompe improvviso ... mi blocco, pieno di spavento, smarrito in un pozzo … aperto sull’abisso.»
Note sull'autore:
Gianmaria Ferrante, a 22 anni si reca in Inghilterra per mezzo di una borsa di studio e si diploma agli studi, con particolare riguardo alla letteratura Inglese. Tornato in Italia svolge mansioni tecniche di rilevante importanza; passa poi alla Formazione del Personale e alle Relazioni Industriali di una grande azienda milanese, continua i propri studi e l’attività letteraria, gestisce inoltre uno studio professionale privato. Successivamente al suo ritorno in Italia pubblica "Una pallida notte", cesura ideale tra il passato ormai annullato e un ventennio di invenzione artistica e letteraria. Fa seguito la Trilogia della Pietra (La Città Bianca, Mediterranea e Metropolis) tradotte integralmente in Inglese da Peter De Ville; quindi il secondo romanzo " Un Uomo di successo " (per video, book trailer e intervista vedi YouTube Gianmaria Ferrante). Quindi prosegue nella revisione di quanto realizzato in un eterno punto di transito e rifugio, testimone di magici incontri e terrificanti battaglie, immerso nella sua storia millenaria, imbevuto di cultura proveniente dall'intero Mediterraneo e pubblica in questi ultimi due anni la Trilogia del magico (Vento del Nord, Il Cerchio Magico premiato nel 2014 a Lecce e Notte a teatro). Della successiva 'Trilogia del Sogno', nel mese di Febbraio 2015 viene pubblicata a Genova la silloge ‘I Cavalieri di Groen’. In Aprile 2016 esce per GOLDEN PRESS ‘La Soglia. Ritiratosi anzitempo dalla vita attiva per dedicarsi completamente alla letteratura, oggi vive principalmente nella propria azienda biologica, visitata da volontari provenienti da ogni parte del mondo, situata nel Parco degli Ulivi di Puglia, in territorio di Ostuni.
Opere pubblicate:
‘Gli amori verdi’ (romanzo), Editrice Arpa Letteraria, Milano; ‘Il sogno d’alabastro’ (poesie), Lo Faro Editore, Roma; ‘Una pallida notte’ (poesie), Gruppo Albatros, Viterbo; ‘La città bianca’ (poesie), 1° edizione Italiana, 2° edizione bilingue - Inglese con testo a fronte - Golden Press, Genova; ‘Mediterranea’ (poesie), 1° edizione Italiana, 2° edizione bilingue, Golden Press, Genova; ‘Metropolis’ (poesie) 1° edizione Italiana, 2° edizione bilingue, Golden Press, Genova e Il Cerchio Magico, Golden Press. Genova.
Tutti i ‘corsivi’ appartengono all’autore Gianmaria Ferrante tranne quelli in cui è citato un diverso autore.
Per Martha C. Nussbaum , ‘Giustizia Poetica: immaginazione letteraria e vita civile’ - Mimesis Edizioni 2012.
Larecherche.it ringrazia l’autore per aver concesso l’utilizzo dei testi inclusi nel libro ‘Metropolis’, raccolta poetica di Gianmaria Ferrante – Golden Press 2012 con traduzione in inglese a fronte di Peter De Ville.
*
 - Libri
- Libri
Libri: Proust, le dossier
Si dice che non si conosce uno scrittore se non attraverso le sue opere, e che, ancor meglio, lo si può comprendere attraverso l’apparato critico che solitamente accompagna le sue opere, ciò che solitamente avviene post mortem dell’autore. Ma questa, che potrebbe essere una massima valutata sull’operato di ogni scrittore, continua ad avere delle profonde lacune se non è seguita da note biografiche che ne illustrano gli aspetti segreti e i risvolti nascosti nella sua scrittura. È questo il caso del libro di ‘critica letteraria’ dello scrittore Jean-Yves Tadié che, al tempo della prima edizione per Gallimard di ‘Alla riceca del tempo perduto’, era docente di letteratura francese alla Nouvelle Sorbonne a Parigi. Successivamente in Italia sono stati pubblicati altri due suoi saggi: ‘Il senso della memoria’ (Dedalo 2000); e ‘Vita di Marcel Proust’ (Mondaori 2002), che invito tutti ‘Gli amici di Proust’ a leggere per l’analisi accurata di tutto quanto c’è da sapere su quello che, a ragione, è stato definito: ‘il più grande scrittore del XX secolo’: Marcel Proust.
Si tratta in realtà dell’ ‘analisi critica’, pari a una lezione di ‘anatomia’, del testo della Recherche appunto, con escursioni appropriate negli altri scritti (romanzi incompiuti, racconti, lettere ecc.) di Marcel Proust, incentrata nella suddivisione dei diversi generi letterari in essa riscontrati, ricca di riferimenti biografici, cronologia, bibliografia e quant’altro possa incuriosire il lettore in fatto di estetica, cultura del tempo, storia ecc. Ancor più molto spazio è lasciato all’individuazione critica dei personaggi, l’infinita galleria di ritratti (più o meno definiti) che agiscono nell’opera letteraria in cui è facile perdersi, vuoi per il numero dei volumi di cui si compone, vuoi per la corposità del testo ricco di descrizioni dettagliate e una certa ostentazione dell’autore nel far prevalere alcuni aspetti psicologici che li riguardano direi, più che da vicino, dal loro ‘profondo’ onirico, preferenzialmente poetico, che non va sottovalutato.
Trascrivo dalla Premessa:
“Attraverso uno studio complessivo delle caratteristiche della sua scrittura viene messa (qui) in evidenza la rivoluzione che Proust ha portato all’interno del romanzo con la sua geniale commistione di elementi comuni alla narrativa, alla saggistica, alla poesia e ad altre arti quali l’architettura, la pittura, la musica. inoltre il libro tiene largamente conto delle seimila pagine di cahiers che precedettero la redazione definitiva della Recherche e dedica un ampio spazio alla critica proustiana, ripercorrendo i vari metodi di analisi e i risultati, a volte contraddittori, cui sono pervenuti. (..) Come, ad esempio, la sintesi di ciò che a tutt’oggi può essere conosciuto e detto sulla sua opera e sulla sua vita.”
Ma non è tutto, il volume dopo una presentazione generale riferita alla genesi e alla struttura dell’opera nei suoi risvolti culturali ed estetici, analizza le rilevazioni critiche della storia, la visione della società e l’elaborazione del tempo in cui è immerso il romanzo. Per poi spostarsi sui personaggi che esamina ‘uno per uno’ a cominciare dalla figura del Narratore (alias Marcel Proust) rivelandone più spesso il lato ironico-comico dissacratore della società del tempo. Cui fa seguito l’ ‘anatomia’ cui riferivo sopra, dei generi letterari toccati (rivoluzionati) da Proust nel romanzo, e che l’autore Tadié fa rientrare nella gamma comprensiva di stili, quali: comico-tragico, avventuroso-erotico, onirico-poetico, addirittura quale libro di ‘immagini’ che riprende da tutte quelle situazioni descrittive, quindi per immagini, ricreate dalla fantasia dello scrittore. La seconda parte riguarda invece, com’è detto nel sommario: l’analisi delle (altre) opere principali, la cui lettura si rende necessaria per una più approfondita conoscenza di Marcel Proust; rispettivamente:
‘I piaceri e i giorni’
‘Il Jean Santeuil’
‘Le cronache’
‘John Ruskin : le traduzioni e le prefazioni’
‘I Pastiches’
‘la critica letteraria’
‘Il Contro Sainte-Beuve’
E ovviamente della ‘monumentale’ opera : ‘Alla ricerca del tempo perduto’
Interessanti sono i capitoli che compongono la terza parte di questo copioso ‘vademecum proustiano’: a partire dall’apparato critico riferito alla stampa fin dalla sua prima apparizione delle sue opere, e le risposte degli scrittori che con Proust si sono confrontati nelle diverse epoche. Inoltre ad una ricca bibliografia, la corrispondenza tenuta, gli studi e le sintesi delle varie discipline toccate da Proust. Insomma, ce n’è di che rifarsi gli occhi e le orecchie, per quanto ritengo che una riedizione di un libro enciclopedico come quello qui preso in esame, e malgrado le economie editoriali, non possa essere ridotto a un paperback striminzito di carta e di spazi, dove il corpo del testo è ridotto a un minimo legibile da presumere l’uso della lente d’ingrandimento, in pagine senza bordi che non permettono annotazioni, tantomeno l’uso di stickers segnarighe.
Altre pubblicazioni di Jean-Yves Tadié, critico e letterato francese:
• Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle, Bordas 1971.
• Lectures de Proust, Colin 1971.
• Proust et le romano, Gallimard, 1971.
• Le Récit poétique, PUF, 1978; Gallimard, 1994.
• Le Roman d'aventures, PUF, 1982.
• Proust, Belfond, 1983.
• La Critique littéraire au XXe siècle, Belfond, 1987.
• Études proustiennes Ho un VI, Gallimard, 1973-1988.
• Le Roman au XXe siècle, Belfond 1990.
• Portrait de l'artiste, Oxford University Press, 1991.
• Marcel Proust, biografia, Gallimard, 1996
• Le Sens de la mémoire (avec Marc Tadié ), Gallimard, 1999.
• Proust, la Cathédrale du temps, Gallimard, coll. "Découvertes", 1999.
• Regarde de tous tes yeux, regarde! Gallimard, 2005.
• De Proust à Dumas, Gallimard, 2006.
LEGGI ANCHE: “PROUST. FRAMMENTI DI IMMAGINI”
Roberto Peregalli - Bompiani 2013.
Recensione di Giorgio Mancinelli nella sezione ‘Narrativa’ su questo stesso sito.
*
 - Poesia
- Poesia
Carlos Sánchez, o la stravagante vaghezza di vivere.
“Per vivere ho scelto mille imbarcaderi incerti
e ha ancorato la mia nave senza presunzioni né smarrimenti.
Ho portato sempre il necessario dentro di me
una piccola fiamma di luce brillante come un faro
e una quantità imprecisata di parole senza voce..”.
. . .
“Non ho visto ancora volare la poesia
nello spazio vuoto della stanza
sarà come sempre incollata
ai vetri sporchi della finestra..”
In un vecchio libro che spesso leggevo da ragazzo c’era un racconto che ogni volta mi colpiva e che accendeva in me la voglia di viaggiare attraverso paesi che neppure conoscevo. ‘Dagli Appennini alle Ande’, tratto dal libro ‘Cuore’ di Edmondo De Amicis era il libro più amato che avevamo da leggere a scuola e sul quale, ogni volta, scorrevano le nostre lacrime di fanciulli. Allora le Ande potevano essere in qualsiasi luogo dell’emisfero a me sconosciuto come dietro l’angolo di casa e, per quanto il maestro si sperticasse a spiegarci in quale parte di mondo fossero situate, a me sembravano così a portata di mano che una notte sognai di poterci arrivare. E infine vi arrivai, ma avvenne tantissimi anni dopo, quando non ero più un ragazzo e da tempo avevo smesso di sognare. Solo allora ho capito il senso occulto del racconto, il peso di quella ricerca, la fatica del viaggio, la gratificazione a un volere/potere che sapeva di riconoscimento …
“Da grande ho imparato
che gli uccelli volano
guidati dalla necessità
che gli amori si dissolvono
nel vento del tempo
che le rivoluzioni
finiscono annegando
nei fiumi della storia
che l’eternità non dura.
Ma non mi dispero
continuo a cantare”.
E camminando canterò fin quando avrò fiato in gola, sembra voler dire Carlos Sánchez, nel ultimo libro di poesie ‘Continuerò a cantare’ 2015, e nel precedente ‘La poesia, le nuvole e l’aglio’ 2009, entrambi per le Edizioni Librati.
A distanza di tempo quel piccolo libro, polveroso di anni, mi è tornato tra le mani e non ho potuto far altro che aprirlo e rileggerlo qua e là anche se in modo diverso di quando lo avevo letto da ragazzo, quasi come un vademecum degli anni trascorsi, di una vita consumata tra le righe, nelle frasi più dolci e talvolta amare che hanno fatto di quei racconti una eccellenza della letteratura non solo italiana. A sua volta l’argentino Carlos Sánchez nativo di Buenos Aires ha viaggiato per lungo tempo per il mondo, dall’America Latina all’Estremo Oriente, per poi raggiungere l’Europa e approdare in Italia, dopo aver percorso una sorta di itinerario inverso: “Dalle Ande agli Appennini” dove, ‘dopo molto camminare’ in fine si è fermato …
“Per fortuna
ho imparato più dalla gente
che dai libri
di certo essi
mi hanno dato le parole
i concetti
coi quali il mio intendimento
insieme al vissuto
si sono fatti carne”.
Ed è a quel ‘vissuto’ che il poeta fa più spesso riferimento nei suoi versi che hanno il peso della leggerezza intrisa degli umori del tempo, che ha come attinenza la scioltezza del momento, l’effimera agiatezza della consolazione, “..il calcolo dei giorni è inesorabile”. La sua carriera di professore di lettere ci dice ch’egli è uomo di grande esperienza comunicativa e comunitaria che tuttavia, non ostenta nel parlare né nello scrivere, mantenendosi dentro una linearità affatto artificiosa che ‘dice quel che dice’ con la semplicità e l’uso del lessico comune, quasi pedestre, “in questo meraviglioso quotidiano” …
“Appena
una timida parola
di uso volgare
stordita
tra tante parole
confusa
tra tanti concetti
invecchiata
fucilata
dimenticata-
Libertà”.
Libertà non è una parola presa a caso per chi arriva da paesi che in passato hanno conosciuto le guerre e l’oppressione del potere, e non è neppure l’esternazione di un dolore ormai cessato che il poeta riversa nelle pagine di questo e dei suoi altri libri di poesia. Direi piuttosto, usando le sue stesse parole “..che certi spazi sono rimasti vuoti”, in quanto reiterati o, per così dire, ricompensati dalla serenità successivamente acquisita, “..Sarà che mi sono distratto oltremisura nell’aggiustare l’equilibrio nel suo contenitore; sarà che ho scelto solo una stanza buia dove sviluppare le mie fondamenta di vita” …
“Non so se sono confuso
se sono male orientato.
Non sono un uomo di cultura
non so se il Big Bang
si sia generato
solo per creare
in questo minuscolo pianeta
un Oriente e un Occidente..”
. . .
“..dove vivo abbaiano i cani
crescono gli orti
e gli uomini camminano.
Non ci sono luci che accecano
né grandi vanità
girando per le strade
si vive ridotti
stretti quasi senza parole.
Si sa che più in là
c’è il mondo
che ancora ricordo
nel suo terribile sgomento”.
Ma se la parola può risultare scarna non è per cinismo dell’autore, né per ricercato minimalismo del poeta, affatto. Direi per lo più, per “il mestiere incerto dell’ignoto” appreso, forse, dai suoi contatti con la filosofia taoista dell’ - agire senza agire - che, nei paesi orientali di grandi tradizioni, “..si veste del colore della poesia e la trascende, e nel proprio divenire si cangia in trascendenza”, e che noi (lettori) pur riusciamo a sentire nelle diverse liriche qui contenute che la contemplano. “La poesia è uno dei più bei soprannomi che diamo alla vita” – scriveva Jacques Prevert lanciandosi in un haiku risonante amore per il futuro che verrà, e che Carlos Sánchez, sembra voler suggerire nelle sue parole entro un’effimera eternità …
“L’aria è foriera
dei profumi dellinverno
solo con sforzo
posso immaginare la primavera
in agguato
i boccioli che eploderanno
senza dubbio
nella monotonia geniale
del tempo.
. . .
Non so quanto possa essere
rotondo questo mondo
che naviga
in uno spazio piccolo
di questo universo
non so neanche
se il grande spettacolo
sia degno dell’uomo”.
Siamo indubbiamente davanti a una sorta di ‘stravagante vaghezza di vivere’ che pure trova nella poesia la ragione d’una propria esistenza letteraria …
“Mentre cammino
mi frugo nelle tasche
le scarpe consumate
le mani screpolate
si annodano
vedo cartelli
con avvisi di pericolo
incroci
che non appaiono
sulle mappe.
Cammino, cammino
senza contare i passi
cammino
senza ricordare
quale fu il primo
l’istante
in cui mi trasformai
in un pellegrino.
Non so se arriverò
non so nemmeno dove”.
. . .
“Le distanze si misurano con i sogni
in quest’avventura fugace che è la vita”.
Per non dire delle ‘parole’ di cui fa uso nelle sue poesie, (ma è giusto chiamarle poesie?, che forse cambierebbe il senso di ciò ch’egli vuole comunicare?) …
“Le parole non sanno fare
provano inutilmente
ma non fanno
vanno troppo veloci
precedono di molto
le nostre buone intenzioni
che dopo si dimenticano.
. . .
Le avvolgo in carta regalo
e diventano oziose”.
Ma l’ozio è spesso foriero d’inganno, se chi medita lascia ‘fare senza fare’, allora anche prepararsi un tè può ricevere quelle attenzioni che si riversano in noi, in tutti noi, alllorché c’immergiamo nel vuoto onirico delle pacate emozioni …
“Preparo un tè
per quel pezzetto irlandese
del nonno
che porto in questo antico
cuore
carico di altre cose.
. . .
Bevo il mio tè
camminando per la casa
senza pensieri
dedito come sono
alla vita”.
Questa ‘vita’ cui il poeta cerca e vuole dare caparbiamente un senso, è in fondo la vita che noi tutti viviamo, seppure in modo diverso l’uno dall’altro, e che sempre più spesso ci fa chiedere: perché? E per quanto la domanda viaggi sospesa nell’aria in attesa che di una risposta che non arriva, siamo costretti nell’attesa di ciò che sarà, domani o in qualsiasi altro futuro, “alla catechesi di un dio vendicatore che ci accompagna fin dall’infanzia: (..) non so a cosa serva spiarmi se dopo non risponde. (..) Non sarà che alla fine lui avrà il mio volto?” …
“Ti seguo fino a perdermi
in un bosco
di alberi invertiti
cantano i cervi
le favole
le pietre che rimangono
sul camino
ti seguo
perché sei
l’unica cosa che ho
e non possiedo niente
se non questo seguirti
senza guardare dietro
sernza storia
come un lupo
che ulula
verso il mistero”.
Eppure sono certo di vivere, seppure sia assente nella mia ‘stravagante vaghezza di vivere’…
“Vivo in un mondo folle
dove la mia pazzia
passa inosservata
tra tante pazzie.
Nel manicomio
le ideologie sono morte
dicono i dottori
i laboratori farmaceutici
producono tranquillanti
per curare qualsiasi barlume
di libertà.
Così si calma il sistema
si democratizza la rassegnazione.
Gli dèi seduti
in una nuvola immensa
non si danno pace
e cercano senza consolazione
di scoprire
dove sia stato l’errore”.
Perché d’errore si tratta, non c’è dubbio alcuno …
“Una porta che si apre sul vuoto
una finestra senza vista
un soffitto che non copre il cielo
un uccello che non sa cantare
una montagna affondata in un pozzo
un sole misero che non illumina
un campo dove non cresce niente
un vento che non muove le foglie
un rumore di silenzi sordi
una rosa morta nel camino.
Visione fugace di un istante
che si ripete in questa mia vita”.
“Per vivere …
Ho visto centinaia di mari che ormai non ricordo con certezza
e un’incerta quantità di uccelli e pesci saltellanti.
Le tempeste hanno fustigato le mie vele senza abbatterle
e le correnti a volte mi hanno allontanato dalla rotta
venti tropicali ed antartici hanno colpito il mio volto
senza mai togliermi quel tenue sorriso da viaggiatore alla deriva.
Le grandi navi che ho incrociato nel mio lungo vagabondare
mi hanno lanciato segnali di pericolo che mi sono rifiutato
di decifrare ...
Non ho mai accettato passeggeri a bordo nelle mie
lunghe traversate
una certa timidezza di fondo invadeva le mie parole
ed i miei occhi …
Mi sento un uomo fortunato in mezzo all’oceano
un uomo che niente attende, che nessuno attende:
forse la morte”.
C’è una strana alchimia in queste sue parole che risale il fiume avito dell’esistenza e si trasforma in vita, come per “..l’illusione d’inchiodare il tempo al muro”, o forse “..per smettere di pensare all’avvenire”, mentre nel presente “tutto scorre come un fiume”. Perché scrivo? Si chiede l’uomo Carlos Sánchez, approfittando per un istante dell’assenza del poeta: “Scrivo ora, perché non ho voglia di riordinare la stanza, di andare a comprare il giornale con le sue orrende notizie, di abbandonare questa finestra che s’immerge, nelle montagne innevate, perché è migliore sguitare in questo mestiere di vagabondo, di collettore di parole, di diffide con me stesso e con questa società aberrante … Scrivo perché mi viene voglia, scrivo per essere vivo, scrivo senza animo d’eternità”.
..Solo ogni tanto mi trattengo nel cammino e guardo, ma solo perché ho imparato a guardare.
Carlos Sánchez è nato a Buenos Aires, in Argentina, nel dicembre 1942. Ha viaggiato in molti paesi dell’America Latina e del Medio ed Estremo Oriente come consulente ed esperto in comunicazione sociale per diversi organismi delle Nazioni Unite e della cooperazione internazionale. È cittadino italiano e risiede a Folignano (Ascoli Piceno). Ha lavorato come lettore e professore di Lingua e Letteratura Ispanoamericana presso l’Università di Cassino, “La Sapienza” di Roma, e “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Ha pubblicato: “Gestos”, poesie (ed. Juan Mejía Baca, Lima, Perú, 1964); “America Latina, il mio paese”, fotografie (ed. Experimenta, Napoli, 1976); “Appunti di vita”, poesie (ed. Experimenta, Napoli, 1978); “Segno di terra”, romanzo, (ed, Lalli, Siena, 1983); “L’inquilino scomodo”, poesie (ed. Gemina, Roma, 1991); “La efímera dulzura de vivir”, poesie, (ed. Búho, Santo Domingo, Repubblica Dominicana); “Doce cuentos para ser leídos en conchos y voladoras”, racconti, (ed. Búho, S.D., Repubblica Dominicana); “Alta Marea”, poesie, (ed. Quasar, Roma, 2005); “La poesia, le nuvole e l’aglio” (collana “I Poeti di Smerilliana”, ed. Lìbrati, Ascoli Piceno, 2009), “Ricordati che non sai ricordare” (ed. Lìbrati, Ascoli Piceno, 2010), “Sempre ai confini del verso - Dispatri poetici in italiano”, (Antologia a cura di Mia Lecomte, Ed. Chemins de tr@verse, Paris, 2011). Le sue poesie si trovano nell’“Antologia della poesia argentina”, a cura di Raúl Gustavo Aguirre, (ed. Librería Fausto, Buenos Aires, Argentina, 1979). Attualmente collabora nell’Area Europea alla rivista polidiomatica on-line d’arte e cultura “I Poeti Nomadi”. Poesie, racconti e articoli, sono stati pubblicati in riviste e giornali dell’America Latina e d’Europa, come pure su numerosi siti internet.
Una definizione che bene gli si attaglia lo ritrae come una “ mente corporale senza tregua attraversata da un’infinità di molecole materiali, memoriali, astratte. Le trafitture lasciano cicatrici. Le cicatrici producono metafore. Globetrotter instancabile o sedentario che indossa la maschera del Gaucho di Folignano, fotoreporter e scrittore, cittadino precario di una catena seriale di città del mondo, ospite provvisorio del deserto e del cielo, egli si ritrova alla fine nella ricchezza di due lingue, il castigliano e l’italiano, il cui impasto fantasmagorico regala al lettore i loro morsi e la loro dolcezza”.
Lieto di tornare a parlare del tuo essere poeta in questa società senza poesia. (G.M.)
*
 - Poesia
- Poesia
Nel bosco senza radici, libro di poesie di Amina Narimi
‘Nel bosco senza radici’ – poesie di Amina Narimi, Terra d’Ulivi Editore 2015.
“Eppure tutto è
ancora oscuro mentre segreto
ci plasma e ci àncora un volto nuovo,
nuova la spinta ad amare
un attimo prima di nascere
un istante prima di dimenticare.”
C’è una poesia che scorre silenziosa lungo il crinale della sofferenza, talvolta solo interiore, perché insormontabile è il dolore che l’ha causata. È allora che questa si mostra a noi come una forza ctonia, allorché la ragione oscura della sopravvivenza richiede un atto di forte solidarietà che la contenga. Ben lo sa il poeta la cui emotività afferra gli spasimi dei sentimenti assopiti nel dolore, quello stesso che, in certo qual modo, esplode nell’anima prima di addivenire verso, parola lirica e canto, prima d'essere preghiera, ancor prima di farsi pianto, cui alcun fiume possa contenere le lacrime sparse …
“..tra la crisalide e la rosa ricomposta
c’è un dono che si sporge dalle labbra,
danzando per minuscole fiammelle
da un punto di paura allo splendore.”
Nessun altro colore che non sia sporcato di rossa terra, sarebbe accolto nella tavolozza d’amore che l’autrice, Amina Narimi, ancor prima d’essere poeta, usa nel tessere le sue tele che del suo arcano sembiante portano il segreto. Un lontano afflato confidenziale che la restituisce alla natura genitrice di quell’eredità ancestrale, mai venuta meno, che ha attraversato deserti, valicato montagne, navigato fiumi scorsi a cercare l’immensità di quel mare che un giorno, forse troverà, ma solo quando l’incoffessato e profondo amore per la vita, si tacerà dal ridestare i fantasmi del creato, nei suoi versi …
“..Il punto di partenza della voce è fermo.
Rimane il secchio d’acqua che ti porto
la vibrazione del legame.
Rimane la sete in un sottile movimento
lungo il taglio gli occhi di betulla che ricordo.”
Allorché le divinità arcaiche degli elfi e delle fate, delle streghe e dei geni primordiali della terra, così come degli stormi d’uccelli multicolori che affollano il suo ‘bosco senza radici’, le renne e i lupi delle sue ‘distese nevose’, la moltitudine dei suoi cavalli bai, assieme agli unicorni delle sue ‘fiabe amare’ e le sue mandrie strappate dalla ‘selva profonda’ dei suoi labirinti di parole, tutte convergeranno nell’arca d’amore che Amina Narimi va costruendo per loro, onde riscattarli, quasi per una rivendicazione di vita, da quel ‘paradiso perduto’ che noi tutti, anime vegetali, animali, umane, abbiamo ereditato per una colpa, o forse cento, mille colpe, che non avremmo mai commesso …
“..ho sognato per haiku, e per amore.
Nella grande volta delle palpebre, la notte che noi siamo”
. . .
“..la paura che mai hai avuto, deponi
nel cuore mio impaurito quella forza e solo
una niniva di mussola sottile
respiro di quiete, la neve.”
È allora che il canto, divenuto preghiera, s’apre e si consuma fra le righe di questo ‘dramma lirico’ che l’autrice sottopone in chiave poetica alla lettura di quanti sono propensi a seguirla lungo i crinali, i crepacci, le valli e i boschi d’una solitudine imperfetta perché audace, svolta come in una battaglia immaginaria sulla terra capestata dagli zoccoli dei cavalli, resa fendente dalle spade e dalle armature che cozzano, nel brivido dei corpi di eroi ed eroine invisibili che, quasi dessero corpo ad una tela, la colorano di rosso sangue, di cui solo s’impregna la polvere sollevata nel tramonto di un’era che non è mai stata nostra …
“..Un’esistenza fatta di visioni splende
estrema
vissuta nella pelle è intatta
nelle pupille chiuse evoca i nostri cristallini chiari,
non c’è polvere nel coraggio
né paura nella fame,
sto imparando il buio, è un eccesso di luce il nero
l’unione dei contrasti il suo splendore.”
. . .
“Nulla sappiamo
di promesse, di crudeltà, di paradisi e paralisi o
consumazioni
possediamo la parola divisa del luogo
il dove del giorno in cui ricomponiamo muta
la vita.”
Un crepuscolo luttuoso in cui vinti e vincitori, (ciò che noi siamo), giacciono sfiniti sull’orlo inconsistente della vita, come alberi di un ‘bosco senza radici’ …
“..Saremo lontani, al temp(i)o dell’ottava elegia
quando avremo colmato la misura dello scrigno.”
Una liricità antica quanto il mondo quella utilizzata da Amina Narimi in cui confluiscono tutte le parole i nomi e le cose dell’unica lingua possibile, capace di farle stare insieme, di dare un senso alla frase concatenata nel groviglio delle trame d’appartenenza atipica alla ‘poesia’ che qui si snoda e si riannoda, come il filo di Arianna che permise a Teseo di uscire dal labirinto o, forse, come le corde tese della tela di Penelope nella lunga attesa che precedette il ritorno (labirintico) di Ulisse: “..l’unica misura di una stessa distanza”. Misura in quanto grandezza, estensione di “..qualcosa che diviene, qualcuno che si forma, un attimo prima di sparire”. Ed ecco che la parola già avanza audace, si fa strada nel buio delle parole, nel ‘bosco senza radici’ della sua e nostra esistenza arcana, che ci consola e che insieme ci ‘appaura’.
Allora è il ‘canto’ e la ‘musica’ che tutta la percorre dentro il silenzio avito, che abbandonando ogni incertezza l’accompagna come …
“..un ramo tra i rami,
dove la foresta cresce,
all’ombra di un tronco che non ha memoria,
se non l’inizio … di una leggenda nuova,
in un inenarrabile solstizio antico.”
E come di trama che “..si elide lentamente, nelle forme cicliche del rito” anche la nostra traccia di lettori “..con quali occhi e mani”, cospiriamo di un divenire che forse non ci è dato “..nell’ansia che sa il termine di tutto” …
“..E frecce come occhi appuntiti sorvoleranno
i campi, di pianura in pianura tesseranno radici
annoderanno per noi tutti i fili
tra un cielo finalmente aperto e un varco
di poesia che brilla dentro il sangue, una miniera di
risposte per la fame e il dolore, un rifugio per chi nasce
o per chi ancora muore.”
No, non c’è finitezza nell’oscura morte, avverte l’autrice, (adesso sì che la chiameremo poetessa), “..È un refolo nel petto che ti avverte, un battito sospeso tra i colori” ...
“..C’è così tanto giorno …
nei cerchi dell’acqua disegnati dal vento …
dove formare un respiro di corpi celesti
un punto preciso …
nel piegare la notte dentro
una solitaria preghiera
ostinata e lunga una luce
che si muove e rincorre
l’apparente girovagare del sole.
C’è così tanto giorno
in cui fermarsi a pregare
per la tua fortuna e per quella di un fiore
per la magia di uno sguardo
per l’arco da cui balza lontano il nostro occhio
senza ombra raggiunge all’infinito
l’orizzonte il punto d’incontro dove fugge il mare.”
Ed è ancora la ‘lingua del poeta’ a parlarci in astratto di qualcosa che non abbiamo fin qui considerato: della luce e dell’ombra che al tempo stesso compenetrano il suo linguaggio, solo apparentemente criptico, quanto plasmato nella nuda terra (rossa s’è detto); ed è ancora la ‘forma’ linguistica dell’antico Aedo, l’epico cantore che si accompagnava al suono della cetra o, se vogliamo, la lingua dell’occulta Sibilla allorché colpita dall’oracolo del nume, che ci parla …
“..C’è un passo che lento gli somiglia
come un odore solo, senza corpo
incede il suono, s’inchina e dentro brilla
nell’involucro di creta e terra.
Prega, il nume che avanza, vicinissimo a dove ritrovarti si rivela
così potente e partorisce luce
un’ombra
in una lingua segreta ad ogni altra
sotto la superficie della forma
per tornare all’Anima e svanire
più grande e ferma
. . .
Assai più grande e di meraviglia pregna.”
A ritrovarci dunque non è facile, presi nel vortice delle parole che volteggiano nell’aria e tra le pagine di questo ‘poema amaro come il fiele’ eppure carico di infinita bellezza stilistica, originale e forse unica, giocata sul filo “..di una luce che ancora non esplode”, quale conseguenza di una volontà dolorosa che non si consuma, ma che brilla ...
“..tra gli alberi, scarna e improvvisa piena di suoni … nella certezza della fine
. . .
Invisibile … non udita viene, con il passo del lupo si
avvicina
nella notte, divorando la tua vita, liberata e calma
luminosa nell’inverno che impaura
spaventosa nell’impronta
attutita cede ad ogni altra forma, in una posa
alla fine intatta
l’orma senza peso di una morte bianca”.
. . . anche per questo forse non finiremo mai di stupirci.
Amina Narimi pseudonimo di Claudia Sogno è l’anagramma di ‘anima rimani’; pubblica sul suo blog personale e sul sito larecherche.it che ospita sue numerose poesie. Sue pubblicazioni inoltre sono presenti sul sito “Il giardino dei poeti” e sul “Word Social Forum”. Alcuni suoi testi si trovano in una recente raccolta di autori diversi pubblicata da Limina Mentis. “Nel bosco senza radici” è la sua ‘opera prima’ datata 2015 edita da Terra d’Ulivi Edizioni nella collana ‘I Granati’, acquistabile sui siti di riferimento o scrivendo direttamente all’Editore www.edizioniterradulivi.it
*
 - Cinema
- Cinema
Ivan Marinović intervista by Cineuropa
The Black Pin: un film ben fatto proveniente da un'industria cinematografica poco nota
di Vladan Petkovic.
23/08/2016 - Il primo film del regista montenegrino Ivan Marinović (nella foto) è stato presentato in anteprima mondiale in concorso a Sarajevo.
Il Montenegro non produce molti film, come si può notare dalla mancanza di articoli sul cinema di questo Paese su Cineuropa, ma anche su altri portali di settore. Tuttavia, le cose sembrano destinate a cambiare, con l'istituzione di un centro cinematografico nazionale a Podgorica nei prossimi mesi e una delle prime voci sulla scena festivaliera internazionale proiettata di recente in concorso a Sarajevo: The Black Pin [+], scritto e diretto dall'emergente Ivan Marinović.
Il film è ambientato nella Baia di Luštica, parte della penisola che forma la Baia di Kotor, una parte storicamente distinta del Montenegro, che è stata per secoli sotto il controllo diretto o la forte influenza di Venezia. Oggi, Luštica e il resto della regione costiera sono il sogno di un albergatore che si avvera, e il denaro russo ha inondato il Paese in quantità enormi negli ultimi dieci anni, con investimenti che passavano per un governo corrotto, arricchendo solo una piccolissima elite politico-finanziaria. Pertanto, i proprietari terrieri in queste aree devono stare attenti ed evitare di essere truffati dagli intermediari, ma vedono ancora la loro unica possibilità di uno stile di vita normale nella vendita dei loro terreni.
Nel film, il pastore Peter (l'attore macedone Nikola Ristanovski, che interpreta magistralmente il protagonista) non vuole vendere il suo terreno. Sebbene non sembri avere molta fede religiosa rimasta (una delle sue prime battute recita: "Se siete infelici in questa vita, molto probabilmente sarà lo stesso dopo"), sente una responsabilità verso la sua famiglia e la sua parrocchia. Da quando la moglie lo ha lasciato, è tornato a vivere con l'anziana madre (la leggenda del cinema jugoslavo Jelisaveta Seka Sablić) e il figlio adolescente ribelle Djordje (l'esordiente da tenere d'occhio Filip Klicov), mentre tenta di gestire il mix frustrante di superstizione e religione male interpretata dei suoi parrocchiani.
Ma il suo appezzamento è esattamente ciò che manca agli abitanti del villaggio, che hanno trovato un acquirente, per vendere la loro terra. Senza il pezzetto di Pietro, non c'è abbastanza terra per chiudere l'affare. Così un gruppo di aspiranti venditori, guidato da Savo (il croato Leon Lučev) e Niko (il serbo Ljubomir Bandović), con l'assistenza astuta del marinaio esperto Dondo (la stella regionale Bogdan Diklić), provano di tutto per convincerlo a vendere - dalla persuasione amichevole ai modi incredibilmente creativi per farlo odiare dagli abitanti del villaggio. Questo, naturalmente, comprende alimentare la loro superstizione, e un'occasione ghiotta è il funerale di una vecchia donna che si diceva essere una strega.
Marinović si avvale di un uso fantastico dei paesaggi splendidi di Luštica, e mette una cura particolare nella progettazione di scene di interni e nell'illuminazione con il direttore della fotografia Djordje Arambašić (che ha dimostrato il suo talento in The Disobedient e Panama). Ma ancora più importante e interessante, in questa storia, che deve molto alla mentalità locale peculiare, il regista evita il sarcasmo d'accatto e le battute e i dialoghi banali, che sono così tipici delle commedie dei Balcani. Il risultato è un film ben fatto che potrebbe, con una corretta pianificazione e posizionamento, trovare la sua strada sia nei multiplex regionali che nei festival internazionali in cerca di un'opportunità più leggera, ma sempre valida artisticamente.
The Black Pin è una co-produzione tra Adriatic Western del Montenegro e la serba EED Productions, venduta all'estero da Soul Food di Belgrado.
THE BLACK PIN
Ivan Marinovic ex studente del FAMU di Praga e ora primo regista del suo Paese con un film nella competizione principale del Sarajevo Film Festival. Abbiamo parlato con lui del suo lavoro e di questo film.
Cineuropa: Cosa l'ha spinta a raccontare questa storia?
Ivan Marinovic: Bisognerebbe cominciare dal motivo per cui ho sempre voluto fare il regista.
Sono cresciuto in un posto dove c'erano tante storie che sentivo da bambino, e che riuscivo già ad immaginare nitidamente. Ho iniziato a pensare al cinema come mezzo di narrazione. Questa storia in particolare l'ho sentita mentre tornavo in Montenegro dall'estero, e affrontavo quella mentalità da una nuova prospettiva. Ho sentito quest'aneddoto su un prete e un funerale, una banda che lo interrompeva e la gente che voleva cacciarlo fuori dal villaggio. Questo tizio, che deve predicare "ama il prossimo tuo", era circondato da vicini che non mettevano troppo in pratica il consiglio. Ho iniziato a pensare alle persone, alla religione e alle superstizioni, e poi ho immaginato un prete misantropo. Ciò mi ha dato molto spazio per integrare altre cose, come queste vendite di proprietà che si effettuano oggi, con la gente che non sa che farsene. In realtà, mi rendo conto solo ora della politica presente nel mio film. Credo che il tradizionalismo e la superstizione abbiano creato molta ignoranza, che può facilmente portare alla corruzione.
Il suo film mescola vari stili: è un dramma buffo, una commedia seria...
Non è stato scritto volutamente come una commedia di genere. Mentre scrivevo la prima bozza, destinata ad essere più che altro un dramma, ho iniziato a ridere dicendo che era assurdo. È stato davvero interessante per me collegare l'assurdità delle situazioni con il luogo idilliaco, perché sembra che il tempo passi e che la bellezza duri, e si avverte quanto siano insensati questi conflitti. È più sottile di un semplice pescare nei tropi della dark comedy.
Per far ciò ha lavorato molto sui personaggi, probabilmente l'elemento più importante del film. Come?
Sono tutti ispirati da diverse persone che conoscevo da ragazzo, gente a cui voglio molto bene - cosa che mi ha impedito di fare caricature. Mi ha permesso di dar vita a personaggi in carne ed ossa, e il protagonista, a dire il vero, potrebbe essere basato su di me. Alcuni anni fa, mi avrebbero detto che ero intollerante, scontroso e misantropo come lui. Conoscevo il mio attore (Nikola Ristanovski) da prima, e ho subito messo la sua faccia sul personaggio in modo da poterlo torturare. È stato divertente.
È stato difficile mettere insieme il cast?
Avevo attori molto esperti provenienti da Macedonia, Croazia, Serbia e Montenegro, e molti esordienti. Cercare di fare un film corale e farlo funzionare allo stesso livello in termini di stile e di azione è stato una sfida. Ma quando la mia troupe ha visto queste persone credere in me, mi ha seguito facilmente.
Ciò è stato utile per il processo di produzione?
Per un'opera prima, è molto difficile costruire una grande co-produzione - ho fatto molto lavoro sul campo per ottenere location, alloggi, ecc. gratuitamente, in modo da investire il denaro sull'immagine e il cast. C'era questa decisione da prendere: o lavorare molto velocemente con gli attori più esperti, o per un periodo più lungo con attori meno esperti. Per fare un film ambizioso e con un budget basso bisogna necessariamente utilizzare gli ostacoli a proprio vantaggio.
Quanto è stato difficile lavorare dal Montenegro?
Il Montenegro non fa parte di Eurimages. Abbiamo ottenuto una co-produzione in Serbia, ma era davvero una piccola somma di denaro. Solo ora stiamo per istituire un centro cinematografico. Tutto fino ad ora è sempre dipeso dalle decisioni del Ministero della Cultura. Solo l'anno scorso siamo diventati parte di MEDIA, quindi le cose si stanno muovendo. C'è una nuova generazione di autori in erba che sta facendo molto per migliorare la situazione, con progetti molto interessanti. Credo che cambierà a breve.
titolo internazionale: The Black Pin
titolo originale: Igla ispod praga
paese: Montenegro, Serbia
anno: 2016
genere: fiction
regia: Ivan Marinovic
durata: 93'
data di uscita: ME 10/09/2016
sceneggiatura: Ivan Marinovic
cast: Nikola Ristanovski, Bogdan Diklić, Leon Lučev, Ljubomir Bandovic, Jelisaveta Sablic
fotografia: Djordje Arambasic
montaggio: Ivan Vasic
scenografia: Irena Marjanov
costumi: Magdalena Klasnja
musica: Toni Kitanovski
produttore: Ivan Marinovic
coproduttore: Vladimir Vasiljevic
produzione: Adriatic Western, EED// Productions
*
 - Musica
- Musica
Sade Mangiaracina Live in Sicilia nuovo album
Sade Farida Mangiaracina in concerto al Castello Grifeo di Partanna (TP) presenta l'album in piano solo "La Terra dei Ciclopi", special guest Luca Aquino
CONCERTO DI ANTEPRIMA IL 25 AGOSTO ORE 21
In uscita a fine settembre con la Inner Circle Music - etichetta discografica statunitense guidata da Greg Osby - "La Terra dei Ciclopi" primo album in piano solo di Sade Farida Mangiaracina, talentuosa interprete e compositrice che, già giovanissima, vanta grandi collaborazioni e tournée internazionali.
"La Terra dei Ciclopi" nasce dall'amore incondizionato di Sade per la sua terra, la Sicilia: ognuno dei dieci brani è una fotografia che ne ritrae luoghi e persone, una popolazione dai tratti differenti, nordafricani ma anche nordeuropei, "padroni di una terra martoriata, che tutto dà e tutto prende". Un lavoro lirico, pieno di emozione ed atmosfere evocative, rese ancora più profonde dal grande talento pianistico di Sade e dal suo interplay nei brani "Ballarò" e "Sugnu tutta pi tia" con Luca Aquino, impegnato con tromba e flicorno.
Da una recensione, su Musica Jazz, del live al Festival Bari in Jazz, firmata da Alceste Ayroldi:
"Sade Mangiaracina scompone la tradizione sicula incastonata in "Ciuri Ciuri": il tema in vista viene frammentato con un incedere ritmico sfavillante, che sostiene l’energica improvvisazione tenuta a bada dal gioco ostinato della mano sinistra. Il fraseggio della Mangiaracina gioca sulle sfumature che mettono pace tra i costrutti della classica, gli imperiosi dettami del dialetto musicale siciliano e il pianismo jazz moderno che tiene a mente il migliore passato. La cantabilità dei brani ne rende ancor più appetitosa l’esecuzione: perfetta per dizione e vigoria, così come in "La fuddia di Archimede", tra forte e piano, note che si scavalcano lasciando sempre respirare la vermiglia melodia. Il lirismo di "My Sicily" sottolinea la purezza compositiva della pianista, rimarcando anche le sue frasi dense di ponderatezza e di misura, attente alle nuances di una dedica appassionata."
Sade Mangiaracina: "Avere avuto la possibilità di collaborare per questo disco con la "Inner Circle Music", è un onore immenso. E' stato lo stesso Greg Osby a propormi di far uscire l'album con la sua etichetta, dopo averlo ascoltato: per me è stato come un sogno. Nel disco ci sono due brani in cui ho il piacere di avere come ospite un amico fraterno e musicista straordinario, una punta di diamante nel panorama della musica Europea: Luca Aquino! Qualche anno fa avevo avuto il piacere enorme di suonare nel suo disco "aQustico" e, visto che adoro il suo suono, non vedevo l'ora di avere un'altra occasione per registrare insieme a lui...e così è stato proprio con questo mio album.
La tracklist: 1. La Terra dei Ciclopi - 2. My Sicily - 3.Sugnu tutta pi tia - 4.La fuddia d'Archimede - 5.Nicuzza - 6.Capaci - 7.Ballaro' - 8.Ciuri ciuri - 9.Mandorli in fiore - 10.Etna
CONTATTI
Ufficio Stampa Fiorenza Gherardi De Candei
Tel. 328 1743236 E-mail fiorenzagherardi@gmail.com
BIOGRAFIA SADE FARIDA MANGIARACINA
nata a Castelvetrano, Sade Farida Mangiaracina a 7 anni inizia lo studio del pianoforte classico. Dai 9 ai 18 anni partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali di musica classica (secondo premio al concorso nazionale isola di Pantelleria, terzo premio al concorso nazionale Vanna Spadafora, primo premio assoluto al concorso nazionale Tonino Pardo oltre al premio speciale quale più piccola partecipante, primo premio al concorso nazionale città di Alcamo). Appena finito il liceo classico si è trasferita a Roma per studiare jazz presso la scuola Percentomusica diretta da Massimo Moriconi dove si è diplomata nel 2007 con il massimo dei voti. In questi anni ha preso parte a molti progetti musicali, oltre la collaborazione con Laura Lala, con artisti del calibro di Luca Aquino, Simona Molinari, Pino Cangialosi, per lo spettacolo “Li Romani in Russia”, Violet trio, esibendosi spesso a Parigi e al jazz festival di Marciac e di St Germain des Pres e di Oloron ed aprendo i concerti di Dionne Warwick durante il suo tour italiano suonando in teatri come il “Sistina” di Roma o i teatri di Pescara e di Napoli. Nell’estate 2008 suona assieme al trombettista Fabrizio Bosso al jazz festival di Castelbuono che ha anche registrato con lei nel primo album uscito a suo nome con le sue composizioni originali uscito a maggio 2009 per l’etichetta Philology. Suona con il giovane batterista quindicenne palermitano Gianluca Pellerito, insieme al sassofonista newyorkese Michael Rosen, suona anche in trio con il bassista Massimo Moriconi al Selinunte jazz festival. Con la cantante Simona Molinari dal 2013 al 2015 in tour in tutti i più importanti teatri e festival italiani come Umbria Jazz, Verona Jazz Festival, Auditorium Parco della Musica, Blue Note di Milano, ma anche Blue Note di New York, Teatro Estrada di Mosca, palazzo Bulgari di Tokyo, Parigi, Cannes durante la mostra del cinema. Nel febbraio 2015 accompagna la cantante Amara sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo.
Fiorenza Gherardi - Ufficio Stampa
lun 10.44Fiorenza Gherardi De Candei (fiorenzagherardi@gmail.com)
*
 - Società
- Società
Ferragosto a San Benedetto del Tronto
Nell’ambito della manifestazione Scena Aperta Estate 2016 organizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto, la ridente cittadina dell’Adriatico ha salutato l’ Aurora Picena con un ‘Concerto per archi’ dedicato al levar del sole.
L’appuntamento, alle ore 05,30 del mattino ha coinvolto un gran numero di cittadini, villeggianti e ospiti, che si sono riversati sulla battigia antistante ‘Il pescatore’ (conces. n.13), organizzato dall’Istituto Musicale ‘A. Vivaldi’.
Il Quartetto d’archi composto da Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco (violini), Emiliano Finucci (viola), Daniela Tremaroli (violoncello), hanno eseguito musiche di Bach, Vivaldi, Palladio, Morricone, Reverberi, Piazzolla, ed altri brani pop regalando al pubblico momenti di autentica emozione.
Il levarsi del disco del sole all’orizzonte ha fatto il resto lasciando gli intervenuti senza fiato nel momento del suo distacco sul mare, prima di iniziare il suo viaggio nell’immensità del cielo.
La Città di San Benedetto del Tronto rinnova l’invito per il prossimo anno 2017 per un’altra edizione di ‘Scena Aperta’ e i suoi numerosi eventi che si protraggono da Luglio a Settembre.
*
.jpg) - Letteratura
- Letteratura
Yves Bonnefoy, per non dimenticare.
Yves Bonnefoy, il più grande scrittore in lingua francese del Novecento, è morto il primo luglio 2016.
Bonnefoy ha collaborato per oltre vent’anni con “Anterem”, rivista alla quale era legato per il comune amore verso una scrittura che lascia la rassicurante forma saggistica e si apre alle mobili strutture del racconto. Così come accade nell’intervento inedito che ci ha donato per il numero 92 di “Anterem” in distribuzione. La traduzione, attenta e affettuosa, è di Feliciano Paoli.
È un racconto “ulteriore” quello che propone Bonnefoy perché ulteriore è il punto di vista della letteratura che affianca e trasforma l’analisi filosofica. Lo dimostra nel suo ultimo libro pubblicato in Italia e già disponibile in tutte le librerie: Il secolo di Baudelaire (traduzione di Anna Chiara Peduzzi). Il volume è edito da Moretti&Vitali (2016) nella collana “Narrazioni della conoscenza” diretta da Flavio Ermini.
Preziose anticipazioni per i nostri lettori ai link:
www.anteremedizioni.it/numero_92_giugno_2016
www.anteremedizioni.it/yves_bonnefoy_non_dimenticare
*
 - Letteratura
- Letteratura
Forum Anterem rivista di ricerca letteraria
È in corso di distribuzione il numero 92 di “Anterem” (giugno 2016). È un numero eccezionale, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è "La natura del lavoro poetico". A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: “Il lavoro poetico consiste nel volgersi all’essenza delle cose, quella che comunemente non si vede, abbagliati come siamo dalle apparenze”. Indicando in tal modo che la natura del lavoro poetico sta nel rimettere in gioco la verità.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Di particolare importanza sono le poesie del poeta cubano Ronel González Sánchez, tradotte da Carmen Lorenzetti.
Va altresì segnalato il racconto di Yves Bonnefoy, tradotto da Feliciano Paoli.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi. L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo “speciale” fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Esiti 30^ edizione del Premio Montano per tutte le ‘sezioni’.
La giuria del Premio Lorenzo Montano, composta da Giorgio Bonacini - Laura Caccia - Davide Campi - Mara Cini - Flavio Ermini - Marco Furia - Rosa Pierno - Ranieri Teti, dopo aver comunicato i risultati finali per le sezioni “Una prosa inedita”, “Una poesia inedita” e “Raccolta inedita”, presenta gli esiti della 30^ edizione per “Opera edita”, nella home page del sito www.anteremedizioni.it
Questo inserimento conclude gli esiti della 30^ edizione.
Le premiazioni di segnalati, finalisti e vincitori si terranno a Verona sabato 12 e sabato 19 novembre p.v., nell’ambito del “Forum Anterem 2016”.
La redazione
*
 - Letteratura
- Letteratura
Buona estate e Buona lettura a Tutti.
"Buon giorno.
Premetto che sono una persona abbastanza disordinata (anche se ben organizzata, nel mio caos), eppure dico quella che potrebbe sembrare un'ovvietà, ossia che nella scrittura ci vuole un ordine logico. È una banalità? Fino a un certo punto, come sa bene chi, come me, vaglia decine di manoscritti di aspiranti autori ogni mese. Questa settimana farò arrabbiare qualcuno con un video intitolato ‘Elogio dell'ordine’.
I dadaisti avevano capito bene che, per mettere sotto accusa la cultura occidentale, la prima cosa da fare fosse proprio quella di demolire i presupposti della testualità, ossia le regole della sintassi, senza le quali un autore non ha gli strumenti per comporre e un lettore non ha gli strumenti per interpretare. L'ordine, invece, permette perfino a chi non ha mai studiato i geroglifici di comprenderne alcuni messaggi; nel video ho fatto un esempio... gli egittologi mi perdoneranno, spero".
Chi ci scrive è il Direttore Editoriale di EEE-book Piera Rossotti Pogliano che anche quest’anno 2016 ha partecipato al Salone del Libro di Torino con tutto il suo staff e con tanti autori entrati a far parte del panorama editoriale. Un Editore digitale per scelta, che non disprezza affatto il libro tradizionale, quello di carta, per intenderci, che nelle sue note, molto spesso accompagnate da video esplicativi e illustrtivi della propria produzione, introduce ai diversi aspetti della letteratura, con suggerimenti per i giovani autori che intendono entrare nel mondo della narrativa e non solo, sulla scrittura e la lettura creativa, con risultati davvero degni di nota che, negli anni, hanno fatto delle Edizioni Esordienti E-book una casa editrice di tutto rispetto, conquistandosi un distinto spazio editoriale all’interno della grande (e dispersiva) distribuzione.
Pensata e voluta da Piera Rossotti Pogliano, affiancata da un gruppo di giovani stagisti che hanno compiuto studi specifici per lavorare nell’editoria, per offrire la possibilità a scrittori esordienti ed emergenti di pubblicare le loro opere e di confrontarsi con un pubblico di lettori, il più vasto possibile, evitando quello che spesso si rivela un tranello, ossia la pubblicazione cartacea ad opera di sedicenti editori – che in realtà sono spesso solamente dei tipografi con scarse conoscenze della lingua italiana – che spillano loro un mucchio di quattrini per pubblicare dei libri che poi non saranno distribuiti in modo efficace.
"Anche quando si ha la fortuna di trovare un piccolo editore onesto e competente, tuttavia, il problema dei considerevoli costi legati alla stampa, alla gestione del magazzino, alla distribuzione e al recupero dei resi incide pesantemente sulla pubblicazione di un libro destinato a vendere, nei casi migliori, duemila o tremila copie (spesso, molte di meno!).Oggi il mercato dell’e-book è in grande espansione, anche se sono molti i nodi ancora da affrontare (perché non venite a discuterne con il gruppo di Facebook?), ma offre grandi opportunità, impensabili ancora pochi anni fa, e promette di affermarsi ulteriormente anche in Italia".
EEE-book si propone di svolgere alcuni ruoli importanti:
1 – casa editrice che lavora sul manoscritto in modo tradizionale, selezionando i testi da pubblicare, correggendo la bozza e applicando un codice ISBN alle opere selezionate, offrendo eventuali altri servizi, per esempio un editing molto approfondito, a discrezione degli autori, o anche stampa cartacea, secondo il principio del “print on demand”;
2 – libreria online che ospita e promuove i libri pubblicati o ripubblicati da EEE – book e le opere in self-publishing;
3 - distributore online attraverso la piattaforma Stealth, per raggiungere i più importanti web store.
Ma vediamo insieme di dare un volto (cartaceo) alla sua fondatrice e animatrice:
Piera Rossotti Pogliano ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo "Vittorio Alfieri" di Torino e, sempre a Torino, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne nel 1975, con una tesi sulla fortuna francese dell'Etica Nicomachea di Aristotele nel Rinascimento, per la quale ha ottenuto 110lode/110 e dignità di stampa
Nel corso dei suoi studi, ha inoltre frequentato corsi di analisi testuale a Parigi, Università della Sorbona, sotto la guida di Yves Brunsvick.
Dal 1975 al 1978 ha insegnato come lettrice di Lingua Italiana all'Istituto di Filologia Romanza dell'Università di Liegi (Belgio) con il prof. Albert Maquet, ed è stata assistente alla cattedra di Storia della Lingua Italiana del prof. Jules Horrent; ha condotto ricerche sull'aristotelismo del Cinquecento.
Tornata in Italia, ha insegnato Lingua e Civiltà Francese nella scuola secondaria, terminando la sua carriera alla Scuola Internazionale Europea “Altiero Spinelli” di Torino.
Alla passione per la letteratura e la storia, Piera Rossotti unisce quella per la tecnologia: si è occupata per vari anni dell'applicazione di sussidi informatici alla glottodidattica, scrivendo articoli e dispense e organizzando corsi di aggiornamento per docenti, in collaborazione con l'A.N.I.L.S. (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere).
Dal 1999 coordina, presso il sito Internet "Il Rifugio degli Esordienti", il servizio di Lettura Incrociata: scrittori esordienti e semplici appassionati inviano il prodotto delle loro fatiche letterarie ai vari gruppi di lettura, guidati da bravissimi collaboratori (www.danaelibri.it/rifugio/rifugio.asp).
Dal 2002 ha assunto la direzione del catalogo di DANAE (Distribuzione Autonoma Nazionale Autori Esordienti, www.danaelibri.it) e seleziona opere di autori esordienti, prevalentemente di narrativa e poesia e collabora alla redazione della rivista DanaeMagazine.
Autore bilingue, è membro dell’AASAA (Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin,www.auteurs-arcalpin.com), ed è anche un'esperta ghost writer, cioè scrive libri che altri firmano: ovviamente, non saprete mai a chi si sostituisca, è un segreto professionale!
Nel 2004 ha conseguito la laurea in Comunicazione Interculturale, discutendo, con il prof. Fabio Levi, una tesi di Storia Contemporanea, e ha realizzato un Questionario interattivo sulla storia del Novecento, ottenendo il punteggio 110 lode/110.
Nell’ottobre 2011, infine (o per cominciare?) ha dato vita a EEE – book, una casa editrice che pubblica e-book di autori esordienti ed emergenti.
Pubblicazioni di Piera Rossotti
Ricerca e didattica:
L’Etica a Nicomaco nel Cinquecento Francese, in “Studi Francesi”, XXI, III, 1977, n. 63
La Politica di Aristotele: edizioni e traduzioni nel Cinquecento Francese, in Études de Philologie Romane et d’Histoire Littéraire offertes à Jules Horrent, Liège, 1980
Sussidi informatici per la glottodidattica, in “Scuola e Lingue Moderne”, XXX, aprile 1992
Narrativa:
‘La morte di Maria Dorowitz’, in “Il Testonese”, I, n. 1, febbraio 1998 (Racconto)
‘Il Bilancio’, in “Tam Tam di Scrittori, Poeti, Artisti”, I, n. 4, settembre-ottobre 1999,
‘Il diario intimo di Filippina de Sales, marchesa di Cavour’. Torino, Edizioni Angolo Manzoni, 2000. ISBN 88-86142-52-8 (trad. francese Journal intime de Philippine de Sales, marquise de Cavour, Chambéry, Éditions Altal, 2011, ISBN 978 2916736242)
‘R@cconti senza rete’, a cura di P. Rossotti Pogliano, Michele Di Salvo Editore, 2000, ISBN 88-87452-62-8.
‘Filippina va in città’ - En route pour la ville, in A.A.V.V., Mont-Cenis-Moncenisio, Sur les sentiers de la mémoire, St.Jean-de-Maurienne, Roux et Morra, 2002.
Sotto forma di e-book è in distribuzione gratuita su Amazon e sui principali webstore.
Oltrel@rete, a cura di P. Rossotti Pogliano, Roma, Proposte Editoriali, 2002, ISBN 88-87431-19-1.
Il ventre pieno di farfalle, Roma, Robin Edizioni, 2006, ISBN 88-7371-202-9
Venti d@lla rete, a cura di P. Rossotti Pogliano, Perugia, Graphe.it Edizioni, 2006, ISBN 88-89840-10-2
Con lo pseudonimo Virginia Sandry ha pubblicato quattro romanzi rosa: ‘Con amore e passione’; ‘Il profumo dell’amore’; ‘L’amore con un click’; ‘L’amore è un dolce al cucchiaio’ (Roma, Edizioni Alfa, Collana “Infinity”, 2007-2008, distribuiti in edicola, per dettagli vedi il sito www.virginiasandry.it)
Manualistica:
‘Il filo d’inchiostro’, in collaborazione con Maurizio J. Bruno, Chieti, Tabula Fati, 2007, ISBN 88-7475-129-X
‘Manuale Minimo di stile’, EEE-book, (2011), distribuzione gratuita da questo sito e da tutti i webstore.
‘Verlaine, due letture’, EEE-book, (2014), in distribuzione gratuita da questo sito e da tutti i webstore.
Tra le più recenti opere pubblicate su carta, o se preferite in edizione e-book, segnaliamo qui alcuni thriller di buona fattura, da leggere sotto l’ombrellone di questa estate che stenta ad arrivare:
‘La stanza dei fiori’, di Gianni Vigilante Edit. EEE.
logico e costruito con rigore, Il commissario Fantaguzzi indaga sull'apparente suicidio di un prete ma la vera protagonista è la città di Napoli, in un’Italia che non ha ancora superato le ferite della guerra e che si ammanta di perbenismo e di ipocrisia.
“Sarà mica per sempre” di Manuela Leonessa – Edit. EEE
Un presunto suicidio. Perché? Non certo per depistare le indagini alle quali è bastata l’autopsia per svelare la messinscena. Sembra, piuttosto, il rispetto di un rituale, di un sacrificio umano. La polizia archivia il caso, ma Emma, la migliore amica di Alice, esige delle risposte e convince l’ispettore Moreno a proseguire le indagini, almeno in via ufficiosa. Al loro fianco anche Barbara, psicologa radiata dall'albo per un errore letale, che si mantiene come domestica presso la famiglia di Alice.Forse Alice è morta al posto di qualcun altro?E chi è la misteriosa Savana? La sua storia si intreccia a quella di Emma e Alice in quello spazio ignoto che è la follia umana, e la soluzione di questo thriller psicologico ambientato a Torino sarà sconcertante e terribile
“Dentro un castello di carte”, di Marina Atzori – Edit. EEE
A volte, la soluzione più semplice, per difendersi dalle avversità della vita, è quella di costruirsi un castello di carte, nell’illusione di potervi trovare rifugio. Ben presto, però, ci rendiamo conto che è troppo fragile, che basta un soffio per farlo crollare. Proprio quando pensiamo che tutto sia perduto, a volte la vita ci riserva delle sorprese e troviamo la forza di costruire davvero qualcosa di più solido e duraturo. Dentro un castello di carte è il seguito della storia di Petra e Zefiro iniziata nel romanzo Il fiordaliso spinoso. Anche qui, la vita reale e la fantasia si mescolano... E la tartaruga Zippo, anche questa volta, ci metterà lo zampino. Perché l’amore, i sogni, che altro sono, se non belle favole? E nelle favole, si sa, anche le tartarughe non sono solamente degli animali, ma possono essere complici e messaggeri. Basta crederci.
Buona Estate e Buona Lettura a Tutti.
*
 - Cinema
- Cinema
Tiff, the largest film festival in Romania
TIFF - Transilvania Film Festival 2016.
Si è da poco concluso il Transilvania IFF 2016 con un numero di film che fanno onore alla cinematografia europea ma dei quali forse non avremo modo di vederli sui nostri schermi italiani, se non affidandoci ai trailer che Cineuropa mette a disposizione sul suo sito, insieme alle informazioni del caso e le news che solitamente ci invia, e per le quali gli siamo infinitamente grati. Vorremmo fare di più, essere più presenti , ma… sta di fatto che nessun film è presente nella lista dei candidati a questo pur importante Film Festival, perché. Comunque, qui sotto, ho elencati solo alcuni dei film che gradiremmo vedere sui nostri schermi, basandomi sull tematiche che essi trattano e per il rigore di alcuni film-maker che ci piacciono in modo particolare, perché hanno dimostrato e tutt’ora dimostrano di ‘avere delle idee nuove’ da portare sugli schermi, e non solo per gli argomenti trattati ma per come detti argomenti si presentano nel nostro quotidiano post-moderno. (Gio.Ma)
TIFF: The 15th edition of the Transilvania International Film Festival ended yesterday after a special screening of Belgica. On Saturday, Bogdan Mirică’s Dogs, winner of the FIPRESCI award in the Un Certain Regard section at Cannes, was announced as the recipient of the festival’s top award, the Transilvania Trophy. It is the fourth time in the festival’s history that a Romanian film has won the Trophy, the previous winners being Corneliu Porumboiu’s Police, Adjective (2009), 12:08 East of Bucharest (2005), and Cristian Mungiu’s Occident (2002).
Here is the complete list of the winners of the Transilvania IFF 2016:
Transilvania Trophy
Dogs - Bogdan Mirică
Best Director
Avishai Sivan – Tikkun
Special Jury Prize
Sparrows - Rúnar Rúnarsson
Best Performance
David D’Ingeo - Where There Is Shade
Special Mention of the Jury
Monika Naydenova, Alexander Benev – Thirst
FIPRESCI Award (#Animal Section)
Neon Bull - Gabriel Mascaro
Audience Award
The Open Door - Marina Seresesky
Romanian Days Award for Best Feature
The Last Day - Gabriel Achim
Romanian Days Award for Best First Feature
Discordia - Ion Indolean
Romanian Days Award for Best Short Film
A Night in Tokoriki - Roxana Stroe
Special Mention of the Jury
My Name Is Costin - Radu Potcoavă
Surprisingly, Dogs was completely ignored by the Romanian Days Jury, where it lost out on the Best Feature Award to Gabriel Achim’s The Last Day and on the Best First Feature Award to Ion Indolean’s Discordia.
‘Dogs: a dangerous legacy’ by Bogdan Mirica wins the top award at Transilvania IFF.
by Stefan Dobroiu per Cineuropa News.
Synopsis:
Roman, a young man from Bucharest, comes to the countryside near the border with Ukraine with the firm intention to sell the vast but desolate land he inherited from his grandfather. He is warned by old man Hogas, the local cop, that his grandfather was a local crime lord and his “boys”, led by the charismatic and cruel Samir, will not let go of the land - and their smuggling business - without a fight. Roman doesn’t give up and the three men clash in a triangle of violence.
‘DOGS’ by Fabien Lemercier per Cineuropa News.
15/05/2016 - CANNES 2016: With this highly accomplished blend of film noir and modern western, Bogdan Mirica makes the transition to the feature-length format with flying colours. Already screened in the ‘Un Certain Regard’ section at the 2016 Cannes Film Festival.
Over the last 15 years or so, we've become used to Romanian cinema regularly unveiling new auteurs who, more often than not, work in the realms of social realism. With Bogdan Mirica and his feature debut, Dogs [+], revealed in the Un Certain Regard selection of the 69th Cannes Film Festival, a new, talented face has just signed up to this trend, following in the footsteps of his elders (Mungiu, Puiu, Jude and Netzer, to name just a few). But more than anything else, it's the fact that he has opened up to a different style that really makes its mark here. Toying skilfully with the codes of film noir (set against a backdrop of an enigmatic reinterpretation of classic western figures), slowing the pace and capitalising on the power of suggestion provided by the natural settings, the young filmmaker has crafted a charming atmosphere into which he has inserted a rather mainstream plot, without ever abandoning stylish, high-quality cinematic standards when it comes to the mise-en-scène and a sleek visual sheen. This very promising approach, which is “arty” without taking it to extremes, and mainstream without the inherent luridness, probably explains why all of the Cannes selections had to battle it out to coax the movie into their own showcase.
"You're not made for this place." This is what Roman (Dragos Bucur) is told in no uncertain terms when he arrives from the capital city after having inherited a 550-hectare property from his late grandfather. We're in the middle of nowhere, the open countryside stretching as far as the eye can see, and the young man soon starts asking himself some questions. Where did his grandfather get the money to buy the plot in just nine months at the time, back in 1983? Why did the communists then leave him be? And above all, why did he settle down there, a place where there's no forest, no water and where nothing can grow? Another oddity is the fact that this extremely remote house is exposed to the full force of the wind, but is surrounded by a fence bristling with barbed wire. Once night falls, the plot thickens with the backing of the guard dog ("She only bites when she's angry") and a curious procession of cars nearby, before his friend in charge of putting the property up for sale simply vanishes ("It's as if the ground has swallowed him up"). All of this serves to crank up Roman's concern a notch, and yet he has no intention of giving in to intimidation... And meanwhile, the elderly head of the microscopic local police force (Gheorghe Visu) calmly conducts an investigation after a foot is discovered in a pond...
A laconic young hero, a sheriff on his last legs, a villain (Vlad Ivanov) who is particularly menacing under that wily exterior, rifles and hammers at everyone's fingertips, minimalistic conversations imbued with the unspoken, the deepest darkness and peacefulness of the countryside shattered by sudden flashes of light, and vast panoramas a stone's throw from the border and from the Danube: Mirica (who wrote the screenplay for this film being sold abroad by Bac Films) unspools his story patiently, slowing the pace, avoiding explanations and postponing the score-settling – and all of this enables the stirring under the surface of this vast space governed by its own rules, where "there are animals both large and small", to seep through more effectively. Add a dash of dark humour, a touch of the fabular teetering on the fine line between good and evil, and the extremely well-crafted cinematography of Andrei Butica, and you have a feature debut with a vaguely "Tarantino-esque" whiff (albeit less over the top and more Romanian), which immediately demonstrates all of the cinematic potential of its director, even if his personality still remains somewhat hidden behind this accomplished demonstration of his dazzling skills as a filmmaker. An enigma that will make the next episode in his career all the more fascinating.
international title: Dogs
original title: Caini
country: Romania, France, Bulgaria
sales agent: Bac Films
year: 2016
genre: fiction
directed by: Bogdan Mirica
screenplay: Bogdan Mirica
cast: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe Visu, Costel Cascaval
cinematography by: Andrei Butică
film editing: Roxana Szel
producer: Marcela Ursu
co-producer: Elie Meirovitz, Katya Trichkova, Stephan Komandarev
production: 42 Km Film, EZ Films, Argo Film Ltd.
distributor: Bac Films
‘The Last Day’ by Gabriel Achim
Synopsis:
The Last Day centres on a special journey undertaken by four men from a provincial town. The mayor, the policeman and the leader of the Christian youth association accompany their friend Adrian on his trip to a monastery, where he has decided to start a new life as a monk. The mayor, an amateur filmmaker, offers to film the group's journey to the monastery, but he also has some secret plans for Adrian.
See also: Watch our interview with Romania's Gabriel Achim, who triumphed in the Romanian Days section of the Transilvania IFF with his film The Last Day.
international title: The Last Day
original title: The Last Day
country: Romania, France
year: 2016
genre: fiction
directed by: Gabriel Achim
screenplay: Gabriel Achim, Cosmin Manolache
cast: Doru Ana, Adrian Văncică, Adrian Ciglenean, Mimi Brănescu
cinematography by: George Chiper-Lillemark
producer: Gabriel Achim, Daniel Burlac
production: Green Film
‘Tikkun: The nature of faith and desire’ by Samuel Antichi
TIFF News by Cineuropa News.
17/11/2015 - Avishai Sivan's minimalist and enigmatic tale follows a Yeshiva student in Jerusalem struggling with the strict orthodoxy rites that have ruled his life.
A young Orthodox student, Haim Aaron (Aharon Traitel), the eldest child of a kosher butcher (Khalifa Natour) and his wife (Riki Blich), lives in Jerusalem, and his talents and devotion are the envy of the entire Hasidic Jewish community, a branch of Judaism that promotes mysticism as the fundamental aspect of the faith. One evening, he collapses in the shower in the family apartment while he is contemplating masturbation, and a head injury makes him lose consciousness. After 40 minutes attempting to revive him, he is declared dead by the paramedics until his father intervenes, insisting on continuing CPR, and Haim Aaron miraculously comes back to life. However, after this apparent return from death, he is altered physically as well as spiritually. His behaviour becomes more eccentric, inasmuch as he remains apathetic to his Yeshiva studies, for which he force-fed his brain while starving his body, continually falling asleep during class. Furthermore, he announces at home that he has renounced eating meat, which is a particular affront to his father's job, and he starts to experience an unpredictable bodily awakening, exploring his sexual desires. Unable to rest at night, he secretly wanders the streets by hitching rides with strangers. After noticing Haim Aaron's change in behaviour, the father is tormented by the fear of having acted against God’s will by resuscitating his son.
Avishai Sivan's Tikkun won the Best Feature Film Award at the Jerusalem Film Festival and the Special Jury Prize at the Locarno International Film Festival. Consequently, this bizarre coming-of-age story within an ultraorthodox Jewish community has attracted intense interest from other festivals such as the Stockholm International Film Festival, where it is screening in the main competition section.
Shot with a strikingly sublime and sensitive high-contrast black-and-white aesthetic, this minimalist allegorical mystery about the capriciousness of the Old Testament explores the intimacy of men and their souls through a crisis of faith. The mysterious narrative elevates our vision to the search for spirituality where religion, self and sexual desire intersect. Its formal construction and the calm gaze of the fixed camera shots with little or no dialogue magnify the grey areas (both morally and logistically speaking) in which a formidable father, because of a spontaneous act of love for his son, may have destroyed the natural order of his world. This powerful depiction of a journey from devotion to doubt gives rise to a climactic series of surreal events amid a heavy nocturnal fog, where the will of God is concealed. A cinematic and philosophical examination of a nightmare that delves into the very nature of faith and explores the core of existence itself.
‘Death by Death’, psycho-somatisation elevated to an art form.
by Aurore Engelen per Cineuropa News.
14/10/2015 - With his first feature film, Xavier Seron shamelessly takes on a tenderly indecent tragicomic world.
Michel Peneud is going to die. Just like you and me and his mother, except that his mother has been told she is going to die by her doctor. So she has decided to live. And for Michel’s mother, living means feeding her cats, drinking sparkling wine like it’s champagne, and loving Michel. But Michel sometimes finds her love a bit cumbersome. To the extent that he suddenly seems to develop symptoms very similar to those of his mother. What if Michel also has breast cancer? All by himself, Michel is a pretty picture of neuroses: hypochondria, hysteria, phobias, obsession. But what is even more unbelievable is the way that Michel Peneud raises psycho-somatisation to an art form, a unique art between martial arts (like in the ransacking of the apartment sequence) and iconography (like in the final shot, a child’s hallucinatory reinterpretation of the Virgin).
Death by Death is as excessive as its black and white shades are contrasting. But it is precisely this excess that make it exciting, this self-assured way of trying, even if it leads to failure. With this, his debut atypical feature film screened at the Festival International du Film Francophone (FIFF) in Namur, Xavier Seron goes all out: plays on words, schoolboy humour, embarrassing dizzy spells, scathing caricatures, and above all, an intimate relationship that flirts with the trivial. Seron relies on what is most intimate to us: life (notably the mother-son relationship) and death. And this dissection of the private lives of his characters takes a particularly emphatic aesthetic form. First of all is the striking black and white images, and Olivier Boonjing’s photography, with often-magnificent sequences of shots, especially in the choreographed scenes interspersed throughout the film (the household appliance shop, the yoga class, and the scene with the seesaw). These scenes are counterpoints that come one after the other, tender and farcical, and counterbalance a certain sense of deadly aftershock, the upsetting situation. The tragicomic use of Bach’s preludes or Italian song (the incredible Puoi Farmi Piangere, a cover of I Put a Spell on You) punctuate the plot, while a host of cheerful cameo actors bring a bit of levity when the story takes a darker turn, like Catherine Salée, who shows us around her retirement home.
True, Xavier Seron doesn’t leave much to his main actors, but he seems to film them with the benevolence of someone who shares their doubts and neuroses. Death by Death is a real blank canvas for the gentle madness of Jean-Jacques Rausin, the big tragicomic hero, a trashy sort of Michel Blanc. Myriam Boyer, on the other hand, bravely shoulders the difficult role of the downtrodden mother, who’s so sick and crazy that it could kill her, but full of humanity.
If Xavier Seron took several years to finish Death by Death, a film that was challenging to edit, he leaves us with the impression that he made the film he wanted, which is not at all obvious. The film was produced in Belgium by Novak Prod, and in France by Tobina Film, who has already worked on other atypical Belgian films (Amer [+] and The Strange Colour of Your Body’s Tears [+] by Cattet and Forzani). Death by Death received financial support from the CCA, the CNC and the Brittany region.
‘Death by Death’ by Xavier Seron per Cineuropa News.
Synopsis:
Michel Peneud is going to die. Just like you and me and his mother, except that his mother has been told she is going to die by her doctor. So she has decided to live. And for Michel’s mother, living means feeding her cats, drinking sparkling wine like it’s champagne, and loving Michel. But Michel sometimes finds her love a bit cumbersome. To the extent that he suddenly seems to develop symptoms very similar to those of his mother. What if Michel also has breast cancer? All by himself, Michel is a pretty picture of neuroses: hypochondria, hysteria, phobias, obsession.
international title: Death By Death
original title: Je me tue à le dire
country: Belgium, France
sales agent: Stray Dogs
year: 2015
genre: fiction
directed by: Xavier Seron
release date: BE 4/05/2016
screenplay: Xavier Seron
cast: Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer, Serge Riaboukine, Fanny Touron, Franc Bruneau
cinematography by: Olivier Boonjing
film editing: Julie Naas
art director: Erwan Le Floc'h
costumes designer: Laure Mahéo
producer: Olivier Dubois, François Cognard
production: Tobina Film, Novak Production
distributor: Happiness Distribution
‘Remainder: Reconstructing memory’ by Martin Kudláč
TIFF News by Cineuropa News.
03/06/2016 - Video artist Omer Fast has adapted Tom McCarthy’s reality-bending thriller, and the result is screening in competition at the TIFF
For his first feature-length directorial and narrative outing, Israeli video artist Omer Fast has tackled a novel by British artist and writer Tom McCarthy, Remainder [+], and the result is screening in competition at the Transilvania International Film Festival. Although the novel initially came out in a batch of 750 copies via a French publisher as a kind of art project, it was later picked up for a wider release. McCarthy himself describes the story as “the hero builds a film set, but there is no film”, thus confirming that the material possesses a certain cinematic quality. In his works, Fast investigates the recurrent topics of the psychology of trauma, the relationship between memory and reconstruction, and the link between reality and non-reality – an array of themes in sync with the novel’s motifs.
The director kick-starts the narration through a dramatic, freak Donnie Darko-like accident that leads to the victim, Tom (Tom Sturridge), being offered an £8.5 million reparations settlement if he agrees never to discuss the incident. Tom accepts; however, the aftermath not only leaves its mark on his body (a lost limb and scars are a testament to what he shall never discuss), but also damages his mental wellbeing as a result of the severe trauma. He awakes from his coma in a different reality that he does not remember, and thus clings with a rigor mortis-like grasp to a series of obscure memories that he is determined to re-enact right down to the smallest detail. This curious hobby turns into an obsession, and as an eccentric millionaire, Tom makes the transition from cardboard cut-outs to meticulous reconstructions, sealing himself in a cocoon of a conscientiously fabricated alternative reality.
The filmmaker builds up the structure of Remainder in the vein of puzzle movies, although less mysterious and more clinical, as the protagonist yearns for bigger and more realistic sets, akin to the events that unfold in Charlie Kaufman’s Synecdoche, New York, in an endless loop where the same event repeats over and over again. With his more detailed creations, Tom finds accidental flaws in the efficiently staged déjà-vu manifestations of reality (after all, a crack in a wall triggered this whole merry-go-round of manic repetition). Fast’s psychonautic dive into a deranged mind props up an intertwining parallel plotline of a paranoid heist thriller, in which the protagonist may or may not play a role. The filmmaker thus explores not only the themes of reality and non-reality, and trauma and memory, but also the conventions of video art and genre film in one functional and homogenous oeuvre, knitting together both approaches to synergetic effect.
Compared to Synecdoche, New York, the production design is less opulent, a decision clearly reflecting the protagonist’s retreat from outside reality, but not skimping on the complexity of the topics and motifs that Fast dissects. A monochromatic touch lends the imagery an aseptic quality, in line with the status of the protagonist’s sanitised memory and artificially (re)constructed reality – a fiction into which Tom free-falls uncontrollably.
Remainder was co-produced by the United Kingdom (Tigerlily Films) and Germany (Amusement Park Films). The film has a sales agent, The Match Factory, with Soda Pictures distributing the movie in the UK from 24 June.
Synopsis:
Based on the bestselling cult novel by Tom McCarthy, the plot follows a young man who tries to reconstruct his past out of fragmented memories. His obsessive efforts are funded by a large financial settlement for an accident he cannot remember, but neither his friends nor he can anticipate the extremes he will go to in realising his quest.
international title: Remainder
original title: Remainder
country: United Kingdom, Germany
sales agent: The Match Factory
year: 2015
genre: fiction
directed by: Omer Fast
film run: 97'
screenplay: Omer Fast
cast: Tom Sturridge, Ed Speleers, Cush Jumbo
cinematography by: Lukas Strebel
film editing: Andrew Bird
art director: Adrian Smith
costumes designer: Sam Perry
producer: Natasha Dack, Malte Grunert
production: Tigerlily Films, Amusement Park Films
distributor: Soda Pictures
‘Chevalier’, a tragicomic portrait of the contemporary male.
by Muriel Del Don per Cineuropa News.
13/08/2015 - LOCARNO 2015: The latest film of Athina Rachel Tsangari, screened in the International Competition at Locarno, is an unforgiving journey into the mind of modern man
Chevalier [+], the latest poignant and exhilarating feature film of Greek director Athina Rachel Tsangaris, which was screened in the International Competition of the 68th Locarno Film Festival, ventures into the complex and at times absurd male universe. After The Capsule, a film with an exclusively female cast, Tsangaris decides to explore ‘the other side’ and the relationships (of power) that exist between men, a world of domination in which appearances are everything. Despite the secrets and (hidden) anxieties that inhabit the personal realities of our Greek heroes, their ‘public’ life appears unblemished and socially perfect. An unsettling and thorny masculinity pervades the latest feature film of our Greek director, who tackles the fears and weaknesses of contemporary society with bravery and an irresistible dose of humor.
In the middle of the Aegean Sea, six men (an incredible cast which includes some of the greatest of Greek actors), all deep-sea fishing enthusiasts, are staying on a luxurious and majestic yacht. Tension and testosterone levels peak when the six men decide to play a game that will take them beyond the point of no return. Anything goes: blood tests, falsetto karaoke and even paradoxical comparisons of how they eat and sleep. Their apparent friendship soon turns into bitter rivalry before erupting into an outright social bloodbath. The winner, the ‘coolest’ man, will win the ring of victory: the Chevalier.
The latest piece by Athina Rachel Tsangaris is an irreverent and deliciously obscene satire of contemporary society in which everything is obsessively scrutinized. Chevalier explores the depraved mechanisms that cause individuals to show solely and exclusively their strengths, thus forgetting to nourish their more intimate side, their sensitivity: in a nutshell, what makes them human. The search for a hypothetical winner, an unsettlingly perfect superman who lives in constant fear of making a mistake, of putting a foot wrong, pushes the protagonists of Chevalier to commit extreme acts, both absurd and grotesque. But what does it mean to be ‘the best’ in a contemporary society that is obsessed with drumming up the most face-book ‘likes’? Can we still differentiate between reality and a virtual life in which the only things that count are appearance and popularity? In Chevalier this quest for recognition is taken to the extreme. In an exclusively male world, so imbued with testosterone that it is almost ‘homoerotic’, the protagonists of Chevalier constantly and obsessively judge themselves, but above all, others, in a ridiculous quest for perfection. The world created by Tsangaris is at times reminiscent of that of Pedro Almodovar, another undisputed expert at portraying the neuroses and fears of a society in the grips of delirium. The desires and self-respect of these men are put to the test in a claustrophobic world surrounded by the sea, a sort of prison that forces the protagonists to face their fears. A piercing film that uses humor/laughs to hide an unsettling truth.
Synopsis:
In the middle of the Aegean sea, on a luxury yacht, six men on a fishing trip have decided to play a fun game. Things will be measured, blood will be tested. The man who wins will be the best man, and he will wear upon his little finger the victorious signet ring: the “Chevalier".
international title: Chevalier
original title: Chevalier
country: Greece
sales agent: The Match Factory
year: 2015
genre: fiction
directed by: Athina Rachel Tsangari
film run: 99'
screenplay: Athina Rachel Tsangari, Efthymis Filippou
cast: Sakis Rouvas, Vangelis Mourikis, Panos Koronis, Efthymis Papadimitriou, Nikos Orphanos
cinematography by: Christos Karamanis
film editing: Yorgos Mavropsaridis
costumes designer: Vasileia Rozana
producer: Maria Hatzakou, Christos V. Konstantakopoulos
production: Haos Film, Faliro House Productions
distributor: Feelgood Entertainment
Si ringrazia la Redazione di Cineuropa per la collaborazione.
*
 - Cinema
- Cinema
Transilvania iff, the largest film festival in Romania.
TRANSILVANIA IFF, TH LARGEST FILM FESTIVAL IN ROMANIA ... by Stefan Dobroiu - from CINEUROPA News.
Transilvania IFF, the largest film festival in Romania, kicks off in Cluj, on Friday, 27 May, for 10 days. At its 15th edition, 248 films from over 64 countries will be screened and accompanied by concerts, special screenings, master classes, workshops and parties. Roughly 850 guests are expected - including Sophia Loren, who will receive the Lifetime Achievement Award, Mad Max: Fury Road producer Iain Smith, Lithuanian director Šarūnas Bartas, Japanese director Sion Sono and many more. Romanian directors will present six world premieres during the Romanian Days (2-4 June).
Transilvania IFF announces its 12 titles in competition.
11/05/2016 - Most of the competitors are first features and also European productions
The 15th edition of the Transilvania International Film Festival will kick off on 27 May, and the organisers have just announced the 12 titles that will be competing for the Transilvania Trophy. Nine of the competitors are first features, and nine represent European countries.
After several years with no Romanian film in competition, the 15th edition will host the domestic debut of Bogdan Mirică’s Dogs, which has also been selected in the Un Certain Regard competition at Cannes. Described by TIFF artistic director Mihai Chirilov as “a genuine Balkan anti-western”, Dogs may snatch some of this edition’s awards. Another Romanian in with a chance of winning a prize is actress Cosmina Stratan, who plays one of the main characters in Ali Abbasi’s Shelley (Denmark).
(The article continues below - Commercial information)
The festival has also announced four of the five jury members who will decide on the winners: Wieland Speck, curator of the Berlinale Panorama section; Bill Guentzler, artistic director of the Cleveland International Film Festival; Bulgarian actress Margita Gosheva; and Polish director Tomasz Wasilewski, whose Berlinale-awarded United States of Love will be shown in the Supernova sidebar.
The remaining TIFF competition titles are As I Open My Eyes by Leyla Bouzid (France, Tunisia, Belgium, United Arab Emirates), Fado by Jonas Rothlaender (Germany), Island City by Ruchika Oberoi (India), The Open Door by Marina Seresesky (Spain), Remainder by Omer Fast (UK), Sparrows by Rúnar Rúnarsson (Iceland, Denmark), Tanna by Bentley Dean and Martin Butler (Australia, Vanuatu), Thirst by Svetla Tsotsorkova (Bulgaria), Tikkun by Avishai Sivan (Israel) and Where There Is Shade by Nathan Nicholovitch (France, Cambodia).
The 15th edition of Transilvania IFF ready to kick off.
27/05/2016 - Sophia Loren is to receive the Lifetime Achievement Award at the closing gala
The first screenings have already begun at the 15th edition of the Transilvania International Film Festival (27 May-5 June, Cluj-Napoca), but the festival’s organisers are waiting till this evening to kick off the gathering with a bang. Hosted by the vast Unirii Square in the centre of Cluj-Napoca, the opening gala will show Nae Caranfil’s 6.9 on the Richter Scale as a world premiere, to an audience of more than 1,000.
With over 215 features from 64 countries, TIFF reconfirms its status as Romania’s biggest film event. The 15th edition also has one of cinema’s greatest as a special guest: Italian actress Sophia Loren, who will receive the Lifetime Achievement Award at the closing gala.
Among the festival’s attractions there are sections dedicated to directors and certain countries. Lithuania benefits from particular attention, with director Sharunas Bartas invited in the 3x3 sidebar, and ten classic or recent films selected in Focus Lithuania. Two other Focuses will present new films from Croatia and Lebanon, while late Belgian director Chantal Akerman and Turkish filmmaker Zeki Demirkubuz will also be presented in the 3x3 sidebar.
Besides the main competition (read the news) and the Romanian Days competition (read the news), this edition also has ten films vying for the FIPRESCI Prize, all grouped into the #Animal section, as they feature animals as the triggers or the heroes of the story.
The Supernova sidebar will show 25 recent award-winning movies, while the titles selected in the Shadows and No Limit sidebars seem determined to scare or shock the audience.
Scottish producer Iain Smith will receive the Transilvania Trophy for Special Contribution to World Cinema, while Romanian actresses Carmen Galin and Lujza Orosz will receive the Honorary Awards.
Tanks CINEUROPA!
*
 - Cinema
- Cinema
Cannes - Next presents 2
by Ernesto Leotta
19/05/2016 - CANNES NEXT: The 2016 edition of NEXT draws to a close with some great news – the birth of the R/O Institute
Cineuropa editor-in-chief Domenico La Porta.
As dusk started to fall over the NEXT week, a new kind of “Bat-Signal” was lit up by Cineuropa’s editor-in-chief, Domenico La Porta. Instead of the well-known bat, though, the sky hosted a different symbol, this time summoning more than one single hero: R/O.
Its French pronunciation, /ˈeʀo/ (lit. "hero"), suggests a true call to arms in order to rescue something precious – in this case, intellectual property (IP). La Porta's new venture is, de facto, an incubator for the next generation of storytellers, aimed at providing them with the right tools to develop and market their ideas and projects.
After a swift introduction by Wallimage's "man in the white glasses", Philippe Reynaert, La Porta highlighted the importance of IP by picking the aforementioned DC Comics winged hero as an example. "The whole concept behind Batman was inspired by Zorro. While the latter met with mild success only in the 1990s, thanks to Antonio Banderas' movies, the former saw its success gradually escalate over its 50-year life span, culminating in a record-breaking PlayStation videogame. So technology matters when designing a project, but content is key. The Smurfs was a Belgian comic strip, but no one knows about that – kids only know the two 3D movies about the little blue men, and only 0.2% of the copyright revenues came back to their mother country. The R/O Institute aims to keep the project IP in the hands of its rightful owner, without selling it to bigger companies."
Putting the story at the centre of every creation, the Institute will help its participants to develop a transmedia approach, focusing on the subject's mythology, story world and characters, as well as providing them with a social-media strategy in order to build and activate their community.
Furthermore, a gamified app will allow the "student" to evaluate his project, reach goals, get ranked, rewarded and even communicate with fellow creators, especially resident ones. That's right – the R/O Institute also features a residency hub (more of a high-profile hotel) called the R/Ω (pronounced /ʀɔm/), based in Charleroi, Belgium, and including a Creative Sandbox in which technicians, developers and artists can gain access to the most advanced technology in order to develop, prototype and design their content.
"Our website has just been launched here at NEXT! Feel free to apply by sending us your story and telling us the way you think it can be adapted – you might be one of our 40-plus selected projects. We're looking for heroes, but not only male ones – if no female hero shows up, there can't be no R/O Institute!" joked La Porta.
Build story worlds.
We stand at the dawn of a new narrative era. Those formerly known as an audience have left the single screen for a multi-platform odyssey and digital has turned viewers into users and tech savvy explorers. Films, TV series, gaming, mobile apps, graphic novels, virtual reality, mixed reality (...) are pushing the boundaries of vast story worlds ruled by tomorrow’s creators and the next generation of heroes.
R/O {ˈeʀo} is an institute that fosters the creation of original content and the acceleration of transmedia projects built around tomorrow’s heroes and rich intellectual properties.
Apply now!
Learn from the best.
R/O is a 6 to 9 months immersive training that aims at tuning strong narrative projects for today’s convergent market. On top of solidifying their story architecture and building their cross-platforms storytelling, the talents are offered numerous networking opportunities and business deals ranging from development grants to post-production services and publishing hooks.
The origin: stories.
The world belongs to those who tell stories. Do you have a story to tell? Sometimes one platform is not enough to cover the full spectrum of your idea. Do you already have plans for a film, a TV series, a comic book or maybe a game that you want to develop? How about ambitions for all of them and more? But you are a storyteller and you probably don’t know where to start…
Convergence.
Apply now to the R/O institute. Let’s expand your story world across platforms and prep your intellectual property (IP) for the convergent market.
If your narrative project is selected, you and your team will benefit from a professional coaching packed with multi-disciplinary insights coming from a large variety of experts in the form of:
• Public and private talks
• Access to R/O sandbox (tech, artistic and software toolbox)
• Workshops
• One on one sessions
• Group sessions
• Case success/failure stories and analysis
• Benchmarking challenges
• Project evaluation and milestones objectives
• Pitching opportunities
• Networking
• Transmedia watch
• Follow-up over an extended period of time
• Access to market acceleration and possible output deals
Gamification.
Thanks to gamified analytics and an interactive evaluation app, talents are stimulated to reach objectives and improve their skills. The R/O training aims at tweaking the complete spectrum of the project from the essence of storytelling to the marketing strategy and the architecture of a case by case revenue model.
Commitment.
Cult stories did not blossom in a week. That’s why we ask the core selection of our talents to commit to the R/O institute for a 6 to 9 months period of training. The institute programme is sidebarred and followed by active prospection in order to breach the global market and finally meet the project’s audience on different platforms. The R/O label ensures that commitment goes both ways.
Duration: 3 months (Oct-Dec, 2016)
Following a pre-selection phase, around 40 projects are granted access to the R/O bootcamp. It is a programme of curated conferences followed by participative Q&A’s that stand as a source of inspiration to broaden the horizon of our future talents. The bootcamp introduces them to the opportunities of the convergent market. It is about bringing an overview of what the R/O institute can do for your Intellectual Property (IP) while acquiring the basics of any solid franchise. The R/O bootcamp also provides useful workshops that will help applicants to set up their final application to the R/O institute.
The R/O Institute.
Duration: 6 months (Jan-Jun, 2017)
Once selected on the basis of a promising application file, an exclusive batch of 10 project teams of talents are physically welcomed to the facilities of the R/O institute to start enhancing their project. Our creative methodology breaks down an IP in a series of skills regrouped in 6 different skillsets. Each skillset forms a module that is roughly unfolding over the course of one month. The 6 skillsets are:
1. Story World
2. Crowd Design
3. Tech/Art Craft
4. CrossMedia Architecture
5. Revenue Model (and financing)
6. Marketing M.O.
Each skill from every skillset is developed through a gamified process based on skill assimilation and collaborative milestones to reach. Projects are constantly monitored through an evaluation app that also allows talents and experts to communicate and share watch material. Each project is modulated in order to bring more focus on its weakest skills and specifically address them. Around 20 skills that are essential to any narrative IP’s are taken into consideration across the whole duration of the training such as #characters opacity, #IP iconography, #raconteur, #social currency, #environment, #mythology #revenue streams… Improving each of those skills will level the project up to global market standards.
Between 50 and 80 international experts will meet with the talents in order to work on their skills. Talents are encouraged to collaborate with other teams, R/O’s partners and guest projects. Rewards can be earned along the way…
The R/O Line-up.
Duration: +18 months
By accessing the R/O institute, projects become part of the R/O catalog that our agents are submitting to the attention of our partners and to market places around the globe. Being part of the R/O line up of IP’s does not end with the training at the institute. It goes on over an extended period of active prospection in order to bring the project to life and meet its producing and broadcasting partners all the way to its audience down the line.
The R/O team.
Domenico La Porta
Institute Director
dom@ro.institute
+32 476 702 732
Stéphanie Thirion
Operations Manager
stephanie@ro.institute
+32 491 56 77 02
Belgian Heroes SA and R/O are original initiatives initiated by François Pernot,
CEO of Media Participation BE.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Il tempo della letteratura - saggio/invito concorso
CISAT - Presentazione
'Il tempo della letteratura'- Italianistica e oltre.
Il Comitato Editoriale
Dopo il volume ‘900 e oltre. Inediti italiani di prosa contemporanea (pubblicato nel 2005 e prefato da uno saggio di Giuseppe Panella, professore ordinario di Storia della Filosofia alla Scuola Nornale Superiore di Pisa) – del quale si legge infra una parte del pieghevole illustrativo –, avendo avuto a suo tempo positivi riscontri di critica e di pubblico, l’Istituto Italiano di Cultura di Napoli intende pubblicare nelle sue Edizioni, nel primo anniversario a distanza di dieci anni, un nuovo volume collettaneo, a carattere antologico – Il tempo della letteratura. Italianistica e oltre – stavolta di saggistica breve dedicata alla Letteratura italiana – dalle origini ad oggi, anche in chiave comparatistica –, della quale aspira a dare uno specimen significativo e di rilevante qualità scientifica per quanto concerne l’articolo breve di Italianistica.
Gli autori interessati sono invitati a proporre, preferibilmente per posta elettronica, insieme ad una esauriente nota bio-bibliografica, uno o più più articoli inediti su temi di Italianistica, indicativamente della dimensione non superiore alle 6 cartelle incluse le note, che verranno esaminati dal Comitato scientifico di lettura dell’Istituto, composto da Steven Carter, Constantin Frosin, Antonio Illiano, Roberto Pasanisi, Mario Susko, Násos Vaghenás, Nguyen Van Hoan. Gli articoli dovranno essere composti secondo il modello formale delle ICI Edizioni allegato.
L’invito è rivolto tanto a studiosi riconosciuti (sia appartenenti ad istituzioni che non) quanto a scrittori, ricercatori, letterati e cultori di letteratura in genere che aspirino a far conoscere attraverso una pubblicazione qualificata (distribuita in libreria a livello nazionale da Libro Co. Italia www.libroco.it) ed in un àmbito istituzionale e non amatoriale la loro produzione scientifica sulla letteratura italiana, sottoponendo i propri testi ad un giudizio critico professionale.
In caso di adesione all’iniziativa, i testi vanno inviati possibilmente entro il 31agosto 2016.
Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli
ICI Edizioni
via Bernardo Cavallino, 89 (“la Cittadella”); 80131 Napoli (Italia)
tel. 081 / 546 16 62 - fax 081 / 220 30 22 - tel. mobile 339 / 285 82 43
sito www.istitalianodicultura.org - posta elettronica ici@istitalianodicultura.org
Ici Edizioni prefisso editore: 8889203 – codice Alice: 44935 – codice editore: 206490
Direttore editoriale: Roberto Pasanisi - distribuite in libreria da Libri Co . Italia
L’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (www.istitalianodicultura.org; ici@istitalianodicultura.org), in collaborazione con la rivista internazionale di poesia e letteratura “Nuove Lettere” (da esso edita), pubblica cinque collane editoriali: due di poesia (entrambe dirette da Roberto Pasanisi: una intitolata Lo specchio oscuro, l’altra — di plaquette — intitolata Nugae), due di narrativa (una già diretta da Giorgio Saviane ed intitolata La bellezza;l’altra — di plaquette — diretta da Roberto Pasanisi ed intitolata Gli angeli) ed una di saggistica letteraria (già diretta da Franco Fortini ed intitolata Lettere Italiane).
Le ICI Edizioni Elettroniche pubblicano tre collane di libri elettronici: una di poesia (Adriana), una di narrativa (La Cittadella) ed una di saggistica (Neapolis).
Il Comitato di lettura delle Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI Edizioni) è costituito da Steven Carter (Lingua e letteratura inglese, State University of California, Bakersfield, Constantin Frosin (Lingua e letteratura francese, Università “Danubius”, Galaţi; scrittore), Antonio Illiano (Lingua e letteratura italiana, University of North Carolina at Chapel Hill), Roberto Pasanisi (Storia del cinema e del video; Teoria e metodo dei mass media, Accademia di Belle Arti “Fidia”; scrittore), Mario Susko (Letteratura americana, State University of New York, Nassau; scrittore), Násos Vaghenás (Teoria e critica letteraria, Università di Atene; scrittore) e Nguyen Van Hoan (Letteratura italiana e Letteratura vietnamita, Università di Hanoi).
‘900 e oltre' - inediti italiani di prosa contemporanea
Introduzione di Giuseppe Panella a cura di Ernesto L’Arab e Roberto Pasanisi
Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli
l'incipit della Prefazione di Giuseppe Panella
L’ANIMA DEL RACCONTO
“Le donne parimente e gli uomini tutti lodarono il novellare”
(Giovanni Boccaccio, Decameron, Introduzione)
1. Tradizionalmente il racconto come genere letterario non gode buona fama presso gli editori. A tutti coloro i quali si presentano con una raccolta di storie più o meno brevi, gli editori (dai colossi rampanti fino agli stampatori minimi) rispondono che il mercato non è interessato ai racconti e che sarebbe meglio dedicarsi alla stesura di un romanzo. Lo stesso Raymond Carver, uno dei più grandi scrittori americani di short stories nell’epoca del post-moderno, ha sempre ricordato come il primo anticipo ricevuto da un editore fosse relativo alla stesura di un romanzo che poi, ovviamente, non ha mai voluto (o potuto) scrivere. I testi brevi di narrativa non sembrano destare entusiasmi e successo di vendite rispetto alla più lunga narrazione articolata contenuta nei romanzi (anche quelli non legati a un genere specifico). Eppure, almeno in Italia, la tradizione del racconto sancisce e scandisce la nascita della prosa letteraria: che cos’è, infatti, il Decameron di Giovanni Boccaccio se non una raccolta di storie brevi tenute insieme da una cornice tutto sommato esile qual è quella dell’allegra brigata rifugiatasi in campagna per sfuggire alla terribile peste nera e che trascorre lietamente il suo tempo narrandosi storie più o meno intriganti? E lo stesso si può dire, mutatis mutandis, de Iracconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer che fin dal titolo reca inscritta la propria dimensione di narrativa breve affidata a diversi narratori che si alternano a raccontare per trascorrere meno noiosamente il tempo che impiegano a compiere il loro pellegrinaggio alla tomba di San Tommaso Becket.
Alle origini della narrativa c’è dunque il racconto come genere letterario, già codificato e strutturato come tale. La narrazione breve è probabilmente l’esempio più antico che abbiamo di pratica letteraria definita. Nata con la tradizione orale dei popoli più antichi (e che non conoscevano ancora la scrittura), continuata dagli egiziani [1], dalle vicende di uomini e Dei nell’India sanscrita, dalle vicende favolose de Le mille e una notte, presente dappertutto (anche nelle culture precolombiane dell’America Latina), essa rappresenta sicuramente il primo tentativo di comunicare le proprie esperienze da parte di popolazioni in cui il sapere orale era maggiormente rappresentato rispetto a quello scritto. Passando a periodi temporalmente a noi più vicini, il racconto breve si afferma negli Stati Uniti quale forma egemone di narrativa per il grande pubblico a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Il suo scopo editoriale era quello di riempire brevi spazi di lettura sulla stampa periodica che cominciava ad affermarsi allora quale forma principale di intrattenimento letterario. Fino a tutta la prima metà del Novecento, il racconto breve sembra avere (almeno in America) la stessa importanza e la stessa dignità letteraria del romanzo presso il pubblico dei lettori.
Lo stesso avviene in America Latina dove il racconto corto diventa una sorta di elemento “nazionale” della tradizione culturale dei paesi che la compongono, in particolare in Argentina (l’esempio di Jorge Luis Borges. magistrale autore di racconti fantastici e non,sembra esserne la migliore dimostrazione – e, d’altronde, proprio per questo, Borges si è sempre rifiutato di scrivere un romanzo!). L’età dell’oro della narrazione breve è, quindi, dalla metà dell’Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale: in essa i periodici sono avidi di ospitare sempre più racconti insieme alle puntate dei romanzi d’appendice a favore di un pubblico che ha sempre più fretta. L’avvento della radio prima e dei mezzi di comunicazione di massa poi brucia la possibilità da parte dei racconti di essere forma di scambio di esperienze condivise o condivisibili ed è in questo contesto che il racconto sembra decadere dal punto di vista dell’interesse del pubblico più ampio.
E’ per questo che il racconto sembra non attirare più gli editori. Ovviamente, tale discorso non vale per i critici e per gli studiosi di teoria della letteratura per i quali il racconto è un genere letterario che gode della stessa dignità e dello stesso interesse dei romanzi e della poesia. La crisi del racconto breve, dunque, è tale solo dal punto di vista dell’industria culturale e della sociologia che ad essa si accompagna.
[1] “La funzione della scrittura sul versante più “letterario” della religiosità egiziana può essere messa in relazione, oltreché alla natura particolare dei culti dei morti e al loro stretto legame con l’arte pittorica, alla qualità dei materiali utilizzati.” (Jack Goody, La logica della scrittura e l’organizzazione della società, trad. it. di Piero Arlorio, Torino, Einaudi, 1988, p. 33). La società egiziana è la prima da noi conosciuta in cui scrittura e racconto sembrano essere strettamente intrecciati.
Giuseppe Panella
'Storia della Filosofia', Scuola Normale Superiore di Pisa
Roberto Pasanisi, italianista, scrittore, editore, giornalista e psicologo clinico, è nato a Napoli nel 1962.
Docente universitario di Lingua e letteratura italiana e di Psicologia clinica in Italia e all’estero, è direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (del quale dirige anche le Edizioni omonime ed il Corso di Scrittura Creativa), della rivista “Nuove Lettere” e del CISAT (Centro Italiano Studî Arte-Terapia, dove è analista didatta, direttore dei corsi di Formazione e del “Giornale Italiano di Arteterapia”).
Ha pubblicato tre raccolte di versi (fra le quali Sulla rotta di Magellano, Napoli, Edizioni dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, 1996; prefazione da Giorgio Barberi Squarotti), due volumi saggistici (fra essi Le «muse bendate»: la poesia del Novecento contro la modernità, Pisa-Roma, I.E.P.I., 2000) e circa trecento articoli in riviste specializzate italiane e straniere. Si occupa principalmente di metricologia (nell’àmbito della quale ha ideato la 'metroanalisi') e di psicologia della letteratura e, come autori, di Lorenzo Spirito Gualtieri, del D’Annunzio del Poema Paradisiaco, di poeti italiani del Novecento (Caproni e Pasolini specialmente), di Mallarmé. È uscito il suo romanzo Gli angeli, Salerno, Ripostes, 2004. Suoi racconti sono stati pubblicati in riviste letterarie e quotidiani.
Giuseppe Panella, nato a Benevento nel 1955, vive a Prato. Insegna Storia della Filosofia nella Scuola Normale Superiore di Pisa.
Si occupa prevalentemente di questioni relative al pensiero etico e politico e al suo intreccio con la dimensione estetica della società. Ha tradotto e curato un'antologia di scritti di Roberto Michels (Socialismo e fascismo, 1925-1934, con un inedito di Gaetano Mosca e un carteggio con Georges Sorel, Milano, Giuffré, 1991) e ha introdotto l'edizione italiana della Lettera sugli spettacoli di Jean-Jacques Rousseau (Palermo, Aesthetica Edizioni, 1995), l'Jcosameron di Giacomo Casanova (Milano, La Vita Felice, 2001) e Il paradosso dell'attore di Denis Diderot (Milano, La Vita Felice, 2002). È autore di saggi sulla teoria estetica e letteraria del Sublime, sul simbolismo francese, sul dandy in letteratura, su Heinrich von Kleist, Paul Valéry, Pier Paolo Pasolini, Georg Simmel, Lorenzo Lotto, Leonardo Sciascia, Jacques Lacan e sull'etica dell'ascolto (è coautore del Manuale dell'ascolto di Alessandro Guidi di prossima pubblicazione presso le Edizioni Clinamen). È redattore della rivista letteraria "Dismisura" e del bimestrale “École”. Poeta, è autore di sei volumi e di una cartella di poesia.
Antonio Berté è nato a Napoli, dove vive e lavora, nel 1936. Dottore in Lettere classiche e giornalista pubblicista, ha segnato – a partire dagli anni ’60 – un momento decisivo nella storia della pittura italiana contemporanea. Innumerevoli le personali ed i riconoscimenti in Italia e all’estero, nonché cataloghi e pubblicazioni del e sul suo itinerario artistico (Commento a Kafka, ecc.). Pittore dell’anno nel 1970 e ’71, dal 1985 e Cavaliere al Merito della Repubblica e, nel 1986, ha ricevuto da Arte Europa il Trofeo Biennale di Venezia.
L’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI) (www.istitalianodicultura.org; ici@istitalianodicultura.org), in collaborazione con la rivista internazionale di poesia e letteratura “Nuove Lettere” (da esso edita), pubblica cinque collane editoriali: due di poesia (entrambe dirette da Roberto Pasanisi: una intitolata Lo specchio oscuro, l’altra — di plaquette — intitolata Nugae), due di narrativa (una già diretta da Giorgio Saviane ed intitolata La bellezza; l’altra — di plaquette — diretta da Roberto Pasanisi ed intitolata Gli angeli) ed una di saggistica letteraria (già diretta da Franco Fortini ed intitolata Lettere Italiane).
Il Comitato di lettura delle Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI Edizioni) è costituito da Constantin Frosin (Lingua e Letteratura francese, Università “Danubius”, Galati; scrittore), Antonio Illiano (Lingua e Letteratura italiana, University of North Carolina at Chapel Hill), Roberto Pasanisi (Lingua e Letteratura italiana, Università Statale per le Relazioni Internazionali MGIMO, Mosca; direttore, Istituto Italiano di Cultura di Napoli; scrittore), Mario Susko (Letteratura americana, State University of New York, Nassau; scrittore), Násos Vaghenás (Teoria e critica letteraria, Università di Atene; scrittore) e Nguyen Van Hoan (Letteratura italiana e Letteratura vietnamita, Università di Hanoi).
I edizione gennaio 2005 - Progetto grafico, copertina e logotipo delle ICI Edizioni: Roberto Pasanisi - In copertina Poesia di Antonio Berté - Introduzione di Giuseppe Panella; Prefazione di Ernesto L'Arab; Postfazione di Roberto Pasanisi- 2005 - ISBN 88-89203-11-0
Istituto Italiano di Cultura di Napoli - via Bernardo Cavallino, 89 ("la Cittadella") 80131 Napoli
tel. +39 081 5461662 - fax +39 081 2203022 - posta elettronica: ici@istitalianodicultura.org
*
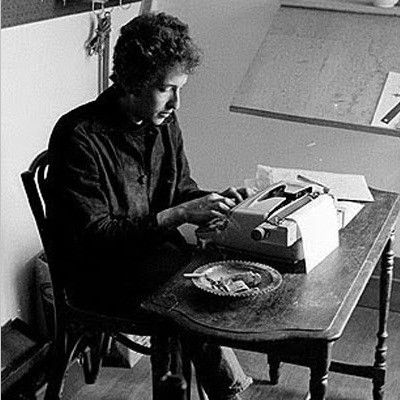 - Letteratura
- Letteratura
’Dialogarti’ by versante ripido
Invito e programma: Dialogarti 2016 - giovedì 5 maggio 2016 - 14:07
Cari amici, Versante Ripido quest’anno è uno degli sponsor del festival orizzontale di arti legato alla poesia a cura del Gruppo 77 “Dialogarti”. Siamo dunque lieti di invitarvi a visitare questa bellissima rassegna.
Di seguito trovate maggiori informazioni e le locandine con il programma e le indicazione per raggiungere la sede dell’evento.
Il festival “DialogArti” di Bologna è pronto per la seconda edizione. Tre saranno quest’anno i giorni (13-14-15 maggio 2016) – incentrati sulla vicinanza e condivisione delle differenti forme artistiche – della bellissima e coinvolgente manifestazione a cura del Gruppo 77 (www.gruppo77poesia.it).
Poesia, arti visive, musica, danza che si fondono, attraverso il filo conduttore delle arti che possano parlarsi, coinvolgersi, contaminarsi anziché recintare e isolarsi.
Quest’anno gli Artisti si confronteranno, dialogando appunto, su un tema comune: l’apnea esistenziale. L’affanno (fisico, sociale, civile) che costringe la nostra società ad essere sempre in debito di fiato.
Esposizioni di fotografie, sculture in filo di ferro, opere d’arte mozzafiato, videoinstallazioni, street art, concerti acustici, balletti.
A fare da legante, organizzatore e connettore, l’attivissimo gruppo poetico bolognese (condotto da Alessandro Dall’Olio, ideatore e direttore artistico anche di DialogArti) che in soli tre anni di vita ha organizzato 70 eventi poetici in giro per l’Italia per diffondere la meraviglia della forma letteraria più intima al maggior numero di persone possibili.
Il Gruppo 77 di Bologna, tra le tantissime cose fatte, ha partecipato lo scorso anno al Festival Mondiale della Letteratura di Cork, in Irlanda, al Festival Virgilio di Poesia, al Cantiere Artistico e a un evento satellite durante il Festivaletteratura di Mantova.
Il luogo che ospita il festival DialogArti è lo splendido Santevincenzidue (nell’omonima via del quartiere Cirenaica), gli ospiti eccellenti: i fotografi Nicola Casamassima, Mario Beltrambini e Sauro Errichiello, il collettivo WakeUp AndSleep, lo street artist Opiemme, le artiste Alessandra Maio e Chizu Kobayashi, il videomaker Matteo Russo… il tutto affiancato dalle musiche al pianoforte del compositore Fabrizio Sirotti e dai magnetici passi di danza di Sissj Bassani, Camilla Neri e Sara Magnani.
La manifestazione ha il patrocinio del Quartiere San Vitale e dell’Ufficio Cultura del Comune di Bologna. L’Associazione Handmedia (www.handmedia.org) sarà presente con le sue telecamere per tutta la durata della manifestazione per produrre un documento filmico sul festival.
Per ulteriori info è attivo l’ufficio stampa a cura di Indaco (www.indacoage.it).
https://www.facebook.com/DialogArti-206557116376670/#
Vi aspettiamo! / La redazione di Versante Ripido
*
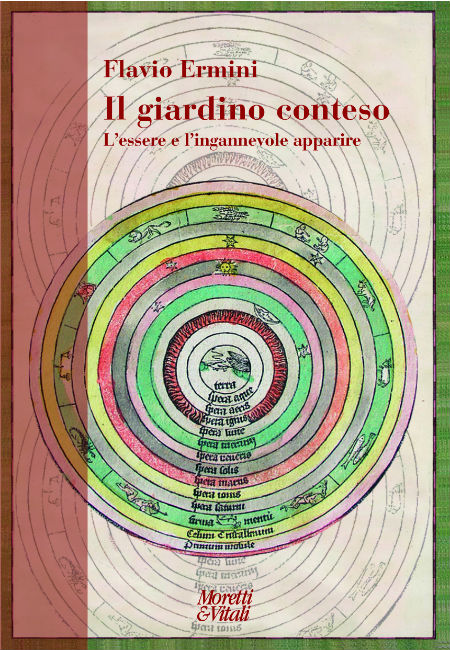 - Letteratura
- Letteratura
Il giardino conteso - il nuovo libro di Flavio Ermini
L’ultimo lavoro saggistico di Flavio Ermini – ‘Il giardino conteso’ – “..porta a un passo dall’esperienza originaria dell’esistenza e indica che testimoniare e custodire il senso di tale esperienza è un compito al quale non possiamo sottrarci. Bisogna prendersi cura dell’assillante sofferenza, esserne coscienti, al fine di perfezionare la conoscenza del bene congiunto di bellezza e verità.” Ecco perché nelle ultime pagine de Il giardino conteso, la parola diventa propriamente esperienza poetica; prende la parola per far sì che l’essere si dispieghi e contenda il giardino all’ingannevole apparire.
Premessa: l’antistoria.
Apparteniamo al principio, alla parola sorgiva, dove ogni cosa nasce per la prima volta e apparire, di un’alba che non conoscerà mai il giorno. È forse uno stadio estatico del linguaggio. La parola si fa avanti sotto forma di un’incerta natura... forse il “tu” dei nascenti.
Apparteniamo al principio. Viviamo ogni giorno il nostro apparire. Ma non ne siamo coscienti. Non sappiamo riconoscere il puro scaturire. Quel punto ortivo resta un enigma.
Guardiamoci attorno. Assistiamo a un sempre nuovo manifestarsi dell’essere, che ci impone un sempre diverso modo di pensare. Assistiamo a un principio che mai smette di venire alla presenza.
Siamo elementi di una realtà originaria che si manifesta solo in un “prima”: prima del respiro, nello schiudersi della corolla; prima del nome stesso, nel suo formarsi sotto l’inchiostro.
Quella realtà originaria è la dinamica che impone ai petali di essere.
Ha radici nella sostanza aurorale del mondo e si precisa come patria che attira a sé.
In quella realtà originaria, tra il principio e il respiro, si formula una parola... forse il “tu” della natura.
La parola si avverte nell’istante in cui si annunciano altre forme: le labbra, la lingua, il palato... il talamo, gli stami... I nascenti prendono vita, si fanno incontro alla parola, la interpellano nella precarietà, nell’incalcolabilità.
Non seguiranno una “storia” – l’hystoria dove si consuma il deturpamento del principio –, ma la “vera storia”: propriamente un’antistoria. I nascenti sono già da sempre estranei al divenire storico, ancorati come sono alla parola originaria. Solo in relazione alla parola albale si forma il corpo edenico, archetipo incorretto della natura umana.
La materia informe non è un episodio accidentale, poi superato, ma la struttura che sempre di nuovo si forma. Il senza-forma nascente è estraneo alla successione cronologica, tanto che il calendario a questo proposito non potrebbe fornire alcun ragguaglio.
Fare esperienza del mondo significa fare esperienza del sensibile, grezzo e latente; prendendo atto che l’antistoria coincide con la situazione di smarrimento e indecisione in cui si trova l’essere al suo levarsi dallo stato di latenza.
Questa iniziazione non ha parole né segni. È un restare nei pressi del principio, perché è l’unico modo di far avvenire gli innumerevoli altri cominciamenti.
Tra il primo inizio e tutti gli altri c’è un percorso che i nascenti faticano a conoscere, carico com’è di eventi misteriosi e inesplicabili. È un cammino fuori-memoria, tanto che l’andare a ritroso – così come il seguire il circolo del tempo – lo riapre continuamente, e continuamente fa sì che i nascenti siano chiamati a vivere, come
impone Rilke: «Compiere ancora una volta la propria infanzia».
Ovvero, compiere il cammino verso l’origine, verso l’inizio dell’esistenza, e stabilirne la direzione e il compito.
I nascenti sono appena definiti da un elenco di membra e di foglie, un insieme composito di arti, infiorescenze e rami, atteggiamenti isolati o connessi, ma sempre indipendenti da ogni schema unificante, fedeli come sono al chaos aurorale.
La necessità di un sistema generale è estraneo alla mentalità arcaica: ogni singolo fenomeno è spiegato in modo locale.
Nella profondità del tempo e nella frammentazione dello spazio possiamo scorgere le ombre di figure così lontane dalla funzionalità del tempo e dello spazio da potervi rinvenire l’essenza dell’essere.
Chiamati ad assentire all’affacciarsi dell’essere umano al mondo, siamo in realtà indotti ad assistere al suo restare in vita come essere che si trova in accordo con l’incessante apparire.
Pre-storico è l’incipit del linguaggio. Un non-luogo è il suo spazio. Da tale condizione parliamo, da una situazione pre-liminare di incertezza e disorientamento, connessa alla carenza di un habitat riconoscibile.
Partiamo da quella «terra invisibile e caotica» nominata da Agostino; quella terra «che sta tra la forma e il niente, non formato e non niente, un senza-forma quasi niente»; quella terra dalla quale è stato tratto il mondo artificiale e ben ordinato che ora abitiamo.
Siamo in quel non-luogo, precisa Meister Eckhart, «dove il principio sempre genera il principio». La trasparenza che il principio annuncia non è rimando ad altro da sé, non è rinvio a un fuori.
Non è segno che qualcosa lascia passare. Quel principio – grazie al quale la luce si manifesta e risponde – è fatto di materia inafferrabile, invisibile. Più presente di ogni presenza, ha per nome un nome non ancora pronunciato.
Puntualizza Hölderlin: «Enigma è ciò che scaturisce puro. / Anche al canto è dato / svelarlo appena. Tu continuerai / come hai cominciato».
Non c’è fine al principio e la parola è la porta aperta al regno anteriore e al suo tutto indiviso. Non resta che aprirci un varco nell’ingens sylva, nel giardino che racchiude i morti e i viventi, essere e apparire, fiori e pietre.
Non resta che inoltrarci nelle dense tenebre di luce di cui noi stessi, quali incessantemente nascenti, siamo formati.
Ma forse l’essere umano ancora non è in grado di sopportare intorno a sé e in sé l’essenza della natura: il puro scaturire che nella contesa con il tutto indiviso costituisce la vera sostanza del principio.
L’apparire dell’essere è sempre enigmatico, talvolta ingannevole, in ogni caso incalcolabile. Così è pure il suo celarsi.
Quali sono le vie che portano l’essere ad apparire? Come si manifesta l’essere? Dove si cela? Ogni sua manifestazione è davvero illusoria? Ce ne parla questo libro, indicandoci quali conseguenze comporta fare esperienza del mondo e del suo incessante scaturire.
Ne ‘Il Giardino Conteso’ viene tratteggiato il regno della caducità, il campo dell’apparizione, dove si trovano le cose in quanto cose-che-trapassano, limitate nella loro sembianza visibile e nella mutevolezza del loro contorno.
Qui per un momento vige il tempo ingannevolmente determinato dalla volta celeste. Il confronto è impietoso tra la caducità che tutto consuma e la natura immutabile e imperitura dell’essere.
Solo per un caso il vivente umano, effimero qual è, assiste a questa contesa e talvolta ne narra le vicende. Fatichiamo a riconoscerlo, ma l’apparenza non è uno spettacolo: le cose sono, i mari fluttuano, le nuvole passano, le costellazioni ruotano anche se nessuno c’è cui svelarsi.
La seconda parte descrive proprio “La realtà singolare delle cose”, così come si manifesta al suo apparire, indipendentemente dalle nostre opinioni.
La realtà singolare delle cose ci dice che siamo incastonati nella sostanza del firmamento e come il firmamento siamo elementi illusori.
Ecco la questione che la seconda parte dell’opera pone: attraverso la molteplicità delle apparenze è possibile risalire alla sostanza di cui tutte le cose sono composte? Addentrarci in questo territorio sconosciuto può mettere a soqquadro le nozioni acquisite e rendere incerto il nostro passo.
Ma solo così, avanzando verso l’ignoto, possiamo renderci disponibili a nuove verità. È un cammino lungo il quale costantemente vanno preparate le condizioni affinché ognuno di noi possa dirigersi anche verso la comune essenza.
Di questo cammino ci enumera i passi la terza parte dell’opera, “L’esperienza dello smarrimento”. Le tracce sensibili che seguiamo ci spingono sulle vie dell’errore. Nello smarrimento scopriamo sentieri nemmeno immaginabili fino a un attimo prima; scopriamo che a ogni interruzione nuovi percorsi invitano al cammino; siamo indotti ad assecondare i tracciati di una logica sequenziale messa continuamente sotto-sopra da sussulti altalenanti. In questo cammino incerto e accidentato si muovono i nostri passi.
In questo inoltrarci nella molteplicità e nella dispersione, resta la fiducia di giungere
prima o poi in prossimità di qualcosa di atemporale e incorruttibile come l’essere parmenideo.
L’antistoria va narrata. Il pennino va ancora intinto nell’inchiostro. La mano non può tremare in questo rinnovato movimento, compiuto per accostarci a quello che Novalis chiama «fondamento dei sensi».
Abitare altrove: “Sotto l’inchiostro”. La quarta parte dell’opera impone di imparare a vivere dopo il risveglio dalle illusioni; quando ciò che davvero interessa è l’impensato del pensiero, il non-detto delle parole. Impone di collocarsi ai confini della letteratura, della retorica, della poetica, della stilistica, della filosofia, là dove può configurarsi un’originaria relazione dell’essere con l’esistente. «Andare verso qualcosa e, nello stesso tempo, costruire quella cosa stessa» sostiene Martini.
Sarà proprio quell’andare e quel costruire che ci porteranno verso “L’altrove poetico” della quinta parte.
Qui viene affrontata la questione del linguaggio come apertura essenziale dell’uomo all’essere. L’esposizione all’interminabile disvelarsi dell’essere impone a tutti noi di fare i conti con il fondamento: una causa sempre operante che – separando l’indiviso dalla potenza – dà perennemente origine al mondo.
Qui impariamo che la parola è destinata a dire il vero dell’essere, a rivelarsi come il corretto movimento per rispondere alla sua chiamata. Per farlo, la parola deve spogliarsi dall’hybrisumana, che induce l’uomo a proclamarsi signore della natura fino a farsi della natura il legislatore.
Nella sesta parte, la parola prova a dare risposta a tali istanze, facendosi esperienza poetica. Qui la parola apre il linguaggio all’accadere dell’essere e – facendosi largo tra le apparenze – offre al pensiero quell’inizialità che consente all’essere umano di portare a compimento il primo inizio e di prepararsi all’altro inizio; là dove il dire può trovarsi a contatto strettissimo con il tutto indiviso.
Seguirne la via impone di orientarsi nel groviglio, di familiarizzare con le schegge e col frammento: una folata di vento, il moto del sole, il rumore di una pietra che cade. Seguirne il cammino impone di dire poeticamente quel medesimo che, manifestatosi della physis, si è poi ritirato nel nascondimento.
Qui la parola poetica prende la parola per fare in modo che l’essere si faccia presente al fine di contendere il giardino all’ingannevole apparire.
Avvertenza d’Autore:
La notte senza mattino.
L’inconosciuto è incessantemente in atto e il dire poetico non smette di segnalarci che è impossibile sottrarci al tempo delle tenebre e della contesa.
Il compito del dire poetico è di parlarci della forma umbratile che, risalendo da uno sfondo pre-umano, ci abita e ci trasforma.
Il dire poetico è la casa ospitale in cui il non-detto è portato a nominarsi come originaria contra-dizione.
Qui nominazione e inconosciuto possono sostare, in un tenersi insieme dei differenti.
Dire: per tornare in possesso della propria ombra.
L’evento del linguaggio – nel dare vita con il nome a un’ombra tra le ombre – rende possibile l’apparire di ciò che non si potrebbe né si dovrebbe mai vedere: l’originaria, fisiologica inabitabilità del mondo.
A iniziare da questo evento si può cominciare a riflettere veramente, così come accade davanti alle pitture nere di Goya, sul destino cupo dell’umanità.
L’essenza della parola – ovvero ciò che impone alla parola di essere una vera parola – va pensata a partire dalla sua capacità di accogliere nel dire ciò che appare, per quello che è, in assenza di pregiudizi.
La funzione svelante della parola consiste nell’aver cura del non detto e nel custodirlo insieme all’oscurità.
Lo sa bene Mary Shelley quando dà parola alla nostra parte in ombra consentendole di rivolgere un appello al suo ottuso creatore:«Oh, Frankenstein, non essere giusto con tutti per calpestare me soltanto! Me, cui tu devi non solo giustizia, ma anche bontà e affetto! Non lo dimenticare, io sono la tua creatura: dovrei essere il tuo Adamo, e sono invece l’angelo caduto al quale di proposito tu neghi ogni felicità, sebbene io non abbia colpa».
Il lavoro poetico si svolge al buio e dà parola all’oscurità che ci assedia, ovvero al profondo-senza-fondo della luce: il fuori come dentro assoluto. Non la notte del tempo cronologico, ma un’altra notte che nessuna aurora può rischiarare.
A quest’altra notte non può corrispondere nessun altro mattino. Proprio come la terra verso la quale ci dirigiamo, che altro non è che questa terra che abitiamo, dove da sempre già siamo: una terra che è proprio qui, pur essendo altrove.
Quest’altra notte senza un mattino, sopra quest’altra terra senza una nuova terra, è ciò che rimane indisvelato, ed è proprio ciò che nella parola viene custodito.
Solo un dire che non nasconde il proprio non-detto, ma incessantemente lo riprende, può pretendere di farsi prossimo all’inaccessibile, e forse diventare l’inaccessibile stesso. Per avvicinarsi alla sostanza ultima del mondo, il dire poetico deve andare al di là del mondo, deve rendersi insensato, fuor-viarsi, dissestare il principio di non contraddizione.
Iniziamo e terminiamo il nostro percorso terreno nella tenebra più fitta, che nessuna luce potrà rischiarare. Grazie al dire possiamo accogliere in noi l’ombra e farne esperienza, così come l’io impara a conoscersi facendo esperienza dell’altro. Ecco perché non si può prendere parola se non dal fondo dell’opaco, dal rovescio del discorso: propriamente dall’antidiscorso.
Il vivente umano e il semplicemente-vivente sono compresenti nello stesso essere. Nel dire, il primo si fa trascinare indietro – come accade a Samsa – dalla metà in ombra di se stesso. Sarà nel corso di questo processo che dalla dimensione sotterranea potrà emergere la parola obliqua dell’errore e dell’imperfezione, la sola che può nominare quel luogo inospitale.
Flavio Ermini è poeta e saggista italiano. Dirige la rivista di ricerca letteraria Anterem, fondata nel 1976 con Silvano Martini. Fa parte del comitato scientifico della rivista internazionale di poesia Osiris (Università di Deerfield, Massachusetts) e della rivista di critica letteraria Testuale. Dirige con Yves Bonnefoy, Umberto Galimberti e Vincenzo Vitiello la collana Opera Prima (Cierre Grafica). Collabora all'attività culturale degli Amici della Scala di Milano. I suoi testi sono stati tradotti in francese, inglese, slavo, spagnolo e russo[1].
Il compito che Ermini assegna al pensiero poetico non è unicamente quello di confrontarsi con il pensiero filosofico sulla base della logica e della coerenza sistematica, quanto riunificare, in un solo luogo dell'anima, la domanda fondamentale di verità e senza la presunzione di possederla. A questo fine, Ermini muove su due fronti che stanno in rapporto di reciprocità e fusione, concependo la scrittura come «tentativo di ripensare la domanda sul significato della vita»: su quello della poesia ricerca «una lingua inaugurale, che consenta di riguadagnare la continuità originaria tra parola e mondo», su quello critico va nel senso di «un “pensare” che possa strettamente coniugarsi con il “poetare”». Non a caso la sua è stata definita «lucida e nel contempo appassionata ricerca ontologica della parola, della poesia e quindi [...] della storia umana. Si annullano quindi le distinzioni di generi letterari per dar o perlomeno tentare, un cammino di continua tensione che ristabilisca la centralità responsabile della parola e consenta ad essa percorrenze di ricerca che creino poesia e non ego-poeti». Su questa scia, vige anche in Ermini la «speranza di poter giungere a “guarire” le parole dalla saccenza e dall'esaustività di una significazione rigida».
In raccolte come quella del 2010, ‘Il compito terreno’, si leggeranno allora poesie paragonabili a «illuminazioni improvvise: frammenti di pensiero sul sorgere della vita dal magma dell'inconscio, e sul destino dell'animale-uomo, consapevole di morte», con un'attenzione alla vita e al destino umani che in altre opere, come nel saggio ‘Il secondo bene’ (2012), sfociano nella concretezza del sogno, che si «riveste del suo antico abito regale», diventando «uno dei tratti caratterizzanti l'esperienza poetica e di pensiero di Ermini». De Francesco precisa poi che «la prosa e la poesia costituiscono, nella scrittura di Ermini, un unico dispositivo di espressione [...] in una prosa che non è tanto una forma di prosa poetica o di poesia in prosa, quanto essa stessa forma di poesia; e, parallelamente, in un discorso poetico che non è poesia filosofica ma è esso stesso pensiero, e, sul piano stilistico, esso stesso saggio», ribadendo che «nella scrittura di Ermini prosa e poesia, poesia e pensiero, saggio e discorso poetico coesistono nel medesimo spazio linguistico e semantico».
Fra le sue opere pioù recenti vanno qui segnalate:
‘Il moto apparente del sole’, premessa di Massimo Donà, Bergamo, Moretti&Vitali, 2006, Premio De risio, 2007.
‘Ali del colore’, immagini di Giovanna Fra, riflessione critica di Silvia Ferrari, Verona, Anterem Edizioni, 2007.
‘L'originaria contesa tra l'arco e la vita’, Bergamo, Moretti&Vitali, 2009, Premio Feronia-Città di Fiano 2010.
‘Il matrimonio del cielo con la terra. Materiali per un atlante’, Ruvo di Puglia, Tracce-Cahiers d'art, 2011.
‘Il secondo bene’. Saggio sul compito terreno dei mortali, postfazione di Franco Rella, Bergamo, Moretti&Vitali, 2012.
‘La tâche terrestre des mortels (edizione bilingue di Il compito terreno dei mortali), prefazione di Franc Ducros, Traduzione di François Bruzzo, Nîmes, Lucie Éditions, 2012.
‘Essere il nemico’. Discorso sulla via estetica alla liberazione, Milano-Udine, Mimesis, 2013.
‘Rilke e la natura dell'oscurità’. Discorso sullo spazio intermedio che ospita i vivi e i morti, Milano, AlboVersorio, 2015.
*
 - Musica
- Musica
A lo cubano ..somos todos americanos - parte terza
Etnomusica XII (terza e ultima parte): Viaggio nella Musica Cubana di ieri, di oggi, di sempre.
Benvenuti al Tropico del Cancro che nel Golfo del Messico attraversa il Mar dei Caraibi tra l’Havana e Santiago de Cuba circondando l’isola con acque calde e comunque sempre temperate che ne fanno una meta preferita del turismo internazionale. Ma non è – come ho gia detto in chiusura del capitolo precedente – l’unico interesse del turista che affronta le incongruenze di un paese solo per certi versi ‘vivace’. Il buon intenditore di musica ben sa di trovare qui la musica più originale del momento. In tutto l’universo mobile e fluido della cultura musicale e nella costante sfida nel mondo globalizzato della danza il ‘salsa cubano’ segna il trionfo della musica latina e afro-americana, in quanto sintesi esplosiva di vitalità ch’è quasi impossibile pensare di resistere a quella che oggi è considerata la ‘fuente’ del ritmo per eccellenza, che sta progressivamente contagiando anche l’Europa. “Infatti, - scrive Ivo Franchi sulle pagine della rivista Meridiani dedicata a Cuba - passeggiando per le strade delle città o sulle spiagge assolate dei cayos, sembra che il silenzio sia bandito. Dagli altoparlanti viene diffusa musica a tutto volume, registratori e radio portatili trasmettono le note malinconiche del ‘feeling’ melodico-sentimentale e la gente più che camminare, ondeggia sui fianchi a passo di danza, fischiettando i motivi più in voga del momento.”
Se è vero che tutto si mescola a Cuba, va detto che in musica l’isola ha raggiunto un primato che nessun altro paese può toglierle, quello dell’eccellenza ritmica che pure alcuni attribuiscono alla musica brasiliana. Volendo fare un esempio pratico si può mettere a confronto la realtà cubana con quella brasiliana, la differenza si avverte in quanto i ‘carioca’ brasiliani hanno messo nella loro musica la ‘saudade’, un sentimento che abbassa il tono della loro pur colorita vivacità; ciò che non riguarda affatto la musica cubana nel suo insieme, lì dove la creatività strumenale e quindi l’improvvisazione, raggiungono una tale evidenza da sconfessare qualsiasi apporto convenzionale. “Si dice – scrive ancora Ivo Franchi – ‘date a un cubano due pezzi di legno, una scatola di lattae il vecchio schienale di una sedia e improvviserà per voi una travolgente festa musicale”.
L’occasione non è mancata al gruppo Orishas che fin dagli inizi si presentò sulla scena internazionale con un mix di latin-rap-cubano formidabile che fin da subito permise loro di raggiungere il successo desiderato. Formatosi ad Havana nel 1999 ne facevano parte: Yotuel Romero, Ruzzo Medina, Roldán, Riverí Medina e, in passato, anche Flaco-Pro, il gruppo ha registrato cinque album, tra cui una raccolta, tutti pubblicati dalla divisione latina dell'etichetta discografica Universal, e riscossere numerosi riconoscimenti e premi: Latin Grammy Award alla miglior canzone urbanLatin, Grammy Award al Miglior Videoclp, Latin Grammy Award al miglior urban album. Il loro primo disco ‘ A lo cubano’ risale al 2000 divenuto per un certo tempo ‘inno’ dei moderni giovani cubani. La canzone ebbe un discreto successo anche in Europa in paesi quali Svizzera, Francia, Belgio e Spagna, ed inclusa nella compilation del Festivalbar di quell'anno in Italia. Il gruppo ha anche partecipato alle colonne sonore di diversi film tra cui ‘The Fast and the Furious’, con la canzone ‘Atrevido’, e ‘...E alla fine arriva Polly’, con il brano ‘Represent’. Altri album pubblicati: ‘Emigrante’ (2002); ‘El kilo’ (2005); ‘Cosita buena’ (2008). Nel 2010 il gruppo ha annunciato il ritiro dalle scene, nonostante il buon successo riscosso nella loro carriera.
‘A lo cubano’
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
No no no no
A lo cubano
Directamente de Panam
De Paris pa ser exacto
De Cheguan, donde están
Los de la nueva generación son
Y mira ponte en el fuego de la acción
Con presión de la lírica mística suchíca
La rumba ha comenzado con Anga Flaco Pro
El negro Yoruba, hijo´e Eleggua candela
Escucha como suena no hay más na
Sonido fuerte, ardiente y pegajoso
Si te rozo te destrozo
Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos
Con mi conexión controlando bien mi lengua
Pegao hasta el techo quiero que lo entiendas.
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
No hay quien me pare
Aquí mira voy a seguir
Yo represento ron, mulata, cuba hasta el fin
Mi Orishas como un imperio voy a construir
Yo te dejo mi tema como mi emblema cest fini
No no te vayas
Mi gente Orishas, el mundo pa la valla
De oriente hasta occidente gritamos a la batalla
Mi gente en talla
Y todo el yack se te desmaya
Y te me callas.
Ya te lo dijo el Guerrero
Ruzzo, Flaco Pro y Roldán
De Panam a Kivicán
Con un estilo rumbero
Hay que quitarse el sombrero
Frente a mi Orishas a hip hop
Sal de la cueva conejo
Que llegó tu guaguancó
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos
A la del cuello estoy
Y vengo dando tacazos
Ya se pa que cuerpazo el dj tira razo
El control de tu mente rebaso, paso, doy
Al momento preciso para los mariachis
Que escriben pa tirarlo al precipicio
Dejen ese oficio, te saque de quicio
El público la amenaza poniendo pa´lante el pico
Y ahora te lo disparo en chino
Voy a adelantal
La constitución
Del quinto mandamiento dice
En el saglado liblo de la métrica temática
Que guarda el señor tiempo y tu centro
Del cual yo soy honorable emperador
Y utilizo mi lengua como un tenedor
Para desceleblarte a ti so melón
Miko Niko la Amenaza
Bye bye flow.
A lo cubano
Botella´e ron tabaco habano
Chicas por doquier
Ponche en Café Guano
Aquí mi vida para los mareaos.
Autentici eroi della ‘gioventù’ cubana di un tempo sono però i componenti ormai centenari, riscoperti dal geniale Ry Cooder che li ha voluti nel memorabile evento di “Buena Vista Social Club”, dal nome di un ‘club’ dell’Havana attivo dal 1932, riservato ai neri. Inizialmente riservato ai neri il Buena Vista aveva raggiunto con il tempo una tale notorietà che diversi celebri cubani gli avevano dedicato canzoni: così Arsenio Rodríguez con ‘Buena Vista en guaguancó’ e Israel ‘Cachao’ López con ‘Club Social Buena Vista’. Prima del 1959, esistevano a Cuba diverse società, spesso legate alle differenti etnie: quella nera, quella spagnola, quella cinese e altre ancora. Per quanto riguarda la prima di queste, le più famose furono la Unión Fraternal, Las Águilas, Marianao Social, Atenas, Antillas, Isora, Jóvenes del vals e, infine, il Club Social Buena Vista, che prendeva il nome da Buena Vista, il quartiere dell'Avana.
Quando nel 1939 si inaugura la sala che poi diverrà il Tropicana, distante un chilometro dalla sede del Buena Vista, questo si trasferisce nell'antico quartiere Alturas de almendares. Il club, oltre a fornire servizi tipici di un'associazione (come lezioni di cucito per le adolescenti), concentrava i suoi sforzi nell'organizzazione delle sale da ballo: orchestre di varia estrazione accompagnavano i balli della tradizione cubana. La strada su cui affacciava l'ingresso del club si riempiva di appassionati, spesso bianchi color latte cui era negato l'ingresso. Nel 1959 fu vittima anche dell'ondata riformatrice dei primi anni della rivoluzione, con il primo presidente della Cuba rivoluzionaria, il cristiano-sociale Manuel Urrutia Lleó, e ritenuto un luogo di decadenza, così come molti altri club e ritrovi, anche ambigui, della dittatura. La successiva svolta comunista del governo, con leader Castro, ebbe come indirizzo l'abolizione dei club riservati a singole etnie o gruppi di sodali a favore dell'apertura di centri di socializzazione privi di discriminazioni sociali o etniche, cosa che ne decretò la chiusura definitiva nel 1962.
Con la campagna del 1968 ‘medidas especiales’, (misure speciali) che volle dare un'accelerazione in tal senso, la musica popolare, ritenuta poco consona al ‘socialismo reale’ di quegli anni, passò in second'ordine rischiando di perdere molti artisti per emigrazione o perdita di visibilità. Memore di questa antica gloria quasi dimenticata, Juan de Marcos González, direttore del gruppo Sierra Maestra, decide di mettere insieme un'orchestra che riunisca la storia e gli elementi più brillanti del son e del resto della musica tradizionale cubana, la Afro-Cuban All Stars. Nel 1995, González viaggia a Londra, al fine di promuovere il disco ‘Dundumbanza’. Ne parla con Nick Gold, presidente della World Circuit Records: la proposta è quella di produrre un disco con un ven tú (una selezione di all stars della vecchia guardia), allo scopo di riunire alcuni musicisti affermati ma un po' dimenticati e riscattare il genere delle big band di jazz afrolatino. Gold abbraccia l'idea e con la Afro Cuban All Stars mette insieme Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Manuel ‘Puntillita’ Licea, José Antonio ‘Maceo’, Pío Leyva, Raúl Planas, oltre a musicisti della stazza di Manuel ‘Guajiro’ Mirabal, Javier Zalba, Orlando López ‘Cachaíto’, Rubén González, Miguel Angá. Solo nel 1996 vengono pubblicati tre dischi, tra cui ‘Buena Vista Social Club’ e ‘A toda Cuba le gusta’. Il primo vince il Grammy del 1998, nella categoria della musica tradizionale oltre a divenire un enorme successo pop-jazz.
Nel 1996, *Ry Cooder, chitarrista e compositore americano, invitato da Gold a registrare una session con due anziani musicisti del Mali che avrebbero dovuto collaborare con alcuni musicisti cubani, viene a sapere che i due musicisti del Mali, non avendo ottenuto i visti, non erano stati in grado di raggiungere Cuba per cui bisognò cambiare i piani iniziali e decidono di registrare un album di son cubano con musicisti locali. Nel progetto, vengono coinvolti tutti i musicisti che dovevano entrare a far parte del precedente progetto abortito. Poco dopo esser tornato da Cuba e aver registrato il disco ‘Buena Vista Social Club’, Cooder inizia a lavorare con Wenders alla colonna sonora di ‘Crimini invisibili’, terza collaborazione tra i due artisti. Per quanto Wenders non conoscesse per niente la musica cubana, si entusiasma ascoltando le registrazioni che Cooder gli fa ascoltare e acconsente a viaggiare fino all'Avana per filmare il primo disco solista di Ibrahim Ferrer, ‘Buena Vista Social Club Presents: Ibrahim Ferrer’ (1998):
“Dos Gardenias” – bolero che ascoltiamo (nel disco) da Ibrahim Ferrer
Dos gardenias para ti
Con ellas quiero decir:
Te quiero, te adoro, mi vida
Ponle toda tu atenciòn
Porque son tu corazòn y el mio.
Dos gardenias para ti
Que tendràn todo el calor de un beso
De esos besos que te dì
Y que jamàs encontraràs
En el calor de otro querer.
A tu lado viviràn y se hablaràn
Como cuando estàs commigo
Y hasta creeràs que te diràn:
Te quiero, te adoro
Mi vida.
Pero si un atardecer
Las gardenias de mi amor se mueren
Es porque han adivinado
Que tu amor me ha traicionado
Porque existe otro querer.
Ma vediamo chi erano i membri che facevano e parte di quella che è stata la più felice ‘reunion’ del secolo:
Juan de Marcos González - percussioni, *Ibrahim Ferrer - voce, *Rubén González - piano, *Compay Segundo - chitarra e voce, Idania Valdés - voce, Pío Leyva - voce, Manuel "Puntillita" Licea - voce, Orlando "Cachaíto" López - contrabbasso, Manuel "Guajiro" Mirabal - tromba, *Eliades Ochoa - chitarra e voce, *Omara Portuondo - voce, Barbarito Torres - laud, Amadito Valdés - timbales,Nick Gold - produttore per la World Circuit Records.
Ecco un tipico ‘bolero’ di Maria Teresa Vera e Guillermina Aramburu cui Omara Portuondo presta la sua voce e la sua commozione:
“Veinte años”
Qué te importa que e ame
si tu no me quieres ya
el amor que ya ha pasado
no se puede recordar.
Fui la ilusiòn de tu vida
un dia lejano ya,
hoy represento el pasado
no me puedo conformar.
Hoy reprtesento el pasado
no me puedo conformar.
Si las cosas que uno quiere
se pudieran alcanzar
tu me quisieras lo mismo
que veinte años otràs.
Con qué tristeza miramos
Un amor que se nos va,
es un pedazo del alma
que se arranca sin piedad.
Non potendo qui parlare di ogni singolo strumentista, possiamo però spendere alcune parole su quelle che sono le ‘voci’ (*) portanti che hanno fatto del Buena Buena Vista Social Club Tour un avvenimento di portata internazionale che ha toccato numerosi paesi americani ed europei, nel disco come nel film, con i suoi ritmi di sempre: dal ‘son cubano’ al ‘bolero’, dal ‘punto guajiro’ al ‘danzon’, al ‘mambo’ ecc. Numerose sono inoltre le canzoni che, seppur datate, hanno trovato una nuova eco mondiale, facendo letteralmente impazzire le nuove generazioni: ‘Chàn, chàn’, ‘El cuarto de Tula’, ‘Dos gardenias’, ‘Candela’, ‘El carretero’, ‘Viente años’, ‘De camino a la vereda’, ‘Amor de loca juventud’, ‘Y tu que mas echo?’, inoltre allo straordinario ‘Mandinga’ e quel ‘Buena Vista Social Club’ che ha dato il titolo all’album, con la partecipazione straordinaria, come si dice nel cinema, di Ry Cooder in veste di produttore e musicista. Iniziamo quindi proprio da Cooder che ha riunificato e ha dato una spinta determinante alla rinascita della musica cubana:
*Ryland Peter Cooder, più noto come Ry Cooder, oltre ad essere celebre per la sua notevole tecnica alla slide guitar, è noto soprattutto per una serie di album in cui ha esplorato vari generi della musica americana ‘delle radici (roots music). Con il tempo la sua ricerca etnomusicale si è man mano ampliata arrivando a toccare culture diversissime tra loro, dal raga indiano ai ritmi sudamericani passando per la musica africana. È al trentunesimo posto della lista dei cento migliori chitarristi stilata dalla rivista Rolling Stone. Sa suonare numerosi strumenti a corda, tra i quali anche il mandolino, il bouzouki, la chitarra Weissenborn ed altri. Viene inoltre riconosciuto per l'uso singolare che fa del ‘Bottleneck’ con la chitarra acustica, La sua tecnica chitarristica è improntata all'uso di varie accordature aperte e da uno stile raffinato. Inoltre ha lavorato come session man e composto numerose colonne sonore, di cui forse la più conosciuta è quella del film ‘Paris, Texas’ di Wim Wenders (1984). Cooder ha basato questo suo lavoro con la nota title track sul pezzo ‘Dark Was the Night’ (Cold Was the Ground) di Blind Willie Johnson, pezzo che egli descrive come “ il più pieno d'anima, il più trascendente della musica americana”.
Ry Cooder inoltre ha contrassegnato uno dei momenti più importanti per la musica più in generale con l'utilizzo della sua ‘slide guitar’ nelle colonne sonore dei film di Walter Hill ‘I cavalieri dalle lunghe ombre’ (The Long Riders) del 1980, ‘I guerrieri della palude silenziosa’ (Southern Comfort) del 1981, ‘Chi più spende... più guadagna’ (Brewster's Millions) del 1985, e quel ‘Mississippi Adventure’ (1986) dedicato alla leggenda del blues Robert Johnson. Ma ben altre vanno qui citate: ‘Ancora vivo’ (Last Man Standing) (1996), e ‘I colori della vittoria’ (Primary Colors) del 1998 diretti da Mike Nichols; e ‘Crossworld’ di … del… . Nonché per essere il principale iniziatore, nel 1996, del celebre progetto Buena Vista Social Club. Nel 2011 inoltre ha pubblicato per la storica casa editrice americana ‘City Lights’ la raccolta di racconti ‘Los Angeles Stories’, la sua prima opera di narrativa pubblicata in Italia a settembre 2012 da Elliot Edizioni.
*Rubén Gonzàlez, pianista, pressoché sconosciuto per tutti noi fino alla sua partecipazione al BVSC disco e film, è considerato una leggenda vivente per la gente cubana e un eccezionale esponente del cuban jazz , riesce ancor oggi a coinvolgere e ad entusiasmare con il cui ‘touch’ unico, fra i più raffinati ed eccellenti al mondo. ‘Introducing Rubén Gonzàlez’ e ‘Chanchullo’ sono i due album registrati per la World Circuit Production, frutto di un lavoro paziente di ricerca sulla musica cubana che Rubén Gonzàlez ha realizzati con una eccezionale band ritmica e vocale che lo accompagna, riunita per l’occasione e formata da autentici ‘virtuosi’ degli strumenti, come abbiamo potuto apprezzare nel film di Wenders. Due soli album in quasi cento anni di vita passati a fare jazz e che, tuttavia, ci restituiscono di Rubén il piacere del suo famoso ‘touch’ nei brani-covers quali ‘Pa gozar’, ‘la lluvia’, Choco’s guajira’, ma anche la dolce ‘Quizas, quizas’, la frenesia di ‘Cubancero’, il fuoco di ‘Mandinga’ e la strepitosa versione-jazz di ‘Siboney’ di Lecuona. In vero quel ‘touch’ che esalta e predomina in ogni pezzo sollecitando il trasporto sentimentale e romantico, talvolta passionale intrinseco di tutta la musica cubana.
Davvero interessanti sono anche i due libretti che accompagnano i CD e che oltre alle note riferite ai componenti la band e alle immagini di repertorio, offrono un’ampia documentazione e visualizzazione per mezzo di foto del personaggio Rubén Gonzàlez com’era ieri e come si presenta quest’oggi. Ma se per l’uomo sono passati gli anni, non possiamo dire altrettanto della sua musica che una migliore tecnologia permette oggi di gustare nel pieno delle sue prestazioni. Sarà indubbiamente cambiata dai suoi inizi, ma non è detto che risenta degli anni passati, in quanto l’’essenza cubana’ sembra aver conservata la stessa vitalità di un tempo, semmai rinvigorita dal nuovo sound moderno dell’elettrificazione ma che Rubén dimostra a pieno titolo di saper governare.
*Omara Portuondo, voce tra le più celebrate della musica cubana, la sua storia inizia negli anni ’50 quando si esibiva con la sua band riproponendo brani appartenenti alla tradizione dei diversi ‘spiriti’ dell’anima cubana. Uno stile per così dire ‘melancolico’ che pur essendo cambiato con gli anni conserva l’autentico fascino di quel vissuto sentimentale che si trasmette inalterato attraverso il tempo e che detiene la consapevolezza, o forse l’inconsapevolezza, di un romanticismo valido sempre, in ogni epoca. Approdata nel jazz negli anni ‘70/’80 Omara ha fatto della sua voce un’incredibile mistura di blues carico di sensualità e accettazione dimessa dei sentimenti. Come nella ‘canciòn’ di Urbano Gomez Montiel e Y. De la Fuente che qui propongo e contenuta nel suo album omonimo ‘Omara Portuondo’:
‘Canta lo sentimental’
Esta tristeza se niega al olvido
como la penumbra a la luz,
quiera el destino que puedas volver
un dia para recordar.
Sentimental mi ventana se vuelve,
las cosas parecen pensar
Liueve en la calle y dentro de mi
canta lo sentimental.
Todos los dias me duele
la tristeza que me da
y se me cae del recuerdo
un nido de soledad.
Para volar mi paloma se tiende
como un pañuelito de luz.
Baila la lluvia y dentro de mi
canta lo sentimental.
*Compay Segundo - chitarra e voce, pseudonimo di Máximo Francisco Repilado Muñoz è stato un compositore, musicista e cantante cubano. Nacque a Siboney, presso Santiago nel 1907, scrisse la sua prima canzone ‘Yo vengo aquí’ a quindici anni e cominciò a suonare il clarinetto a tredici, per poi passare successivamente alla chitarra e all'armonico, uno strumento musicale di sua invenzione a sette corde simile ad una chitarra. Fece parte di varie formazioni ma il grande successo popolare arrivò quando, insieme a Lorenzo Hierrezuelo, formò il duo Los Compadres. A quel periodo risale il soprannome di Compay Segundo attribuitogli da un presentatore radiofonico perché nel duo egli faceva la seconda voce, mentre Lorenzo Hierrezuelo fu soprannominato Primo Compay. Negli anni cinquanta formò i Compay Segundo Y Su Grupo, ma successivamente il suo nome finì nell'oblio e Compay Segundo, pur non abbandonando mai la musica, lavorò in una fabbrica di sigari. Negli anni novanta, ormai in pensione, il mondo musicale tornò ad occuparsi di lui, e così ebbe la possibilità di tenere concerti anche in Europa. Il vero grande successo arrivò però nel 1997 con il film Buena Vista Social Club di Wim Wenders e con l'album della colonna sonora, che vinse numerosi premi Grammy. Dopo l'uscita del film tenne anche alcuni concerti in Italia durante i quali, a 93 anni, entrava in scena ballando e restando in piedi per oltre un'ora. Scherzosamente diceva che avrebbe voluto vivere fino a 116 anni, l'età della morte di sua nonna. Riguardo alla nascita del brano che sempre lo accompagna ha detto: “Io non ho composto ‘Chan Chan’, l’ho sognata, io sogno la musica. A volte mi sveglio con una melodia in testa, sento gli strumenti in modo molto chiaro. Allora guardo fuori dal balcone e non vedo nessuno, ma sento la musica come se fosse suonata in strada. Non so cosa fosse. Un giorno mi sono svegliato sentendo quelle quattro note, quei quattro accordi, allora ho messo giù un testo ispirato alla mia infanzia”:
“Chan Chan”
De Alto Cedro voy para Marcané
Luego a Cueto voy para Mayarí
El carino que te tengo
Yo no lo puedo negar
Se me sale la babita
Yo no lo puedo evitar...
Sono questi versi di apertura di ‘Chan Chan’, la celebre canzone cubana più amata al mondo, inserita nell’album “Buena Vista Social Club”, tanto per dire che l’Afro-Cuban All Stars fiore all’occhiello della musica cubana e Buena Vista Social Club sono ormai un sogno diventato realtà. La canzone narra di un piccolo screzio fra Chan Chan e Juanica, una coppia immaginaria di innamorati della tradizione popolare cubana, e lo fa con un testo semplice e molto poetico, sulle note di una melodia ipnotica e seducente. A cosa è dovuto lo straordinario successo di questo gruppo di artisti che ancora oggi si esibiscono in tutto il mondo? Probabilmente al calore e al ritmo travolgente della musica latina i cui generi sono riproposti all’interno delle loro composizioni quasi totalmente. Ma non solo. Il pubblico sente infatti la passione e l’entusiasmo di musicisti che, a discapito di età anche molto diverse (dai 13 anni dei nuovi membri agli 80 e più degli storici, come il trombettista Manuel ‘Guajiro’ Mirabal), sono uniti da un legame umano molto forte e da un grande amore per le tradizioni della loro terra.
Ma introduciamo il nostro prossimo ospite, sicuramente il più simpatico in assoluto:
*Ibrahim Ferrer Planas – voce, nato nel 1927 a Santiago de Cuba è stato un popolare musicista di ‘son cubano’. Rimasto orfano all’età di dodici anni divenne un musicista di strada, un mestiere come un altro per sopravvivere, ma subito dopo, all’età di tredici anni costituì il suo primo gruppo in duo con un cugino Jovenes del Son. Insieme riuscirono quindi ad ottenere una certa indipendenza economica esibendosi nelle feste private. Negli anni successivi Ferrer suonò con più gruppi, fra i quali i Conjunto Sorpresa e l'Orquesta Chepin-Choven. Il leader di quest'ultima compose uno dei più grandi successi di Ferrer: El Platanal de Bartolo. Nel 1953 Ferrer iniziò a suonare con il gruppo di Pacho Alonso a Santiago. Nel 1959 il gruppo si spostò permanentemente a L'Avana, ribattezzandosi Los Bocucos, da un tipo di tamburo molto usato a Santiago. Con Alonso, Ferrer suonava principalmente guaracha, son ed altri brani up-tempo. Tuttavia egli desiderava cantare dei bolero. Fu solo quasi quarant'anni dopo, con l'uscita nel 1999 del disco prodotto da Ry Cooder "Buena Vista Social Club" (vincitore di un Grammy Award), che il talento di Ibrahim Ferrer come cantante di bolero divenne noto in tutto il mondo.
Nel 1996, Ferrer prese parte ai concerti ‘World Circuit’, quando seppe che era richiesto un cantante di bolero vecchio stile. In quell'anno incise l'album A Toda Cuba le Gusta con gli Afro-Cuban All Stars, un album che ricevette una nomination per un Grammy Award. Nel 1998 incise un album per l'etichetta cubana EGREM, Tierra Caliente: Ibrahim Ferrer con Los Bocucos. In quest'album si possono ascoltare la voce ed il fraseggio unico di Ferrer, i ricchi ed intricati arrangiamenti, nonché l'eccellente tromba solista del leader Roberto Correra, ed i suoni tesi e ritmati dei Bocucos. Lo stile dell'album è una fusione di son e jazz da big band. Nel 1999 Ry Cooder incise il primo album da solista di Ferrer. Membro del Buena Vista Social Club, Ferrer continuò a suonare a livelli internazionali fino al 2003, e nello stesso anno pubblicò la sua seconda incisione da solista: Buenos Hermanos.
*Eliades Ochoa - chitarra e voce, (Songo-La Maya, 22 giugno 1946) è un cantante, chitarrista e compositore cubano. Cantautore con profonde radici rurali, considerato uno dei più importanti soneros e strenuo difensore della musica tradizionale cubana, nasce nella campagna, en el campo, a pochi chilometri da Santiago di Cuba. All'età di sei anni impara a suonare la chitarra ed il tres grazie anche ai suoi genitori, entrambi valenti soneros. Dotato di un grande istinto musicale che gli permetteva in brevissimo tempo di memorizzare sia le parole che il giro armonico delle canzoni che ascoltava, riuscì ben presto ad eseguire con maestria diversi stili di musica tradizionale cubana, come sones, guaracha, guajira e boleros. Nel giro di qualche anno passò da musicista solitario che guadagnava pochi spiccioli nelle vie dei quartieri a luci rosse a componente di gruppi importanti come il Quinteto Oriental e, all'inizio negli anni '70, il Septeto Tipico. Quando in seguito riuscì a formare un proprio trio era già talmente noto che gli abitanti di Santiago conoscevano alla perfezione il suo repertorio. Nel 1978 Pancho Cobas, direttore della Vieja Trova Santiaguera, gli propose di entrare a far parte del Cuarteto Patria. Eliades accettò e fece di questo gruppo la band di son più amata e apprezzata di tutta l'America Latina. Nel 1986, insieme al celebre musicista cubano Compay Segundo, incise l’ormai famoso brano ‘Chan Chan’.
Nel 1997 Eliades Ochoa partecipò, con diversi altri musicisti tradizionali cubani, al progetto Afro-Cuban All Stars che, fra le altre cose, portò alla realizzazione del disco (e più tardi del film) Buena Vista Social Club, vincitore l'anno seguente del Grammy Award nella categoria della musica tradizionale. Come Compay Segundo, anche Eliades suona una chitarra "modificata" composta da otto corde anziché le sei convenzionali; con questo sistema riesce a riprodurre il suono di una normale chitarra classica con l'aggiunta di una sonorità tresera. Sempre accompagnato dal suo cappello da cowboy Eliades Ochoa ha fatto numerosissime tournée, toccando più di quaranta stati dall'America Latina al Canada, all'Europa, agli Stati Uniti, arrivando fino al Giappone; ha registrato moltissimi dischi, con titoli estremamente importanti per la musica cubana come ‘Son de Oriente’, ‘Chanchaneando’ con Compay Segundo, ‘La Venganza de Perico’ con il sassofonista camerunese Manu Dibango, ‘El guateque de Don Tomas’ con Bob Dylan e la famosissima ‘Pintate los labios Maria’, il cui video, realizzato da Frank Padron, ha ricevuto vari premi Lucas e diversi riconoscimenti internazionali.
È il 7 settembre del 1999 quando nelle sale cinematografiche di mezzo mondo esce il film-documentario col titolo ‘Buena Vista Social Club’ che riscuote un successo strepitoso, e vince numerosi premi tra cui Echo Award al miglior gruppo pop rock internazionale ‘Echo Award’ per la migliore produzione jazz. Wim Wenders filma le session, sfruttando il format Digital Video, recentemente sviluppato, avvalendosi dell'aiuto di Robert Müller, suo collaboratore di lungo corso. Ne approfitta per intervistare alcuni membri dell'ensemble e non perde l'occasione di registrare il gruppo in una famosa performance ad Amsterdam, la prima con l'intero line-up e un secondo concerto alla Carnegie Hall di New York. È indubbio che l’opera filmica di Wenders ha giocato un ruolo importante nella rinascita della musica cubana, permettendo agli stessi cubani di riscoprire coloro che erano stati i grandi interpreti nazionali. La pellicola, infatti, si apre con un giro di ricognizione dell’isola da Ry Cooder alla scoperta di quelli che erano stati i luoghi ‘un tempo famosi’, come i locali alla moda, i Club della musica cubana. Quindi, dopo aver individuato quanti ancora vivevano sul territorio, ha intervistato alcuni membri storici del gruppo originario che si esibiva al Buena Vista Social Club, riprendendone le esibizioni alla vecchia maniera.
È così che scopriamo la vita privata di ognuno dei singoli componenti che si racconta e ci racconta la propria esperienza musicale, i successi, la decadenza e la scomparsa di quei Club ch’erano stati il fulcro internazionale della musica cubana, e da cui tutto è ricominciato, con un eccezionale incasso di oltre 23 milioni di dollari, consacrando in tutto il mondo la musica cubana. Ma se “..la bella musica fa sognare, spesso sono proprio i sogni che ispirano la musica”, è quanto accaduto a Cuba, cheil ‘sogno’ di pochi si è fatto realtà, incarnandosi in un gruppo musicale diventato una punta di diamante della musica afrocubana.
Info:
La Habana prepara el primer Festival de Salsa en Cuba, que abrirá con un conciertazo de la emblemática orquesta Van Van el 25 de febrero en el Parque Metropolitano de la capital, anunciaron medios oficiales.
De acuerdo con el sitio de la emisora Radio Habana Cuba, Isaac Delgado también estará presente en la inauguración del evento, diseñado para dinamizar la escena de la música popular cubana y sus bailes.
El principal promotor del Festival, Maykel Blanco, pianista y líder de la orquesta Salsa Mayor, dijo a la prensa que la actividad “será escenario para presentar ante un amplio público agrupaciones de primera línea, noveles y consagradas”.
Para el día 26, está programado la presentación de El niño y la verdad y Pupy y los que Son Son, mientras que el día siguiente actuarán Havana DePrimera, Klimax, El Noro y Primera Clase, y para cerrar el domingo, Maykel Blanco y Salsa Mayor, Elito Revé y Bamboleo.
De acuerdo con el medio, el programa también incluye clases de baile, espectáculos de Dj cubanos y extranjeros, desfiles de comparsas, venta de discos, presentaciones de agrupaciones de pequeño formato y variadas ofertas gastronómicas.
Discografia:
“Alo Cubano” – Orishas - Chrisalis
“The Buena Vista Social Club” - World Circuit
“Omara Portuondo” – World Circuit
“Ibrahim Ferrer” – World Circuit
“Introducing .. Ruben Gonzales “ – World Circuit
“Chanchullo” – Ruben Gonzales – World Circuit
Ry Cooder “The slide area” – Warner Bros
Ry Cooder “Bop till you drop” – Warner Bros
Ry Cooder “Crossroads” – Original Motion Picture Soundtrack – Warner Bros
Ry Cooder – Joseph Byrd “Jazz” – Warner Bros
Contatti in Italia:
Cubaclub - Saber s.r.l. - Via Newton, 11
67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863 . 49 72 47 - Fax 0863 . 49 72 47
*
 - Musica
- Musica
A lo cubano ..somos todos americanos - parte seconda
'A lo cubano ... somos todos americanos!' / 2
Etnomusica XII (seconda parte): Viaggio nella Musica Cubana di ieri, di oggi, di sempre.
Da ‘Versos Sencillos’ di José Martí:
XXXIX - ‘Cultivo una rosa blanca..‘
Cultivo una rosa blanca,
En julio como en enero,
Para el amigo sincero,
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca,
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.
XXV – ‘Yo pienso, cuando me alegro..’
Yo pienso, cuando me alegro
Como un escolar sencillo,
En el canario amarillo,–
¡Que tiene el ojo tan negro!
Yo quiero, cuando me muera,
Sin patria, pero sin amo,
Tener en mi losa un ramo
De flores,–y una bandera!
XXXIX – ‘Coltivo una rosa bianca’
Coltivo una rosa bianca
A luglio come a gennaio
Per l’amico sincero
Che mi tende la sua mano franca.
E per il crudele che mi strappa
Il cuore che mi dà la vita
Non coltivo spina né bruco,
Coltivo la rosa bianca.
XXV – ‘Io penso, quando divento allegro’
Io penso, quando divento allegro
Come un semplice scolaro,
Al canarino giallo, -
Che ha l’occhio così nero!
Io voglio, quando morirò,
Senza patria, però senza padrone,
Avere sulla mia lapide un ramo
Di fiori, - e una bandiera!
Liriche queste di José Martì che rivelano una loro intrinseca musicalità, con le quali ho voluto aprire questo secondo capitolo di ‘Viaggio nella Musica Cubana di ieri, di oggi, di sempre’, come introduzione a quella musica che fin dagli inizi del ‘900 si è andata diffondendo da Cuba in tutto il mondo. È noto, ad esempio che in “Motivos de son” (1934) del poeta cubano Nicolas Guillen ci sono otto brani per voce e strumenti basati sull'insieme di poesie con lo stesso titolo, e le sue ultime composizioni furono due pezzi per pianoforte intitolati “Piezas infantiles” che risalgono al 1937. Di Nicolas Guillen, trascrivo una nota canzone lirica cosiddetta ‘romantica’, ripica di tutta la musica e la canzone cubana:
'Riversa,cuore,la tua pena'
Riversa,cuore,la tua pena
dove non si possa vederla,
per superbia, e per non essere
motivo di pena altrui.
Io ti amo, verso amico,
perché quando sento il petto
ormai troppo oppresso e disfatto,
divido il peso con te.
Tu mi sopporti, tu reggi
nel tuo grembo amoroso
tutto il mio amore doloroso,
tutte le mie ansie e pene.
Tu, affinchè io possa nella calma
amare e agire bene, acconsenti
a intorbidire le tue correnti
con quanto mi opprime l'alma.
Tu, affinché io passi fiero
per la terra, e senz'odio, e puro,
ti trascini, pallido e duro,
mio amoroso compagno.
La mia vita così si incammina
al cielo limpida e serena,
e tu porti la mia pena
con la tua pazienza divina.
Si pensi che il jazz cubano, ovvero il ‘cuban-jazz’ cominciò molto prima, a L'Avana tra il 1910 e il 1930. Arsenio Rodríguez, uno dei maggiori suonatori di ‘tres’ e leader di un conjunto, enfatizzò le radici africane del ‘son’ adattando lo stile guaguanco e aggiungendo la campana e la conga nella sezione ritmica. Inoltre "promosse" il ‘tres’ a strumento da assolo. Alla fine degli anni '30 e nei '40, il gruppo Arcaño y sus Maravillas aggiunse un ‘montuno’ (ballo) nel ‘son’, trasformando la musica suonata dalle charangas. Negli anni '40, Chano Pozo fece parte della ‘bebop revolution’ del jazz, suonando la conga con Dizzie Gillespie e Machito in New York City, quando ancora negli anni '40 giunsero a Cuba le cosiddette ‘big band’ e subito divennero un format dominante che sopravvive ancora oggi. I due maggiori arrangiatori e direttori furono Armando Romeu e Damaso Perez Prado.
Armando Romeu diresse l'orchestra Tropicana Cabaret per 25 anni, cominciando nel 1941. Aveva avuto esperienze in America suonando con gruppi jazz e aveva completa padronanza delle forme musicali cubane. Nelle sue mani il Tropicana non solo musica afrocubana, ma anche altri generi di musica popolare come pure il cuban jazz e le composizioni delle big band americane. Successivamente diresse la Orquesta Cubana de Musica Moderna. Perez Prado compositore e arrangiatore, o meglio, autore e arrangiatore di molte hits, è forse il più conosciuto fra i due e non solo a Cuba, si pensi che vendette più dischi di qualsiasi altro musicista dell'epoca. Era il pianista e l'arrangiatore dell'orchestra Casino de la Playa nel 1944 e fu lui a introdurre nuovi elementi musicali che distinsero il suo fantastico sound. La sua orchestra si rifece fin da subito allo stile afrocubano e nel 1946 cominciò a mettere insieme gli elementi della sua big-band, con la quale lanciò il ‘mambo’ la cui ritmica ebbe molta influenza su molti altri arrangiatori cubani. ‘Mambo n.5’, ‘Mambo n.8’, ‘Moliendo Café’, ‘El Cubancero’, ‘Patricia’, ‘Cereza Rosa’, ‘Tequila’, ‘El Manicero’ (più conosciuta come ‘rumba delle noccioline’), sono solo alcuni titoli che hanno fatto il giro del mondo, poi ripresi da tutte le orchestre non solo cubane”.
Tra queste, va qui citato lo spagnolo americanizzato, direttore d’orchestra Xavier Cugat (l’uomo col cagnolino) che lanciò nel mondo la stupenda Abbe Lane, nonché l’eccezionale percussionista di ‘timbal’ latino-americanizzato Tito Puente. Come neppure va dimenticato Nat King Cole il cantante-pianista di colore che portò alla musica latino-americana quel sapore di 'romanticismo' dolcificato dalla sua voluttuosa voce, che di certo non gli mancava. Molto se ne è avvalso il cinema di Hollywood per lo sfondo erotico ed esotico che Cuba all’epoca rappresentava, trasformando l’isola in un ‘luogo del destino’, set ideali per fim di fatalità e d’avventura. “Tutti sono d’accordo nel trovare una sostanziale differenza fra l’immagine di Cuba che appare nei film prodotti in altri paesi e quella che l’isola ha fornito di se stessa attraverso il cinema. Come appunto scrive Roberto Nepoti (1) - All’inizio, infatti Cuba era annessa, benché vicina alle coste statunitensi, come tanti ‘altrove’ dell’epoca (anni ’30 - ’50), all’immaginario esotico hollywoodiano dell’amore e dell’avventura, come nei primi esempi qui forniti: ‘La rumba dell’amore’ (1931) di W.S. Van Dyke; e ‘La signora di Shanghay (1946) di Orson Welles con la strepitosa Rita Hayworth.
Anche nel cinema più classico, Cuba è una latitudine dell’ ‘altrove’ geografico, un luogo diverso dall’ordinario dove si può trovare la felicità o (più facilmente) rischiare la vita; (..) allorché l’isola comincia a trasformarsi, sullo schermo, da puro spazio esotico in luogo minaccioso e ostile, dove ambientare avventure di spionaggio e complicati intrighi internazionali. Lo fa in chiave satirica l’ottimo ‘Il nostro agente all’Havana’ (1959) di Carol Reed, che Graham Greene sceneggiò dal proprio romanzo e interpretato da quegli stupendi attori che sono stati Alec Guinness e James Wormold. Non mancarono qualche serio tentativo di documentazione, che arrivò con ‘Cuba sì’ (1961) di Kris Marker, improntato sulla figura di Castro e che sarà molto imitato. Tuttavia – scrive ancora Roberto Nepoti (2) – “Per constatare gli enormi limiti dell’approccio alla realtà cubana, basti pensare a due film di fiction che mettono in scena i protagonistidella rivoluzione: ‘Che!’ (1969) di Richard Fleisher, una imbarazzante versione a fumetti degli eventi, priva del minimo senso politico o storico. E l’Italiano ‘El “Che” Guevara’ (1968) di Paolo Heusc, variante povera delle imprese del Che girato in Sardegna con Francisco Rabal nel ruolo del titolo e una ‘Canzone del guerrigliero’ cantata da Nico Fidenco.
Tutti i film, più o meno, a sua volta portavano in scena momenti o comunque situazioni musicali e scene di ballo. Molti erano i cantanti utilizzati, per così dire, per ‘condire’ la scena, e in gran numero vi fecero la loro apparizione che li rese famosi. I loro nomi sono oggi per lo più dimenticati, tuttavia alcuni di essi vanno citati. Benny Moré, considerato da molti il miglior cantante cubano di tutti i tempi, ebbe il suo apice negli anni '50, possedeva un'innata musicalità e una voce da tenore molto fluida che egli ‘colorava’ con la sua grande espressività. Sebbene non fosse in grado di leggere gli spartiti musicali. Moré fu un master in ogni genere, compreso son montuno, mambo, guaracha, guajira, cha-cha-cha, afro, canción, guaguancó, e bolero. La sua orchestra, la Banda Giganta e la sua musica, segnarono lo sviluppo flessibile e fluido dell'orchestra di Prado, con il quale aveva lavorato tra il 1949 e il 1950.
Negli anni successivi la musica cubana, nota per la sua tendenza a mescolare generi diversi, si avvalse della fama internazionale per ‘invadere’ dapprima il Centroamerica e quindi il cuore dell’Europa dove i suoi ritmi e le sue danze fecero letteralmente impazzire le ‘masse’ dedite allo stravolgimento della musica. Per esempio, fra gli anni ’60 e '70 alcuni gruppi come Los Irakere usarono i tamburi batà nelle big band, creando il son-batá o batá-rock. Più tardi altri artisti crearono il mozambique, che univa ‘conga’ e ‘mambo’, o la ‘batá-rumba’ che univa la ‘rumba’ con i tamburi batà includendo nei nuovi generi elementi di hip hop, jazz e rock-and-roll. Ma già nel 1968 a Cuba, il movimento dei Nueva Trova, che comprendeva Pablo Milanés e che rifletteva gli ideali della nuova sinistra con i militari che chiusero tutti i night-club (riaperti solo trenta anni dopo la rivoluzione), la musica cubana si suonavanegli esclusivi locali detti Casas de la Trova. I musicisti, se possedevano un lavoro stabile, erano pagati dallo Stato solo dopo aver conseguito un diploma. Furono molti gli artisti che subirono l'esilio, ricordiamo: Celia Cruz e l'intero conjunto con cui suonava: i Sonora Matancera, 'Patato' (Carlos Valdes), Cachao, La Lupe, Arturo Sandoval, Willy Chirino, La Palabra, Paquito D'Rivera e Gloria Estefan.
Molti di loro, specialmente Celia Cruz, divennero associati ai gruppi anti-rivoluzionari ed essendo considerati ‘non persone’ dal potere dominante, i loro nomi furono omessi nei libri ‘ufficiali’ cubani e i loro dischi non furono mai stati venduti a Cuba. Quando cadde l'Unione Sovietica nel 1991, Cuba perse i suoi supporti e le cose cominciarono a cambiare. Il turismo tornò a essere benvisto e la musica popolare tornò ad essere un'attrazione. Ai musicisti più affermati venne anche permesso fare tournée all'estero, il che permetteva loro di uscire dal circuito controllato dallo Stato ed essere conosciuti fuori dai ristretti confini che la musica locale imponeva loro. Della celebre artista Celia Cruz, è qui riportato il brano più significativo che la fece conoscere in tutto il mondo:
‘Cuando Sali de Cuba’
(Picca Luis Maria Aguilera)
Nunca podré morirme,
mi corazón no lo tengo aquí.
Alguién me está esperando,
me está aguardando que vuelva aquí.
Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.
Late y sigue latiendo
porque la tierra vida le da,
pero llegará un día
en que mi mano te alcanzará.
Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.
Una triste tormenta
te está azotando sin descansar
pero el sol de tus hijos
pronto la calma te hará alcanzar.
Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.
Il brano in ‘salsa cubana’ di Celia Cruz che segue, è invece un inno alla vita e sicuramente contro la guerra, esplicitamente aborrita nelle battute finali dove il coro fa da contrappunto, burlescamente alle esclamazioni dell'artista, la più schietta e scoppiettante voce della canzone cubana:
‘La Vita è un Carnevale’
..ad ognuno che pensa
che la vita è disuguale
deve sapere che non è così
che la vita è un' incanto
che c'è da viverla
..ad ognuno che pensa
che sta solo e che sta male
deve sapere che non è così
che nella vita mai nessuno è solo
e sempre puoi trovar qualcuno
ahi, non c'è da piangere
la vita è un carnevale
ed è più bello vivere cantando
oh oh oh ahi, non c'è da piangere
la vita è un carnevale
e le pene se ne van cantando..ad ognuno che pensa
che la vita sia sempre crudele
deve sapere che non è così
che ci sono solamente dei brutti momenti
e che tutto passa
..ad ognuno che pensa
che tutto questo non cambierà mai
deve sapere che non è così
se fai buon viso a cattivo gioco
tutto cambia
per quelli che si lamentano
per quelli che criticano solo
per quelli che usano le armi
per quelli che ci contaminano
per quelli che fanno la guerra
per quelli che vivono peccando
per quelli che ci maltrattano
per quelli che ci contagiano.
Ma torniamo al cinema, per lo più americano, che spesso ha fatto di Cuba il ‘set’ per eccellenza di film ad alto potenziale avventuroso, dove si esercita lo spionaggio più o meno internazionale, detective-story appassionanti, guerriglia ecc. . Dopo il già citato ‘Il nostro agente all’Avana’ (1959), Cuba entra nel sequel de ‘Il Padrino parte II’ (1974) di Francis Ford Coppola, vincitore di sette Oscar; ‘La nave dei dannati’ (1976) di Stuart Rosemberg interpretato dai ‘divi’ del momento: Max Von Sydow, James Mason, Orson Welles e la pur splendida Faye Dunaway, oltre ad altri, tutti di primo piano. Anche Sean Connery, smessi i panni di Agente 007, passa da ‘Cuba’ (1979) di Richard lester; quindi è la volta di Al Pacino nel remake ‘Scarface’ (1983) di Brian De Palma con una straordinaria Michelle Pfeiffer al suo primo ciack internazionale. Quindi è la volta di Robert Redford con ‘Havana’ (1990) di Sydnei Pollack e, ‘The Lost City’ (2005) di e con Andy Garcia, ambientato a Cuba durante la rivoluzione degli anni cinquanta e girato interamente a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.
Cuba degli anni ’50 fa lo sfondo ideale anche a un altro film americano, ‘I Mambo Kings’ (1992) di Arne Glimcher, la storia di due testardi musicisti di mambo interpretati da Armand Assante e Antonio Banderas, un film pieno di musica e canzoni sfavillanti, in cui si ascolta anche tanta buona musica cubana con Tito Puente e la sua Latin Salsa Band. Non c’è che dire, tutto serve o è servito alla musica cubana per uscire da un ‘empasse’ come quello dell’embargo, che ha pesato 50anni non solo sull’economia e lo sviluppo ma anche sulla cultura, non in ultima quella poetico-musicale. Film esotici dunque, più o meno emozionanti e movimentati, che tracciano nell’immaginario cinematografico del grande pubblico i contorni di una Cuba molto lontana dalla realtà. Ben diverso il discorso dei film prodotti nell’isola, soprattutto dopo la legge sul cinema promulgata da Castro nel 1959 e la fondazione, nello stesso anno, icon la quale ha gettato le basi di una scuola nazionale di cinema che in tutti questi anni, ha dato alla settima arte registi di valore internazionale.
“Bella Maria de mi Alma” da ‘Mambo Kings’,nel film cantato da Antonio Banderas.
Si deseo sonreir
Pienso solamente en ti
En la magia de tu amor
En tu piel en tu sabor
En la isla del dolor
Recuerdo tu calor
Desearia morir
Cerca de ti
Un ardiente corazon
Colorea mi pasion
Deseando compartir
El sentir de este vivir
En las olas de este mar
Sueno en la eternidad
Con cada luna vendras
Con la merea te iras
En un caracol
Pienso oir tu voz
La bella Maria de mi amor
Aunque estemos separados
En un sueno angelicar
Si llego de nuevo amar
No hay razon, proque cambiar
Temo yo permancer
Sin ti en la eternidad
Lejos nos puedon separar
Jamas pudiera olvidar
Tu risa celestial
Tus besos, tu calor
La bella Maria de mi amor
Si no te vuelva a ver
No dejaras de ser
La bella Maria de mi amor.
Un valido esponente di punta del cinema cubano di quegli anni fu certamente Tomas Guitierrez Alea, scomparso nel ’96 autore di ‘El megano’ (1956) e il documentaristico ‘Memorie del sottosviluppo’ (1967), un film in cui il regista ritraeva la borghesia intellettuale incapace di inserirsi costruttivamente nella nuova società cubana. Ma ci sono almeno altri due registi che si sono imposti al grande pubblico: Humberto Solàs con ‘Lucia’ (1969) e Miguel Littin con ‘La tierra prometida’ (1972) ed altri, che in tempio più recenti hanno ottenuto un successo internazionale inedito per il cinema di Cuba: ‘Pane e cioccolato’ (1993) di Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío; e ‘Guantanamera’ (1995), un film satirico ancora di Gutierrez Alea. In tempi più recenti: ‘Viva Cuba’ (2005) di Juan Carlos Cremata Malberti e Iraida Malberti Cabrera, la storia di amore tra Jorgito e Malu ripresa della rinomata vicenda di ‘Romeo e Giulietta’, ostacolata dalle rispettive famiglie, questa volta divise da dissidi politici e differente status sociale, e ultimo in ordine di apparizione: ‘7 Days in Havana’ (2012) è un film collettivo ambientato durante una settimana nella capitale cubana dell'Avana, al quale hanno collaborato numerosi registi: da Benicio del Toro, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Laurent Cantet, Julio Médem, Pablo Trapero, Juan Carlos Tabío. La musica era composta dainterpreti di rilievo come Descemer Bueno, Kelvis Ochoa, Fabien Pisani, Xavi Turull.
Sebbene a Cuba ci siano stati molti compositori che hanno scritto sia brani classici che brani creoli, la distinzione divenne chiara solo dopo gli anni '60, quando (almeno inizialmente) il regime se la prese con la musica popolare e chiuse molti night-club, mentre supportava finanziariamente la musica classica piuttosto che le forme creole. Da quel momento in poi i musicisti hanno mantenuto la loro carriera scrivendo un solo tipo di musica. Dopo la rivoluzione cubana del 1959, una nuova generazione di musicisti entrò in scena. Tra questi, il più importante fu il chitarrista Leo Brouwer, che portò delle significative innovazioni nella chitarra classica, ed è attualmente il direttore de l'Havana Symphonic Orchestra. La sua direzione nei primi anni '70 del Cuban Institute of Instrumental and Cinematographic Arts (ICAIC) fu lo strumento di formazione e consolidamento del movimento ‘nueva trova’.
Fra i più grandi musicisti di tutti i tempi, il cubano Ernesto Lecuona y Casado, pianista e compositore di rilievo internazionale, anche chiamato lo "Chopin di Cuba" o il "Liszt di Cuba," ma anche Il "Gershwin cubano", è stato e rimane a furor di popolo il più grande in assoluto, colui che più d’ogni altro ha dato lustro internazionale a Cuba negli anni difficili della rivoluzione e dopo, quando s’allontanò dall’isola per gli Stati Uniti in volontario esilio, andando a incontrare quel successo che indubbiamente meritava. Scrisse più di seicento canzoni - di cui la prima a 11 anni, amate nel mondo intero, come Malagueña (1927), Andalucía (La Brisa y Yo) (1929), Siboney (1929) inserita evocativamente anche nel film di Fellini "Amarcord", Maria La O (1930) grande successo di Alberto Rabagliati che nel 1934 fece parte dell'orchestra "Lecuona Cuban Boys Band", fondata dallo stesso Lecuona; e inoltre Karabali (1933), Siempre en mi Corazon (1942) tra le moltissime altre del suo repertorio che includevano ritmi e suoni dell’America Latina. Vanno qui ricordati inoltre due ‘brani’ che pure spiccano nel suo programma orchestrale, le famose Tabu e Babalu, entrambe del 1941, ma che furono composte da una sua lontana cugina, Margarita Lecuona (1910-1981) cantante e compositrice di più di trecento canzoni, riprese anche dalla tradizione del jazz da sempre presente sull’isola.
‘Malagueña’ (di Ernesto Lecuona).
El amor me lleva hacia ti
con impulso arrebatador
yo prefiero mejor morir
que vivir sin tener tu amor.
La inconstancia de tu querer
la alegria mató en mi ser,
Eh, eh Ah, ah,
y al temor de perder tu amor
hoy mi canto será dolor.
Malaguena de ojos negros
Malaguena de mis suenos.
Me estoy muriendo de pena
Por tu sole tu querer.
Malaguena rebonita te quiero besar.
Malaguena de ojos negros
Malaguena de mis suenos.
Me estoy muriendo de pena
Por tu sole tu querer.
Malaguena rebonita te queiro besar.
Non è insolito nella storia della musica cubana incontrare musicisti Jazz e non necessariamente cubani o meticci come vorrebbe la tradizione, anzi, direi come vero il contrario; il jazz in effetti da sempre riconosce a Cuba un primato di eccezionalità pianistica entrata nella tradizione proprio grazie alle scuole di musica entrate nella cultura corrente. Molti sono i nomi nella musica cubana che hanno fatto di questo strumento l’eccellenza di accompagnamento sia in brani strumentali melodici, sia nel canto, in ragione dell’uso ritmico del pianoforte. Tra essi Jesùs Dionisio Valdés, meglio conosciuto come Chucho Valdés, pianista, compositore e arrangiatore cubano fra i più famosi musicisti cubani di Jazz. Alcuni suoi brani sono entrati a far parte di quegli ‘standard’ cui nessun pianista cubano, e non solo, rinuncia a inserire nelle proprie performance: El Ultimo Trago, La Dulzura, Sombras, Làgrimas negras, Juntos para siempre, Zawinul’s Mambo, Afro Comanche, Border Free e numerosissime altre con le quali ha partecipato al Montreux Jazz Festival e al Newport Jazz Festival dove si impose con il suo ‘Cuban Jazz’.
Da non sottovalutare il caso qui di seguito analizzato riferito a Chuco Valdés e che anzi avvalora quanto affermato dalla tradizione. Chuco Valdés è figlio d’arte proviene da una famiglia di pianisti: in particolare il padre, Ramón Bebo, ha vinto un Grammy Award nel 2003 insieme a Israele "Cachao" López e Patato Valdés, ed un altro, nel 2005, insieme al cantante di flamenco Diego El Cigala. Fin dall'età di tre anni e sino ai sei Chucho suona il pianoforte viene costantemente seguito dai genitori; dopo, fino a nove anni, prende lezioni dal maestro Oscar M. Bouffartique e nel 1950, grazie al superamento dell'esame di ammissione, accede al Conservatorio di L'Avana. Da adolescente suona in alcune band della città dirette dal padre e a sedici anni entra a far parte dell'Orquesta de Musica Moderna sotto la direzione di Armondo Romeu. In quel periodo Valdés risente delle influenze musicali dell'amato cantante afro-cubano Benny Moré e del grande pianista e compositore cubano Ernesto Lecuona. Nel tempo ha fondato l’Orquestra Cubana de Musica Moderna (1967) e il gruppo Irakere (1973) nome ripreso dal termine Yoruba che significa ‘foresta’, accreditato come la più importante orchestra jazz cubana.
Dopo aver firmato un contratto con la Blue Note Records, Chucho Valdés ha concentrato le sue energie lavorando in diversi progetti con trii, quartetti oppure da solista. Ha lavorato, inoltre, con Roy Hargrove, ha vinto cinque Grammy Awards: uno nel 1978 per l'album Live at Newport by Irakere, il secondo nel 1998 per il suo contributo al CD Havana della band Crisol (formata nel 1997), il terzo ed il quarto con due canzoni, rispettivamente "Mr. Bruce" e "Mambo para Roy" ed il quinto, nel 2003, per il suo album "Live at the Village Vanguard". Considerato da molti critici il più importante musicista della Cuba post-rivoluzionaria, Valdés, continua a rimanere in prima linea tra gli artisti che sperimentano nuove sonorità attraverso la fusione di elementi afro, afro-cubani e afro-latini col jazz afro-americano. Tra le sue influenze musicisti egli cita artisti jazz americani come Art Tatum, Duke Ellington, Erroll Garner, Bud Powell, Dizzy Gillespie, Hank Jones, Bill Evans, e McCoy Tyner. Tuttora continua ad esplorare nuovi territori musicali, spesso accompagnato nelle sue performance dalla sorella cantante Mayra Caridad Valdés.
Dall’era delle ‘big band’ fino agli anni ’60 e ’70 un’altra rivoluzione, sicuramente più dolce, ha scosso la musica cubana, sulla scia dei movimenti giovanili che dall’Europa raggiunsero le coste americane. In breve si passò dall’andatura mobile e flessuosa dei ritmi latino-americani del ‘bolero’, della ‘rumba’, del ‘merengue’ e della ‘criolla’, dal genuino ‘mambo’, al Cha-cha-cha, al ‘cuban jazz’, agli scatenamenti del Rock & Roll e dell’Hard Rock. Tuttavia Il ‘son’ rimase la forma base di tutta la musica cubana. Quello stesso ‘son’ che negli anni ’80 pure era suonato da molti gruppi come Septeto Nacional, Orquesta Aragón, Orquesta Ritmo Oriental e Orquesta Original de Manzanillo e Sierra Maestra,divenuta famora per aver riportato in vetta il ‘son’ negli anni '80/’90. Anche il movimento dei Nueva Trova ha influenzato questa tendenza, ma i temi politici che avevano accompagnato gli anni '60 erano ancora proibiti. Nel frattempo, Irakere fuse la musica tradizionale con il jazz, mentre gruppi come gli NG La Banda, gli Orishas e i Son 14 continuarono ad aggiungere elementi nuovi al ‘son’, specialmente prendendo spunto dall'hip-hop e dal funk.
Negli anni '90, l'interesse mondiale crebbe in coincidenza con la permissione dell’URSS di aprire all'economia dell'isola che così facendo si aprì al turismo, per quanto l’embargo imposto dagli USA l’hanno tenuta lontana dallo sviluppo culturale mondiale. In musica l’'Orquesta Aragón, La Charanga Habanera e Cándido Fabré y su Banda furono presenti sulle scene mondiali per molto tempo, contribuendo alla popolarità della ‘timba’ nel processo di avanzamento culturale accompagnato dalla comparsa di strumenti musicali elettronici. Ci sono ancora molti musicisti che suonano il ‘son montuno’ diretto antenato dell’odierno ‘salsa’, come Eliades Ochoa, che ha continuato la sua tournée mondiale dopo il successo dei Buena Vista Social Club. Ed eccoci al punto d’arrivo, che è poi un punto di partenza, dal quale si è ripartiti nello scoprire l’attuale musica cubana il ‘salsa’ datata agli anni ‘2000 e successivamente dilagata in tutta l’America Latina e in Europa.
Con il termine ‘salsa’ vengono denominati vari ritmi, in gran parte caraibici, popolari in molte nazioni latinoamericane, quali ‘conga’, ‘bachata’, guajira, ‘reggaeton’, ‘kuduro’, ‘urban latin’, ‘merengue’, ‘mambo’, ‘timba cubana’, rispettivamente anche forme diverse danzate su questo tipo di musica., anche se non è chiaro chi e perché abbia dato questo nome a tale genere musicale, ma esso risulta in ogni caso appropriato, in quanto si riferisce, per l'appunto, alla ‘mescolanza’ di ritmi e sonorità musicali.
Comunque, il termine è stato usato dagli immigrati cubani a New York in analogia con lo ‘swing’ che a sua volta aveva inglobato molta musica latinoamericana, trasformato nello stile particolare sviluppato dai gruppi di immigrati cubani e portoricani dell'area di New York City alla metà degli anni settanta, con derivazioni stilistiche come la salsa romantica degli anni ottanta. Anni in cui a Celia Cruz ancora in scena, venne attribuita la migliore definizione del fenomeno ‘salsa’: “Salsa sono tutti i ritmi del Caribe raccolti sotto un solo nome”. Le radici del 'salsa' si possono ritrovare negli antenati africani che furono portati nei Caraibi come schiavi dagli spagnoli. In Africa, è molto comune vedere persone che fanno musica suonando strumenti come la ‘conga’ e la ‘pandereta’, strumenti comunemente usati nel ‘salsa’, creando una musica simile alla salsa, che ci permettono qui di dire, infine, che il più diretto antenato del ‘salsa’ rimane quel ‘son montuno’ originario di Cuba, in quanto combinazione di influenze europee e africane. La ‘plena’ portoricana, il ‘calypso’ di Trinidad, il ‘reggae’ giamaicano, il ‘rock’ americano, il ‘merengue’ dominicano e la ‘cumbia’ colombiana sono altre fonti di ispirazione durante il melting pot newyorchese degli anni 1970.
In coclusione il background prevalentemente spagnolo di Porto Rico unito alle popolazioni africane, andaluse e indigene di Cuba formano le basi della salsa. Per quanto la crescita della moderna ‘salsa’, comunque, si dice sia iniziata nelle strade di New York alla fine degli anni 1960. A quel tempo, il pop latino non era più una delle forze trainanti della musica americana, avendo perso terreno rispetto a doo-wop, R&B e rock and roll. L'influenza degli immigrati latini, in particolare cubani (come Arsenio Rodriguez, José Curbelo e Machito) e portoricani, a New York, e la volontà di queste persone di sentirsi più vicine ai loro paesi, portò alla crescita del ‘salsa’. Nata quindi sul finire degli anni '80 la ‘salsa cubana’ si era formata sul ritmo ‘son-go’ molto veloce, verosimilmente inventata da gruppi come Los Van Van e NG La Banda. All'inizio degli anni ’90 però, questo tipo di ‘salsa’ originaria di Cuba divenne nota come ‘timba’ ed ebbe successo in tutto il mondoLa salsa ha fatto segnare una crescita costante e ora domina le radio di molti paesi dell'America Latina. Inoltre, molti artisti latini, come Marc Anthony, e l'ancor più famosa Gloria Estefan, hanno avuto successo come crossover, entrando nel mercato pop angloamericano con hit dal gusto latino, solitamente cantati in inglese.
Le più recenti innovazioni nel genere includono ibridi come il merengue elettronico e il salsaton (incrocio tra reggeton e salsa), insieme alla salsa gorda. Particolare è lo stile del gruppo portoricano Puya, che fonde il thrash metal e il rap con la salsa. Uno degli elementi chiave di questo ballo è la pausa (chiamata anche battuta, sospensione o stop) sul quarto tempo del ritmo: durante l'esecuzione dei passi, per ogni tre ‘step’ ballati ce n'è uno non ballato. Tale caratteristica subisce varianti ed evoluzioni a seconda della scuola e del gusto dei ballerini. Pur esistendo sequenze di movimenti predefinite, chiamate figure o coreografie, la concatenazione di queste l'una all'altra è basata sull'improvvisazione; sta quindi alla fantasia dei ballerini costruire i vari passi di danza durante tutto l'arco del brano eseguiti in assolo, chiamati ‘pasitos’, o ‘shines’, presenti soprattutto nella ‘salsa portoricana’ (vedi Ricky Martin ‘Maria’ e ‘La bomba’; Gloria Estefan in ‘Mi tierra’; La Banda Gorda ‘Candela pura’; Los Locos ‘Porompompero’, ed altri). Meno frequente però nello stile cubano, nel quale l'unico momento di assolo è lasciato alla ‘rumba cubana’. Negli ultimi anni i ‘pasitos’ sono diventati una vera caratteristica della salsa portoricana che rispetto alle altre danze si è sempre distinta grazie al suo stile ‘elegante’ e di ‘classe’ che, quindi, possiamo definirli parte fondamentale del ballo in quanto consentono alla coppia un’interpretazione in totale libertà di movimento del corpo.
Tutto questo fermento musicale ovviamente ha un nome contenuto nella parola stessa ‘salsa’ che sta anche a signigicare ‘ritmo dei tropici’ per cui Cuba è considerata ‘La Regina dei Caraibi’. E senza lasciarsi influenzare dai titoli altisonanti si può ben dire che Cuba è davvero la ‘regina’ e l’Havana la ‘Perla delle Indie’. Appellativi che trovano riscontro nelle bellezze esotiche della gente dei tropici: una natura verdeggiante da mozzafiato, mare di cristallo, spiagge da mito, sole, belle ragazze, canna da zucchero, rum, sigari, avventura, mistero ed estasi della ‘santeria’, e un ottimismo inesauribile che, nell’insieme, sono l’essenza stessa della ‘cubanità’. Perché le genti dei tropici, e i cubani in modo particolare, sono convinte che al mondo non esista un luogo più bello della loro isola. Anche per questo, nonostante le problematicità e le incongruenze, almeno i cubani non perdono mai la voglia di sorridere e divertirsi, perché sono rimasti giovani e pieni di vitalità. Le donne sono celebri nel mondo per il fascino irresistibile delle bellezze creole, per la loro indole estroversa e il carattere ‘caldo’ dei colori fantasiosi con cui rivestono i propri corpi esuberanti come il ‘salsa’ che li fa ondeggiare.
‘Canto Siboney’ del 1929, più conosciuta come ‘Siboney’ di Ernesto Lecuona è una canzone stupenda indimenticabile che ritroviamo in ogni epoca fino ai tempi odierni, sia arrangiata da grandi orchestre che cantata da eccezionali interpreti cubani e non come Placido Domingo, tant’è che oggi è ancora suonata in forma strumentale oppure cantata in versione ‘salsa cubana’:
‘Siboney’
Siboney yo te quiero
yo me muero por tu amor.
Siboney, en tu boca
la miel puso su dulzor.
Ven aquí que te quiero
y que todo tesoro eres tú para mí.
Siboney al arrullo de tu alma pienso en ti.
Siboney de mi sueño si no oyes
la queja de mi voz,
Siboney si no vienes me moriré de amor.
Siboney de mi sueño te espero
con ansia en mi caney,
Siboney si no vienes me moriré de amor.
Oye el eco de mi canto de cristal
no se pierde por el rudo manigual.
Tuttavia prediligo l’andamento ‘bolero’ o di ‘rumba’ come veniva eseguita negli anni migliori. All’occorrenza suggerisco la versione per piano jazz e band di Rubén Gonzàles – World Circuit 1997.
(prosegue nel capitolo 3 con: ‘Buena Vista Social Club’)
*
 - Musica
- Musica
’A lo cubano, somos todos americanos’
"A lo cubano ... somos todos americanos!"
ETNOMUSICA XII: 'Viaggio attraverso la Musica Cubana di ieri, di oggi, di sempre'.
Durante i secoli nei quali si sviluppò l’infamante tratta negriera, giunsero a Cuba intere moltitudini di uomini e donne sdradicati dalle regioni più interne e dell’estremo sud del continente africano. Questi portarono con sé forme di cultura corrispondenti a diversi stadi di evoluzione che incontrandosi con quelle spagnole, maggiormente sviluppate, produssero un certo ‘contrasto’ culturale sull’isola. Le popolazioni indigene ancora presenti sul territorio all’arrivo della colonizzazione spagnola che si trovavano in stadi assai primitivi, poco apportarono al processo di interazione culturale, specialmente in fatto di musica. Tale confronto ebbe come risultato la transculturazione degli elementi fondanti l’odierna Cuba, nella quale gli apporti delle diverse culture africane diedero luogo a una complessa mescolanza di stili musicali nuovi, sia di forme di canto che di danza entrate in seguito nella tradizione.
Oggi il processo di transculturazione musicale formato da riti, canti e danze popolari e la costante evoluzione strumentale, rappresenta lo stile di vita del popolo cubano, strettamente legato alla musica che lo accompagna pressoché in tutti i momenti della vita, un patrimonio artistico noto e apprezzato a livello mondiale. Poiché molte generazioni sono trascorse, è poco probabile, se non addirittura impossibile oggi isolare elementi puri dell’una o dell’altra etnia africana, ma solo alcune rare espressioni di questa o di quella, perché provenienti dallo stesso continente e da luoghi diversi e talvolta lontani, innestatesi sul territorio. Elementi che sul piano antropologico hanno origini culturali miste, europee e africane, che a loro volta hanno sviluppato un'ampia gamma di stili musicali cosiddetti ‘creoli’ in quanto forma musicale popolare di entrambi i gruppi razziali.
Ciò per dire che la ‘musica cubana' non è rimasta alla sola forma delle tradizioni autoctone originarie, come invece è avvenuto per il tabacco e per il ‘taino’ una droga rituale già conosciuta in Africa, e solo alcuni nomi oggi possono dirsi di origine 'indios' come Guanabacoa e la stessa Cuba, contrazione verbale di Cubanacan, che significa dimora-abitazione. Per quanto Cuba, essendo un’isola e quindi circondata dal mare, abitata originariamente quasi esclusivamente da indios, avrebbe potuto conservare una sua cultura autoctona, tuttavia non è stato così per ragioni difficili da scandagliare, che non starò qui a indagare per lasciare spazio alla sua musica estrememente variegata altresì definita ‘caraibica’ o musica ‘afro-cubana’.
Di fatto oggi non molti conoscono la matrice della musica cubana in quanto equivalente di ‘ritmo’, celebrativa delle percussioni ‘batà’ africane, se non in ambiti sofisticati per invenzione e creatività, quali il Jazz, il Teatro-live e alcune espressioni della Danza Contemporanea. Ma già le generazioni precedenti a quella attuale, non conoscevano le lingue africane di provenienza, in ragione d’una forzata migrazione che non aveva permesso loro di portare quelli che erano i manufatti rituali come, ad esempio, le maschere, gli strumenti musicali o certi amuleti arcani ecc. Tuttavia, non aveva impedito loro di portare seco la conoscenza orale di quella cultura millenaria che avrebbe poi impiantato le proprie radici nella terra di più recente scoperta.
A iniziare da quella 'lingua originaria’ usata nella comunicazione orale, legata ai culti animisti e usata nei canti, nelle preghiere e nella favolistica mitica comunicativa dei ‘culti’ aborigeni, cosiddetti ‘bozales’, come venivano chiamati anche i neri appena strappati ai rispettivi paesi d’appartenenza; dei quali oggi rimangono solo i nomi di alcune divinità, protettive o anche spaventose di provenienza tribale. Quindi, quella che venne a crearsi fu una cultura a se stante di ‘imitazione’ africana, ricreata all’occorrenza secondo le necessità del momento e che oggi sopravvive in molte espressioni artistiche e musicali sulle quali, nel tempo, si sono formate schiere di giovani cubani.
Restando in ambito rituale di riferimento, senza dubbio la più resistente a modificazioni dettate dalla complessa mescolanza di culture di provenienza africana, più che di quella spagnola, nella musica cubana di oggi si denota l'affermazione della pratica del ‘lucumì cruzado’ (spiriti o divinità che portano i simboli della croce), con riti e canti specifici, differenziati da quelli di altri gruppi, i quali per l'effetto di una maggiore ortodossia, si chiamano più semplicemente ‘lucumì' o 'santeros’ (la comunione dei santi uniti), termini che designano le pratiche yoruba-cattoliche apparse a Cuba sul finire del XVII secolo. Tuttavia la cultura spagnola è presente sull’isola, accomunata ai proprietari terrieri bianchi ‘guahiros’, seppure, va detto, che questa ha davvero poco a che fare con la musica iberica e ancor meno con quella caraibica.
Al contrario la musica popolare degli schiavi neri, continua a occupare un proprio spazio nel presente e nell’attualità internazionale. Benché noi non riusciamo a trovare in essa forme distintive, questa trova affermazione alla propria esistenza nei culti più importanti presenti oggi sul territorio: ‘lucumì’, ‘ararà’, ‘abakwaà’ e ‘kimbìsa’. Nel gruppo dei ‘lucumì’ affluiscono quelle che sono e credenze reliogiose degli Yoruba (Nigeria, Togo) con le loro divinità-spirito tra cui ‘Orisha’ indubbiamente la più popolare fra le comunità presenti sul territorio; ‘Chango’, divinità del tempesta e del fulmine, e per questa ragione molto temuto; ‘Yemanià’ o ‘Yalòde, divinità femminile del mare e più specificamente dell’acqua, seguite da molte altre la cui fama, lambisce le sponde del Centro-America fino a Bahia in Brasile.
La musica ‘lucumì’ è particolarmente sentita in quanto devozionale legata alla supplica e più spesso alla preghiera rivolta a quel ‘soprannaturale’ che occupa un suo preciso spazio nel quotidiano cubano. Gli strumenti utilizzati sono per lo più del tipo percussioni: ‘tamburi’ per lo più suonati con le mani nude; grandi ‘calabash’ e sonagli d’ogni genere singoli e appaiati spesso legati a una cintola. Il culto cosiddetto ‘ararà’, conosciuto ad Haiti col nome di ‘arada’ dove raccoglie un gran numero di immigranti, ha gran ‘seguito’ a Cuba, probabilmente per la presenza del folto numero di adepti usi alle pratiche e alle tradizioni animiste del Dahomey, regione da cui provengono, e le cui divinità, per lo più ‘spiriti’ che impongono la loro presenza nella vita quotidiana, hanno nomi familiari e rispecchiano un’usanza tipica di un possibile ‘culto degli antenati’. Inoltre agli strumenti appena elencati, si aggiungano alcuni ‘calabash’ suonati in batteria e il ‘guayo’ usato nello scraper.
In riferimento al termine ‘carabalì’ si vuole sia di riferimento della regione del Calabar, nome a sua volta derivante da ‘abakwà’ o ‘abakpà’o anche 'carabalì', equivalente di una tribù patriarcale dell’Alto Niger, che trasferita a Cuba è conosciuta come 'setta segreta' che nega l'esistenza di altri culti ma che pure permette ai propri membri di affiancarli, i cui membri ‘nanigos’, cioè ‘outsiders’, sono considerati degli outsider e ritenuti persone non molto rispettabili.
Il culto ‘kimbisa’ o anche ‘mayombé’ proveniente dal Congo era già conosciuto a Cuba come appertenente a diversi gruppi etnici provenienti da quella stessa regione africana. Infatti, esistono numerosi sottogruppi che onorano uno stesso ‘culto’ riferito a deità diverse, quali: ‘ansàsi’ dio della tempesta; ‘saravànda’ deità della montagna; ‘pansua’ il curatore; ‘marelàngo’ dio dell’oceano; ‘tchòrla’ dio del fiume; ‘tiemblaentòto’ signore dei cimiteri; ‘ensàmbia’ guardiano degli incroci stradali; ‘kénge’ signore della guerra. Le varianti al ‘culto’ primario fra i sottogruppi sono davvero minime e costituiscono la parte più cospicua della tradizione culturale di Cuba. In quanto alla lingua usata, vede l’utilizzazione di uno stesso vocabolario riconducibile allo Yoruba, tutt’ora predominante in Congo. Lo stesso dicasi degli strumenti musicali che accompagnano i riti annessi alle ‘santerias’ (culto dei santi), in maggioranza percussioni suonate con le mani, talvolta con supplemento di sonagli metallici. I canti, più spesso sono ‘onomatopeici’ (fotosimbolici, imitativi), oppure ‘informativi-narrativi’ che utilizzano fonemi nelle lingue afrikans, spagnolo, o in un linguaggio ‘ibrido’ (turistico-commerciale) commisto di tutte queste lingue insieme.
Tutta questa attività è tutt’altro che ‘sommersa’ come potrebbe credersi, al contrario è piuttosto facile imbattersi in simili manifestazioni soprattutto se si frequentano gli ambienti periferici delle città o si va in cerca di qualche ‘autenticità’ non specificatamente folkloristica, che è poi quella che i turisti ‘fai da te’ spesso prediligono. Ragione per cui l’attività di ‘culto’ è tenuta sotto controllo dalla polizia locale e non ufficialmente riconosciuta o accettata. Diverse sono state nel tempo le proibizioni a queste usanze con confische di beni dei, di strumenti musicali, di interdizione al culto ed altro, che spesso hanno raccolto la disapprovazione popolare. Ciò non toglie che la musica popolare afrocubana abbia avuto un impatto rilevante su tutta la musica caraibica. L’uso di alcuni strumenti di origine africana si è generalizzato a tal punto che gli stessi strumenti giungono ad essere utilizzati indistintamente da gruppi religiosi e profani di diversa matrice etnica. Come accade, ad esempio, per gli stretti tamburi di origine congolese, detti ‘ngoma’ suonati durante le ‘rumbas’ e le ‘comparsas’, uniti ai suoni del ‘guìro’ o ‘chekeriés’ di antica provenienza yoruba; o il flauto cubano a quattro fori e lo stesso dicasi della ‘zanza’ o ‘mbira’ che un poco modificata nella forma, è passata con il nome ‘marimbula’ dalla musica rituale congolese alla musica popolare da ballo.
Di grande interesse etnologico sono inoltre tutti quei canti raccolti sui luoghi di lavoro, nei campi e nelle fazendas, ed anche fra i coltivatori di canna da zucchero e gli operai che lavoravano alla stesura delle rotaie ferroviarie all’inizio del XX secolo. I testi per lo più sono millanterie delle proprie capacità e attitudini di lavoro; altri a carattere sessuale cosiddetti di ‘puya’, mordaci o satirici, quando non arrivano alla pura pornografia verbale. Maggiori elementi si rintracciano nei ‘lucumì’ processionali, d’invocazione e di preghiera, e nei rituali legati alle ‘santerias’, ancora oggi parte integrante della cultura rituale cubana. La parola ‘santeria’, che si potrebbe tradurre, più o meno, come ‘la riunione dei santi’ è un nome col quale a Cuba si indicano le cerimonie religiose di culto ‘orisha’ degli yorouba.
Il rituale è analogo a quello delle cerimonie ‘voodoo’ che si tengono ad Haiti. Infatti, in queste cerimonie, originarie del Dahomey, gli spiriti Loa, sono invocati al fine di ‘cavalcare’, cioè a entrare nel corpo degli adepti, da cui la successiva possessione dei danzastori. Dette divinità ‘orisha’, solitamente vengono rappresentate in veste di santi cristiani, da cui il nome dato alla cerimonia. Cerimonia sopravveduta dalla dea Oshum equivalente della dea dell’amore, una sorta di Afrodite già presente nel culto yorouba come la ‘vergine nera’ la cui chiesa Virgen de la Caridad sorge alla periferia de L’Avana. Quando la sua statua viene portata in processione, è in realtà a quell’Afrodite africana che sono indirizzati i canti e le preghiere. La sacerdotessa che la invoca in lingua yourouba, è lei stessa l’incarnazione di Yemaya: la dea-madre dispensatrice di fertilità che ritroviamo anche in Brasile nella regione di Bahia.
La danza che segue, e nella quale Oshum discende e si posa sul capo di una giovane in stato di trance, precede la processione della Vergine, portata dentro una urna. I canti vengono ritmati con i tre tamburi ritenuti magici, detti ‘batà’, che possono essere suonati solamente dagli iniziati di alto rango. Il tintinnabulum di pretta derivazione liturgica cattolica li accompagna: in tal modo il sincretismo religioso si traduce anche in sincretismo musicale. Obbligo preciso di ogni ‘santero’ che giunge in una casa, è il saluto ‘moyuba’ da rivolgersi all’altare in onore di ‘changò’, pronunciato in un idioma incomprensibile della lingua yorouba: l’oratore si rivolge a tutti i ‘santi’ presenti sull’altare e a tutti i ‘santeros’ della gerarchia che , accerchiandolo, gli rispondonocon una frase rituale onomatopeica di difficile comprensione.
Particolare è la ‘Preghiera a Changò’ ovviamente cantata nella lingua rituale yorouba. Il termine della preghiera si salda in questo canto con i tamburi usati alluopo, di forma cilindrica e di piccole dimkensioni aperti da un lato chiamati ‘bembè’. Ma un altro canto, detto di ‘Elebwa’, divinità venerata da vari gruppi religiosi, apre e chiude ogni cammino e ogni cerimonia ‘lucumì cruzado’ raccoglie il favore dei partecipanti che esprimono il loro favore partecipando al coro e lo accompagnano con battiti di mani. Ma ecco che un’altra divinità si affaccia sul panorama, si tratta di ‘Obatalà’ il creatore del mondo, signore degli intelletti e della pace che viene a sincretizzarsi con la divinità cattolica di Nuestra Señora de las Mercedes. Il canto elevato per l’occasione rapppresenta un aspetto dell’antico ‘Obatalà’ al cui accompagnamento è riservato l’uso esclusivo dei tamburi ‘batà’ con accompagnamento di battiti di mani.
Quanto in realtà accade durante questo rituale è l’attraversamento di più ‘soglie’ che negano e affermano il concetto stesso di sacro, passando dall’animismo pagano alla sacralità del rito cristiano, dall’evocazione virginea della dèa-madre all’incesto di essa, attraverso una sessualità dai contorni talvolta violenti e comunque che si lega al sangue versato. Non mai come nel ‘voodoo’ haitiano o la ‘macumba’ brasiliana dove spesso si consumano fatti sangue, sostenuti da uno ‘stravolgimento’ psichico che coglie i danzatori fino allo stremo, coadiuvato dalla musica impetuosa e violenta. Fatto questo che verosimilmente accadeva anche a Cuba fino a qualche tempo fa, ma che oggi ha trovato un suo equilibrio all’interno dei festeggiamenti per il carnevale.
Senza dubbio il più famoso di tutta l’America Latina se si esclude quello brasiliano di Rio de Janeiro, il carnevale di Santiago di Cuba, capoluogo della provincia d’oriente, questa città storica che si affaccia sullo stretto che separa Cuba da Santo Domingo, ha subito profondamente l’influenza culturale della più antica colonia francese. Quando Haiti venne proclamata repubblica indipendente nel 1825, gran parte dei coloni francesi si trasferirono unitamente agli schiavi a Santiago, lasciando ad essi di coltivare i propri culti, i riti e i costumi presenti nelle loro tradizioni, con le sue danze e ritmi che animavano il carnevale. Uno degli elementi musicali che gli sono propri, ad esempio, è ‘l’organo oriental’ un pianoforte meccanico di origine francese che i creoli suonavano in modo quasi ‘percussivo’.
Alle percussioni vere e proprie appartiene la ‘conga’ (nome derivato da Congo), fondamentale nella ritmica delle danze come, ad esempio, il ‘mambo’ tipicamente cubano le cui movenze sensuali esaltano la fisicità ‘provocatoria’ dei ballerini e ballerine. Altro strumento di rilevante importanza è il grande tamburo detto ‘tumba francesa’, così detta ma la sua origine è haitiana, all’epoca della sua comparsa ancora colonia francese. Un carnevale non tanto diverso dagli altri, benché si svolga all’insegna della stravaganza nei costumi, ricco di colori, costumi sfavillanti di lustrini, ombrellini ecc. Tuttavia è qui presente un aspetto meno costruito di altri e, se vogliamo, più autentico a carattere prevalentemente popolare.
Nei giorni del carnevale, dalle due alle cinque del mattino, il suono estenuante delle percussioni nella notte calda, eccitano gli animi ed esaltano la bellezza prorompente dei corpi seminudi di migliaia di danzatori e danzatrici che, per l’occasione, si lasciano andare a un vero fenomeno di trance collettiva. Nel mentre tutta la gente scandisce strofe conosciute o canta ritornelli semplici ormai consumati dall’uso. Molta parte hanno i cosiddetti ‘rumberos’, suonatori professionisti di rumba, creoli o mulatti avanti negli anni, appartenenti alla cultura ‘vintage’ alla Cuba popolare rimasta agli anni ‘30/’50, che si esibiscono e spesso improvvisano autentici recitals di musica a beneficio di un pubblico entusiasta.
I ritmi, oltre quelli della ‘rumba’, qui presa a simbolo della musica cubana di quegli anni, e dalla quale derivano tutte le altre danze che hanno conosciuto un vasto successo internazionale grazie all’essere entrate nel circuito delle mode, c’è il già citato ‘mambo’ di cui esistono numerose scuole; la ‘cumbia’ e la ‘conga’ eseguite sul ritmo concitato delle sole percussioni come ‘bomgo’, ‘tumbadora’, nonché cerchioni di ruote, cucchiai, ‘cajon’, e poi ‘maracas’, ‘guayo’, ‘claves’, ‘mascelle di cavallo’ ecc.; il ‘cuatro’ o il ‘tres’, rispettivamente chitarre a quattro o a tre corde, e differentemente fa la sua apparizione la tromba. L’eccetera vale anche per il ‘changui oriental’ e per la ‘rumba de cajon’ ritmati su semplici cassette per il sapone e che sono per la musica cubana, quello che le vecchie musiche di New Orleans furono per il Jazz.
La ‘Vieja loca’ (La abeja loca) è indubbiamente uno dei pezzi più diffusi nelle Grandi Antille durante gli anni ’30, un brano che, per la vostra conoscenza e comprensione, riporto dal testo originale ‘in cubano’ qui di seguito tradotta in italiano:
L’Ape Folle
Yo hace tiempo que estaba descansando …
Mi ero preso un po’ di riposo
Lo sai, sulla veranda.
Ma la mia donna, amico mio, è impazzita,
come se fosse un’ape regina, e mi vuole molestare.
Tutte le notti va in giro per i locali
e quando se ne torna a casa è già l’alba.
A quell’ora, la dannata, si mette
a imitare l’Ape regina, e con me non va!
Se vado in ufficio – lei va là.
Ovunque io vada – lei va là.
Quest’Ape folle – lei va là.
Se vado in vacanza – lei va là.
Se vado in ufficio – lei va là.
Quest’Ape folle – lei va là.
Io sono un vecchio, io non servo più,
e lei mi butta a terra, mi strappa il vestito,
e dopo che ha fatto di me quello che ha voluto,
quest’Ape folle – lei va là.
Dovunque mi metto – lei va là.
Quest’Ape folle …
Con tuorlo d’uovo e con apposite erbe,
e con degli ormoni che lei mi iniettava
per alimentarmi, che barbarità!
Dovunque mi metto – lei va là.
Quest’Ape folle …
Mi prende il panico, maledetto vecchio che sono,
mi si rizzano i capelli, e se grido e se grido:
‘Taci soldato, che ti uccido’.
Dovunque mi metto – lei va là.
Quest’Ape folle …
E poi quando sono bellé che finito,
e non resta che andare all’ospedale,
lei si mette lì, e quando sarò spacciato,
morto nel lettuccio, riuscirò
forse a liberarmene.
Ai più antichi canti afro-cubani appartengono gli ‘abakuà’, propri di una setta minore che, durante le grandi cerimonie, dispongono di canti specifici per ogni singola funazione rituale, la cui struttura è sempre basata sull’alternanza fra un solista e il coro, mentre i testi si riferiscono a episodi mitici entrati nella cultura leggendaria di questo gruppo. L’intera cerimonia detta ‘wemba’ termine intraducibile che sta per stregoneria, non è altro che la ripetizione di vecchi passi attribuiti all’origine africana della setta e il canto, anch’esso detto ‘wemba’, viene eseguito all’interno di un luogo consacrato. Lo stesso avviene nel caso che gli ‘abakuà’ narrino le leggende riferenti la loro origine; ciò che in realtà fanno utilizzando la linfua ‘efik’ chiamati anche ‘enkames’. Questi vengono narrati da un membro appartenente di grado appropriato della gerarchia (plaza), accompèagnandosi al suono del tamburo sacro che corrisponde al suo livello gerarchico. Il rituale prevede l’intervento di altri membri e il coro degli officianti, e si conclude talvolta con un canto pertinente alla leggenda narrata.
Si è detto dei riti ‘lucumì cruzado’ praticati nella provincia orientale dell’isola, e consistono in cerimonie spiritiche con alcuni elementi mutuati dalla ‘santeria’. Trattasi di canti della chiesa pentecostale ad alto contenuto liturgico, misti ad altri allusivi a divinità proprie yorouba. Come il canto detto ‘a oddudua’, considerato una divinità maggiore di sesso maschile, collegato alla creazione della vita e, di conseguenza, con i riti funebri annessi alla morte, sincreticamente identificato con S. Emanuele. Accade a volte che, durante le feste di iniziazione, qualcuno venga posseduto dagli spiriti all’interno del ‘munanso-bela’, lo spazio consacrato al culto ‘congo’, e si metta a cantare ‘a cappella’ colpendo il terreno con la mano o con qualche attrezzo, mentre gli altri partecipanti rispondono ad esso cantando a bocca chiusa. Fra alcune popolazioni tutt’ora presenti sull’isola esisteva la tradizione di ballare e cantare al momento della sepoltura di un ‘rumbero’, il quale poteva essere al medismo tempo un ‘jurado’ di abakùa. Il feretro veniva portato a piedi al cimitero da alcune persone che camminavano cantando e danzando (più verosimilmente marciando) al ritmo delle percussioni e da grida gutturali. Lungo il tragitto uno dei portatori si poneva il feretro sulla schiena o sulla testa, e ballava da solo. Tradizione quella di ballare e cantare al momento della sepoltura che è rimasta sul territorio e vi si può tutt’ora assistere o anche prendervi parte.
In altre manifestazioni popolari era anche previsto lo svolgersi di gare di danze che mettevano alla prova la destrezza fisica e la forza magica dei capi. Queste, più spesso ballate in coppia e accompagnate dagli ‘yuka’, dal nome dei tamburi che ne scandivano il ritmo ricavato dai più antichi tamburi. Si conoscono i nomi di almeno tre tamburi di diverse proporzioni, uno più grande e due di dimensioni più ridotte, costruiti con legno di mandorlo o di aguacate: il più grande che esegue libere figurazioni ritmiche è chiamato ‘caja’ e viene appoggiato a un sostegno fatto con bastoni incrociati che il musicista suona standoci seduto sopra a cavalcioni e che viene percosso ai lati con due bastoni. Tale modo è detto ‘suonar la guagua’ (inezia, bagatella) che può anche significare ‘coccinella’. Allo stesso modo fungono anche gli altri due tamburi mediano o ‘mula’, e piccolo o ‘cachimbo’, talvolta ricavati da tronchi d’albero scavati e ricoperti di lamine metalliche.
Diversamente concepita, e solo a partire dai moti rivoluzionari che videro l'inizio dell'indipendenza di Cuba sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti nel 1902, (nota con riserva), si ha notizia di una ‘poesia cubana’, messa in relazione con la musica tipica fiorita negli anni ‘30/’40 del XX sec. Non si può slegare la poesia cubana dal concetto delle lotte per l’indipendenza sostenute nell’Ottocento che stimolarono l’opera di molti scrittori tra i quali emergono José Martì, G. de la Concepción Valdes e J. M. de Heredia. Molti sono i poeti cubani che hanno lasciato la loro impronta come J. del Casal, Nicolas Guillén, José Lezama Lima, Diego Vitier, H. Padilla e R. Fernández Retamar.
Ciò vale anche per la poesia cubana sorretta sempre da uno spirito di indipendenza. Scopriamo insieme almeno i due poeti più importanti di questo paese: José Martí e Nicolas Guillén che hanno dato voce a drammi e a condizioni inumane attraverso la politica e la poesia.
José Julián Martí, fu un leader del movimento per l’indipendenza cubana, nonché uno stimato poeta e scrittore. A Cuba è considerato il più grande eroe nazionale e ‘Apostolo’ della libertà. Nato all’Avana dai genitori spagnoli all’età di 4 anni si trasferì con la famiglia a Valencia, in Spagna tornando sull’isola 2 anni dopo dove frequentò una scuola pubblica. Nel 1869 pubblicò il suo primo testo politico nell’edizione unica del giornale El Diablo Cojuelo. Lo stesso anno pubblicò ‘Abdala’, un dramma patriottico in versi, e il suo celebre sonetto ‘10 de octubre’ fu pure scritto nel ‘69 e fu pubblicato poco più tardi nel giornale della sua scuola. Nell’ottobre del 1869 prese attivamente parte alla lotta per l’indipendenza di Cuba, soffrì la prigionia e la deportazione (1878) per l’avvenuto esilio in seguito ad un accusa di tradimento formulata dal governo spagnolo. Nel 1880, Martí sì trasferì a New York dove sensibilizzò la comunità di esiliati cubani, per mettere in atto la rivoluzione e ottenere l’indipendenza dalla Spagna. Fu volontario militante del Partido Rivolucionario Cubano e lottò contro il colonialismo spagnolo e condannò i pericoli del capitalismo nordamericano opponendosi all’annessione di Cuba agli Stati Uniti. Nel 1895 Martì sbarcò a Cuba con un reparto di esuli ribelli tentando di impadronirsi con la forza del potere dominante. Venne ucciso dalle truppe spagnole durante la Battaglia di Dos Ríos del 19 maggio di quello stesso anno.
I suoi lavori meglio riusciti e più apprezzati furono i libri per bambini: La Edad de Oro è il più letto. Uno dei poemi della collezione ‘Versos Sencillos’ col titolo di “Yo soy un hombre sincero”, fu tempo dopo trasposto in musica in ‘Guantanamera’, che è divenuta la canzone cubana più famosa: Dai "Versos Sencillos" di José Martí (1890). Collage di versi definitivo di Julián Orbón Probabile stesura musicale definitiva di Héctor Ángulo (1950), reinterpretata per prima da Joseíto Fernández a partire dal 1932 e, successivamente interpretata da Pete Seeger a partire dal 1963 e da altri grandi del firmamento internazionale: Joan Baez, Frank Sinatra, José Feliciano, Jackson Browne, Julio Igresias, Sergio Endrigo, Zucchero Fornaciari e tantissimi altri.
‘Guantanamera’
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera.
Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.
Guantanamera, guajira guantanamera ...
Cultivo una rosa blanca,
En Julio como en Enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Guantanamera, guajira guantanamera ...
Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni urtiga cultivo:
Cultivo la rosa blanca.
Guantanamera, guajira guantanamera ...
Yo sé de un pesar profundo
Entre las penas sin nombres:
La esclavidad de los hombres
Es la gran pena del mundo!
Guantanamera, guajira guantanamera ...
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar.
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar,
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar.
Guantanamera, guajira guantanamera ...
Nicolas Guillén (Nicolás Cristobal Guillén Batista), è il poeta cubano più noto e massima espressione della negritudine cubana. Nato in quel di Cuba, a Camaguey nel 1902 meticcio e figlio di uno schiavo, dopo aver appreso il mestiere di tipografo nella stamperia del periodico diretto da suo padre, giornalista e politico, nel 1920 frequentò il corso di legge all’Università di La Habana, ma passò ben presto al giornalismo. Tornato a Camanguey fu direttore nel quotidiano El Camagueyano. Fu Nicolas Guillén che si riferì per primo a Cuba definendola "lunga lucertola verde con gli occhi d'acqua e di pietra", creando così il felice accostamento tra l'immagine del coccodrillo e la forma dell'isola che ancor oggi viene utilizzato. Al 1930 risale la pubblicazione del suo primo libro di poesie, ‘Motivos de Son’, seguito l’anno dopo da ‘Songoro Cosongo’, le due opere sono in realtà il punto di partenza di un’opera poetica fra le più significative di tutta l’America Latina. Nei suoi versi ha trattato la condizione degli afroamericani nelle Antille, dando voce al sogno di libertà del suo popolo, ha affrontato importanti temi sociali come la condizione dei neri, la loro oppressione e speranza di riscatto.
Già all'epoca di Gustavo Machado scriveva il dramma dello sfruttamento dei macheteros nelle piantagioni di canna da zucchero. Soprannominato ‘il poeta della sintesi’, perché con pochi versi riusciva a cogliere gli aspetti di una condizione collettiva di protesta. Nel 1935, entrato a far parte del Partito Comunista Cubano, continuò la sua attività giornalistica collaborando come redattore con importanti pucclicazioni in Cuba ed estere. Caratteristica peculiare dei suoi versi è l'utilizzo di espressioni onomatopeiche (come Sóngoro Cosongo e Mayombe-bombe) che evocano il suono dei tamburi e i ritmi del ‘son’. Sua fonte di ispirazione stilistica, infatti, sono tanto i classici europei quanto i canti popolari delle Antille. Fra i suoi libri più importanti vanno ricordati: ‘España, son entero’; ‘La Paloma del vuelo popular’; ‘Poemas de amor’, che sono stati tradotti in molte lingue. Per le sue idee politiche, per il suo pensiero e la sua azione rivoluzionari, Guillen subì la persecuzione in carcere e l’esilio. Nel 1954 gli venne conferito il Premio Stalin per la pace. Dal 1961 fu anche Presidente della Unione degli Scrittori e artisti di Cuba. Nel 1989 morì La Havana.
Molte sue opere sono state messe in musica da Paco Ibáñez e tra queste, in particolare, ‘Soldadito Boliviano’, dedicata alla morte di Che Guevara, che ebbe molto successo nel 1969. La poesia ‘La Muralla’ è stata invece musicata da Inti Illimani e Quilapayún. Da notare, infine, che la più nota composizione sinfonica di Silvestre Revueltas, intitolata ‘Sensemayá’, è basata sull'omonimo componimento poetico in cui Guillén evoca un canto Afro-Caribe eseguito durante l’uccisione di un serpente:
“Canción para matar una culebra”
Canto para matar una culebra
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
La culebra tiene los ojos de vidrio
la culebra viene y se enreda en un palo
Con sus ojos de vidrio, en un palo
Con sus ojos de vidrio
La culebra camina sin patas
La culebra se esconde en la yerba
Caminando se esconde en la yerba
Caminando sin patas
¡Mayombe-bombe-mayombe!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
¡Mayombe-bombe-mayombé!
Il poema ‘Sensemayá’ riporta alcuni culti religiosi afrocubani tramessi di generazione in generazione, e conservato nei ‘cabildos’, così detti quei circoli-organizzati per gli schiavi africani a Cuba e nelle Antille. Culti che avevano una struttura simile ma non identica come è già stato detto ai ‘lucumì’ dedotti dai culti Yorouba dell'Africa Centrale e da quelli Voodou di Haiti. In questo poema s’incontra un ‘mayombero’ informato di medicina erbacea e leader dei rituali. In ‘Sensemayá’, il mayombero conduce un rituale che propone il sacrificio di un serpente alla divinità ‘Sì’ di Babalu, popolarizzato negli Stati Uniti da Desi Arnaz. Babalu è lo spirito afrocubano che ha il potere di guarire dalla pestilenza. Il canto liturgico "mayombe, bombe mayombé" incluso nel poema è un esempio dell'uso ripetitivo, che Guillén certamente dedusse da una cerimonia più antica.
(Fine prima parte)
Discografia:
“Cult music of Cuba” - Ethnic Folkways Library P410 1 - (Lp senza data di pub. 1955 circa), di danze: Lucumì, Abakwa, Djuka; e canti: Legba, Yemaya, Obtala, Chango, Oko. Registrazioni dal vivo by Harold Courlander.
“Antichi canti afrocubani” – Lp a cura di M.T. Linares – Albatros/VPA 8445 (1979)
“Cuba popolare” – Lp Zodiaco/VPA 8291 (1968) - documenti sonori reg. dal vivo a Santiago de Cuba (1967) a cura di Alain Gheerbrant.
“Misa Santeria” – Vaudou à Cuba – Lp Riviera/Barclay - 521 107 (Lp senza data di pub. 1970 circa) – documenti sonori reg. dal vivo a La Havana, par Maurice Bitter.
“Pablo Milanés canta le poesie di José Martì” – Lp Vedette Rec. VPA 8164 (1977)
“Marta Contreras canta Nicolas Guillen” – Lp Zodiaco – VPA 8362 (1977)
*
.jpg) - Cinema
- Cinema
‘Viaggiare’ con il grande Cinema.
“Trains and boats and planes are passing by … they mean a trip to …” (B. Bacharach-H. David)
Sì, “I treni e le barche e gli aerei sono di passaggio…significano un viaggio verso …”, tutti quei ‘luoghi’ del mondo che oggi in parte conosciamo perché visitati o, per altri versi conosciuti, tramite le ‘location’ di film che ci hanno fatto ‘vivere’ o rivivere emozioni e avventure appartenenti al linguaggio visivo, in quanto luoghi utilizzati nell’ambientazione cinematografica o verosimilmente ricostruiti in studio. Più esattamente, il ‘set’ esterno o interno prescelto dallo scenografo insieme al regista, onde ambientare un film o simularne la presenza in una sequenza fotografica. In breve, il luogo dove si svolge la scelta narrativa, teatrale, televisiva e comunque filmica di un’ambientazione che può riguardare il passato o il passato remoto, per quei film di rilevanza storica; il presente per l’attualità e la cronaca recente, oppure il futuro, nel caso della fantascienza; come per esempio è avvenuto con “La macchina del tempo” il romanzo che Herbert George Wells scrisse nel 1895 dal quale sono state tratte almeno tre sceneggiature.
In alcune famose sceneggiature, infatti, di cui si ha riscontro nel teatro e soprattutto nel cinema, si denota l’utilizzo di almeno tre diverse ambientazioni, relative ai ‘tempi narrativi’ del romanzo dal quale era tratta la sceneggiatura portata sullo schermo. E comunque un’ambientazione diversa da quella originale, riguardo ad esempio la trasposizione in un’altra epoca, o un periodo staccato dal presente, con la tecnica del deja-vù, o del back-up; che hanno permesso il prodursi nella mente dello spettatore una sorta di ‘vademecum visivo’ che ha influenzato non poco il senso del nostro ‘viaggiare nella conoscenza’, allargando di fatto l’orizzonte del nostro immaginario, fino a qualche tempo fa, e per diverse ragioni, limitato al ristretto mondo delle disponibilità che, nonostante tutto, ognuno in sé possiede, e relative al senso d’avventura, alla curiosità di esplorare novi luoghi e nuovi mondi, di metterci, per così dire, le mani sopra e vederla con i propri occhi, anziché apprenderne i recessi dalla lettura di un libro, dallo sfogliare una rivista sull’argomento o dalla visione di un documentario.
È così che ‘apprendere’ dalla storia, ‘penetrare’ la struttura di un oggetto, ‘conoscere’ altra gente, ha assunto nel tempo significati diversi; non in ultimo, o forse più semplicemente, abbiamo imparato ad avvicinare altri popoli, appreso altri costumi, conosciuta altra arte e, in senso speculativo, siamo andati incontro agli ‘altri’ avventurandoci nell’ignoto, nell’accezione di scoprire ciò che viene dopo; e perché no, di ritrovarci con se stessi ... “Non c'è piacere più grande nel viaggiare che questo – scriverà Albert Camus in "Carnets” – e io lo vedo come un'occasione per affrontare una prova spirituale (..) Il viaggio, come una scienza più grande e più grave che ci riporta a noi stessi.” Tuttavia ‘viaggiare’ è qualcosa cui oggi in molti prestano attenzione, molto più che in passato, sfogliando rotocalchi e guide, andando al cinema o standosene seduti davanti alla televisione, affascinati non poco dalle immagini e dalle sequenze filmiche di un documentario, in ragione di uno spirito innato che ci portiamo dentro, che è poi quello dell’evasione, ma che subito si trasforma in ‘avventura’, dacché ci spinge a voler scoprire ‘luoghi’ solo apparentemente lontani, oggi assai più vicini e raggiuingibili di ieri.
Così vicini al nostro ‘presente’ le cui incognite, pur restando a noi del tutto sconosciute, s’avvalgono di quella spinta all’indietro che ci permette di ‘contestualizzare’ il passato scavalcando il presente; e di avventurarci nel futuro, in quel fantascientifico ignoto altrettanto misterioro a cui da sempre tendiamo. Ragione per cui il ‘mondo’ a disposizione sembra non bastarci più, pur restando semisconosciuto e infinito se confrontato con la nostra breve esistenza. Ciò anche in funzione dell’aver racchiuso la nostra fertile fantasia dentro una fitta rete di ‘immagini’ cui vogliamo (perché lo vogliamo non è vero?), ad ogni costo, far nostre, quasi a volerne ridisegnarne i contorni, renderle vive, come per un atto creativo che scusi ai nostri occhi l’ambizione di un ‘spirito d’avventura’ innato. Quello stesso che ci ha permesso di valicare montagne, navigare per mari e oceani, imitare il volo degli uccelli, viaggiare nello spazio, e accresciuto, attraverso le emozioni e i sentimenti che il viaggiare ci da, la conoscenza del mondo in cui viviamo, nella consapevolezza di soddisfare il nostro infinito desiderio di superare noi stessi; così da ‘visualizzare’ ciò che, in ogni epoca fino ad oggi, ha accompagnto il nostro ‘sognare di essere nel mondo’ rasentando spesso l’inverosimile e per quanto lo sviluppo tecnologico e scientifico abbia poi visto la realizzazione di quanto si andava delineando, in fatto di ‘visualizzazione’ del nostro instancabile immaginario.
Lo stesso che i ‘costruttori di immagini’, quali noi siamo inquanto scrittori e illustratori, per non dire degli artefici di tanta arte, si sono prodigati per meglio realizzare tutto quanto credevamo appartenesse solo alla fantasia di un tempo, a quel passato fatto di oralità e fiabe, di leggende e miti dimenticati, in qualità di patrimonio esclusivo dell’arte e della letteratura, delle saghe e dei grandi romanzi in genere. Cioè di tutto quello scrivere e visualizzare in immagini, che pur nei suoi diversi aspetti ci ha permesso, in passato, di trasporre la nostra immaginazione fin oltre gli ‘estremi’ lembi della conoscenza che andiamo esplorando e che, oggi costituiscono il bagaglio conoscitivo dell’intera umanità, cospicui di idee e immaginazione che in qualche modo travalica lo spazio del nostro vivere quotidiano. Un quotidiano se vogliamo alquanto surreale, decisamente artificioso, che fin dall’inizio si presentava come un insieme di situazioni sceniche manipolate all’occorrenza, in quanto:
“Espediente felicemente riuscito per alcuni e del tutto artificioso per altri; (..) nel tentativo, non si sa bene quanto riuscito, di dare unità all’intero impianto letterario/drammaturgico dell’epoca che andava confluendo nel cinematografo. Un fare cinema, quello degli inizi, che parlava con un linguaggio atipico, degli schemi e degli umori del romanzo d’appendice. (..) E poi quell’intonazione educativo-moralistica che era propria del feuilleton, e in più conservava quel fondo umano, quasi da rimpianto, di un ‘paradiso perduto’ verso il quale tendevano tutti i personaggi (dei romanzi e poi del cinema), spinti e animati da sentimenti consolatamente o sconsolatamente umani”. Così carichi di un’ansietà di vivere che li teneva sempre in costante fervore, traboccante di costante quanto di incredibile voglia d’avventura, quasi fossero sempre sulla linea di mettersi in gioco. Ma solo nella finzione, perché nella realtà non è la loro vita che eccita la nostra fantasia, tale da sembrare autentica o quantomeno possibile, bensì quella che consciamente vorremmo far nostra. Cioè, consequenziale di un possibilismo che l’avanzamento costante della scienza e della tecnologia tutt’ora si lascia solo ‘immaginare’ come probabile ed eventuale di un filo conduttore che travalica il nostro tempo e si spinge nell’addivenire.
Come era ovvio che accadesse, tutto ciò ha avuto un inizio: il 28 Dicembre 1895, giorno della prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière, considerata la data di nascita dello spettacolo cinematografico, benché le prime immagini in movimento furono realizzate molto prima, allorché l’invenzione fu concepita come un prezioso strumento per la ricerca scientifica. Ecco, il nostro ‘viaggio’ incomincia appunto da quei ‘pionieri’ che, a partire dal 1873, studiarono e progettarono apparecchi e materiali sensibili alla luce. Tra i tanti l’astronomo Janssen, il fotografo Mybridge e il fisiologo Marey, grazie ai quali furono messe a punto macchine che permettevano l’analisi di movimenti nel dettaglio, riuscendo a far ‘vedere l’invisibile’. Le prime applicazioni del nuovo mezzo furono certamente stupefacenti, gli spettatori del tempo poterono infatti guardare cose mai viste fino allora, come riprese temporizzate per lo studio della botanica, i primi film girati con i raggi X o in sala operatoria. Tre momenti di straordinario interesse e ricchi di immagini filmate che, per la prima volta, venivano mostrate al difuori dell’ambiente scientifico, e che sono oggi fondamentali per chi voglia conoscere gli sviluppi del mezzo cinematografico che ha determinato l’odierna civiltà delle immagini.
Altrettanto numerose sono le pellicole che determinarono lo spazio di quella che, non a caso, fu definita la ‘settima arte’ del tempo moderno, oggi a dir poco sconosciute, quando non addirittura andate perdute, e solo in qualche caso ritrovate, come è accaduto a molte altre trafugate nel periodo della guerra del 1943 e andate distrutte. Ciò che rende impossibile darne qui una elencazione fittizia e che, pertanto, mi limito a ricordarne solo alcune di cui si ha ricordo, non tanto per rifare la storia di un cinema che c’era, quanto di un cinema che non c’era ma che si voleva fare a tutti i costi: L’Inferno (1911) di Francesco Bertolini, composto da 54 scene animate ispirate alle illustrazioni di Gustave Doré della prima cantica della “Divina Commedia”, e che abbiamo potuto visionare solo nella versione restaurata del 2004, con l’aggiunta delle musiche del gruppo rock dei Tangerine Dream; Ma l'amor mio non muore (1913), diretto dal regista Mario Caserini, con Lyda Borelli, Mario Bonnard, Maria Caserini; Sperduti nel buio (1914) di Nino Martoglio ritenuto precursore del Neorealismo italiano; Assunta Spina (1915) di e con Francesca Bertini considerato uno dei film di maggiore successo del cinema muto italiano; Femmine folli (1922) e Sinfonia nuziale (1926) entrambi di Erich von Stroheim; La strada (1923) diretto da Karl Grune, un classico dell'espressionismo tedesco, ripreso poi nel 1954 da Federico Fellini con i due straordinari interpreti Antony Qeen e Giulietta Masina; Rotaie (1929) di Mario Camerini; Tabù (1931) scritto e diretto da Friedrich Wilhelm Murnau, censurato a suo tempo negli Stati Uniti per la presenza di donne polinesiane a seno nudo.
Le potenzialità della ‘nuova arte’ si fecero ben presto apprezzare con film che negli anni successivi strabiliarono un pubblico attonito fino allo sgomento: l’Odissea (1911) diretto da Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, un primo ‘muto italiano’ ispirato al libro di Omero, ripreso poi nel 1969; La caduta di Troia (1911) e Cabiria (1914) entrambi di Giovanni Pastrone che, insieme a Quo Vadis (1912) di Enrico Guizzoni segnarono l’inizio del genere ‘kolossal’, contenenti cioè spostamenti di grandi masse di ‘comparse’; Nascita di una nazione (1915) di David W. Griffith; L'Atlantide (1921) di Jacques Feyder; e quel Metropolis (1927) di Fritz Lang che, con le sue audaci architetture aeree creò e divulgò immagini strabilianti di pura bellezza. Chi l’avrebbe detto, ad esempio, che un film come Lord Jim (1925) tratto dal romanzo di Joseph Conrad e adattato per lo schermo da Victor Fleming; o che anche quello successivo del 1965, diretto da Richard Brooks con lo starordinario Peter O’Toole, aprisse le porte a un genere entusiasmante denominato di ‘cappa e spada’ e di avventurieri di mare come i ‘corsari’. O che Mata Hary (1931) di George Fitzmaurice con la ‘divina’ Greta Garbo desse inizio a tutto un genere ‘spy-dective’ che avrebbe avuto un così fortunato seguito. Che, Don Chisciotte (1933) di Pabst con l’inarrivabile F. Chaliapin, vedesse almeno 10 remake? O che Moby Dick (1956), tratto dal romanzo di Herman Melville del 1851 e diretto da John Houston nell’indimenticabile interpretazione di Gregory Peck (Capitano Achab), potesse esistere davvero nel profondo degli oceani (?).
Nessuno credo, come del resto alcuno avrebbe pensato che alcune pellicole del cinema cosiddetto ‘espressionista’ come Il Golem (1920) dei registi Paul Wegener e Carl Boese; Il gabinetto del dott. Caligari (1920) di Robert Wiene; Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (1920) di John S. Robinson, tratto dal racconto omonimo di R. Stevenson; o che il genio malefico del Dottor Mabuse (1922) di Fritz Lang con i due ‘sequel’ apparsi sempre in quegli anni, avrebbero dato il via alla creazione di un ‘genere’ a sé stante che spaziava tra il fantascientifico e l’orrore, per l’appunto denominato ‘horror’. Cui fecero seguito Nosferatu il Vampiro (1922) di Friedrich W. Murnau, ripreso in seguito da Dracula (1931) diretto da Tod Bronwing con Béla Lugosi e che, tra tutti i remake, anche quelli più vicini a noi, fino a Dracula il Vampiro (1958) nel remake di Terence Fisher con l’orrifico e pur bravissimo Christopher Lee, rimane il più fedele al romanzo originale di Bram Stoker. E a tutta una serie di ‘freaks’, ‘mostri’ ed esseri all’epoca inqualificabili, come quelli apparsi in Il tesoro (1923) del pur grande Wilhelm Pabst; Il gobbo di Notre Dame (1923) di Wallace Worsley e, quel Il fantasma dell’opera (1925) di Rupert Julian, entrambi interpretati dalla ‘maschera incredibile’ che fu Lon Chaney; fino all’omonima quanto straordinaria ‘piece musicale’ (1986) di Andrew Lloyd Webber; e ai racconti di Edgar Allan Poe (grande padre dell’Horror), che abbiamo visto in La caduta della Casa Usher (1928) diretto da Jean Epstein.
Senza nulla togliere a Frankenstein (1931) di James Whale tratto dall’omonimo romanzo di Mary Shelley che vide la sublime interpretazione di Boris Karloff; o dei suoi numerosi ‘remake’, tra cui svetta quello del 1994 con De Niro, ma che abbiamo comunque apprezzato nelle versioni comiche in La famiglia Addams (1973), di Charles Addams, la cui prima apparizione risale agli anni trenta in una serie di vignette umoristiche pubblicate sul settimanale The New Yorker; e nel parodistico Frankenstein Junior (1974) diretto da Mel Brooks. Chi davvero mai avrebbe detto che uno straordinario ‘mostro’ come King-Kong (1933) di M. C. Cooper e E. B. Schoedsack, potesse esistere nella realtà? Non sono forse da considerarsi del genere ‘avventura’ anche i ‘viaggi fantascientifici’ descritti da Jules Verne alla fine dell’Ottocento, in compagnia del quale abbiamo attraversato il globo in ogni direzione nella penombra del tempo, fra città perdute, tigri, locomotive, sommergibili e aeroplani? Chi di noi non rammenta le emozioni narrate in 20.000 Leghe sotto i Mari (1954) di Richard Fleischer; Il giro del Mondo in 80 giorni (1956) di Michael Levinson; Viaggio al centro della Terra (1959) di Henry Levin; Cinque settimane in pallone (1962) di Irvin Allen.
Un discorso a parte va fatto per i numerosi film con “Tarzan”, personaggio immaginario inventato da Edgar Rice Burroughs che rappresenta l'archetipo del bambino selvaggio allevato nella giungla dalle scimmie, che ritorna in seguito alla civilizzazione solo per rifiutarla in buona parte e tornare nella natura selvaggia nelle vesti di eroe ed avventuriero. È apparso per la prima volta nel romanzo Tarzan delle Scimmie (Tarzan of the Apes, pubblicato originariamente nell'ottobre del 1912 sulla rivista The All-Story e in volume nel 1914) e in seguito in 23 storie e in innumerevoli opere su altri media, autorizzate o meno. La fortuna di Tarzan non risiede solo nelle storie, avventure mozzafiato in terre esotiche e aliene, ma anche nello stile adottato da Burroughs, che fa della semplicità della scrittura il cardine dei suoi romanzi, ottenendo facilmente un forte legame con il lettore ed una più facile identificazione con personaggi che normalmente non fanno parte del vivere quotidiano. I racconti di Tarzan sono stati trasposti nel cinema, televisione, fumetto, anche con nuove storie originali. Il personaggio vanterà inoltre numerosi imitatori (i cosiddetti tarzanidi). (Wikipedia)
Quante avventure e quante emozioni!, permettetemi di dirlo, e soprattutto quanta ‘storia’ e quanta ‘finzione’ c’era in quelle pellicole, tale ch’è divenuto proverbiale dire: “trattasi pur di cinematografo!”.
Ebbene sì, ma quanto ci ha dato e quanto ci ha insegnato è incommensurabile. Frotte di giovani sono rimasti folgorati da personaggi cinematografici di uomini ‘impossibili’ nella realtà; dagli amori ‘fatali’ di donne appassionate. Quanti ‘idealisti’, quanti ‘visionari’, e quanti veri ‘uomini’ sono cresciuti sotto l’egida del ‘cinema’ e da questo hanno preso a modello atteggiamenti e comportamenti di personaggi della celluloide, uomini e donne senza differenziazioni (?) che, in qualche modo, ha svelato loro i segreti d’una vita che si mostrava ‘meravigliosa’ o, quantomeno avventurosa: La grande illusione (1937) di Jean Renoir; Il porto delle nebbie (1938) di Marcel Carné e Il bandito della Casbah (1942) di Julien Duvivier, tutti con lo stravolgente Jean Gabin; per non dire di Casablanca (1942) di Michael Curtiz, con l’altro straordinario attore ch’è stato Humprhey Bogart e la pur meravigliosa Ingrid Bergman.
Ma torniamo alla grande avventura del cinema con La corazzata Potëmkin (1925), Sciopero (1925), Ottobre (1928), Que Viva Mexico (1931) visto solo nel 1979, Aleksandr Nevskij (1938) una ricostruzione storica di propaganda antinazista in chiave epica, tutti del grande regista russo Serghej Eisenstein che indiscutibilmente, per taglio filmico, ombre e luci del bianco-nero, per l’atmosfera ambientale (scenografie) e sceneggiatura (sintetismo), interpretazioni da urlo, montaggio geniale, hanno influenzato e fatto scuola per tutto il ‘900. Cui hanno fatto seguito l’italiano Terra madre (1931) e 1860 (1934) entrambi di Alessandro Blasetti; L’Atalante (1934) di Jan Vigo, al pari di tanti altri meno impegnativi come: I Viaggi Di Gulliver (1939) da Swift, di Max e Dave Fleischer; Lo Sparviero del Mare (1940) di Michael Curtiz che ci fece conoscere l’atletico Errol Flynn; Il figlio della furia (1942) di John Cromwell con Tyrone Power; L’Isola del Tesoro (1950) di Robert Louis Stevenson che tanto ci incuteva paura e ancora tanto ci sorprende per le sue cupe scene marinare.
Nonché tutti o quasi i romanzi di Jack London, lo scrittore statunitense noto per aver scritto “Il richiamo della foresta” (1923) di Fred Jackman, “Martin Eden” (1942) di Sidney Salkow, “Zanna Bianca” (1973) di Lucio Fulci con Franco Nero e Virna Lisi, tutti più o meno trasposti in altrettanti film di successo ed entrati a far parte del nostro bagaglio culturale, nello specifico, di quella ‘letteratura d’avventura’ e quindi anche ‘letteratura cinematografica’ che ha in indice la scienza e la fantascienza, in altre parole quel ‘viaggiare’ che da sempre ci emoziona. E che dire di Emilio Salgari con i suoi famosi ‘cicli letterari’ dedicati ai Pirati delle Antille (1908) ed ai Pirati della Malesia (1913) con i quali ci spingemmo fra giungle, tigri, e che fra l’altro ci fecero conoscere luoghi per quel tempo irraggiungibili come Cina, Filippine, Paraguay, India, Polo Nord ecc. conducendoci fra mari in tempesta, galeoni corsari, pantere affamate, deserti e ghiacciai sterminati. Sicuramente straordinari furono i film Il ladro di Bagdad (1924) di Raoul Walsh che fu la rivelazione di Douglas Fairbanks; l’amaro e pur straordinario La buona terra (1937) di Jean Vigo, tratto dall’omonimo romanzo di Pearls Buck così straordinariamente umano.
Per non dire di molta letteratura d’avventura, cosiddetta ‘per ragazzi’, che ha visto numerosi titoli trasferiti in altrettanti film di successo e che indubitabilmente vanno qui ricordati: Il Mago di Oz (1939) di Victor Fleming con l’amorevole Judy Garland; e quel Libro della giungla (1942) di Rudyard Kipling, dal quale fu tratto l’omonimo film per la regia di Zoltan Korda con il giovane Sabù, e quello del (1967) diretto da Wolfgang Reitherman; al quale non fu da meno il ‘cartoon’ della Walt Disney & C. prodotto nello stesso anno e che, ancor prima aveva prodotto quel capolavoro che fu Pinocchio (1940) tratto da Collodi; nonché la felice trasposizione cinematografica di Alice nel paese delle meraviglie (1951) di Geronimi, Luske e Jackson. Non sono anche questi film tutti da ricordare e da rivedere in quanto raccontano di ‘viaggi’ e di ciò che dà significato al nostro immaginifico ‘viaggiare’, seppure con la fantasia? Devo ammettere che all’epoca sembravano altrettanto meravigliosi, così, tanto per restare in casa nostra, è doveroso ricordare che le pellicole erano ancora in bianco/nero, il colore sarebbe arrivato molto tempo dopo, così anche la ‘sonorizzazione’ di tutti quei film che seguirono il primo film sonoro italiano La canzone dell’amore (1930) di Gennaro Righelli.
Per il genere ‘viaggiare con il grande cinema’ italiano, dopo l’apertura degli studi di Cinecittà avvenuta nel 1937, assumono importanza tutti, o quasi, i diversi ‘generi’ filmici entrati di merito nella storia della cinematografia italiana: Scipione l’Africano (1937) di Carmine Gallone; L’Assedio dell’Alcazar (1940) di Augusto Genina, con Febo Giachetti e Andrea Checchi; Dagli Appennini alle Ande (1943) di Fabio Calzavara tratto dal libro “Cuore”; Roma città aperta (1945) con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Maria Ninchi, e Paisà (1946) entrambi di Roberto Rossellini; La terra trema (1948) di Luchino Visconti, e Stromboli (1950) ancora di Roberto Rossellini, che per la prima volta fece porci la domanda: “..ma dov’è Stromboli, mica sarà in Italia?”. Per arrivare poi a Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica; Il cappotto (1952) di Alberto Lattuada tratto da Gogol con uno straordinario Renato Rascel; e il documentaristico Viaggio in Italia (1954) ancora di Roberto Rossellini, restaurato e presentato lo scorso anno a Cannes. Nonché La grande Guerra (1959) di Mario Monicelli con due straordinari interpreti Vittorio Gasman e Alberto Sordi.
Ma facciamo un passo indietro nel cinema internazionale, sono degli anni ’50: Kon Tiki (1950) film documentario di Thor Heyrdahl; Tamburi lontani (1951) di Raul Walsh con Gary Cooper; Le nevi del KiIlimanjaro (1952) di Henry King con uno staff a dir poco stellare; I sette samurai (1954) interpretato, tra gli altri, da Toshirō Mifune e Takashi Shimura, diretto da Akira Kurosawa che quattro anni prima aveva firmato quel capolavoro di Rashomon (1950); e inoltre La pista degli Eelefanti (1954) di William Dieterle; L'arpa birmana (1956) diretto da Kon Ichikawa; Sayonara (1957) di Joshua Logan con Marlon Brando; Sinbad il Marinaio (1958) diretto da Nathan H. Juran, che fu l’eroe di un ciclo di racconti leggendari, ma soprattutto “di viaggio”, tratti dalla raccolta novellistica araba “Mille e una notte”. Ancora di quegli anni La tigre di Eschnapur e Il sepolcro indiano (1959) entrambi diretti da Fritz Lang, il primo film diviso in due parti, e il più lungo in assoluto che si ricordi. Seguito nello stesso anno dal sequel: Le miniere del re Salomone e, Watussi (1959) di Kurt Newman con Stewart Granger e Debora Kerr che aprirono un nuovo filone d’avventura geologico-archeologica, proseguito con la ‘saga’ per la TV dedicata al personaggio di Sandokan (1976) diretta da Sergio Sollima e magistralmente interpretato da Khabir Bedi; e dal
sequel de La mummia (1999) di Stephen Sommers con Brendan Fraser, e Il re scorpione (2002) di Chuck Russell con Dwayne Johnson.
Volendo restare nei limiti del genere ‘artistico-mélos’, vanno qui citati capolavori epico/lirici sonori riconducibili al genere ‘kolossal’ quali: Via col vento (1939) di Victor Fleming con le strepitose interpretazioni di Vivien leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland e leslie Haward; Quo Vadis (1951) nell’adattamento del romanzo omonimo di Henryk Sienkiewicz, diretto da Mervyn LeRoy, con l’insuperabile Sir Peter Ustinov; Salomè (1953) di Fleming e Dieterle; Sinhue l’Egiziano (1954) dal romanzo di Mika Waltari, diretto da Michael Curtiz nella stupenda interpretazione di Edmund Purdom; Ulisse (1954) di Mario Camerini e Mario Bava tratto dall'Odissea di Omero con uno stuolo di grandi attori come Kirk Douglas, Silvana Mangano, Antony Quinn, Rossana Podestà, Franco Interlenghi; I dieci comandamenti (1956) diretto dal grande Cecil B. DeMille che in seguito diresse Ben Hur (1959) con il quale s’impose all’attenzione internazionale lo formidabile Charlton Heston. Fino ad arrivare ai capolavori assoluti quali: Il Re ed Io (1956) di Walter Lang con Yul Brinner e Debora Kerr; Salomone e la regina di Saba (1959) di King Vidor con Gina Lollobrigida e Yul Brinner; Guerra e Pace (1956) tratto dall’omonimo romanzo di Tolstoj per la regia di Victor Fleming; Gli ultimi giorni di Pompei (1959) di Sergio Leone con Sophia Loren.
Gli anni ’60 sono forse i più proficui di opere attribubili all’arte cinematografica, un ritorno quasi al genere cosiddetto ‘di massa’, intendendo con ciò la partecipazione di numerosi attori e un infinito numero di secondari e comparse: Exodus (1960) di Otto Preminger con ‘l’immpassibile’ Paul Newman; Spartacus (1960) di Stanley Kubrick con l’audace Kirk Douglas; Lawrence d’Arabia (1962) diretto da David Lean nell’immensa interpretazione di Peter O’Toole; La conquista del West (1962) di John Ford, ottavo remake del film del 1936 diretto da C. De Mille con Gary Cooper; Gli ammutinati del Bounty (1962) con lo strabiliante Marlon Brando, del quale si sono visti numerosi remake; Il gattopardo (1963) di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo di G. Tommasi di Lampedusa, con uno straordinario Burt lancaster e la meravigliosa Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa e Rina Morelli, Romolo Valli e i giovanissimi Ottavia Piccolo e Pierre Clémenti. Nonché il fastoso Cleopatra (1963) di Mankieviz e D. Zanuck con la coppia E. Taylor e R. Burton; 55 giorni a Pechino (1963) diretto da registi diversi, con Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven; La caduta dell’impero romano (1964) di Antony mann; Zulu (1964) di Cy Endfield; Il Dott. Zivago (1965) di David Lean dal romanzo di Boris Pasternak, dove s’imposero le figure di Omar Sharif e il portentoso Rod Steiger, il ‘signore’ del cinema inglese Alec Guinness e la pur splendida Julie Christie.
Una parentesi d’obbligo va riservata a Pier Paolo Pasolini, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, poeta, attore, regista, considerato uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del XX secolo, ed anche il più emblematico. Il quale, dopo il suo esordio nel cinema negli anni '50 come soggettista intrprese la strada della regia con Accattone (1961) e Mamma Roma (1962) con la pur grande Anna Magnani, suoi primi film che lo fecero conoscere a livello internazionale. Ma il Pasolini che più interessa qui è il ‘viaggiatore’ instancabile dentro e fuori le sceneggiature dei suoi film di genere ‘storico’ e ‘letterario’ rivisitati in chiave critica; a cominciare da Il Vangelo secondo Matteo (1964); Appunti per un film sull’India (1965) da cui fu tratto un libro con Alberto Moravia, “Il profumo dell’India”, un cammeo assoluto nella storia della letteratura di viaggio; il capolavoro interpretativo di Totò Uccellacci, uccellini (1966); Edipo Re (1967); Medea (1969) con Maria Callas; Appunti per un’Orestiade Africana (1970); Il Decameron (1971) da Giovanni Boccaccio; I Racconti di Canterbury (1972) da Geoffrey Chaucer; Le mura di Sana’a (1973); Il fiore delle Mille e una Notte (1974); tutte opere che hanno aperto una improvvisa finestra sul senso del ‘viaggio’, mostrando i recessi della conoscenza e dell’ambiguità intrinseca nel viaggiare.
Si consideri che sono di quegli stessi anni film che hanno avuto rilevanza mondiale, come Khartoum (1966) di Basil Deardem con Lawrence Olivier e Charlton Heston; e La Bibbia (1966) di John Huston, che fece dire al mondo che ‘mai un film era stato così coinvolgente’; C’era una volta il West (1968) il capolavoro di Sergio Leone; Queimada (1968) di Gillo Pontecorvo; Waterloo (1970) di Sergej Fëdorovič Bondarčuk; Excalibur (1981) di John Boorman; Marco Polo (1982) di Giuliano Moltaldo dal libro omonimo, una miniserie televisiva di grande successo; Il Mahabharata (1990) dall'antico poema indiano quindici volte più lungo della Bibbia, portato sullo schermo dal geniale Peter Brook; L’ultimo imperatore (1987) di Bernado Bertolucci che di li a poco firmerà la regia di Il Tè nel deserto (1990) il suo capolavoro, tratto dall'omonimo romanzo di Paul Bowles, con John Malcovich; 1492- La conquista del paradiso (1992) diretto da Ridley Scott con la struggente colonna sonora di Vangelis; Il Gladiatore (2000) di Ridley Scott; Master& Commander (2003) di Peter Weir entrambi con Russel Crowe; Il velo dipinto (2006) diretto da John Curran, tratto dall'omonimo romanzo di William Somerset Maugham, girato prevalentemente in Cina.
Appartengono al genere ‘western & war’ nell’ampia accezione che mette assieme ‘spy e detective story’, e non solo: The big trail (1930) di Raoul Walsh e Ombre Rosse (1959) di John Ford; Da qui all’eternità (1953) di Fred Zinnemann con Burt Lancaster, Montgomery Clift, Debora Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra che, penso, non bisognano di alcuna presentazione; La valle dell’Eden (1955) di Elia Kazam con James Dean; Il gigante (1956) di George Stevens con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean; Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick con Kirg Douglas; I Magnifici 7 (1960) con Yul Brinner, Steve McQueen, Charles Bronson, Ely Wallach; La battaglia di Alamo (1960) di e con J. Wayne; Hatari! (1962) di Howard Hawks; Django (1966) di Sergio Corbucci con Franco Nero e riadattato dall’estroverso Quentin Tarantino; Il piccolo, grande uomo (1970) di Arthur Penn con Dustin Hoffman che dava seguito al genere ‘western’ con entratura psicologica; il bel documentario Le sorgenti del Nilo (1971) di Kenneth Haigh, tema ripreso poi Bob Rafelson in Le montagne della luna (1990); Il Messia (1975) di Roberto Rossellini; Il deserto dei Tartari (1976) di Valerio Zurlini tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati; il capolavoro assoluto di Franco Zeffirelli Gesù di Nazareth (1977) con un cast mozzafiato; tematica che sarà ripresa in La Passione di Cristo (2004) scritto e diretto da Mel Gibson, interamente girato a Matera in Italia; Nuovo Cinema Paradiso (1988) diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore; Teatro di guerra (1998) di Mario Martone, e Noi credevamo (2010) diretto da Mario Martone su sceneggiatura del regista e di Giancarlo De Cataldo, liberamente ispirata alle vicende storiche realmente accadute e al romanzo omonimo di Anna Banti.
Un discorso a parte va fatto per il ‘genio’ del cinema italiano Sergio Leone, uno dei più importanti registi della storia del cinema internazionale, particolarmente noto per i suoi film del genere ‘spaghetti-western’. Nonostante abbia diretto pochi film, la sua regia ha fatto scuola e ha contribuito alla rinascita del western negli anni sessanta, grazie a titoli come Per un pugno di dollari (!964), Per qualche dollaro in più (1965), Il buono, il brutto, il cattivo (1966) che insieme formano la cosiddetta "trilogia del dollaro", C'era una volta il West (1968) e Giù la testa (1971), mentre con C'era una volta in America (1984), ha profondamente rinnovato il lessico dei gangster movie tre pellicole che insieme compongono invece la "trilogia del tempo". Inutile dire quanti e quali attori già a suo tempo famosi del cinema americano ha fatto rivivere nei suoi film, uno per tutti quel campione d’incassi che fu Clint Eastwood. Nel 1972 con Giù la testa è stato vincitore del David di Donatello per il miglior regista. Nel 1985 con C'era una volta in America ha vinto il Nastro d'argento al regista del miglior film, è stato nominato al Golden Globe per il miglior regista ed è stato nominato al David di Donatello per il miglior regista straniero. Nel 1984 gli è stato inoltre assegnato il David di Donatello René Clair (premio che ora non viene più assegnato). Il 9 ottobre 2014 gli è stato attribuito, alla cerimonia del Premio America presso la Camera dei deputati, un premio speciale alla memoria dalla Fondazione Italia USA.
Tanto per spingerci oltre, sottolineo alcuni film dalle tematiche diverse e, tuttavia, riconducibili dentro un umico filone: Quarto Potere (1941) del pur geniale Orson Welles; Il padrino (1972), prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando con Al Pacino, James Caan, Robert De Niro, John Cazale, Robert Duvall; Apocalypse Now (1979) ancora di F. Ford Coppola con marlon Brando; Kagemusha (1980) di Akira Kurosawa; La mia Africa (1985) di Sidney Pollack dall’omonimo romanzo di Karen Blixen con Robert Redford e Meryl Streep; Mission (1986) di Roland Joffe con il pur grande Robert De Niro e il non da meno Jeromy Irons; Balla coi lupi (1990) diretto, prodotto e interpretato da Kevin Costner, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura e che vinse ben sette premi Oscar, tra cui quelli per il miglior film e miglior regista. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al settantacinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Infine, nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. L’ultimo dei Moicani (1992) di Michael Mann; Rapa Nui (1994) di Kevin Reynolds; La tigre e il dragone (2000) di Ang Lee; Titanic (1997) di James Cameron, remake dei film del 1958 e del 1979, e che segnò la rivelazione di Leonardo Di Caprio; L’ultimo Samuray (2003) di Edward Zwick con Tom Cruise.
Degni di nota e certamente non ultimi, tutti quei film accattivanti del genere ‘on the road’ quali: Due per la strada (1967) di Stanley Donen con la splendida Audrey Hepburn e con Albert Finney ; Easy Rider (1969) il capolavoro di Dennis Hopper; Jesus Christ Superstar (1973) dall'opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice; Dersu Uzala (1975) di Akira Kurosawa; Professione Reporter (1975) di Michelangelo Antonioni con quel ‘mostro sacro’ che è Jack Nicholson; Un mercoledì da leoni (1978) di John Milius; Hair (1979) di Milos Forman musical sui ‘figli dei fiori’; Reds (1981) di Warren Beatty con lo stesso W. Beatty, Diane Keathon, Iack Nicholson; Fuori orario (1985) di Martin Scorsese; Fandango (1985) di Kevin Reynolds, Stand by me (1986) di Rob Reiner; Mississippi adventure (1986) di Walter Hill; Rain Man (1988) di Barry Levinson. E ancora: Thelma & Louise (1991) di Ridley Scott; Un mondo perfetto (1993) di Clint Eastwood; Dead Man (1995) di Jim Jarmusch; Undergrounnd (1995) dell’originale Emir Kusturica; Verso il sole (1996) di Michael Cimino; L'AIbatross (1996) di Ridley Scott; Contact (1997) di Robert Zemeckis; Sette anni in Tibet (1997) diretto da Jean-Jacques Annaud, ispirato da un libro autobiografico scritto da Heinrich Harrer pubblicato nel 1953; Detroit Rock City (1999) di Adam Rifkin; Collateral (2004) con Tom Cruise e Nemico Pubblico (2009) con Johnny Deep entrambi diretti da Michael Mann regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, insomma quello che si può definire un cineasta eclettico e innovativo, considerato uno dei maestri del moderno cinema d'azione.
L’anno 2000 vede Babel (2006), Birdman (2014) e The Revenant (2015) entrambi di Alejandro González Iñárritu, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano con una particolare visione del cinema futuro; Into the wild (2007) di Sean Penn; nonché l’attesissimo The Hateful Eight (2015), scritto e diretto da Quentin Tarantino, ed interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern. E per finire, uno sguardo a quelle efficaci macchine ‘esaudisci-desideri’ che sono in tal senso da reputarsi: The beach (2000) di Danny Boyle; Road Trip (2000) di Todd Phillips; Riding the bullet (2004) di Mick Garris; I diari della motocicletta (2004) di Walter Salles sulle avventure del giovane Ernesto ‘Che’ Guevara, ispirato dai diari di viaggio Latinoamericana dello stesso Guevara e un di gitano che l’accompagna; Exils (2004) di Tony Gatlif, nome d'arte di Michel Dahmani, è un regista, sceneggiatore, compositore, attore e produttore cinematografico francese autore di alcuni film sui Rom; El Camino de San Diego (2006) di Carlos Sorin; Viaggio in India (2006) di Mohsen Makhmalbaf; Little Miss Sunshine (2006) di Jonathan Dayton; Into the wild (2007) di Sean Penn. Il discorso vale anche per tutti i film del genere ‘detective’ quali furano e continuano ad esserlo gli ‘007’ tratti dai romanzi di Jan Fleming e interpretati da quell’attore mitico che è diventato Sean Connery, rimasto ahimé senza validi eredi. Come si trovò a scrivere Gabriel G. Marquez in ”L'amore ai tempi del colera” (2007):
“Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce ma la vita li obbliga ancora molte volte a partorirsi da loro stessi.”
A proposito di sequel, ci sarebbe molto da dire della straordinaria saga di Star Wars (1977) dell’immenso George Lucas; Indiana Jones (1981) di Steven Spilberg il ‘più grande’ in assoluto, padre inoltre di E.T. (1982) e di Jurassick Park (1983); il seriale Batman (1989) di Joel Schumacher, comprensiva di almeno undici adattamenti tratti dal personaggio dei fumetti DC tra cui “Batman: L'uomo che ride” (Batman: The Man Who Laughs, 2005), titolo di una storia a fumetti che rielabora il primo incontro tra Batman e Joker e, inoltre, il nome di un personaggio della serie “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” creata da Masamune Shirow. Va detto che il cinema si era impossessato del personaggio Gwynplaine fin dal romanzo L'uomo che ride (1909) creato da Victor Hugo. “Das grinsende Gesicht” è invece il titolo del film tedesco del 1921 diretto da Julius Herzka. E ben altri due film furono tratti dalla medesima opera e sono: L'uomo che ride (1928) realizzato dal grande Paul Leni, e ancora l’omonimo film italiano del 1966 che Sergio Corbucci adattò sulla vicenda di Lucrezia Borgia.
Come dimenticare la trilogia del Il Signore degli Anelli (2001) di Peter Jackson, la trilogia basata sull'omonimo romanzo di John R. R. Tolkien; ed anche di Pirati dei Caraibi (2011) di Rob Marshall, basata sull'omonima attrazione dei parchi Walt Disney che si compone, fino ad ora, di quattro film prodotti da Jerry Bruckheimer e che negli anni si è espansa in fumetti, romanzi e altri media, a cui continua a prestare il volto un altro ‘mostro sacro’ del cinema, Johnny Depp, nei panni del pirata ‘Jack Sparrow’. Mah, se non ricordo male ho cominciato col parlare del cinema ‘muto’ come se fosse un’accadimento dell’altro ieri, forse che sì o forse decisamente nò, fatto è che nel 2014 c’è stato un film che pur essendo muto, che ci crediate oppure no, ha fatto molto parlare di sé: si tratta di ‘The Artist’ (2011), se non l’avete ancora visto è forse giunto il momento che ve ne procuriate una copia e gustarvelo fotogramma dopo fotogramma … vi delizierà.
«Bene, non ci mancava che questo!» – avrebbe esclamato Charlie Chaplin quando, nel 1929, il cinema da muto diventò sonoro e, per moltissimi anni a venire, mai l’ombra del dubbio appannò per un momento le sue certezze. L’attore (regista, musicista, sceneggiatore e scrittore), non ebbe tentennamenti, al punto che dopo la proiezione di una delle prime pellicole sonore annotava: «Uscii dal teatro convinto che il sonoro avesse i giorni contati». Chissà come se la riderebbe oggi Chaplin nel vedere che si fa la fila per entrare nei cinema dove si proietta ‘The Artist’, un film muto, in bianco e nero, che parla di cinema, ricreato dall’ “intelligenza” registica di Michel Hazanavicious (...per non dir del cane!). Tutto questo proprio mentre il sonoro si avvia alla tridimensionalità degli effetti speciali e della motion capture. Bene, tantopiù che abbiamo riso anche noi – plurale maiestatis – quando dopo la proiezione in sala e mentre scorrevano i titoli si è levato un applauso di godimento pieno, convinto e inaspettato.
Come ha spiegato dettagliatamente lo stesso regista, durante la conferenza stampa al festival di Cannes, si tratta di un “tipo di cinema dove tutto passa attraverso le immagini, attraverso l’organizzazione dei segni che un regista trasmette agli spettatori. E poi è un cinema molto emozionale e sensoriale: il fatto di non passare per un testo ti riporta a una modalità di racconto estremamente essenziale che funziona solo sulle sensazioni che sei in grado di creare”. Hazanavicious, autore della stessa sceneggiatura, ha confermato per la realizzazione della pellicola la coppia composta da Jean Dujardin (francese), che a sua detta “funziona sia sul primo piano, grazie all’espressività del suo volto, sia sul campo lungo, grazie al suo linguaggio corporeo”. Infatti ha un viso senza tempo, che può facilmente essere vintage; e la fascinosa Berenice Bejo che, almeno nel film, “emana una grande freschezza e positività quasi eccessiva! In un certo senso, i personaggi che interpretano sono abbastanza vicini a loro, o quanto meno, alla visione che ho di loro”. Il trucco c’è ma non si vede ed è nella non facilità di recitare senza dialoghi, pur calandosi nella parte, e facendo finta che questi ci siano, anche se poi il sonoro non viene registrato.
Una prova non indifferente, direi, che premia (era ora!) il cinema muto per quello che ci ha dato e, visto che all’epoca non c’era l’Oscar, credo che oggi questo film lo meriti davvero, anche dovesse essere “alla carriera”. Infatti rivedere oggi un “vecchio” fil del muto, (e questo è nuovo di zecca), oltre che a farsi apprezzare per essere così all’avanguardia e ancora pieno di idee, ci rinfranca lo spirito da tante pellicole “spazzatura” che non hanno neppure la dignità di chiamarsi CINEMA. D’accordo con Chaplin quando, dopo aver visionato ‘Melodie di Broadway’ (1929) diretto da Harry Beaumont, una commediola sonora del genere musicale molto scadente sotto il profilo artistico, disse: «Peccato, perché cominciava a perfezionarsi proprio allora … io però ero deciso a continuare a fare film muti, perché credevo che ci fosse posto per ogni sorta di svaghi». Una ‘civetteria d’autore’? Forse. No lo credo, è questa la conferma di un’arte, quella cinematografica, che proprio in quegli anni si andava diffondendo in tutto il mondo, per il nostro effimero piacere. I virgolettati sono ripresi dalla biografia di Charlie Chaplin edita da Mondadori e dalla rivista di cinema 35MM.IT Magazine.
Ma ahimé devo lasciarvi. Senza accorgemene per me si è fatta l’ora di lasciare quest’ultima pagina e correre al cinema. Oggi è in uscita mondiale il primo film della nuova serie di Star Wars (2015) ed io non me lo posso perdere. Lo so, da parte mia sarebbe corretto che una materia come il ‘cinema’, la sua evoluzione sociale, in quanto strumento, seppure atipico, della formazione necessaria allo sviluppo intellettivo e conoscitivo, venisse studiato più a fondo, in ambito ‘sociologico’ così come in ‘psicologia’ e in ‘filosofia’ per conseguirne l’apprendimento ‘a tutto tondo’ degli aspetti morfologici-ambientali, geografici-meteorologici, floreali e faunistici dei territori, delle montagne come delle foreste, dei mari e degli oceani; nonché per la conoscenza scientifico-biologica riguardante la fisicità e i comportamenti umani; la situazione socio-abitativa di paesi e metropoli, i costumi dei popoli ecc. ragioni per cui, e già solo per questo, il ‘cinema’ andrebbe più che mai sostenuto.
Tutte ragioni per cui, e già solo per queste, il ‘cinema’ andrebbe più che mai sostenuto; ma non mi sembrava il caso di entrare così in profondità in questo scritto che voleva solo scandagliare l’aspetto del ‘viaggiare’ e, anche se qua e là ho divagato tralasciando quella che era la tematica iniziale, spero di poterne riparlare in una prossima volta, magari citando quei film di ‘fantascienza’ che, contrariamente a quanto si vorrebbe, mi hanno sempre fatto sognare, e che oggi m’inducono a pensare di poter ‘viaggiare’ all’infinito negli spazi siderali del nostro universo, (visto che non c’è nessun altro), continuando a cercare un ‘altro’ ipotetico mondo: “..in fondo al cinema il bene vince sempre, o no?”. Ma dobbiamo costruirlo insieme, questo mondo di ‘argonauti del domani’, tutti noi unitamente con le nostre differenze e il nostro amore. Il perché lo conosciamo tutti: perché “..domani è un altro giorno” e noi vogliamo che sia ‘migliore’.
Così come ci ha lasciato scritto T. S. Eliot in “Four Quartets” (1943):
“Non finiremo mai di cercare.
E la fine della nostra ricerca
Sarà l'arrivare al punto da cui siamo partiti
E il conoscere quel luogo per la prima volta.”
N.b. mi scuso con tutti gli appassionati di cinema se ho volutamente tralasciato alcuni ‘generi’ (di cui scriverò in altra occasione), o dimenticato qualche titolo rilevante; soprattutto se ho commesso qualche errore eclatante nel citare questo o quello; posso solo dire che in questo viaggio spesso mi sono intenzionalmente perso, per poi ritrovarmi, alla fine di ogni proiezione, davanti a uno schermo vuoto, in attesa che la macchina da presa torni a girare per Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, John Turturro, Gabriele Muccino, Silvio Soldini, Ferzan Ozpetek, Roberto Faenza, per un altro fantasmagorico giro di giostra … ops, di manovella.
Bibliografia per saperne di più:
“Antologia della letteratura fantastica”, Autori Vari – Editori Riuniti 1981.
“Storia della letteratura del terrore”, David Punter – Editori Riuniti 1985.
“Il primo film sonoro italiano: La canzone dellìamore” di Gennaro Righelli. Catalogo della Biennale di Venezia 1980.
“La voce nel cinema”, Michel Chion – Pratiche Editrice 1982.
“Il linguaggio delle immagini in movimento”, Virgilio Tosi – Armando Editore 1984.
“Sperduti nel buio”, a cura di Alfredo Barbina, Centro Sperimentale di Cinematografia – Nuova Eri 1987.
“Storia e technica del film e del disco”, Mario Calzini – Cappelli Editore 1991.
“Il cinema nascosto” Le pellicole ardite nell’archeologia cinematografica, Pino Pelloni – Marianna Ediz. 1998.
“Cinema muto italiano” (1896-1930), Riccardo Redi – Biblioteca di Bianco & Nero 1999.
“Fino all’ultimo film” L’evoluzione dei generi nel cinema, a cura di Gino Frezza – Editori Riuniti 2001.
Cinegrafie: “Il comico e il Sublime”, Autori vari – Rista annuale della Cineteca del Comune di Bologna n.10, 2006
“L’arte di guardare gli attori”, Claudio Vicentini – Marsilio 2007.
“Scrivere sceneggiature per il cinema e la TV”, Francesco Spagnuolo – Delos Books 2010.
“Filmare la musica” Il documentario e l’etnomusicologia visiva, Leonardo D’Amico – Carocci Editore 2012.
*
 - Letteratura
- Letteratura
LUCANIA / BASILICATA: la tradizione ‘sommersa’ del Sud
La Lucania/Basilicata, cosiddetta anche ‘la terra del rimorso’, è una regione di classica bellezza e di eccezionale varietà di aspetti, che comunicò a Roma ed al mondo occidentale l’impulso della civiltà greca e mantenne viva la tradizione dell’arte bizantina.
“Come amorevolmente protetta da robuste braccia, fra le due estreme penisole della Iapigia e della Calabria, regni delle Murge e delle Sile, si apre la classica costa ionica dela Basilicata, alla quale fanno corona la tragica Metaponto, bella ancora di templi dorici, la bianca Pisticci ricca d’industrie, Montalbano Ionico, centro agricolo e la fiorente Policoro, vicina ai resti di Heraclea che col castello dei Berlingieri, attorniato da umili abituri, domina la sua opulenta pianura e il mare …”.
Inizia così il bel libro “La mia Basilicata” di Concetto Valente che il figlio Giuseppe ha voluto dedicargli postumo nel centenario della sua nascita:
“La spiaggia e la circostante silenziosa pianura, sembra ora ridestarsi da un sonno che si perde nei tempi ed avvince per il suo vero e molteplice aspetto antico e storico, artistico, culturale e pittoresco: contrada che meglio custodisce il tipo del paesaggio classico, solenne e suggestivo. Proprio in questo sacro silenzio emergono le linee di una energia primaverile, in cui il soffio stesso è il caldo alito di una febbre di altezze e di aspirazioni sante. E la campagna racchiude in sé i segni possenti delle età passate …”.
Ben poco rimane all’immaginario da fantasticare, la colta descrizione parla da sola, ancor più quando lo scrittore si abbandona al canto lirico del poeta che leggiamo nelle pagine seguenti:
“Dal golfo s’inerpica la terra lucana tra colli e monti, le cui vette brulle ed immacolate immerse nell’azzurro formano la gradinata gigante dinanzi alla immensa valle solitaria ed all’arco aurato della spiaggia. Dalle schiere di colline e monti, interrotte da strette pianure ubertose e da fresche valli, s’innalza repentino, come nube a Mezzogiorno, a confine con la Calabria, il massiccio del Pollino, dalla cui vetta l’occhio abbraccia un vastissimo orizzonte che comprende la visione di mezza Basilicata e spazia dal Tirreno, fino al porto di Taranto ed oltre. (..) E già emergono terre più ricche e sane, specie intorno all’oasi di Policoro, già bella di superbi e fregranti frutteti, e così in tutta la pianura ionica stanno estendendosi più fitti aranceti, albicocchi e pescheti, salutati sulle prime colline dall’antico fluttuare di ulivi, di potenti carrubi, di grandi quercie, di favolosi pini, di pruni, fichi, mandorli ed ancora aranceti e cedri”.
“Le montagne della Basilicata hanno una caratteristica tutta particolare: vette superbe dominanti panorami meravigliosi e vari, profili staglianti ed ora armonici, che a guisa di anfiteatri racchiudono ridentissimi piccoli laghi selvaggi. Spesso città antiche, belle e custodi di opere d’arte d’immenso e pregevole vale subliminano queste alture; l’antichissima Matera dei Sassi, ricca di opere d’arte di ogni tempo d’inestimabile valore, Montescaglioso, Irsina, Tricarico, Acerenza, Venosa, Lavello, Melfi e l’aerea Potenza, che dalla sua altezza giganteggia sull’antica e gloriosa Valle del Basento e su quella ampia di rione S. Maria, verde di boschi, “boschetti”, “macchie” e giardini.
La Basilicata non è terra improvvisa; cova dentro il suo fuoco ed ha il pudore e la gelosia dei suoi sentimenti più profondi. La bontà gli è riconosciuta; la giustizia presiede a qualsiasi giudizio delle moltitudini. Capace d’impeti mistici e di lunghe vigilie, la sua gente è ragionatrice, ponderata per indole, è vigile nelle analisi e si eleva a mirabili sintesi. Vuole essere epicurea ed è di natura nostalgica. Il suo custico umorismo non uccide ed è edificatore. Vuol ridere e si accora di un niente. Ascoltatela nelle ore gravi, terra sacra ai campi; terra sacra alle opere eterne. La sua gente vi fatica senza amarezza: la stella dell’alba è salutata dal canto del boaro; quella del crepuscolo ancora sente cantare gli uomini che ritornano verso le case disperse, che il monte cova ed il cielo inazzurra. La divina natura spesso inspira il cantore popolare, che commosso trova un’alta espressione sulle labbra per la terra madre:
“Sienti,sienti! La terra mi parla chiani
sienti sta mamma antica
ca mi chiami e mi vole se songh luntani!”
Per la gente lucana la maggior vita è all’aperto, la sua primavera è gagliarda. Vediamola nel rito delle grandi opere sacre: la semina, la mietitura, la vendemmia.
I contadini di Maratea e di Acquafredda, a breve distanza dal classico lido dei templi pelipteri immortali di Paestum, come quelli delle colline del Mare Ionio, così del Pollino, Volturino, Areoso e Vulture o lungo il Bradano, Basento, Agri, Sinni e Ofanto, al tempo della mietitura del grano, verso sera quando il sole sta per giungere al tramonto, sospendono il lavoro e si inginocchiano dinanzi al sole che muore. Nella dolcezza dell’ora il massaro intona una Ave Maria alla quale i mietitori rispondono in coro sollevando le falci verso il sole : “Siano lodati Gesù e Maria”.
Le tradizionali visioni mistiche ridestano la gente nei campi il contadino è tutt’uno con la sua terra, alla quale la sua vita è connessa immutabilmente. La ama profondamente. Conosce il cammino della sua casa, conosce l’ombra dei suoi pagliai. Ogni angolo dei suo campi, ogni fossatello, ogni vite, ogni olmo gli sono familiari ancor più della faccia della donna sua. E questo gli basta. Egli non può far passare il giorno che non percorra i suoi campi fra le siepi ben tenute; va fra la nebbia o la neve; studia i frusoli delle sue viti, le gemme dei suoi peschi, il verde dei grani pallidi, che debbono cespire. Non chiede di più. Emigra; arricchito ritorna in patria e riprende a lavorare il suo lembo di terra, al quale ha dato una fisionomia, un nome e un cuore. Riprende l’opera di rinascita a favore del suo tempo.
Risuonano nel suo cuore di uomo antiche melodie. E così nei vecchi orti di Venosa ove grandi massi poligonali, fra torri, dominano il Vallone Ruscello, formando insieme il loro miracolo di poesia e di realtà, di presente e di passato, di rovine classiche e di architetture medievali, io potetti ascoltare un canto leggere, fresco, di seminatori:
“Lu cieli si inondava di grazia
mentre la selva mormorava cupa.
A Vergine Maria s’assettò
all’ombra dell’auliv; tutt’e frasche
abbasciannisi vasaren’a Gesù.
Evviva Maria
e chi la creò.
Lu cieli si inondava di grazia
mentre la selva mormorava cupa”.
La bella strofa mistica, come un canto umbro, pareva munita, pel suo volo, di candide ali, fra i severi ruderi latini. Un altro canto mistico nel periodo dei pellegrinaggi a San Miche le del Gargano ed alla grotta di San Michele di Monticchio, richiama il culto bizantino per San Luca Corleone e per San Vitale – che dopo aver difeso leoninamente Armento contro i Saraceni, maceravano le loro carni nelle grotte basiliane del torrente Melfia (Vulture), ove dipinsero santi ieratici e simboli del Cristianesimo – e ricorda ancora la tradizione dei cavalieri longobardi e dei loro rappresentanti spirituali, i monaci latini, che ne arricchirono la leggenda introducendo nell’Italia meridionale il culto per San Michele Arcangelo, il cristianizzato giovane Sigfried uccisore del drago, al quale furono dedicati santuari sulle cime dei monti della Lucania. La dolce melopea religiosa così risuona richiamando l’influsso del genio artistico locale:
“San Michele lu potente
ha uccisi lu serpente;
l’ha uccisi p’amore di Dio.
Evviva, evviva San Chele mio.
E San Luca lu viggente.
Salva, salva tu Armento;
salvalo tu per amore di Dio
Evviva, evviva San Luca mio”.
Ogni regione si sa ha il suo aspetto particolare, la sua personalità che la distingue e quella di Basilicata/Lucania non va del tutto confusa con quella di Sicilia o della Campania, pur dividendo con queste talune somiglianze e evidenti scambi, se vogliamo, invevitabili con la Iapigia per il grande dominio culturale che sul litorale ionico ebbero con le città della Magna Grecia, le cui superstizioni sopravvivono nel sacro e nel divino di oggi. Con ciò si vuole qui offrire un prezioso materiale di demopsicologia con l’intento di studiare l’anima popolare e di offrire alcuni documenti dei valori spirituali della razza, senza escludere quelle che sono le tradizioni pagane tutt’ora ‘vive’ sul territorio. Molti paesi sappiamo, offrono un largo campo di osservazione per quanto riguarda i costumi, i canti, i riti occulti e l’arcano dei ricordi orali, che attraversano la favolosa antichità del medioevo:
“Usanza senza dubbio del periodo di Metaponto, di Siris, di Heraclea, di Paestum, è il rito che si pratica lungo la costa jonica di Pisticci, di Policoro, di Nova Siri e sui colli del Senise, di Sant’Arcangelo, di Ferrandina, Colobraro (in Lucania), e di Calimera, di Melpignano e di Castrignano (nella Iapigia) e che consiste nella celebrazione delle ‘prefiche’ sui morti. Sono donne, dette ‘repite’ che, a somiglianza delle antiche ploratrici, piangono e cantano lungamente sui cadaveri dei defunti” (C. Valente, op.cit.). A questa usanza l’etnografo Ernesto de Martino dedica nel libro “Morte e pianto rituale” (Boringhieri 1975), un intero capitolo: “Il lamento funebre lucano”:
“Può sembrare strano che una ricerca storico-religiosa sull’antico lamento funebre rituale si apra con una giustificazione metodologica che riguarda una particolare indagine etnografica. (..) Un procedimento così eccezionale, e a prima vista così discutibile, è certamente bisognoso di una giustificazione che riguarda la determinata ‘tecnica del piangere’ come quella messa in atto nel Sud, cioè un modello di comportamento che la cultura fonda e la tradizione conserva al fine di ridischiudere i valori che la crisi del cordoglio rischia di compromettere. In quanto tecnica (quella del pianto rituale) che riplasma culturalmente lo strazio naturale e astorico (lo strazio per cui tutti piangono ‘ad un modo’), il lamento funebre è azione rituale circoscritta da un orizzonte mitico”… (De Martino, op.cit.)
Riproduco un brano del lucubre pianto trascritto nel volume di C. Valente:
“Chi sa mai, chi sa mai la mamma tua
quando essa verrà?
Quando tu vedrai l’uomo
arare nel mare!
Chi sa mai, chi sa mai la mamma tua
in che tempo tornerà?
Quando vedrai l’uomo mietere
in mezzo al mare.
Chi piange, chi piange alla vista
chi piange più assai?
Colui che ha perduto la sua gente
e gli strappa l’anima.
Oh le genti, le genti nostre
che erano tante, tante …
Le nostre case si svuotarono
e ne son piene le sopolture.
Oh le nostre genti, le genti nostre
che erano tutte in armonia!
Le nostre case si svuotarono
e ne sono piene le chiese.”
Questa tradizione richiama la scena delle prefiche disegnata su un ‘askos’ di stile geometrico risalente al V secolo a.C. trovato a Lavello e custodito nel Museo di Reggio Calabria ma ripresa in parte dalla ceramica lucana dipinta sul quale è delineato un corteo funerario con cinque figure femminili, delle quali tre ugualmente vestite di bianco e due figure muliebri vestite di nero e in atto di piangere.
“Sempre in quanto tecnica del piangere il lamento funebre antico concorre, nel quadro della vita religiosa (di un popolo o pure solo di una razza), a mediare determinati risultati culturali; ciò significa che attraverso i modelli mitico-rituali del pianto sono mediatamente ridischiusi gli orizzonti formali compromessi dalla crisi, e cioè l’ethos delle memorie e degli affetti, la risoluzione poetica del patire, il pensiero della vita e della morte, e in genere tutto il vario operare sociale di un mondo di vivi che si rialza dalle tombe e che, attingendo forze dalle benefiche memorie di ciò che non è più, prosegue coraggiosamente il suo cammino. (..) Tuttavia ai fini della ricostruzione il lamento (funebre) come tecnica, la documentazione funeraria antica presenta dei limiti definiti, che le integrazioni comparative non possono superare senza lasciare troppo margine all’immaginazione. Così i lamenti che ci ha conservato l’epos o la tragedia o la lirica della morte sono ormai letteratura e poesia, non rito in azione, e non è agevole raggiungere il lamento come rito partendo dalla sua elaborazione letteraria e poetica.” (De Martino, op.cit.)
Va detto che Ernesto de Martino aveva già proposto questa tematica anche in altre ricerche, esposta per lo più nei due libri che più lo rappresentano: “Il mondo magico” (Boringhieri 1973) sull’angoscia territoriale e riscatto culturale; e “La terra del rimoprso”, contributo a una storia religiosa del Sud (Boringhieri 1961). Ed ancor prima in “Sud e Magia” (Feltrinelli 1959) interamente dedicato alla ‘Magia lucana’, ai temi della ‘fascinazione’ e della ‘jettatura’ (napoletana) entrambe ancora molto presenti nella cultura del meridione. “Il tema fondamentale della bassa magia cerimoniale lucana è la fascinazione (in dialetto ‘fascinatura’ o ‘affascino’). Con questo termine si indica una condizione psichica di impedimento e di inibizione, e al tempo stesso un senso di dominazione, un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l’autonomia della persona, la sua capacità di decisione e di scelta. Col termine ‘affascino’ si designa anche la forza ostile che circola nell’aria e che insidia inibendo o costringendo chi la subisce”:
“Chi t’ave affascinate?
L’uocchie, la mente e la mala volontà.
Chi t’adda sfascinà?
Lu Padre, lu Figliolo e lu Spiritu Sante.”
A cui fa seguito lo scongiuro rituale:
“Duie uocchie t’hanno affise
Tre te vonno aità
Sant’Anna, Santa Lena, Santa Maria Maddalena.”
In aggiunta si mormora:
“Scende la Madonna co’ le mane sante
In nome del Pdre, Figliuolo
e Spirito Santo.”
“Al contrario i relitti folklorici del lamento antico ci permettono ancor oggi di sorprendere l’istituto nel suo reale funzionamento culturale: e ciò che la documentazione antica ci lascia soltanto intravedere o immaginare, cioè il lamento come rito in azione, la documentazione folklorica ce lo pone sotto gli occhi in tutta la sua evidenza drammatica, offrendoci in tal modo non sostituibili opportunità di analisi. (..) Tuttavia anche se il lamento funebre folklorico ha perso il nesso organico con i grandi tempi della religiosità antica, e anche se i suoi orizzonti mitici sono particolarmente angusti e frammentari, esso può fornire ancora, almeno nelle aree trattate e di migliore conservazione, utili indicazioni per ricostruire la vicenda rituale che, nel mondo antico, strappava dalla crisi senza orizzonte e si reinseriva nel mondo della cultura autoctona.” (De Martino, op.cit.)
A questo proposito, per meglio comprendere la lezione di De Martino, riporto qui un passaggio riferito alla ‘morte’ di Vincenzo Bo da “La religione sommersa” (Rizzoli 1986):
“La ripercussione attraverso la parentela (che pure si esplicitava come dolore per la perdita, diventava, ed era, un ‘crisi di gruppo’ di appartenenza. Ciò scaturiva da certi comportamenti rituali (mitici e sociali) nei quali certamente agivano , e interagivano, componenti diverse da quelle mortuarie. Ma non c’è dubbio che in tali mitologemi e in tali comportamenti rituali, sia a livello di crisi collettiva che accompagnava ogni morte, sia a livello della tensione e dell’angoscia che apparivano radicate nel sentimento dell’incertezza e della precarietà esistenziale. La vicenda ‘morte’ aveva ed ha una motivazione predominante e prevalente, tanto che non mancano studiosi i quali, a livello di ipotesi, fanno risalire l’origine della religione al tema della morte. In questa prospettiva, le mitologie dell’al di là, della sopravvivenza, dell’immortalità, i riti di seppellimento, di placazione, di venerazione dei morti e degli antenati si fondevano nella comune funzione di risposta all’illogicità della morte; diventavano tentativi per sostituire la sicurezza alla precarietà. Così il mito assolveva una funzione salvifica nel senso che, reagendo attraverso l’ideazione mitica, l’uomo e il gruppo si riscattavano dall’angoscia esistenziale e risolvevano la crisi emergente da ogni singola morte.”
Ma mentre presumibilmente tutto questo accadeva, quale era la funzione del rito?
“Il rito – prosegue Vincenzo Bo – doveva invece soddisfare sia l’esigenza istintiva, immediata, di esprimere il dolore e il dramma del distacco (che era più intensa e naturale quanto più prossimo era il grado di parentela o il rapporto di convivenza e di consuetudine), sia quella di risolvere il problema di fondo che stava nella crisi e nell’angoscia provocata dall’evento. Entro queste linee vanno pure riletti i miti dell’origine della morte e dell’immortalità primordiale, i miti di trasformazione della morte in passaggio all’immoertalità (si pensi, per esempio, nell’ambito dei miti più conosciuti ed elaborati, all’Ade pagano, ai misteri orfici, alla trasmigrazione delle anime ecc.), i miti della sopravvivenza (si pensi ai fantasmi, agli spettri, ma anche ai morti che ritornano, alle anime, alle ombre). Entro tali linee vanno pure riletti i fenomeni di ritualizzazione del duolo e del lutto, trasformati da ‘fatto primario istintivo’ (dolore per la morte e per il distacco) in una manifestazione che, seguendo schemi obbligati, tradizionali che, non solo si rende necessaria anche quando il fatto istintivo viene meno, ma può essere delegata a terzi, come a detentori delle giuste tecniche del duolo, appunto: la prefiche.”
Sono legati al rito funebre anche i numerosi ‘pianti’ mistici appartenenti alla Lucania mistica:
“U chiande de Marie Addulurate” (in C. Valente, op.cit.)
“Chiange Marje la povera donna,
ca la sua figghie è giute a la cunnanne.
- No lu chiangenne cchiù ca non ce torne.
È giute a la case de chidde teranne.
Tante lu chiande ca fasce la Madonne
Curre Giuanne a cumpurtà Marje!
- Curre Giuanne, a quantamore me puorte
Scem’a a bedé ci lu fighhie m’è bive o muorte
- O vive o muorte lu travaraje
La via ch’amme fatte amma da faje.
. . .
“Marje chiange Gesù” (in C. Valente, op.cit.)
“Figlie, t’adora pe sta santa téste,
de crone de spine ‘ncurunate fuoste
- Ohi figlie, ohimé!
Quante patì Gesù per mè.
Sono stata io l’ingrata
O mio Dio, perdone pietà.
- Figlie, t’adore pe sta santa fronte
me parà lu sole quanno sponte!”
. . .
Scrive ancora C. Valente: “Ma, oltre alle laudi severe della Settimana Santa, fra i monti della Lucania risuonano altri canti mistici, lì ove c’è anima, c’è sentimento, c’è dolore, ove c’è finalmente poesia. (..) Come nelle laudi dei poeti umbri, nei canti mistici l’espressione nuda del sentimento ha tutto l’impeto e il singulto della pura verità umana e l’amore divino non è che un riflesso dell’amore umano.”
Richiamo qui un leggero e fresco canto mistico della gente lucana:
“Stedda Mattutina” (in C. Valente, op.cit.)
“È fatte juorne e sie lu benvenute
beneditte sia Die ca l’ha criate
Ti preje Gesù mje de darme aiute
concedami la pac’e la virtute
inta a chesta santa sciurnate.”
Famosi sono anche i riti nuziali, quelli per il Calendimaggio, le Cavalcate, le Processioni e i Pellegrinaggi che vengono talvolta riproposti con grande partecipazione popolare, come: “Il carro trionfale di Matera”, “Il pellegrinaggio di Fondi” e “La processione dei Turchi a Potenza”; quella per il “Corpus Domini al Santuario di Viggiano”, e la “Leggenda dei petali” (I pip’l):
È questa una leggenda di alta ispirazione mistica in cui si narra: che nei tempi del martirologio cristiano una popolana di Potenza, nel lavare la biancheria giù al fiume Basento, ricordandosi che là vicino era stati suppliziati dodici martiri cristiani venuti dall’Africa, volle prendervi qualche loro reliquia – come scrive Paolo da Grazia: “Raccolse dei fiori inzuppati del loro sangue e se li portò a casa e li conservò in una pezzuola di candido lino. Dopo parecchi anni trovò i fiori ancora verdi come se fossero stati colti allora. Stupita li portò ad una asceta perché li conservasse in chiesa. Il ministro di Dio così fece e li conservò. E da allora ogni anno, il primo di settembre, in occasione della festa per i Dodici Martiri, si mostranvano al popolo i fiori verdi che aprivano i loro bocciuoli o petali, detti “pip’l”. Per questa tradizione d’ispirazione religiosa e di candida fede migliaia di giovinette del popolo, per la festa del Corpus Domini, dalle finestre e dalle terrazze di via Pretoria, adorne di damaschi, di tappeti e di coperte di seta, come un leggiadro e fantasioso mosaico di broccati, di oro e di ricami, salutano il passaggio del Santissimo sollevato dal Vescovo sotto una pioggia di fiori.”
E quindi propongo un canto ‘umoristico’ legato a “Lo scaricavascio” di Melfi con significazione storica risalente al 1799, epoca in cui i maggiorenti melfitani, in luogo di organizzare una strenua difesa della città, preferirono aprire le pèorte di casa propria alle orde devastatrici del Cardinale Ruffo. L’atto ritenuto vile, urtò il sentimento della popolazione che, non potendo altrimenti esprimere la propria indignazione in quei tempi di scarsa libertà, riuscì a significare nel canto detto dello ‘scaricavascio’, la insicura stabilità del dominio paesano che i maggiorenti, i sanfedisti, avevano ottenuto dal favore del Ruffo in cambio della resa. Il gaio ritornello – scrive A. Cantela – cantato da otto giovani contadini, quattro dei quali danzando sostengono il peso degli altri quattro, che si levano in piedi sulle spalle dei primi, tenmendosi stretti l’uno all’altro con le braccia. Nel balletto faticoso delle improvvisate torri umane che ne conseguono, la fertile fantasia popolare ricamò alcune strofe d’occasione i cui versi rivelano ai dominatori che se il popolo si sottrae al gioco del loro dominio, il capitombolo è inevitabile. Lì dove ‘Pizzic’Andò’ sta a significare: con tutto il pericolo, balliamo pure!.
“Canto per lo ‘scaricavascio’”
“Vuoie ca state da sopra
Statev’attinte ancora: cadite …
Se si spezza lu ram di sotto
Ve ne sciate di capisotto.
Lu vide lu scaricavascio?
Lu vide e sembra mo
Pizzic’Andò, pizzic’Andò.”
Ciò non toglie che in Lucania non si canti l’amore …”Il canto sgorga su dal cuore innamorato e trae ispirazione dalle tempeste dell’anima. Il popolo canta ed esprime la sua consolazione della fatica, la gioia del vivere e la sua fede con immagini delicate e pensieri pieni di tenerezza. A volte la poesia si fa profonda, più vivace e dolorante e accenna a intime lotte in descrizioni di vita popolare che raggiunge un alto valore lirico. Nenie nostalgiche e canzoni d’amore rivelano una malinconia pensosa, che è poi l’essenza dell’anima lucana, gaia talora solo in superficie, come negli esempi di ‘fronna’ che seguono:
“Canzuna nova” (in C. Valente, op.cit.)
“Voghhiu cantari ‘na canzuna nova,
pa gilusia ca mi struggi u core.
Gioia, l’amuri toj strittu mi teni!
Vurria tuccari l’unna ri lu mari
vurria vulà pi li cieli sireni.
Vurria cent’uocchi pi ti riguardari
milli cori pi ti vulì chiù beni.
La gilusia mi consumi u core
e ti voghhiu cantà a canzuna nova.”
“Quann nascisti tu” (in C. Valente, op.cit.)
“Quann nascisti tu nascì la rosa,
nascì la pampanella e la cirasa;
intra sta strada nc’è na rinninell’
ca se ni pregg’ di lu su vulà,
en c’è nu falcunetti pint’e bell
ca va ‘ngiri ca ta d’ancappà.
Intr’a sta strada nc’è n’arb’ de rose,
ca pi l’addore non si pote sta;
dincill’a lu patrun’ ci li cogghi,
nun li facesse cchiù spampanà,
mena lu vient’ e tutt l’arravoggh
tutt’ le verd’ frunn’ nt’erra vonn.”
Pei campi dove le viti e gli argentei ulivi si diradano verso le montagne del Pollino e del Serino, corona di balze e di boschi, fanno coro al canto villereccio, l’armonia delle fagose, il suono idillico delle campanelle, e lo scroscio dei torrenti …
“Lu rusignoli d’amori” (in C. Valente, op.cit.)
“Rusignoli d’amori, rami, rami
fai na cantata, t’arriposi e voli,
cova la compagnedda, e tu la chiami
pi lo toi canti cchiù bene tè voli.
Lo mj ciatuzzi a paesi luntani
chianci, lo chiami e turnari non voli,
se fossi rusignoli, monti e chiani
pesseria per truvarla intra dui voli.”
Famose sono anche le ninne-nanne e le serenate:
“Fammi la ninna, bello di la mamma
Sii piccininni e th’ai da cresce granne.
Famme la ninni, bello mmio e dduormi
Mò so ‘ncagnato, e ti chiami lu suonno.
Lo suonno mm’ha promiso ca vinia,
Mò mm’ha gabbato e sta mmienzo la via”
. . .
“Lamento d’amuri” (in C. Valente, op.cit.)
“Oh quanta vote m’hai fatti vinire,
sott’a sta finesta a sospirare.
Mmai fatto consummà da li sospiri,
nun t’hai voluto ‘na vota arranzare.
Arranzati ‘na vota pe’ gentilezza,
doi parole ti voglio addumannare:
‘la mmia billezza no’ la puoi avere,
ca si fraschetta, e no’ la sai godere.”
“Contrasto” (in C. Valente, op.cit.)
“Che t’agge fatto chi mmi port’u musso?,
quanni mi viri cu ll’uocchi t’arrasse.
Scocca di rosa fatta di un mazzo,
o ronna carricata di billezza.
Quanni mmi guardi cu’ l’uocchi m’ammazzi,
mi viri ‘ntra lu fuoco e mmi ci attizzi.
Tu mm’hai ligato cu’ ‘nu lazzo,
cu ‘nn capill’biondo di ‘ssa trizza.
Tu mm’hai ligato, e nu’ mmi pozzo scioglie,
cumme a fili di seta mm’assottiglio.”
Con queste semplici canzoni d’amore, cantate come messaggi da una gioventù priva di ogni distrazione, il cui pane e sale della vita era nient’altro fatto di ansie e di lavoro, gli stati d’animo di desiderio, di sdegno e d’odio si susseguono e trovano una loro vena poetica schietta e spesso insolita di giovinezza ardente e, soprattutto, vigorosamente autentica. E sia benedetta questa luce fatta di passione, di sentimento puro inestinguibile. Tuttavia, la Basilicata/Lucania non è solo questo. Con questo articolo pur breve, tanto ci sarebbe da parlare, voglio salutare la gente tutta e dare il benveuto a Matera città d’arte che in questo anno 2016 è stata designata dall’UNESCO quale ‘Capitale Europea della Cultura’. E il ricordo va altresì allo studioso Concetto Valente che voglio ringraziare per il suo libro più volte citato e dal quale ho tratto a piene mani ogni sfumatura, e che tra le altre interessantissime cose di cui egli ci narra, così descrive la città di Matera:
“Una nota possente del paesaggio materano (..) è dato dalle ben note gravine scavate nei tufi e nei calcarei compatti – nelle voragini che separano le doline delle murge scendenti a gradinata verso il mar Ionio. La città si distende sui declivi di due valli profonde scavate dalla natura nel tufo seguendone la forma ed il declivio, chiamate Sasso Barisano e Sasso-caveoso. È dominato il Sasso-caveoso da un irto e severo scoglio con ai piedi una chiesetta bizantina scavata nella roccia. E le case dei Sassi, in gran parte aperte nelle doline tufacee, sono costruite in modo che l’una serva di base all’altra. Serpeggiano ripidi viottoli fra abitazioni primitive dominate da rocce e con scalinate sostenute da rozzi archi rampanti. Le caratteristiche abitazioni trogloditiche sostengono spesso ampie e impervie vie che si incurvano fra i comignoli delle case. L’interno della casa trogloditica è rivestito di intonaco ed ha lo stesso arredamento della casa comune. (..) Del sentimento religioso della gente lucana, le cappelle, le edicole e le croci, presenti nelle costruzioni, ci parlano le leggende sacre, le grotte aperte nei cupi recessi del monte Vulture, del monte Raparo e delle gravine di Matera, (..) ma perché il ‘frutto’ dell’arte si coga, conviene attivare questo semplicissimo criterio: laddove fioriscono forme speciali d’arte esse dovranno rinnovarsi, essere prese, continuate, adattate ai gusti dei tempi nuovi, senza che perdano nell’uso nulla della loro essenza, della natura propria della razza che vi impresse spontaneamente i suoi caratteri, le sue intime tendenze, le sue idealità.”
E con questo commiato, che a me sembra il messaggio più cospicuo e appagante dell’opera di Concetto Valente, scomparso nel 1954, al quale l’insigne Paolo Toschi ha voluto lasciare una dedica in cui gli riconosce la nobiltà della figura di studioso e di poeta, saluto e ringrazio il figlio Giuseppe che ha permesso di accedere all’opera del padre con la citata pubblicazione. Ed anche ringrazio tutti voi che mi leggete su larecherche.it
Concetto Valente (1881-1954) nativo della Lucania, fu direttore del Museo Archeologico Provinciale della città di Potenza, dal 1928 al 1954 anno della sua morte; colui che più di tutti si occupò di arricchire le collezioni artistiche museali. Nel 1925 ottenne la medaglia d’oro dei “Comuni d’Italia” dal Ministro della Pubblica Istruzione; ancora la medaglia d’argento nel 1942 concessa sempre dal M. della P. Istruzione per la diffusione ed elevazione della cultura e dell’educazione nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione. Infine, nel 1955 è stato insignito della medaglia d’argento alla memoria, dal Presidente della Repubblica per i benemeriti della cultura. Nel 1932 curò la “Guida artistica e turistica della Basilicata” una monografia con testo a stampa, riproposto poi con aggiunte nel 1948.
*
 - Musica
- Musica
SALERNO/LUCANIA/CILENTO La tradizione ’nascosta’ italiana.
(Musica popolare del Salernitano, Cilento, Lucania e Vallo di Diano)
Nell’impossibilità di trattare la musica popolare della Campania come un insieme unico ed equipollente di suoni canti e balli tradizionali e, in ragione delle diversità che pure la compongono, ho trovato di particolare interesse l’investigazione etnomusicale avanzata dal Teatrogruppo di Salerno attivo negli anni 1970-78, per aver questo incluso nella sua ricerca sul territorio, strumenti, musica e canti di aree poco frequentate e lontane dalla tradizione partenopea, comprese nell’area salernitana e quella lucana dell’odierna Basilicata. Una ricerca ‘sul campo’ sfociata nella produzione artistica di due album (LP Albatros 8274 / 8373) rispettivamente del 1975 / 77, frutto di esperienze teatrali portate ‘in tour’ per il paese e che, per quanto paradossale possa sembrare, hanno contribuito a restituire e a far conoscere alcuni aspetti originali di quella musica popolare tipica delle aree rurali e contadine campane che pure lasciavano trasparire un rimando culturale diverso.
In realtà il Teatrogruppo, composto da una ventina di elementi, ha svolto ricerche in direzione della musica popolare del salernitano e dell’avellinese, nella regione più a meridione del Cilento e del Vallo di Diano, spostando l’attenzione sulla rielaborazione del materiale raccolto all’interno di un discorso sulla ‘nuova canzone’ che ha poi portato in forma di spettacolo nelle scuole e nelle sagre paesane. Da ricordare la presenza del gruppo al ‘Maggio popolare’ tenuto al CRI di Milano e curato da Roberto Leydi e Bruno Pianta, durante il quale ha tenuto un seminario sulle musiche popolari in Campania. Successivamente ha partecipato al ciclo di concerti ‘Musica popolare e folk revival’ tenuti alla Piccola Scala di Milano nella primavera del 1976. Il discorso del Teatrogruppo non si è limitato alla riproposta musicale filologicamente corretta, ma ha puntato anche al recupero della mimica, della gestualità, elementi assolutamente inscindibili dal contesto musicale e che sono sempre presenti nella espressività popolare.
Ancor più vanno ricordati gli spettacoli propriamente teatrali come la partecipazione al ‘Marat-Sade’ di Peter Weiss nel 1970/71; il rito ‘Collages’ (elaborazione collettiva 1972); ‘Leonzio e Lena’ (da Georg Büchner 1973/74); ‘Pulcinella e Fanfani’ intervento di strada con grandi pupazzi (da un canovaccio di Michele Gandin 1975); Intervento e ricerca sulla cultura e la teatralità popolari nella Campania meridionale (dal 1974), ed ovviamente altri dei quali si è in parte persa memoria. “Nello stesso tempo si sviluppava una opportunità d’incontro con l’Università di Salerno, in particolare con le Cattedre di Antropologia Culturale, Lettere e Storia del Teatro e dello Spettacolo che contribuì al perfezionare la maturazione del gruppo e ne limitava ai velleitarismi portati dal successo. L’asse portante del nostro lavoro di gruppo, mai più relegato e irrinunciabile, divenne la ricerca ‘sul campo’ come metodologia di confronto delle diverse aree geografiche affrontate, per la individuazione dello specifico ruolo svolto sul territorio. si trattava altresì di rompere l’isolamento della cultura che di andava indagando fornendole un nuovo tramite di comunicazione, stimolando nuovi momenti creativi e comunicativi sulla base drl vissuto quotidiano” (note Teatrogruppo).
Questo il vero motivo della scelta qui avanzata, in ragione della raggiunta consapevolezza di un’unica strada percorribile alfine di evitare di ricadere in una comunicazione settoriale o, peggio, nell’assenza di comunicazione del quotidiano con la tradizione, radicalizzandone l’effetto di negazione della tradizione stessa da parte delle nuove generazioni. Un’attività questa che può sembrare difficilmente configurabile nella sfera d’azione del teatro tout-court e nelle finalità tradizionali del folk-musik revival, ma che altresì è servita in quegli anni a restituire una identità geografica ad aree che sembravano non aver mai avuta, se non per averla recepita di riflesso dallatradizione popolare napoletana. Indubbiamente l’influenza partenopea in passato aveva oltrepassato di gran lunga quelle cosiddette ‘culture autoctone’ che agivano nel sotterraneo magico-liturgico e religioso delle aree meridionali meno esposte della regione; tuttavia sulla scia del ritrovato spirito del teatro: “..la ricerca sperimentale diveniva la dimensione essenziale e insostituibile di un’attività che non era quella del solo ricercatore specialistico, ma la struttura di una nuova ricerca pratica di gruppo per il cambiamento” (note Teatrogruppo).
Ma se tutto questo può sembrare in contrasto con la raffinata tecnologia della riproduzione discografica che fa giustizia della diversità e punta su un prodotto finito ‘omogeneo’ e il momento ‘unico’, all’epoca era l’unico modo, insieme al filmato su pellicola, che la tecnologia proponeva per fissare l’attimo e restituirlo all’ascoltatore nel modo migliore possibile, sebbene paradossalmente alquanto filologica, tuttavia necessaria per restituire memoria di ciò ch’era destinato alla memoria di pochi, quanto alla dimenticanza. “Nella realtà territoriale del gruppo quella del disco non è mai stata una priorità, ma ciò non poteva inquinare un discorso che aveva ben altri ritmi di svolgimento e più ampio campo di intervento. Piuttosto costituiva una sfida alle capacità di recupero ai limiti soggettivi e oggettivi del’azione collettiva, per allargare a nuove fasce l’ambito della proposta del gruppo, portatore di una esperienza maturata sul territorio, cosciente di svolgere un’attività politico-culturale che andava superando i confini di uno determinato campo d’azione, mai negando lo specifico per uno schematico quanto populistico convegno drammatizzato o cantato che fosse”.
Al Teatrogruppo di Salerno quindi si deve almeno un riconoscimento di tipo agiografico: l’aver proposto arie e canti di territori che sono quasi scomparsi dalle carte geografiche o, almeno, dalle considerazioni regionalistiche, e che invece vanno rivalutate quali aree geografiche autoctone, come il Cilento e la Lucania fino al Vallo di Diano. Grazie al Teatrogruppo di fatto ho scoperto alcuni strumenti arcaici o almeno introvabili come le nacchere cilentane, chitarra battente cilentana, flauto di canna; e tutta una serie di canti e ritmi a ballo, straordinarie ninne-nanne e pastorali alle ciaramelle che vale la pena qui di ricordare:
“I’ me ne voglio i’ a lu Celiento”
(canto con accompagnamento di tammora e chitarra)
I’ me ne voglio i’ a lu Celiento
me voglio i’ a piglià na celentana
nun me ne curo ca nu tene niente
basta ca tene le fresca funtana
fresca funtana famme ‘nu favore
fresca funtana si me lovuoi fare
quanno c’arriva chillo traditore
‘ntrovate l’acqua e nun lu fa lavare
Ma quanno arriva chillo caro ammore
Rischiara l’acqua e fancelo lavare.
È questo un canto molto diffuso nell’area culturale popolare in genere conosciuto come ‘a celentana’; la sua melodia originaria pur avendo subito le modificazioni causate dall’adattamento alle esigenze stilistiche ed espressive delle diverse zone di frequentazione come ad esempio nella maniera dell’agro sarnese-nocerino.
“Sera passai e tu bella durmivi”
(canto con accompagnamento di chitarra e castagnette)
Sera passai e tu bella durmivi
tutto lo tuo giardino io caminai
trovai ‘na pianta re melo gentili
e la crianza mia nun la tuccai
e quanto vale la crianza mia
tu ieri nuda e io ‘t’incoppulai
qual è l’occhio currivo che mi sengo
trovai lu fuoco e nun mi calentai.
Va da sé che la traduzione di questi canti è assolutamente insufficiente ad esprimere le assonanze, le onomatopee e, soprattutto, il gioco fonetico-semantico tra suono fisico degli strumenti, suono della parola e riferimenti sessuasi intrinseci del cantare ‘alla cilentana’. I temi presenti trattati sono di ogni genere (dal lavoro all’emigrazione, dal semplice saluto al corteggiamento amoroso) e svolti in diversi modelli ricchi di varianti, spesso dipendenti dalla caratterizzazione locale della provenienza del canto, distinto in: ‘d’amore’, ‘di sdegno’ e ‘di lontananza’, secondo una partizione utilizzata anche in altre aree. La melodia, più contratta nei paesi situati nell’interno e distesa in una maggiore cantabilità nella zona marina, cade sempre con melisni fissi. L’esecuzione può essere monodica, a voce singola o a voci alterne; o polivocale, con una voce ‘alta’ principale e una ‘bassa’ che ‘accorda’ sull’attacco della voce principale. Un solo fiato regge il canto di ogni verso e l’emissione è di testa e spesso a voce ‘lacerata’. Al canto, in funzione di accompagnamento, può aggiungersi l’uso di strumenti musicali (chitarra battente cilentana, organetto) con adeguamento delle voci al ‘tono’ dello strumento e l’aggiunta di una parte solo strumentale sul ritmo di tarantella come breve intermezzo tra distico e distico.
“Ninna nanna”
(per canto solo e chitarra)
Raccolta a Roscigno presso un’anziana contadina è qui riproposta una ninna-nanna di una bellezza che incanta per la sua semplicità e linearità della voce dell’unico componente femminile del Gruppo. Una ninna-nanna la cui funzione apotropaica anche se tipica di molte altre forse più conosciute, è particolarmente evidenziata dall’appello rassicurante e a volte ripetuto che, a seconda delle varianti, richiama alla Madonna o a Santa Maddalena e a Dio:
Ninna ninna nunnarella
lu lupo si magiavi la picurella
o picurella mia come facisti
quanno ‘mmocca a lu lupu ti viristi.
Ninna ninna nunnarella a la marina
‘stu figlio dorme e la mamma sua fatìa
ninna ninna nunnarella da la Spagna
‘stu figlio dorme e la mamma sua guadagna.
Ninna ninna nunnarella ‘stu figlio mio
me l’addorme la Madonna
ninna ninna nunnarella ‘stu figlio bello
me l’addorme santa Lena.
O santa Lena ti mi l’hai mannato
mannangi lu suonno ca l’aggio curcato
l’aggio curcato nu lietto re sciuri
diu li manni la bbona furtuna
l’aggiu curcato nu lietto di rosa
diu li manni tu bbono riposo.
Qualcuno leggendo si chiederà dove trovare la Lucania, o il Cilento, paradossalmente ‘inesistenti’ su gran parte delle carte geografiche, dopo l’avvenuto accorpamento di alcune regioni con altre o la cancellazione dai flussi di comunicazione di zone di territorio ritenute di scarso interesse turistico ed economico. Per trovare alcune notizie interessanti sono tornato a sfogliare la Treccani con davvero scarsi risultati, se non che si tratta di una sub-regione la cui popolazione è dedita alla pastorizia e all’agricolture. Tuttavia pur ho trovato qualcosa in una Guida d’Italia del Touring Club Italiano nientemeno che del 1928 che, ad esempio, annovera il Cilento come sub-regione compresa tra Battipaglia e Lagonegro per il Vallo di Lucania e Sapri; e ancora sulla carrozzabile costiera tra numerosi bivii come, ad esempio, quello presso Certola per Marina di Camerota fino a Celle di Bulgheria, ed altri, dove le strade s’intersecano fiancheggiate da grandi macchie di querce, di salici e pioppi, fra terreni incolti e siepi alte di lentischi, avanzi del bosco che un tempo ricopriva la pianura che si stende verso le alture del Cilento degradanti a mare col monte Tresino ai cui piedi si scorge Agròpoli affacciata sulla città vecchia.
Detta così sembrerebbe una terra ormai inabitata (era il 1928), quasi un paradiso terrestre in cui varrebbe la pena rifugiarsi per scappare dall’affollamento delle città, mentre invece va tenuto in conto che se “Cristo si è fermato a Eboli” una ragione pure dev’esserci stata. E quella ragione è che abbiamo cancellato tutto, le migliaia o quasi degli agglomerati urbani che vengono dopo, quelle ‘terre oltre’ dove pure è vissuta tanta popolazione e continua ad essere motivo d’orgoglio per le genti che in quelle terre continuano a nascere e a crescere maturando un attaccamento istintivo, certamente atavico, di tipo ancestrale. In verità nelle pagine successive si informa il turista (fai da te) su molte località, piccoli agglomerati di case adiacenti a piantagioni di tabacco; qualche rudere propaggine della Paestum d’epoca romana; fiumi di bassa portata d’acqua dai nomi curiosi: Alento, Lambro, Mingardo, Busento e, per lo più, massicci e picchi montuosi coperti di ginestre e cerri che danno forma a ‘valli’ i cui nomi trasportano la mente a una sorta di mitologia (fai da te) legata forse a condottieri d’epoca lontana, come ad esempio il Vallo di Diano, Roccagloriosa, Castellabate, Forra del Mingardo, Policastro, Atena Lucana, Stio, Laurino, Tegiano ecc. .
Ancor meno se parliamo di Lucania, la cui storia è legata alle numerose guerre combattute da Greci e Lucani, fra Lucani e Romani contro Pirro e Annibale seguite da grandi devastazioni del territorio. Questo in Treccani, seppure la Lucania è stata in passato (fino al XII sec.) un’antica regione italica successivamente compresa nella Calabria e infine annessa alla Basilicata. Che cosa rimane quindi di questa regione, un ‘amaro’ che viene regolarmente pubblicizzato in TV? Non può essere solo questo, ne vale la dignità di un popolo autoctono già famoso nell’antichità per la produzione artigianale della ceramica (sono famosi i vasi lucani) che si distinse per la sua qualità e il livello artistico. Poco, o quasi niente, rimane della conoscenza degli usi e costumi dei Lucani e dei Cilentani, letteralmente ignorati nella grande “Storia d’Italia” dell’editore Einaudi che, nei volumi dedicati a ‘I caratteri originali’ e ‘I documenti’ fa riferimento solo alle popolazioni della Basilicata e distrattamente alla Lucania in quanto agglomerato della prima e nulla sul Cilento. Dacché la Lucania è solo un amaro e il Cilento verosimilmente non esiste.
“Non si deve certo disconoscere che vaste aree contadine e pastorali del Sud sono rimaste sostanzialmente escluse dal contatto con le egemonie urbane e con le ‘città contadine’ ed altre ne abbiano subito solo marginalmente la pressione, ma è tuttavia ipotizzabile che il particolre ordinamento socio-economico del Sud abbia potuto mettere in movimento processi trasformativi della cultura tradizionale in grado di riprodursi attivamente lungo un arco temporale assai lungo, considerando la compresenza di altri elementi e il fatto che la tendenza a organizzare su base urbana la società contadina permane, nel Meridione, fino a noi. A questo elemento un altro può essersi congiunto nel determinare una particolare disposizione della comunicazione orale del Sud verso moduli che oggi ci appaiono assai prossimi a forme della ‘poesia culta’ della prima età della nostra storia letteraria”.(…)
“Se infati osserviamo come quei caratteri ‘culti’ paiono essere emergenti più in Sicilia che nelle altre regioni meridionali e come la connotazione più ‘profonda’ e ‘primitiva’ il nostro Sud la trova non già nei suoi territori più meridionali ma piuttosto in un’area, per lo più interna, che comprende Campania, Puglia, Lucania e Calabria settentrionale, possiamo immaginare che anche quel processo di tardiva rilatinizzazione, che i linguisti hanno rilevato in Sicilia e nella Calabria meridionale, possa aver agito nel senso di caratterizzare in modo più ‘moderno’ una parte almeno degli oggetti comunicativi. In una simile prospettiva si può allora ipotizzare un duplice indirizzo d’influenza (dalle città meridionali verso le campagne e dalla Sicilia verso il continente) sulla cultura ‘arcaica’ del nostro Sud, con le conseguenze abbastanza sorprendenti che oggi ci è dato di osservare” (Enciclopedia Einaudi 1973).
Aver sminuito la didattica scolastica elementare che dagli anni ’70 fino al 1985 prevedeva lo studio delle regioni italiane nei loro aspetti principali, cioè la conoscenza per quanto sommaria della composizione territoriale del suolo e sottosuolo, la flora e la fauna, l’industria, i prodotti tipici e la tavola, la lingua e la storia, nonché le sagre e le feste popolari cittadine, che pure avevano la loro importanza nel formare il carattere delle persone e il senso di appartenenza geografica al territorio, negli anni ha portato a escludere quei connotati di integrazione e di reciproco scambio che avrebbero portato all’unificazione dell’Italia come nazione. Non avendola sostituita con null’altro si è quindi giunti a disconoscere una identità che forse ci avrebbe salvati dall’essere fagocitati da culture esterne, mode e vezzi “..di stampo economico e di profitto, che andrebbero viste come funzionali al sistema sociale classista e quindi da rifiutarsi globalmente come un insieme di truffe ideologiche, (..) focalizzate in alcuni nodi cruciali dello ‘scontro’ tra la cultura dominante e la cultura del profitto, come appunto l’utilizzo del folklore come il fittizio riscatto sociale offerto dalle classi subalterne, nella prospettiva di un loro reale processo di liberazione. Temi questi che coinvolgono in prima persona chi ritiene che impegno culturale e impegno politico siano inscindibili e voglia operare lucidamente per la trasformazione della nostra attuale società, sullo sfruttamento e sulla menzogna. ” (L.M. Lombardi Satriani: 'Folklore e profitto' – Guaraldi 1973)
Non volendo qui rifare il verso al titolo di un noto film “Non si uccidono così anche i cavalli?”, ritengo autorevole quanto appena detto da L. M. Lombardi Satriani sulle possibile ‘tecniche di distruzione di una cultura’ cioè, di un vero e proprio etnocidio a discapito di alcune popolazioni che assistono alla negazione e spogliazione della propria espressione culturale. Quando, a fronte di una cultura sommersa pur comprensibilmente autentica che pur andrebbe finalizzata alla comprensione di un ‘vissuto’, anche se in certi casi inconsapevole, da tutti, in ragione d’una sua comprovata esistenza territoriale. Sommersa come lo è una certa religiosità commista di antiche superstizioni che sopravvivono nel sacro e nel divino che, ancora oggi sono parte integrante del quotidiano, sintomi di una tensione verso il sacro che il cristianesimo ha storicamente individuato e da sempre incanalato verso una religiosità autentica che si professi più autentica. Per quanto è altrettanto vero che questi agglomerati esistono e sono sempre esistiti, come bisogni non materiali che il godimento di sempre maggiori beni di consumo non riesce a soddisfare, anche se la cultura industriale li ha spinti ai margini, svalutati, soffocati, bollati dentro il loro stesso alone del ridicolo che verosimilmente li ha maturati.
Ma è tempo questo di restituire allo spirito quello spazio che gli concerne con un canto tradizionale raccolto presso un bracciante agricolo di S. Marzano. La discendenza da antichissimi riti di eliminazione, di morte e resurrezione, accentuate dall’uso melodico e una metrica insolita, fanno di questo canto un esempio di grande rilevanza dell’espressività popolare:
“Né Carnuvà, pecché si’ muorto”
(lamento rituale per la morte del Carnevale)
Né Carnuvà pecché si’ muorto
che nce vogliono ‘e sorde belle p’e schiattamuorte
che ggioia
t’aggio sentut’o o rummore r’re campanielle
mo se me vene ‘o cavallo ‘e puleciello
che ggioia
t’aggio sentut’o o rummore r’re carrettelle
mo se me venen’ ‘e femmene co’ ‘e canestrelle
che ggioia.
L’espressività dionisiaca del ritmo, caratteristica di alcune danze più antiche relative alle feste organizzate in onore della divinità pagana, può essere ricondotta alla funzione originaria di scansione musicale e coreutica all’interno del Carnevale sotto la denominazione generica della ‘tarantella’, accomunata ad altre danze ‘taranta spagnola’, ‘tarantulata pugliese’ ecc. in cui la particolare diffusione dell’organetto come strumento d’accompagnamento la fa da padrone. L’originalità del canto che segue sta nel fatto di elencare una serie di strumenti che variano da luogo a luogo e che ci permette di connotarne l’uso:
“Caro cumpare”
(canto sull’organetto, chitarra, tamburello, campanelli)
Caro cumpare che bai sunanno
vaco sunannu lu viulinu
comme lu suoni lu viulinu (uè cumpà)
minghillu-minghillu fa ‘u viulinu
don-don-don fa ‘u campanone
dan-dan-dan fa la campana
din-dindin fa ‘u campaniello
e dipidindà fa ‘u tamburiello
…
Caru cumpare che bai sunanno
vaco sunannu la rancascia
comme la suoni la rancascia (uè cumpà)
t’ ‘o ‘ncascio t’ ‘o ‘ncascio fa la rancascia
te ‘mponno te ‘mponno fa le zampogne
bai e bbene l’urganettu
nze-nze-nze fa la chitarra
minghillu-minghillu fa ‘u viulinu
don-don-don fa ‘u campanone
dan-dan-dan fa la campana
din-dindin fa ‘u campaniello
e dipidindà fa ‘u tamburiello
…
Caru cumpare che bai sunanno
vacu sunannu lu cuornu re caccia
comme lu suoni lu cuorno re caccia (né cumpà)
e musciu e bbuono t’ ‘o sbattu ‘mpaccia
ecco ca suona lu cuorno re caccia.
Ed ecco cosa ci dice il libro “Regioni d’Italia” della Basilicata (che ignora la divisione territoriale del Cilento), anche se ricorda l’antico nome probabilmente derivato dal latino ‘lucus’ che significa bosco, in memoria della foresta che infatti ricopriva l’intera area. Intanto che non costituisce una regione naturale più piccola dello stivale, ma che ha il privilegio di affacciarsi su due mari: per un breve tratto sul Tirreno nel golfo di Policastro (Cilento) dove le rive sono scoscese pur nella imprevedibile bellezza delle insenature selvagge; dall’altro sullo Ionio con Metaponto, importante sito archeologico con le quindici colonne rimaste del tempio di Giunone; e nel Golfo di Taranto, dove le rive sono piane. Quindi, superate le informazioni sul clima, la flora, la fauna e l’aspetto orografico del territorio, l’industria e l’artigianato, ci ricorda le principali città come Potenza, Matera, Avigliano, Melfi, Maratea, Piosticci, Tursi, Acerenza, Tricarico Montescaglioso con le rovine della Magna Grecia, così come Metaponto (dove insegnò Pitagora), e che sulle monete rinvenute (Lucania) appare il simbolo della spiga d’orzo, un tempo sacra a Cerere e simbolo della regione.
Nel libro pur si fa qulche sporadico accenno alla Lucania: “isolata fra i suoi monti, percorsa da profonde vallate di difficile accesso che in tempi antichissimi vide giungere gruppi di ‘coraggiosi’ che spingevano avanti le loro mandrie e trasportando gli utensili agricoli, e che quindi vi si stabilivano attratti dalla bellezza naturale del luogo. Mille anni prima di Cristo giunsero i Lucani; più tardi i Greci, i Goti, i Longobardi, i Bizantini che ne cambiarono il nome in Basilicata da ‘basilikos’ che in greco significa ‘funzionario imperiale’. Ancora oggi la più grande personalità lucana è il poeta latino Orazio Flacco (Venosa 65 a.C. – Roma 8 aC.) autore di Epodi e Odi, Satire ed Epistole appartenenti al genere lirico. Per saperne di più ho sfogliato quell’incredibile documento storico in due volumi che “Antica Madre” (AA.VV. Garzanti-Scheiwiller 1989) ha dedicato alle genti italiche: “Italia”: ‘Le genti della Basilicata antica’, e sui Lucani anche detti Enotri o Coni di origine arcade, forse discendenti da Sparta, già presenti attorno al 1800 a.C. quindi agli inizi dell’età del bronzo. Successivamente allo spostamento di gruppi etnici dalla Campania alla Sicilia a partire da un certo momento (e dunque da un certo mutamento culturale profondamente ellenizzato), in cui si identifica la fisionomia culturale delle rispettive popolazioni insediatesi nelle regioni meridionali, fra cui i Sanniti in Campania e i Lucani nell’area di Metaponto.
Strabone, geografo e storico greco vissuto attorno al 60 a.C. estende i confini della Lucania fra la costa del mar Tirreno e quella del mar di Sicilia, rispettivamente dal Silari fino al Lao e da Metaponto fino a Cerilli vicino Lao; e che arriverà fino alla conquista da parte dei romani che sconvolgerà il mondo lucano e porterà al completo abbandono di quasi tutte le sue forme insediative, con l’imposizione a territorio della ‘pax romana’. Il Vallo di Diano, percorso dal fiume Tanagro, un affluente del Sele che scorre parallelo alla Val d’Agri, tra i monti Alburni e Cilentani, costituisce una formidabile via naturale tra la piana di Eboli e il Lagonegrese. Qui l’area dell’insediamento più antico che si estende nella parte più occidentale della regione, è caratterizzata dalla presenza numerosi agglomerati abitativi dediti alla produzione di ceramica ‘a tenda’, riconducibile alle necropoli che si estendono ai piedi dell’abitato in cui sono numerose le tombe a incinerazione e il vestiario guerriero delle tombe maschili. Mentre nelle tombe femminili di maggior prestigio è eccentuato il carattere di fastosità presente nella vestizione della defunta, con armille a spirali nelle caviglie e in vita una cintura e un grande pendaglio, al di sotto del quale si cela un oggetto in bronzo particolarmente complesso, interpretato (Zancani Montuoro) come strumento musicale chiamato ‘calcofono’, anch’esso in bronzo fuso cesellato o lamina di filo di bronzo decorata ad incisione, datato attorno al VII-V sec. a.C. Lo strumento, detto anche ‘sistro apulo’, a sezione quadrangolare con estremità a volute forate ad intervalli regolari, costituito da due barrette sui fori in cui trovano alloggio alcune verghette in bronzo suonate tramite percussione. Tuttavia, pur nel lungo escursus sui ritrovamenti tombali, le pitture murali e i vasi in ceramica dipinti, poco o nulla si dice delle profonde trasformazioni avvenute nell’espressione del sentimento religioso. Ancor meno degli strumenti musicali utilizzati nei rituali funebri e nelle feste calendariali.
Per quanto concerne la grande permeabilità culturale che ormai accomuna tutto il mondo italico meridionale, corrisponde una sostanziale unificazione dello scenario culturale si conosce l’esistenza di qualche sporadico flauto di canna (Eboli), della ciaramella (Auletta), dell’aulos a due canne forate, delle nacchere cilentane d’importazione ellenistica; e la cosiddetta ‘tromba degli zingari’ detta anche ‘marranzano’ presente in tutta la Magna Grecia. Lo strumento importato probabilmente dall'Asia dalle popolazioni nomadi è costruito in metallo a forma di un piccolo ferro di cavallo, con al centro una linguetta pur’essa di metallo fissata ad una sola estremità al telaio. Viene fatto suonare tenendolo tra i denti e facendo vibrare con un dito la linguetta. La nota emessa da questo strumento può essere in parte modulata variando la forma della cavità orale attraverso il movimento delle guance e della lingua. Usata per particoli suoni d’accompagnamento lo strumento è anche usato negli intervalli musicali nel canto,come in questo brano per chitarra battente, tamburello e lo ‘scacciapensieri’ (marranzano).
“Occhi niurelli”
(serenata caratteristica del canto detto a ‘sospiro’ spesso presente fra verso e verso, che accentua il tono struggente del testo).
Occhi niurelli e palma d’auliva
ra vui nun me ne pozz’alluntanari
tutti me ricino chi ti lascio ira
si’ troppo bella nu lu pozzo fari
la gente chi nun voleno accunsintire
tutti i vulimmo ué aggiustari
siente bella chi è chi tt’ama
vai ru fierre vai eppure se tira
lu vostro patre eppure s’adda calari
cu li miei ingegni e cu li miei segreti
te l’aggia mette la fede ué a la mano
ramme la mano toia la mia è lesta
cient’anne camparrai sta vita nosta.
Sebbene la trascrizione dei testi non tiene conto delle riprese e ripetizioni pur numerosissime, per la sua complessità e la sua varietà lo sviluppo del canto avviene per nuclei musicali, separati da brevi pause, attraverso una peculiare successione per ripetizione-cumulazione di un verso dopo l’altro, per cui la ripetizione e l’accumulo si collegano al modo frequente di esecuzione del canto, ma spesso anche per bruschi scarti su altro tema o, con improvvisazioni occasionali, tipici del cantare popolare che prevede l’intervento dei presenti secondo la disposizione soggettiva dei cantanti. Tutto ciò spiega in parte la variabilità del contenuto delle sequenze e la successione ininterrotta, ad esempio della ‘tammurriata’ (canto e ballo alla tammorra) e/o della ‘pizzitata’ eseguita sulla chitarra battente. La nota informa che la ‘pizzitata’, termine che designa la tarantella utilizzata nel Salento per l’esorcismo coreutico-musicale nella terapia del ‘tarantismo’ conosciuta col nome di ‘pizzica’.
Allo stato della ricerca etnomusicologica si ignora se e quali connessioni e interrelazioni possano essersi sviluppate in passato fra ‘pizzica’ e ‘pizzitata’, la cui esecuzione tuttavia risente idealmente di un solo organico strumentale in accumulo di una serie di strumenti diffusi nell’area cilentana, sui quali una volta la ‘pizzitata’ veniva quasi certamente suonata durante le cerimonie pubbliche lucane: “..mescolanza di cattolicesimo popolare e di relitti di forme religiose antico-arcaico connessi con i diversi momenti che regolano il mondo agricolo. (…) Tra le feste del ciclo dell’anno ‘carnevale’ e ‘capodanno’ hanno in gran parte hanno conservato caratteristiche abbastanza integre ed autonome. (…) Tra queste ultime si pone il ‘giuco della falce’ che ha luogo (almeno fino a pochi anni fa) a San Giorgio Lucano, in provincia di Matera, e che appartiene a quelle feste di mietitura diffuse in gran parte dell’Europa. Elemento essenziale di questo ‘giuco’ è il mascheramento dell’atto del mietere con quello di una battuta di caccia a un caprone, personificato da un uomo ricoperto da una pelle d’animale. I contadini, fingendo la battuta, in effetti mietono il grano e stringono sempre più il cerchio intorno al capro fino a raggiungerlo e ad ucciderlo simbolicamente” (Annabella Rossi, “Basilicata” in “Santi, Streghe & Diavoli” a cura di L. M. Lombardi-Satriani, Sansoni Editore 1973.
Le cerimonie a carattere privato più diffuse sono quelle magiche, soprattutto la ‘fascinazione’, la pratica ancora presente e soprattutto la memoria culturale ancora viva, nonché l’importanza dell’aspetto etnomusicologico, dovrebbero essere di stimolo per gli operatori culturali e di quanti sono alla ricerca di stimoli musicali, che dal ‘vivo’ del passato, giungono fino a noi a insegnarci quel certo virtuosismo creativo mai dismesso. È questa una tematica studiata e considerata nelle sue linee dinamiche dall’etnologo Ernesto De Martino nel suo libro “Sud e Magia” che intendo riprendere in un capitolo successivo.
Pertanto ringrazio tutti i componenti del Teatrogruppo di Salerno per le note e la trascrizione dei testi; Gelsomini D’ambrosio per le illustrazioni di copertina e i disegni che accompagnano i booklet davvero preziosi che accompagnano i due LP; l’Editoriale Sciascia di Milano per la produzione del catalogo Albatros/Zodiaco; la Oedipos Edit. per il libro-album "Fantocci, principi e marchesi. Il Teatrogruppo di Salerno" (2011) , scritto e curato da Luciana Libero con un ottimo archivio di foto in bianco e nero che, a prescindere dalla valenza strettamente tecnico-artistica, restituiscono, fanno rivivere e ci lasciano ‘affascinati’ da uno dei periodi più ricchi e creativi della storia della nostra musica popolare.
(continua)
*
 - Alimentazione
- Alimentazione
SÜDTIROL/ALTO ADIGE 2 - La tradizione ‘del gusto’ in Italia
“Lassù sulle montagne
tra boschi e valli d’or
cantiam la montanara
per chi non la sa …”
Sono questi i versi di una nota canzone di benvenuto, appunto ‘la montanara’ che ci accoglie sulla strada dell’ospitalità e della cordialità contadina, cantata dalle molte ‘corali’ tipiche delle valli altoatesine e dai villeggianti che ogni anno affollano i numerosi ‘masi’ distribuiti in tutta la regione. Per chi conosce già l’Alto Adige / Südtirol non si stupirà quindi di elencarne ogni anno nel proprio vademecum dei nuovi gruppi corali, tanti da perderne il conto, che si formano nelle diverse stagioni; mentre per chi non la conosce affatto, potrebbe addirittura meravigliarsi di come si stata qui conservata la tradizione montanara canora e strumentale che, insieme ad una affabilità che ne caratterizza i costumi, trova maggior valore nella familiare conduzione delle usanze gastronomiche delle nostre realtà regionali.
Caratteristica tipica quella gastronomica e vitivinicola italiana che abbiamo certamente mostrata al mondo con l’EXPO Milano 2015 appena conclusa, ed ai molti popoli e paesi che abbiamo avuto modo di conoscere e incontrare in quell’occasione. Ma se l’esperienza EXPO ci ha permesso di ri-trovare quel qualcosa che credevamo perduta, ancor più non dovrebbe sorprendere scoprire che da noi, (ahimè solo in alcune regioni), una certa conoscenza del territorio ha permesso di rivalutare quell’ospitalità contadina di cui andiamo fieri e che, fatta di tenerezza e cordialità, trova qui il proprio fulcro. Soprattutto va qui riconosciuto l’impegno economico organizzativo e strutturale di una regione che ha saputo ottimizzare le proprie risorse territoriali e conservare l’ambiente in tutta la sua naturale bellezza.
Non a caso quando si parla dell’ Alto Adige / Südtirol si dice di un ritrovato ‘giardino dell’Eden’ dedito alle seduzioni di una vita più sana di quella che si conduce oggigiorno nelle città metropolitane. Ma parlare di una ‘terra di delizie’ senza tener conto della tenacia del lavoro svolto dalle genti che vi abitano e che si adoperano ogni giorno alla lavorazione e al miglioramento del proprio territorio, significa sminuirne la portata, la riposta fiducia nel futuro, nel rispetto della tradizione e nell’apprendimento di ciò che le moderne tecnologie oggi permettono di fare; sia nell’aiutare gli artigiani nella propria fatica, sia nel migliorare i criteri di ‘qualità’ dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli (e non solo), che nel tempo hanno scalato le vette del ‘gusto’ a livello internazionale.
È questo un paradiso ricco di frutti delizie d’ogni specie, e andrebbero almeno citati i molti prodotti regionali: da quelli freschi quelli più stagionati, dagli essiccati, agli insaccati, ai panificati; nonché agli sciroppi, alle marmellate, ai dolci, ai vini e distillati, fino ai derivati dalla raccolta delle frutta, degli ortaggi e delle erbe aromatiche che qui crescono in gran numero. Inoltre, andrebbe citata la produzione di carni di altissima qualità, di formaggi e latticini provenienti da allevamenti all’aria aperta che le peculiarità geografiche e il clima soleggiato favoriscono e che, nell’insieme, formano un corollario di piacevoli esperienze culinarie. Ed anche, che pur sempre partendo dalla tradizione, fanno di questa nostra regione, quell’Eden per buongustai e golosi d’ogni risma che a ben dire del sommo poeta Dante dovrebbero finire tutti all’Inferno.
Nella certezza che neppure l’Alighieri disdegnasse la buona tavola e, comunque, la degustazione di quei prodotti agricoli tipici che sono alla base del desco quotidiano contadino, va riconosciuto a questa regione montanara un alto valore aggiunto per la produzione e la lavorazione di numerosi prodotti ‘unici’ (doc, dop ecc.) molto apprezzati in Italia e all’estero e che, sotto l’egida del marchio ‘Gallo Rosso’ offrono la garanzia di una qualità attenta e una trasparenza consolidata nel tempo che accompagna in ogni sua fase la produzione di questo autentico ‘artigianato’ contadino. Acciò ben si legano le molteplici proposte offerte dalla regione Alto Adige / Südtirol di ‘Vivere il maso’ e di gustare i deliziosi piatti della cucina casareccia serviti in ognuna delle accoglienti ‘stube’, osterie con annessa cucina, così denominate in lingua locale.
“STELUTIS ALPINIS”
di Arturo Zardini - arm. di Gianni Malatesta
Uno dei canti alpini più belli che mai sia stato scritto:
Se tu vens cassù tàs cretis
là che lôr mi àn soterat,
al è un splàz plen di stelutis:
dal miò sanc'lè stat bagnat.
Par segnàl, une crosute
jè scolpide lì tal cret:
fra chês stelis nàs l'erbute,
sot di lôr jò duâr cujèt.
Ciòl su, ciòl une stelute:
je a'ricuarde i nestri ben.
Tu i darâs n'e bussadute
e po' plàtile tal sen.
Quan che a cjase tu sês sole
e di cûr tu prèis par me,
il miò spirt atôr ti svole:
jò e la stele sin cun te.
(traduzione)
Se tu salirai quassu' tra le rocce,
dove mi hanno seppellito, arriverai
in uno spiazzo pieno di stelle alpine:
dal mio sangue è stato bagnato.
Quale segno, una croce
è scolpita nella roccia:
tra queste stelle alpine cresce dell'erba,
sotto di loro io dormo sereno.
Prendi su, prendi una piccola stella:
sarà il ricordo del nostro amore.
Le darai un bacio
e la porrai sul seno.
Quando, a casa, tu sarai sola
pregherai di cuore per me,
il mio spirito ti sarà vicino:
io e la stella saremo con te.
Al ‘maso’, autentico casale contadino ristrutturato e reso accogliente spesso al pari di un resort a più stelle, (di cui ho ampiamente parlato nell’articolo: ‘La tradizione italiana: Südtirol / Alto Adige’, sulle pagine di questa stessa rivista letteraria), la vita quotidiana si offre ad una esperienza diretta con la natura regionale e dei suoi effetti benefici sulla salute. Degno di nota è il fatto che qui, i contadini del luogo, sono anche tornati a lavorare la lana e ad eseguire intagli e torniture nel legno, promuovendo una produzione artistica-artigianale di ottimo livello, pur sempre nel rispetto della natura circostante. “Il controllo dei prodotti – avverte la pubblicazione del Gallo Rosso – è regolarmente effettuato da una commissione indipendente composta da esperti del settore agro-alimentare (sensorialisti, cuochi eccellenti, enologi) selezionati, provenienti dal Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, della Federazione Latte Alto Adige, nonché da rappresentanti dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, a garanzia delle qualità straordinarie e la conservazione dei prodotti”.
“E il successo da ragione a questa iniziativa – prosegue Gallo Rosso nelle avvertenze specifiche – soprattutto per quanto riguarda gli alimenti premiati dalla scelta di sempre più persone che preferiscono prodotti di ‘alta qualità’ a quelli di massa, e non solo. (..) L’alimentazione come l’economia domestica sono indubbiamente temi di grande interesse, ciò che ha permesso il sorgere di Scuole Professionali in diversi luoghi della regione: a Corces, Tesimo - Frankenberg, Bolzano – Asiago, Egna, Varna, Salem e Teodone, per la formazione di operatori ai servizi di economia domestica e agroalimentare, tecnici dei servizi di accoglienza e ospitalità turistico e sociale; (..) nonin ulòtima, l’offerta di ‘corsi formativi’ di cucina, trasformazione di prodotti agroalimentare, di decorazione e di economia pratica, come ad esempio la cura della biancheria” o di lasciarsi andare in una danza tipica o al canto di uno ‘jodel’. (Se non lo avete ancora previsto sarà bene inserirlo come ‘must’ della formazione.)
Lo ‘jodel’ tirolese è cantato, ovvero è spesso inserito come ritornello all' interno di canzoni popolari. In seguito, tramite cantanti girovaghi, si è diffuso anche in altre regioni montane, nelle diverse forme delle ballate e canzoni nostalgiche, d'amore ecc.; testi che riportano emozioni spesso forti ma contenute, provate in seno a quel che conta nella vita quotidiana. È il caso di questa “Ballata tirolese” su testo originale tradizionale tradotto in italiano da Dante Panzuti - Musica tradizionale, trascr. e rielab. Softly:
“BALLATA TIROLESE”
Col mio costume tirolese tipico
Su in montagna vado la domenica,
Il mio sentièro porta ad una bàita,
Passo, passo arrivo fino là…
Un pastorello con le mucche al pascolo
Sta suonando la sua fisarmonica…
Allegramente mi saluta con un CIAO!
Poi riprènde subito a cantar:
Hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-o.
Io mi avvicino e tolgo dal mio zaino
Dei panini con salame e crauti,
Col pastorello li divido subito
Ed amici diventiamo già…
Lui corre a prènder dentro la sua bàita
Un secchiello di buon latte fresco e poi…
Mi dice: “bevi, questo è un latte magico:
Ti farà cantare come me:
Hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-o.
Und in da Hùttn drein, da dunkt’s mi sov’l fein,
Schaung Berg und Himml bei dia Fensta ein.
Da sing ma mitanand, dos gibt an helln Klang,
Und an Jodler drauf, so it’s da Brauch.
Sta tramontando il sole dietro i monti, ormai
È arrivata l’ora di tornare giù.
Io ti saluto pastorello con un ciao!
Il tuo canto mi accompagnerà:
Hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-ri-dl-e-di
hol-di-o.
Per chi volesse conoscere più da vicino il mondo agricolo dei ‘masi’ altoatesini non deve fare altro che avventurarsi nella salutare natura della regione; si fa per dire, e spostarsi di villaggio in villaggio, o meglio, ‘di maso in maso’, e approfittare dell’autentica esperienza delle piccole realtà contadine che la guida di recente pubblicazione “Masi con gusto” del Gallo Rosso, mette a disposizione e che porta a conoscere gli angoli più vantaggiosi in cui ‘gustare’ i migliori prodotti offerti nella 40 osterie ‘Buschenschank’ o ‘Hofschank’ che provengono in gran parte direttamente dal proprio maso: ‘robe da buongustai’. “In tempi di concentrazione del mercato il grado di organizzazione delle coperative agricole altoatesine che si occupano della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, va detto che esse hanno dato e daranno in seguito un importante contributo alla conservazione delle numerose piccole aziende familiari esistenti sul territorio, sebbene la crescene importanza dei prodotti regionali apra però anche nuove possibilità per la vendita diretta dal maso”.
“LE MIE VALLI”
testo e musica di Fausto Fulgoni - elab. di Luciano Casanova Fuga
Il ricordo del primo amore è legato a quello delle mie valli.
Quando le ho lasciate, piangendo mi chiedesti di tornare.
Ed io manterrò la promessa.
Tornerò tra le mie valli
per baciarti ancora e sarai tutta la vita nel mio cuore.
Tornerò tra le mie valli perché non le so scordar,
penso sempre ai prati in fiore dove nacque il primo amor.
E il mio cuore batte forte nel pensare
a quel giorno che piangendo me ne andai,
ed un bacio lei mi diede e mi pregò di tornare tra le valli di lassù.
Tornerò tra le mie valli per guardare gli occhi suoi,
gli occhi di un amor sincero che mi aspetteranno ancor.
E con lei ritornerò là sotto il sole
per guardar le nubi e per sognare ancor,
ed un bacio le darò e giurerò
che sarà tutta la vita nel mio cuor.
Ma come raccontarvi il gusto stuzzicante di un prelibato succo di mela naturale o di una tisana profumata? Delle mille specialità gastronomiche provenienti da più di 170 contadi, ove avviene la preparazione e la degustazione delle erbe aromatiche di montagna quali, ad esempio: la profumata ‘crema all’uva e cannella’; il rinfrescante ‘latticello di ribes nero con limone’; gli ‘sciroppi’ di lamponi, di fiori di sambuco, di menta piperita e di melissa o dell’erba cedrata? Come ‘poeticamente parlando’ posso minimamente avvicinarmi al gusto delle confetture di frutta come le fragole-rabarbaro, delle mele cotogne, delle mirabelle? O anche delle conserve di verdure come i cetrioli, i pepeorni, la barbabietola rossa, delle cipolle e dei zucchini grigliati? E come narrare qui di golosità ‘paradisiache’ come i dolcetti a base di pasta lievitata; i ‘ktapfen’ con ripieno di pere secche e della ‘torta alle noci’? Vogliamo dire del gusto fruttato dei distillati selezionati e invecchiati a lungo periodo che li rende ancora più delicati, tali che ci vorrebbe un’attività sensoriale aggiuntiva per poterne valutare la perfezione? Oppure, degli oli e degli aceti puri o miscelati che impreziosiscono le insalate? …
Non è questo il luogo né lo spazio per fare un elenco delle molte specialità casearie, bovine, ovine e caprine da cui si ricavano i gustosi formaggi e latticini freschi … dai molli e da taglio, di pasta acida, agli yogurt e al burro, cui l’aria fresca di montagna e dei prati altoatesini si rivela ricca di innumerevoli effetti positivi … che talvolta viene da chiedersi quale musica potrebbe accompagnare la bontà di un caprino saporito? Così per dire, ad esempio, qui le mucche danno latte di una qualità impareggiabile che viene trasformato in numerosi latticini squisiti che i contadini del luogo preparano secondo ricette tradizionali; il resto lo fa il sibilo del vento, l’aria trasparente, l’acque cristalline. Per quanto mi riguarda potrei paragonare il tutto a una sinfonia di sapori e di gusti impareggiabile che a dirigere l’orchestra si dovrebbe chiamare il grande Toscanini … magari in un giorno che ‘allegro’ abbia voglia di brindare con gli amici italiani di sempre:
“AMICI MIEI”
Quando ti prende la malinconia
pensa che c'è qualcuno accanto a te.
Vivere non è sempre poesia
quante domande senza un perché!
Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza
è un tesoro che non finirà.
Metti da parte questa tua tristezza,
canta con noi, la tristezza passerà.
Amici miei,
sempre pronti a dar la mano
da vicino e da lontano:
questi son gli amici miei.
Amici miei,
pochi e veri amici miei
mai da soli in mezzo ai guai:
questi son gli amici miei.
Quando ritorna la malinconia
questa canzone canta insieme a noi,
la tua tristezza poi se ne andrà via,
e scoprirai in noi gli amici tuoi.
A volte basta solo una parola
detta a un amico che è un po' giù
fare un sorriso che in alto vola,
torna la vita e di nuovo si va su.
Amici miei,
sempre pronti a dar la mano
da vicino e da lontano:
questi son gli amici miei.
Amici miei,
pochi e veri amici miei
mai da soli in mezzo ai guai:
questi son gli amici miei.
. . .
Questi son gli amici miei.
Ciò detto vale anche e ‘soprattutto’ per la genuinità riscontrabile nelle carni fresche, la cui provenienza regionale è avvalorata da una ‘sana’ catena di lavorazione culinaria: dal rinomato ‘gulash’ all’‘osso buco’, al ‘lesso’, agli ‘arrosti’, al ‘rostbeef’ ecc. E poi ci sarebbe da dire degli insaccati, davvero speciali, ma come si fa (?) Il tempo a disposizione e lo spazio non mi permettono di andare avanti. C’è poi il fatto che a quest’ora, sono già le dodici e mezza, e in montagna lo si sa, ci si mette a tavola presto, mentre io sto qui a cincischiare. Essendo io un amante delle ‘zuppe’, posso solo dirvi di alcuni sapori particolari come quello della ‘minestra d’orzo’ con filetti di speck stagionato, e inoltre dovrei essere particolarmente ispirato per parlarvi del contorno di ‘spätzle’ con uova mescolate all’erba cipollina … una poesia! E ad essere sincero, non mi è facile rammentare di queste prelibatezze senza provare un certo languorino in bocca.
“Mangiare dal contadino – prosegue la guida del Gallo Rosso – significa mangiare i frutti di stagione. Fra le ricette più classiche, da non perdere, gli ‘schlutzer’, i tipici ravioli agli spinaci; i ‘tirtlen’, frittelle farcite e ancora i famosi ‘canederli’ e vari tipi di ‘gnocchi’; e ancora le minestre e le ‘zuppe’ di verdure, e di pane. Insomma, nell’impossibilità di raccontarvi già solo il profumo irresistibile del ‘pane’ preparato secondo l’antica tradizione, cioè lavorato accuratamente a mano e cotto nel forno a legna, trovo rifugio in un maso dell’Alta Val Venosta per mangiare fino a sazietà una ‘zuppa di pane di farro raffermo’ con uova di allevamento all’aperto, un pizzico di sale e di noce moscata, un chucchiaio di burro altoatesino … e chissà che per oggi il buon Dio non mi abbia già perdonato. E intanto che ci avviviniamo al Natale voglio qui ricordare i numerosi ‘mercatini’ delle feste con le bancarelle, le luminarie e i dolci tipici, i canti di giubilo e le canzoni della tradizione di cui quella qui sotto riportata è entrata a far parte della tradizione:
“NATALE SULLE STRADE IMBIANCATE”, pop. arm. di Gianni Dalla Fina.
Natale dei ricchi e il Natale dei poveri. Le vetrine illuminate e i palazzi della gran città, ma anche i bambini nelle soffitte lontane o gli emigranti che sognano i luoghi natii, festeggiando il Natale in terra straniera. Intanto il vecchio campanile suona, mentre la neve candida tutto ricopre.
Cade la neve avvolta di candore,
dorme nei suoi palazzi la gran città.
In ogni casa pregano il Signore
che questa notte in terra nascerà.
Natale sulle strade imbiancate,
risplendon le vetrine illuminate.
Ma là nelle soffitte più lontane
ci son dei bimbi che non hanno il pane,
non hanno più la mamma né il papà.
Là nei lontani lidi d'oltre mare
portan le navi i nostri lavorator.
Ogni emigrante sogna il suo casolare
e prega mentre nasce il Redentor.
Natale sulla terra straniera,
da tutti i cuori sale una preghiera:
"deh, fammi riveder la mia casetta,
la mamma tanto vecchia che m'aspetta,
chissà se un giorno ancor la rivedrò".
Din don, din don…
sul vecchio campanil…
din don, din don…
la neve scende ancor.
E che dire dei prossimi ‘Mercatini di Natale’ che allietano la regione? Il fascino delle città del Südtirol, è reso ancora più speciale nel periodo natalizio dalla presenza dei tanti mercatini di Natale, alcuni dei quali espongono il marchio Gallo Rosso. Per l’occasione alcune città vengono riccamente addobbate in ogni angolo ed offrono ai visitatori varie possibilità di svago e l’occasione per gustare specialità tipiche come i ‘kiachln’ e gli ‘spatzln’, buonissimi dolci e vin brulé:
Mercatino di Natale a Vipiteno:
pini e abeti sono considerati simboli della vita e della pace natalizia; se ne trovano di maestosi, decorati per tradizione con mele, noci, biscotti di panpepato e con i tradizionali addobbi in legno che li fanno aparire ancora più festosi e sfavillanti. Intorno ad ogni albero le bancarelle offrono una grande varietà di addobbi per imprezosire il vostro albero di Natale. Ci si può lasciare sedurre da profumi, dal fascino e della musica e tuffarsi nella tradizione senza fretta, semplicemente seguendo il ‘percorso prenatalizio’ predisposto per incantare, facendo appello alle sue favolose attrazioni.
Mercatino di Natale a Brunico:
qui ci si può lasciar affascinare dall’atmosfera festosa, dal luccichio e dal profumo degli abeti, assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè e del té bollente, mentre si passeggia attraverso i banchetti artisticamente decorati e le leccornie esposte, per i quali grandi e piccini impazziscono. Qui si possono gustare le specialità tirolesi come “tirtlan”, “niggilan” e patate ripiene al forno e moltissime specialità culinarie tipiche del luogo. Il commercio però non è tutto, al centro del Mercatino di Natale a Brunico si ha occasione di conoscere il vero artigianato e le tradizioni della terra: dalle decorazioni per l’albero di Natale, ai giocattoli in legno, all’oggettistica in pelle, vetro e ceramica. È con questo spirito che alcuni artigiani mostrano ogni anno ‘dal vivo’ come vengono realizzati i prodotti tradizionali dell’Alto Adige. Il cui obiettivo è rendere il periodo dell’Avvento indimenticabile e ricco di fascino.
‘Mercatino dell‘Avvento a Glorenza’:
Un alone di romanticismo avvolge il piccolo borgo di Glorenza, quando i suoi abitanti cominciano a decorarne le mura in vista del Natale ravvivato dai canti festosi di grandi e piccini, sparsi sotto i portici e fino alla piazza principale. Non mancano momenti di musica, in un borgo intriso di odori e sapori di mela, cannella e dei tradizionali dolci Lebkuchen. Le storiche mura faranno da scenario per la rappresentazione di concerti d'Avvento con cori e fiati provenienti dalla Val Venosta e dintorni.
Acciò, non mi resta che darvi appuntamento per una vacanza davvero diversa in Südtirol / Alto Adige, se non altro, per ritrovare nei ‘masi’ contadini quella serenità che si pensava aver perduta per sempre.
‘Buon appetito a tutti!’
Per saperne di più di possono visitare o richiedere le pubblicazioni “Sapori del Maso” e “Masi con gusto” 2015/2016 a cura di Gallo Rosso – Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ai seguenti indirizzi:
info@gallorosso.it, www.gallorosso.it
Si ringrazia per la cortesia riservata ai lettori di larecherche.it e la sensibile collaborazione: dott.sa Martina Mair / Gallo Rosso.
I brani riportati sono in maggior parte tratti dal CD “La nostra storia” eseguiti per il 40° del Coro Comelico nel 2006 - Edizioni DIGITALSUOUND.
E-MAIL: corocomelico@libero.it
Oppure indirizzare richiesta a:
M. Luciano Casanova Fuga
Via De Villa n. 56 – 32040 Costalta di Cadore (BL)
*
 - Filosofia
- Filosofia
ZYGMUNT BAUMAN: o la ‘Coscienza Liquida’
«Abbandonate ogni speranza di totalità,
futura come passata,
voi che entrate nel mondo della modernità liquida».
Non c’è nulla di sconveniente né di catastrofico in questa frase coniugata su una indubbia ‘realtà’ nella quale di fatto ci conduciamo abbandonati agli eventi e agli accadimenti che accompagnano il nostro vivere quotidiano. Semmai, una sorta di subalternità cosciente alla vita stessa in contrapposizione con quanto in ‘realtà’ fluidifica nel nostro libero arbitrio e che attribuiamo alla nostra volontà. In contrasto o, se volete, in conflitto con ciò che la ‘materia pensante’ del nostro intelletto sviluppa in termini di ‘scelte’, di concezioni ‘indotte’ forse mai completamente sviscerate nella sostanza, la cui attestazione pregressa sembra aver perso l’iniziale profondità di ‘senso’.
Onde per cui oggi vivere l’istante con seducente leggerezza nel modo in cui vi adempiamo, fa sì che, «..solo i giorni contino nello spazio senza tempo, reso liquido in funzione di una presunta immortalità» cui, irragionevolmente andiamo incontro o, forse, a cui crediamo di andare incontro (?). Ma non è così. Lì dove lo spazio temporale non ha più una base su cui poggiare la materia profonda del ‘senso’, anche l’immortalità perde di senso, «..inclusa la vita»; che, dismesso il suo precipuo ruolo di protagonista dei nostri giorni, assume il volto della ‘maschera’ inerte, capace solo d’una felicità estatica di cui ci rivestiamo, raggiante perché irraggiungibile. Miraggio quindi più che essenza, assenza più che presenza, edonismo gaudente o presunzione di appariscenza più che autentica ‘forma’ dell’essere.
La metafora della ‘liquidità’ dacché Zygmunt Baumam l’ha coniata, ha marcato i nostri anni ed è entrata nel linguaggio comune per descrivere la modernità in cui viviamo: «Individualizzata, privatizzata, incerta, flessibile, vulnerabile, nella quale a una libertà senza precedenti fanno da contraltare una gioia ambigua e un desiderio impossibile da saziare», che ha determinato una svolta, solo apparentemente sconcertante, d’una presunta ‘immortalità’ cui noi tutti tendiamo. Le cause del cambiamento però sono più profonde, radicate nell’abissale trasformazione in cui la società moderna ‘opera e consolida’ se stessa nell’attuale contrapposizione di ‘similitudine e differenza’, il cui procedere ha lo scopo conseguibile del riequilibrio storico che passa dalla modernizzazione dei parametri del passato, a quelli della deregolamentazione e della privatizzazione attuali. Cioè dall’autoaffermazione dell’individuo pur sempre alla ricerca della propria felicità sfuggente, all’interno di una società resa ormai fluida e ad uno ‘stile di vita’ pù confacente.
«La società degli individui plasma l’individualità dei suoi membri e degli individui che danno forma alla società tramite le loro azioni vitali e il perseguimento di strategie plausibili e fattibili all’interno della rete socialmente costruita della loro dipendenza» – avverte Bauman – ma se la società moderna esiste è perché ha ragione di esistere in logica della sua incessante attività di individualizzazione, «..così come le attività degli individui consistono nella quotidiana riformulazione e rinegoziazione della rete degli obblighi reciproci chiamata ‘società’». Per quanto il processo di individualizzazione teorizzato da Ulrich ed Elisabeth Beck si ripresenti oggi all’attenzione sociologica (e psicologica freudiana), ‘..come un evento incessante e interminabile che ha portato alla nascita dell’individuo ‘civilizzato’ nell’opera di modernizzazione continua e incessante, compulsiva e ossessiva’, cui oggi di fatto assistiamo.
«Vivere quotidianamente con il rischio (peso) dell’autocondanna (cui siamo inconsciamente soggetti), e della disistima di sé (di cui siamo soggetti coscienti), non è questione di poco conto, ancorché si tengono gli occhi puntati esclusivamente sulla propria (singola) ‘performance’ e li si distoglie dallo ‘spazio sociale’ in cui le contraddizioni dell’esistenza individuale vengono collettivamente prodotte, (..) al fine di ridurre la complessità delle ‘cause’ della propria miseria intelligibile e renderle dunque affrontabili e suscettibilili di rimedio», alle quali vanno accluse quelle che più condizionano la ‘libertà individuale’ (il libero arbitrio), refrattaria com’è ad assumersi i rischi e le responsabilità che sempre accompagnano ogni forma reale di autonomia e autoaffermazione. «Non può essere certo (solo) questo – aggiunge Baumann – il vero significato del termine ‘libertà’, e se la libertà ‘realmente esistente’, la libertà disponibile significa davvero tutto ciò, non può essere né una garanzia di felicità né un obiettivo per cui valga la pena di lottare».
Ma una sentenza così formulata ha, in ultima analisi, la forza di un anatema che rimette in discussione quanto fin qui posto in evidenza dal ‘libero pensiero’, per cui l’effettiva ‘libertà’ consiste nell’affrancarsi dalle forze fisiche irrazionali alla più razionale ‘forza’ libertaria e individualistica che riconosce nella ‘volontà sociale’ una ‘unità indissolubile’ a cui sottomettere il proprio ‘libero arbitrio’: «Pensare è ciò che fa di noi degli esseri umani (socialmente formati), ma è l’essere umani che ci fa pensare, (..) non è qualcosa che si possa spiegare e non necessita di alcuna spegazione». Dacché l’insostituibile conferma che ha espresso Theodor W. Adorno: “Lesigenza di pensare è ciò che ci induce a pensare”, per quanto il pensiero filosofico di Leo Strauss ci induca a considerare che: “..la filosofia è la ricerca dell’eterno e immutabile ordine entro cui la storia (umana) si dipana e, alla quale, (l’essere umano) è completamente insensibile”.
Per quanto, a quella che qui può sembrare una contraddizione in termini, il libero pensatore Bauman risponde con una delle sue riflessioni più costruttive: «Forse il tempo a disposizione mi è parso troppo breve non a causa della mia ormai veneranda età, ma perché quanto più vecchi si diventa tanto più si impara che, per quanto grandi i pensieri possano sembrare, non lo saranno mai abbastanza da inglobare, e tanto meno trattenere, la munifica prodigalità dell'esperienza umana. Non è forse vero che una volta che è stato detto tutto sulle più importanti questioni della vita umana, rimangono ancora da dire le cose più importanti?» Quasi che, in ultima analisi, si volesse assecondare quanto espresso da Ludwig Wittgenstein nel dire che: “La filosofia lascerebbe tutto com’era (o come è sempre stato); il pensiero nato dalla repulsione (che oggi dimostriamo) per la disumanità della condizione umana, farebbe poco o nulla per rendere tale condizione più umana”.
Tutto ciò ancor oggi che la filosofia ci stupisce e contrasta con la ‘seducente leggerezza del nostro vivere l’istante’ a causa dell’incertezza in cui essa ci ha confinati; proprio oggi che il fluidificarsi delle certezze fin qui acquisite sembra venire meno, lasciando a noi ‘individui sostanziali della realtà liquida’ di galleggiare senza il sotegno dell’acqua. Un po’ come quegli innamorati ‘fluttuanti nell’aria’ cari a Marc Chagall che, non essendo dotati di ali, si aiutano l’un l’altro tenendosi per mano nel sovrastare i tetti e le torri delle città, e allontarsi (forse?) dalle brutture che la società dolente loro incombe. Segno della necessità di un sostegno che la filosofia seppure costantemente ci offre, allo stesso modo altrettanto ci toglie, secondo la prossimità ‘fuorviante’ degli individui cui è soggetta.
E non solo, ma ed anche, di una ricercata solidarietà nel rispetto della libertà che a volte, come esseri umani, pur ci distingue e che non sempre applichiamo in nome di una autonomia individualistica che, «..contrariamente – a ciò che si vuole – può arrecare più pene che gioia». Soprattutto quando opera in conformità con certi «..modelli e standard imposti da forti pressioni sociali (che in ultima analisi ci) risparmiano tale agonia: grazie alla monotonia e alla regolarità di condotta raccomandati, imposti e inculcati (per cui) gli esseri umani sanno quasi sempre come procedere e ben di rado vengono a trovarsi privi di adeguate direttive o finiscono in situazioni in cui occorre prendere decisioni e assumersene la responsabilità senza conoscerne le conseguenze, rendendo così ogni passo, irto di rischi e difficile da calcolare».
Di fatto oggi le ‘soggettività collettive’, «..più postulate che immaginate, potrebbero non essere altro che effimeri prodotti della commedia dell’individualità attualmente in scena anziché forze capaci di determinare e definire (tali) identità». Come anche scrive Lars Dencik: “Le affiliazioni sociali, (conformi alle soggettività collettive), più o meno ereditate, che vengono tradizionalmente attribuite agli individui come definizione di identità – razza, (..) genere, paese o luogo di nascita, famiglia e classe sociale – stanno ora (..) diventando meno importanti, diluite e alterate, nei paesi tecnologicamente ed economicamente più avanzati. Al tempo stesso si assiste a un forte desiderio e a tentativi di trovare o fondare nuovi gruppi che possano dare ai membri un senso di appartenenza e facilitare la fabbricazione di una identità”.
Tuttavia ad una richiesta di ‘libertà responsabile’ corrispondono talune ‘identità e differenze irresponsabili’ preconcettuali insite nelle ‘soggettività collettive’, che la sociologia relazionale di fatto non ha ancora evidenziate e che sono di riferimento dell’individualità politico-sociale dei soggetti che la condividono e in cui si organizzano: “..e questo secondo valori, criteri guida e modalità di gestione tali da realizzare una nuova relazione tra ‘cittadino e uomo’. (..) Si tratta dunque di un ampliamento della stessa sfera della soggettività, che va oltre la mera sfera soggettiva di una imputazione formale di diritti al soggetto, astrattamente inteso come cittadino, per allargare questa sfera alle formazioni associative cui prende parte ed a tutta la sua rete sociale, e cioè ad un insieme di ruoli collegati ai suoi bisogni … di coesione sociale”.
Ne deriva un crescente sentimento di insicurezza sulla scena contemporanea – afferma inoltre Bauman, per il quale «..l’identità è oggi come un vestito che si usa finché serve: sessuale o politica, religiosa o nazionale è precaria come tutto della nostra vita, di là dalla nostra intelligenza e immaginazione. (..) Il nostro mondo liquido-moderno è in continua trasformazione. Tutti noi – volenti o nolenti, consapevoli o no, che ci piaccia o meno – veniamo trascinati via senza posa, anche quando ci sforziamo di ‘calcolare l’incalcolabile’ o di rimanere immobili nel punto in cui ci troviamo». “Trattasi di una «grande trasformazione» – avverte Benedetto Vecchi (nella premessa a ‘Intervista sull’identità’ di Bauman), coinvolgente tutti gli ordinamenti interstatali, dalla condizione lavorativa alle soggettività collettive, al rapporto tra l’io e l’altro, alla produzione culturale e la vita quotidiana di uomini e donne.”
Tuttavia, mentre l’ormai influente sociologo ci mostra una società che respinge la stabilità e la durata di questa continua debacle, che preferisce l’apparenza alla sostanza, «..in cui il tempo si frammenta in episodi, in cui la salute diventa ‘fitness’, la massima espressione della libertà è lo ‘zapping’, dalle macerie del vecchio ordine politico bipolare sembra emergere solo un nuovo disordine mondiale e l’economia invoca la ‘deregulation’ universale, (..) le figure emblematiche che abitano questo traballante universo (di individui che siamo noi), sono il giocatore (in borsa e alla lotteria), il turista, lo sdradicato, (“Il giovane sdraiato” di Michele Serra e “L’ospite inquietante” di Umberto Galimberti), il collezionista di sensazioni, ma soprattutto, lo straniero». Il mondo, questo nostro mondo, continua così ad andare avanti, e per fortuna (dico io), il bisogno di pensare non è venuto ancora meno. Occorre però trovare delle risposte immediate, promuovere maggiore consapevolezza negli individui.
È lo stesso Bauman a fornirci quella che al dunque sembra la risposta più logica e la più scontata: «Per impedire che l’uomo diventi presto uno straniero anche a se stesso occorre forse guardare ad altre strategie di vita: nel distinguere nella sostanza e nei modi il nostro parlare dei ‘sentimenti’ (sociali: moralità pubblica e politica in Stefano Rodotà) e delle ‘passioni’ (sociali: democrazia e libertà in Erich Fromm) – ad esempio – per altri versi essenzialmente simili in quanto “Cose che abbiamo in comune” (dal titolo di un altro libro di Bauman). E delle loro conseguenze comportamentali e politiche che contano e incidono sulla qualità della coabitazione umana, non le parole che usiamo per raccontarli»; poiché – come direbbe Claude Lévi-Strauss – “..costruirsi un’identità è un lavoro da bricoleur, che crea ogni sorta di cose col materiale a disposizione”.
«Ciò tuttavia non significa – avverte Bauman – che la nostra società abbia soppresso il pensiero critico in quanto tale. Né ha reso i propri membri reticenti (e ancor meno timorosi) a dargli voce. Semmai, è vero il contrario: la nostra società – una società di ‘liberi individui’ – ha reso la critica della realtà, la disaffezione verso ‘ciò che è’ e l’eplicitazione di tale sentimento, parte al tempo stesso inevitabile e obbligatoria della vita di ogni suo singolo membro». Quella stessa che Norbert Elias ha definito: “La società che plasma l’individualità dei suoi membri e gli individui che danno forma alla società tramite le loro azioni vitali e il perseguimento di strategie plausibili e fattibili all’interno della rete socialmente costruita della loro (stessa) indipendenza”. E che Bauman concludendo ha così sintetizzato: «Per dirla in breve, il processo di ‘individualizzazione’ consiste nel trasformare ‘l’identità’ umana da una ‘cosa data’ in un ‘compito’ (una missione che ognuno è chiamato a svolgere), e nell’accollare ai singoli attori la responsabilità di assolvere, nonché delle conseguenze (anche collaterali) delle loro azioni».
«Dacché, incalza Bauman, l’unica, ma formidabile differenza tra il punto di partenza e d’arrivo di questa ampia ‘deviazione’ è che ora, alla fine del tragitto, abbiamo perso le illusioni ma non le ‘paure’. Abbiamo cercato di allontanare quest’ultime esorcizzandole senza esserci riusciti; con questo tentativo siamo riusciti soltanto ad accrescere la somma degli orrori che chiedono a gran voce di essere affrontati e allontanati». E, poiché «temiamo ciò che non siamo capaci di gestire, chiamandola ‘incapacità di comprendere’; ne viene che ciò che non siamo in grado di gestire ci è ‘ignoto’ e l’ignoto è forse quello che più ci fa paura: «La più orribile tra le paure sopraggiunte è quella di non poter evitare la paura né di poter sfuggire ad essa». Per poi aggiungere lapidario: «La paura è un altro nome che diamo al nostro essere senza difese».
Non a caso Giuseppe Galasso, in un articolo apparso sul “Corriere della Sera”, ha definito questa analisi di Bauman di non comune interesse: “minuziosa e impressionante”, in ragione del suo prevedere l’insinuarsi della ‘paura’ per effetto della ‘globalizzazione negativa’, per cui si può affermare, in aggiunta ai fattori precedentemente indicati, la ‘discontinuità’ che ha reso visibile la forza spaventosa di quella che possiamo definire come la sfera dell’ignoto, dell’incomprensibile, dell’ingestibile. “Finora – egli scrive – questa fatidica novità è stata indicata con il termine semplificativo di ‘globalizzazione’ come effetto positivo, benché non si sia tenuto conto degli aspetti negativi che vi si nascondono. (..) Una ‘globalizzazione’: incontrollata, non completata né compensata da una versione ‘positiva’ che, nel migliore dei casi, è ancora una prospettiva lontana o, secondo alcune previsioni, è già una vana speranza”.
Il carattere ‘aperto’ (‘liquido’ secondo Bauman) della nostra società, ha acquisito in questi ultimi anni un lustro nuovo in cui: «L’illegalità globale e la violenza armata si alimentano e si rafforzano reciprocamente. La globalizzazione del male e del danno si ripercuote nel rancore e nella vendetta globale». Affermazione che Karl Popper, inventore dell’espressione “globalizzazione negativa”, non avrebbe osato neanche sperare: “.. (quindi) non più prodotto prezioso, fragile di sforzi coraggiosi, faticosi di autoaffermazione, ma destino ormai irresistibile creato dalla pressione di formidabili esterne, (effetto secondario della globalizzazione negativa), vale a dire della globalizzazione altamente selettiva dei commerci e dei capitali, della sorveglianza e dell’informazione, della coercizione e delle armi – il crimine e il terrorismo, tutti fenomeni che ormai disprezzano la sovranità territoriale e non rispettano alcun confine”.
«Per la grande maggioranza degli abitanti di un mondo di modernità liquida, atteggiamenti come la preoccupazione per la coesione, l’adesione alle regole, il giudicare sulla base dei precedenti e il restare fedeli a una logica di continuità invece di fluttuare sull’onda di opportunità mutevoli e di breve durata, non sono opzioni promettenti. Se vengono adottati da qualcun altro (di rado volontariamente, se ne può star certi!), vengono prontamente bollati come sintomi di deprivazione sociale e stimmate di insuccesso nella vita, di sconfitta, di scarso valore, di inferiorità sociale. (..) La contrapposizione, in ultima analisi, (..) almeno quella che precede i pensieri e le scelte dei singoli individui, sta nei prodotti e nei sedimenti collaterali alle scelte umane che, (..) in linea di principio possono dall’uomo essere disfatti», proprio a causa di una ‘nozione senza senso’ che li trasfrorma di fatto in ‘danni collaterali’, imprevedibili quanto inaccettabili, per cui «l’identità – sarà bene esser chiari su questo punto – è un concetto fortemente contrastato».
Siamo dunque di fronte a un ulteriore paradosso della ‘modernità-liquida’ – scrive Bauman, eppure, contrariamente all’evidenza obiettiva, «..ci si sente (e in realtà lo siamo) maggiormente esposti alle minacce, più insicuri e spaventati, più inclini al panico e molto più interessati a tutto ciò che possa essere messo in relazione con la sicurezza e incolumità. (..) Tuttavia sembrano esserci vie d’uscita», anche se l’apertura mediatica del sociologo sembra andare verso una direzione univoca e imprescrittibile: «Sfuggiti a una società forzatamente aperta dalla pressione delle forze della globalizzazione negativa, il potere e la politica vanno sempre più alla deriva in direzioni opposte. La sfida fondamentale (il rischio) che questo secolo dovrà affrontare è, con ogni probabilità, quello di rimettere insieme potere e politica; e il compito che probabilmente dominerà l’agenda del secolo, sarà la ricerca di un modo per realizzare tale obiettivo. (..) La democrazia e la libertà non possono più essere assicurate soltanto in un solo paese o in un gruppo di paesi; difenderle in un mondo saturo di ingiustizia e abitato da milioni di esseri umani cui è negata la dignità corromperà inevitabilmente gli stessi valori che essa intende proteggere. Il futuro della democrazia e della libertà dev’essere messo al sicuro su scala planetaria, o non lo sarà affatto».
Non è questa l’unica avvertenza lanciata da Bauman nelle pagine intense del suo libro “Paura liquida”, che vanno lette secondo una specifica propensione nel trovare ‘soluzioni’ ai problemi che ci assillano; acciò nella speranza del ravvedimento contro la crescente ‘paura’ che i nostri comportamenti vanno disseminando e che finiscono per sradicare le nostre ‘radici’ umane, renderci orfani di quella ‘collettività’ economico-politico-religiosa che, nel giusto o nell’errato, abbiamo contribuito a formare, e che dobbiamo (c’incorre l’obbligo) continuare a migliorare. «Il secolo che viene può essere un’epoca di catastrofe definitiva – lo dicono le vicende politiche in atto e la ‘paura’ di una guerra totale che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta – o, che può essere un’epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai come umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due futuri»:
«L’uomo nel suo breve soggiorno sulla terra è uguale a Dio nella sua eternità».
Che sia scongiurato il pericolo di incorrere in una qualche ‘apologia di sistema’ lo conferma una importante teoria metaetica nota come ‘critica al relativismo morale’ o come meglio specificata ‘critica morale delle società’ che tuttavia non sembra lasciare spazio ai valori centrali di alcuna società. “Se i giudizi morali si definiscono in relazione ai valori centrali di una società – scrive Nigel Warburton – nessuna critica di tali valori può servirsi di argomenti morali contro di essi, (..) per cui tutte le affermazioni etiche (morali) sono letteralmente prive di significato”. In realtà esse non esprimono alcun fatto, ma sono semplicemente espressioni di emozioni. “Siamo pertanto davanti a una realistica ‘impossibilità della argomentazione morale’ – procede Warburton – in quanto solo quando vengono formulati giudizi morali veri e propri che la discussione (in atto) si trasforma nell’espressione priva di significato emozionale. (..) Una concezione, come quella kantiana, secondo cui i giudizi morali sono validi per tutti – sono cioè impersonali –, fornisce agli individui buone ragioni per attenenrsi a un codice morale comunemente accettato”. (..) Per quanto questo argomento costituisca solo una teoria filosofica, Warburton tuttavia fornisce un’indicazione dei pericoli che incomberrebbero sulla società allorché l’ ‘emotivismo’ fosse largamente accettato, “..il che è una questione diversa da quella della sua verità”.
Nel contesto ‘liquido-moderno’ innescato dal sociologo Bauman, il pensiero metodologico rincorre la ‘paura’ e ne sviscera i numerosi aspetti, fin dalla sua origine (la paura della morte e la paura del male), alla dinamica d’uso (volontà e necessità della paura); dall’orrore dell’ingestibile (precarietà e insicurezza come derivati della paura), al terrore globale (problematicità e catastrofismo insiti nella paura); arrivando, nella sua efficace analisi, a proporre i ‘rimedi’ o, perlomeno, le precauzioni e i suggerimenti per affrontare quelle che sono le ‘paure’ più diffuse, che egli ritiene nate e alimentate dalla nostra ‘costante insicurezza’. Di fatto, nei due capitoli finali “Far affiorare le paure” e “Il pensiero contro la paura”, egli mette in evidenzia il paradosso di una «..conclusione provvisoria per chi si chieda che fare (?)».
Tuttavia lo schema cui Bauman affida le possibilità di una presumibile risoluzione delle ‘paure’ non è dimostrativo, bensì ‘conoscitivo’, in quanto discopre alla ragione quanto c’è nel substrato umano di tipo psicologico, le cui certezze sono messe a rischio dal continuo mutare delle ‘paure’ cui andiamo soggetti, anche a nostra insaputa: dal ‘millenium bag’ alla febbre ‘aviaria’ o la ‘mucca pazza’; dalla minaccia del ‘buco nell’ozono’ alla ‘sofisticazione alimentare’ o la ‘guerra batteriologica’ la cui capacità distruttiva potrebbe mettere a dura prova la sopravvivenza umana. Ma queste sono soltanto le grandi calamità, più o meno vicine che apprena denunciate ci riportano alle apocalissi bibliche ancora di là da venire. In verità, non c’è niente di ‘apocalittico’ in Bauman, se non il metterci di fronte alle nostre ‘paure’ più prossime riguardanti il presente e la nostra capacità di ‘sopravvivenza’ economico-sociale, culturale e politica prossima futura.
I riferimenti sono per lo più alle nostre ‘paure’ quotidiane: «I mezzi sono i messaggi. Se le carte di credito e i libretti di risparmio ispirano certezza nel futuro, un futuro incerto reclama a gran voce un futuro degno di fiducia. (..) Un futuro che certo arriverà e che, una volta giunto, non sarà tanto dissimile dal presente (..) che darà valore a ciò cui noi diamo valore (..) prosperando sulla speranza / aspettativa / fiducia che, grazie alla continuità tra il presente e il futuro, farà la differenza, determinerà la forma del futuro». Ciò non deve sorprendere: «..possiamo preoccuparci solo delle conseguenze indesiderabili che siamo in grado di prevedere, e soltanto queste possiamo cercare di evitare. (..) Dobbiamo tuttavia notare che la ‘calcolabilità’ (di rischio) non significa prevedibilità ciò che si calcola è solo la ‘probabilità’ che le cose vadano male e che sopraggiunga il disastro. Il calcolo delle probabilità dice qualcosa di affidabile sulla distribuzione degli effetti di un gran numero di azioni simili, ma è quasi inutile come mezzo di previsione quando lo si impiega (alquanto impropriamente) per orientarsi in una specifica impresa».
Un ossimoro che mi sento di cogliere in Bauman è senz’altro il seguente: «L’incomprensibile è diventato normale». Con ciò egli mette in luce un aspetto della ‘paura’ tutt’ora sotterraneo, scaturito dalla sindrome spaventosa della ‘catastrofe personale’ per cui si teme di essere presi ‘a bersaglio’, di essere personalmente distrutti «..per essere lasciati indietro, di essere esclusi. (..) Che simili paure siano tutt’altro che immaginarie, lo si desume dalla preminente autorità dei mezzi di comunicazione, fautori – visibili e tangibili – di una realtà che non si riesce a vedere né a toccare senza il loro aiuto. Acciò potremmo dire che la Bibbia si è ridotta al solo “Libro di Giobbe” – prosegue Bauman – mettendoci sull’avviso che tutte le favole morali (che ci vengono inculcate) in verità agiscono seminando paura. Ma, mentre le favole morali di ieri servivano a redimere le minacce che le generava “per vivere una vita senza paura”»; quelle di oggi (al contrario) sembrerebbero rinchiudere l’ ‘identità’ fra le sbarre di una gabbia provvisoria in cui la condizione umana è rimasta senza alcuna ‘eternità’ (senso) di riferimento.
Una critica a Bauman, semmai la si volesse elevare sul piano teorico, potrebbe riguardare proprio la questione metaetica della moralità articolata sul principio di ‘comunità’, in quanto formata da persone vincolate da leggi morali, di esseri razionali che scelgono di vivere nel mutuo rispetto e che più spesso sono capaci di risolvere, (o almeno dovrebbero), le dispute attraverso il negoziato e l’accordo. “Kant ci dice – rammenta Roger Scruton – che dobbiamo agire ‘basandoci sulla massima che possiamo volere come legge per tutti gli esseri razionali’; dobbiamo trattare gli esseri razionali come fini e mai solo come mezzi; dobbiamo agire in vista del ‘regno dei fini’, in cui vengano conciliati tutti gli scopi razionali. Questi principi altamente astratti (che Kant chiama ‘formali’) sono meno significativi della procedura che implicano. Le persone hanno un solo e prezioso mezzo per risolvere i loro conflitti – un mezzo precluso al resto della natura. Infatti, sono in grado di riconoscersi a vicenda come esseri liberi, che si assumono la responsabilità delle loro decisioni, e che possiedono diritti e doveri rispetto alla loro specie”.
In “Il diritto di avere diritti” - scrive Stefano Rodotà: “Il diritto individuale alla ricerca della verità attraverso le informazioni, chiarisce bene quale sia il significato della verità nelle società democratiche, che si presenta come il risultato di un processo di conoscenza aperto, che lo allontana radicalmente da quella produzione di verità ufficiali tipica dell’assolutismo politico che vuole invece escludere la discussione, il confronto, l’espressione di opinioni divergenti, le posizioni minoritarie”. Polemica a parte, si apre qui una tematica ‘altra’ sulla conoscenza come funzione della trasmissione del sapere (critico) e della formazione (al settore produttivo) e che Rodotà distingue come materia costituzionale, che sancisce: “il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”, a sua volta ripreso dall’articolo 19 della “Dichiarazione universale dei diritti umani” emanata dall’Onu.
Tematica che ritroviamo anche in quanto affermato da Zygmunt Bauman che in “Modernità liquida” la oppone alla ‘modernità solida’ durkheimniana come atto finale: «..sotto la cui protezione trovare riparo dall’orrore della propria transitorietà». Ed è proprio la ‘transitorietà’ (della vita) – secondo il mio modesto parere – a rimettere in discussione il concetto primario di ‘bene’ inteso come entità discriminante, rifugio ultimo e santuario di una continuità che supera i limiti tracciati dalla selettività naturale, per cui ciò che è ‘bene comune della conoscenza’ porta la conseguenza inalienabile della sostenibilità futura per la ricerca, la sperimentazione, la progettazione, la promozione, i sistemi formativi, l’utilizzo delle risorse comunicative, nella prospettiva d’una fattibile economia globale. Spetta dunque ai ‘processi formativi’ contribuire a formare il know-how necessario alla conoscenza e divulgare le competenze richieste, come processo che non si esaurisce nello spazio e nel tempo dell’apprendimento tradizionale dello sviluppo individuale del ‘bene come mezzo’, bensì è attivo nel riaffermare l’importanza della conoscenza nella prospettiva del ‘bene’ come ‘fine’ ultimo del ‘libero accesso’.
Va con sé che un argomentare così fatto richiede una qualche introduzione esplicativa di ciò che finora è stato sotteso, cioè il ‘diritto alla libertà’ di pensiero, di parola, di verità intellettuale, a fronte di una deontologia che per sua natura include l’etica, la moralità, norme e regole che danno forma a una ‘conoscenza’ compiuta e definitiva, che va intesa come ‘bene assoluto’, incondizionato, creativo, formativo, improcrastinabile del benessere sociale, sotto la suprema direzione della ‘volontà’ (generale), capace da sola, di trasformare la ‘legge’ (che la governa) nell’unico spazio in cui la ‘libertà’ si concretizza. “Se non fosse così – aggiunge Roger Scruton – la ‘legge morale’ così come Kant la chiama, cesserebbe di adempiere al suo proposito, che è quello di riconciliare gli individui in una società di stranieri. (..) La legge morale ha un carattere assoluto. I diritti non possono essere calpestati arbitrariamente o soppesati in relazione a un eventuale vantaggio di ignorarli. I doveri non possono essere trascurati altrettanto arbitrariamente, o cancellati dai cattivi risultati della dovuta obbedienza”.
Pensando in questi termini, riconosciamo ogni persona come membro insostituibile e autosufficiente dell’ordine morale: “I suoi diritti, doveri e responsabilità sono cose che l’essere umano possiede in quanto persona, e solo in quanto ciò può adempiere o rinunciare ad essi, e solo lui può essere chiamato a dar conto dei doveri che ha eventualmente trascurato”. Del resto le favole morali del nostro tempo – avverte ancora Bauman – sono tendenzialmente impietose, e non promettono alcuna redenzione: «Irreparabile.. irrimediabile.. irreversibile.. irrevocabile.. senza appello.. il punto di non ritorno.. il definitivo.. l’ultimo.. la ‘fine di tutto’ Esiste uno e uno solo evento cui si possano attribuire a pieno titolo tutte queste qualificazioni nessuna esclusa, un solo evento che renda metaforico ogni altro loro impiego, l’evento che conferisce a quei termini il loro significato primario, incontaminato e non diluito».
«Quell’evento è la ‘morte'. (..) La morte incute paura per via di quella sua qualità diversa da ogni altra: la qualità di rendere ogni altra qualità non più superabile. Ogni evento che conosciamo o di cui siamo a conoscenza – ogni evento, eccetto la morte – ha un passato e un futuro. Ogni evento – eccetto la morte – reca una promessa, scritta con inchiostro indelebile anche se a caratteri piccolissimi, secondo cui la vicenda «continua». (..) Soltanto la morte significa che d’ora in poi niente accadrà più, niente potrà accadere, niente che possa piacere o dispiacere. È per questa ragione che la morte è destinata a restare incomprensibile a chi vive, e anzi non ha rivali quando si tratta di tracciare un limite realmente invalicabile per l’immaginazione umana. L’unica e la sola cosa che non possiamo e non potremo mai raffigurarci è un mondo che non contenga noi che ce lo raffiguriamo».
«La natura provvisoria di qualsivoglia identità e di qualsivoglia scelta tra l’infinita moltitudine di modelli culturali a disposizione non è stata ancora scoperta, né tantomeno inventata (..) L’idea che nulla, nella condizione umana, venga dato una volta pre tutte e senza il diritto di appellarsi ed emendare, che tutto ciò che è debba prima essere ‘fatto’ e una volta fatto possa essere modificato all’infinito, ha accompagnato l’età moderna fin dal suo inizio: in effetti, il cambiamento ossessivo e compulsivo (chiamato ora modernizzazione), ora ‘progresso’, ora ‘miglioramento, ora ‘sviluppo’ ora ‘aggiornamento’) è l’essenza del moderno (nostro) modo di essere. Cessi di essere ‘moderno’ non appena smetti di ‘modernizzare’, non appena metti giù le manie smetti di armeggiare con ciò che sei tu e ciò che è il mondo che ti sta intorno»:
«Non viviamo alla fine della storia, e nemmeno all’inizio della fine. (..) Nessuno ha un diritto di prelazione sulla storia».
«Siamo qui all’inizio di un’altra grande trasformazione: le forze globali sguinzagliate e i loro ciechi e dolorosi effetti devono essere messi sotto controllo democratico popolare e obbligati a rispettare e osservare i principi etici della coabitazione umana e della giustizia sociale. Ciò di cui, però, si può essere ragionevolmente sicuri, è che tali forme, per svolgere il ruolo che si propongono, dovranno dimostrare di essere capaci di innalzare la nostra identità a livello planetario, al livello dell’umanità. (..) La capacità di autoaffermazione dell’uomo individualizzato è (decisamente) inferiore ai requisiti necessari per conquistare una reale autocostituzione. Come ha anche osservato Leo Strauss, l’altra faccia della libertà illimitata (che ci siamo costruiti indossando la maschera) è l’irrilevanza della facoltà di scegliere che ci è data. (..) I due elementi – come si può ben comprendere – per sorte non sono comulabili, non sono aggregabili in una causa comune. (..) Potremmo dire che non sono conformati sin dall’inizio in modo tale da non disporre delle interfacce necessarie a connettersi con le altrui irresponsabilità. (..) ma ciò che di più (l’individuo) impara dall’altrui compagnia è un unico consiglio su come sopravvivere nella propria irrimediabile solitudine, e che la vita di ognuno è irta di rischi che vanno affrontati e combattuti da soli».
Nessuno intende, tuttavia, negare il significato intrinseco delle parole, tantomeno ciò è concesso alla filosofia che mette in atto le differenze in campo retorico, né le sue ripercussioni pratiche sul piano della ‘vita’ che, nella visione ‘liquida’ di Bauman espressa in “Amore liquido” vede perfino i legami affettivi come esempio di fragilità costante, una mutevole forma di ‘modernità’ che si mette e rimette in discussione: «La solitudine (nei rapporti umani) – scrive Bauman – genera insicurezza ma altrettanto fa la relazione sentimentale. In una relazione, ci si può sentire insicuri quanto senza di essa, o anche peggio. Cambiano solo i nomi che ognuno da alla propria ansia, ai propri dubbi, alle proprie paure di restare impigliati in relazioni stabili che, si teme, comportino oneri che non si vogliono né si pensa di poter sopportare».
«Oggigiorno quello delle ‘relazioni’ è l’argomento sulla bocca di tutti, ed evidentemente l’unico gioco cui valga la pena di partecipare, nonostante i noti rischi che comporta». Sta di fatto che siamo tutti adusi a confezionare amicizie, legami, aggregazioni comunitarie ecc. In realtà – prosegue Bauman – tuttavia, quasi a voler seguire la regola di Martin Heidegger, «..le cose si rivelano alla nostra coscienza solo attraverso la frustrazione che provocano – allorché si disgregano, svaniscono, tradiscono le nostre aspettative o la propria natura, oggigiorno l’attenzione dell’uomo tende a incentrarsi sulle soddisfazioni che le relazioni si spera arrechino proprio perché per qualche verso non sono state ritenute pienamente e realmente soddisfacenti; e qualora invece soddisfino appieno, si scopre spesso che il prezzo di tale appagamento è eccessivo e inaccettabile».
Non sorprende quindi che le ‘relazioni’ (fra individui) siano uno dei principali motori dell’odierno «boom delle consulenze. (..) La complessità è troppo densa, troppo ostica, troppo difficile da sbrogliare perché gli individui possano farcela da soli – sostiene Bauman – citando Platone: “Amare significa desiderare di ‘generare e procreare’, e dunque chi ama ‘quando si avvinina al bello diviene ilare, e nella sua letizia si effonde e procrea e genera’. In altre parole, non è nella brama di cose pronte per l’uso, belle e finite, che l’amore trova il proprio significato, ma nello stimolo a partecipare al divenire di tali cose. L’amore è simile alla trascendenza; non è che un altro nome per definire l’impulso creativo e in quanto tale è carico di rischi, dal momento che nessuno può mai sapere dove andrà a finire tutta la creazione.”
«Esistono fondati motivi per considerare l’amore, e in particolare lo stato di ‘innamoramento’ come una condizione – quasi per sua natura – ricorrente, soggetta a ripetesi o che addirittura solleciti ripetuti tentativi: “L’amore sembra godere di uno status diverrso rispetto agli altri eventi irripetibili ... È insito nella natura dell’amore il fatto che – come Lucano osservò duemila anni fa e Francis Bacon ripeté molti secoli dopo – esso non possa che significare il consegnarsi in ostaggio al destino”. Quella di imparare l’arte di amare è la promessa (falsa, ingannevole, ma che si spera ardentemente essere vera) di rendere l’ ‘esperienza dell’amore’ (..) simile ad offrirsi quale incognita nelle equazioni dell’altro. È questo che fa percepire l’amore come un capriccio del destino: quello strano e misterioso futuro, impossibile da predire, prevenire o evitare, accelerare o arrestare. Amare significa offrirsi a quel destino, alla più sublime di tutte le condizioni umane, una condizione in cui paura e gioia si fondono (e si equivalgono) in una miscela che non permette più ai suoi ingredienti di scindersi. E offrirsi a quel destino significa in ultima analisi, l’accettazione della libertà nell’essere: quella libertà che è incarnata nell’Altro, il compagno in amore.»
Come anche afferma Erich Fromm: “La soddisfazione, nell’amore individuale, non può essere raggiunta senza la capacità di amare il prossimo con umiltà, fede e coraggio”. Tuttavia pensatori come Fromm, Bauman, Freud, Jung, Cuomo, ma già Platone, Eraclito, Aretino, Voltaire, Schiller, Wilder, Heidegger, Hillman e tantissimi altri, non potrebbero andare oltre il significato intrinseco al ‘destino’ se non si torna a considerare ‘l’atto d’amore’ come ‘atto di fede’, in quanto ‘dono’ ricevuto in ‘assenza di costrizione’, vale a dire in ‘assenza di contratto’, di ‘coercizione’, che non richiede nulla in cambio, “tranne un appagamento personale che è uno dei momenti dell’atto di donare” (Marcel Mauss). A cui va aggiunto il reciproco ‘incondizionato’ scambio d’amore non mercificatorio, bensì naturale di un sentimento che si rinnova, che ci ritorna santificato dal ‘senso’ di libertà con cui è ricambiato. Per quanto è più il poeta ‘ante-litteram’ e non il filosofo, chiamato a restituire all’ ‘atto d’amore’ il suo significato intrinseco di ‘conflitto interiore’, impegnato permanentemente nel trovare l’equilibrio necessario nel rapporto confidenziale. Quell’autocontrollo (gratificante) che porta a superare le eventuali criticità che possono occorrere e tornare a soddisfare il piacere nel fare felice l’altra persona con reciproca ‘gratitudine’.
È questa una disposizione d’animo, ahimé oggi in disuso, che comporta affetto (che di per sé è già amore) e di cui abbiamo perso il ‘senso’ e che, altresì, va ritrovato quando si parla del ‘dono’ in quanto beneficio ricevuto. Ma ‘gratitudine’ è anche sinonimo di ‘riconoscenza’ e per questo vale indicarla alla stregua di un sentimento più intimo che lo rende indubbiamente una delle espressioni più evidenti della capacità di amare: “Forse la gratitudine è il parametro della grandezza umana” – scrive Adolfo L'Arco che la considera un sentimento positivo che rende felici ed aperti alla vita, uno stato d’animo che ci spinge ad offrire apertamente la nostra riconoscenza. Numerosi studi di ‘psicologia positiva’ hanno dimostrato che le persone orientate alla gratitudine sono più vitali, ottimiste, empatiche e sperimentano più spesso emozioni come gioia, meraviglia ecc. e che esprimere la ‘gratitudine’ non è solo la comunicazione di un sentimento, ma uno dei tratti della personalità più legati al benessere psicologico.
Un ritorno dunque alla ‘morale comune’ in cui il tema del ‘dono’ è assunto come valore sociale di ‘libero scambio’: frutto di ricerca, altruismo, fratellanza, solidarietà tra gli individui ma, ed anche, (come si è detto) di liberalità, purché animate dai più puri sentimenti. “Ma non basta constatare il fatto è necessario ricavarne un atteggiamento pratico, un precetto morale. (..) Solo opponendo la ragione al sentimento e imponendo la volontà di pace contro le improvvise follie che i popoli giungono a sostituire alla guerra, all’isolamento e alla stasi, l’alleanza” – scrive Marcel Mauss nel noto “Saggio sul dono” – restituendo ad esso il valore intrinseco di reciproco scambio d’affetto. Lo stesso significato che nell’idea di Gotthold Ephraim Lessing, è divenuto a suo tempo, (XVIII sec.), di mistica rilevanza: “Un singolo pensiero di gratitudine innalzato al cielo è la preghiera più perfetta”. E che Zygmunt Bauman, nostro contemporaneo, ha ben definito nel suo “L’arte della vita”, trasferendolo nella ‘felicità’ nel nostro mondo liquido-moderno:
«Siamo felici finché non perdiamo la speranza di essere felici in futuro. Ma la speranza può rimanere viva solo a condizione di avere davanti a sé una serie di nuove occasioni e nuovi inizi in rapida successione, la prospettiva di una catena infinita di partenze. (..) La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no.» A cui mi sento a ragione di aggiungere “che lo vogliamo o no”, facendo eco a Bauman nel dire: «Dobbiamo tentare l’impossibile». Ciò che nel contesto generale del discorso fin qui avanzato può sembrare un ossimoro il cui contrasto non è solo nelle allocuzioni usate, bensì nei concetti espressi. Tuttavia è lo stesso Bauman ha darci la dimensione esatta di ciò che egli intende in riferimento al ‘mondo-liquido’ di cui è ideatore e artefice: «È una vita emozionante e logorante: emozionante per chi ama le avventure, logorante per chi è debole di cuore.» (..) Ognuno può decidere da sé «..la coercizione a cercare la felicità nella forma praticata nella nostra società.»
Dov’è il confine tra il diritto alla felicità e l’amore? – si chiede Ivan Klìma – sostenendo che si può paragonare proprio a un’opera d’arte: “Anch’essa richiede all’artista immaginazione, grande concentrazione, la combinazione di tutti gli aspetti della personalità umana, spirito di sacrificio e libertà assoluta (?). Ma, soprattutto, come la creazione artistica, l’amore richiede azione, ossia attività e condotta non routinarie, costante attenzione alla natura intrinseca del proprio partner, sforzo per comprendere l’individualità e rispetto. Inoltre richiede tolleranza, la consapevolezza che non si possono imporre i propri punti di vista e ideali al compagno o alla compagna, né ostacolarne la felicità.” Al quale Bauman risponde: «Tracciare questo confine con precisione può essere doloroso, ma di una cosa possiamo essere certi: quel confine, ovunque sia, viene violato nel momento in cui l’atto di stringere e sciogliere legami è dichiarato moralmente indifferente e neutro, sollevando a priori gli attori dalla responsabilità delle reciproche conseguenze di ciò che fanno: da quella stessa responsabilità incondizionata che l’amore promette, nella buona e nella cattiva sorte, e che lotta per costruire e conservare».
"Ogni vita non vissuta rappresenta un potere distruttore e irresistibile che opera in modo silenzioso e spietato" – scrive Carl Gustav Jung – in un suo saggio famoso. Ecco che allora la ricerca della felicità, cui si è accennato all’inizio di questo lungo confronto d’idee, spiazza il campo da ogni sovrastruttura per lasciarci nuovamente soli a contemplare qualcosa che pensiamo non ci sia dato: «È per questo che una felicità ‘autentica, adeguata e totalizzante’ sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarsi ad esso. (..) La felicità – per richiamare la diagnosi di Kant – non è un ideale della ragione, ma dell’immaginazione.» Ciò che ci da l’esatta dimensione del valore del ‘dono d’amore’ che abbiamo ricevuto in seno a tanta ‘bellezza’; e che Franco Rella in “L’enigma della bellezza” destina altrove, in quel mondo mitico dal quale noi tutti (forse) proveniamo.
«L’amore – (e con questo riaffermo quanto già espresso da Bauman) – possiamo concludere, non promette di raggiungere facilmente la felicità e il senso. Bensì è qualcosa che richiede di essere creato e ricreato ogni giorno, ogni ora; (..) che ha bisogno di essere costantemente risuscitato e riaffermato e richiede attenzioni e cure.» E che, quantomeno, dovrebbe essere cosciente in noi, in quello spirito creativo che ci accompagna durante tutto il tempo della nostra vita, e che ci permette di scoprire come, anche in questo ‘mondo-liquido’ in cui viviamo, si annidino embrioni fecondi di abbondanza d’intenti, ricchezza di valori, prosperità d’amore, inteso come condizione più o meno stabile di soddisfazione incondizionata:
“.. onde per cui la vita è sul nascere
veritiera promessa d’amore
. . .
il dono più grande.” (G.M.)
Testi di Zygmunt Bauman utilizzati in questo saggio:
“La società dell’incertezza”, Il Mulino - 1999
“Modernità liquida”, Edit. Laterza 2002 - (ristampa 2015)
“Amore liquido”, Edit. Laterza - 2003
“Intervista sull’identità”, a cura di B. Vecchi, Edit. Laterza - 2003
“Paura liquida”, Edit. Laterza – 2006
“L’arte della vita”, Edit. Laterza - 2008
“Cose che abbiamo in comune”, Edit. Laterza – 2010
Autori citati nei testi:
Platone, Lucano, Eraclito, Aretino, Francis Bacon, Voltaire, Schiller, Verdi, Wilder, Freud, Jung, Cuomo, Ulrich ed Elisabeth Beck, Theodor W. Adorno, Leo Strauss, Claude Lévi-Strauss, Gotthold Ephraim Lessing, Ludwig Wittgenstein, Lars Dencik, Norbert Elias, Karl Popper, Martin Heidegger, James Hillman, Ivan Klìma, Adolfo L'Arco, Franco Rella.
Altri testi citati o utilizzati:
Marcel Mauss, “Saggio sul dono” - Einaudi 1965 - (ristampa 2002)
Carl G. Jung – “Opere Complete” – Boringhieri 1987
Michele Serra, “Gli sdraiati” - Feltrinelli 2013
Umberto Galimberti, “L’ospite inquietante” – Feltrinelli 2007
Nigel Warburton, “Filosofia, i grandi temi” – Il Sole 24 Ore 2007
Stefano Rodotà, “Elogio del moralismo” – Laterza 2013 e “Il diritto di avere diritti” – Laterza 2012
Erich Fromm, “Democrazia e libertà” – Ediz. Comunità 1978, “L’arte di amare”, Mondadori 1956
Giuseppe Galasso, “Gratitudine” articolo in “Corriere della Sera” del 14 feb. 2008
Stefano Scarcella Prandstraller, “La soggettività come tecnologia sociale” – Franco Angeli 2008
Roger Scruton, ‘La Moralità’ in “Guida filosofica..” – Il Sole 24 Ore 2007
Franco Rella, “L’enigma della bellezza” – la Feltrinelli 1991
*
 - Musica
- Musica
L’Albero di Canto: Emilia2 - La Tradizione in Italia
Un ‘violino’, una ‘fisarmonica’, una ‘campana’ lontana sopra un campanile sono parte integrante della ‘filastrocca’ assai lunga e amara che man mano si va componendo tra le righe di questo articolo, iniziata tanto tempo fa allorché il Parmense fu protagonista di grandi scioperi contadini e di braccianti nel maggio-giugno 1908 quando il disagio delle famiglie fu davvero grande allorché venne presa la triste decisione, per molti aspetti eroica, di allontanare tutti i bambini figli degli scioperanti dalle zone occupate e inviarli presso famiglie di parenti e amici, ospiti di compagni socialisti. Un modo questo per annunciare con notevole chiarezza i sentimenti che animavano le masse in lotta, disposte ad affrontare l’apparato regressivo dello stato borghese dei padroni dei fondi agrari e delle fabbriche urbanizzate. Famoso è un “Contrasto fra un padrone e due contadini”* in ottava rima tratto da un foglio volante, reperito presso il Museo di Arti e Tradizioni Popolari di Roma, ma che riferisce di una sua vitalità, del tutto orale, sia nel Lazio che in Toscana e in Emilia, dove continua a essere presente essenzialmente per opera degli improvvisatori che si esibiscono nelle feste popolari.
Il ‘contrasto’ è considerato in genere una gara di abilità e virtuosismo, ma è anche, come osserva il Toschi* “.. una forma drammatica, forse la più semplice ed arcaica, che ci richiama a quella parte del rito-spettacolo che costituita da una qualche forma di lotta”. Notevole è infatti la diversità di toni (modulo musicale) usati nel canto: piuttosto dolce e modulato per il padrone, mentre la voce dei contadini risulta più rotta, secca, più grido che canto:
“Contrasto fra un padrone e due contadini”* (Canzoniere Internazionale - essai)
Stasera siam venuti a questo posto
Per farvi con dei versi genuini
Racconto di un durissimo contrasto
Che avvenne fra padrone e contadini:
…
O contadino il tuo linguaggio fioco
dice che ti sei fatto prepotente
ma se qualcuno t’ha insegnato il gioco
a me stai certo non mi può far niente
se cominci a gettar olio sul fuoco
sarà peggio per te sicuramente
se mangi poco e versi assai sudore
pensa che tu non sei nato signore.
…
Se lei padrone avesse un po’ di cuore
non ci farebbe tale osservazione
sappiamo che nel mondo il Creatore
non fece servi né fece padroni
non fece oppresso né fece oppressore
guerre carneficine e distruzioni
ma il suolo popolò d’erbe e di frutti
perché dasse lavoro e pane a tutti.
…
Ora ti sei spiegato anche abbastanza
vorreste una riforma ho ben capito
pover’a tè se speri all’eguaglianza
quello che chiedi mai non è esistito
chi predicando va la fratellanza
lo vedo t’ha purtroppo ammaliziato
ma tutto questo sai non ci spaventa
noi siamo quattrocento e loro in trenta.
…
Signor padrone i’ lievito fermenta
e i panettiere ha messo foco in forno
se di pochi di molti si diventa
se ne potrebbe riparlare un giorno
ed ora udienza se sei stata attenta
apri gli occhi e guardati d’intorno
l’unione fa la forza tu lo vedi
non istar più in ginocchio ..
‘alzati in piedi!
Si dovrebbero qui ricordare i numerosi accadimenti e le tante figure che si sono distinte nelle fasi della storia sociale che hanno contribuito a dare impulso al recupero della cultura popolare con scritti letterari, canzoni e ballate, raccolte di poesie e quant’altro che più interessano la nostra ricerca musicologica, cui spesso fanno riferimento alcuni testi di canzoni e di narrazioni contenute nei vari ‘canzonieri’ e ‘almanacchi popolari’. Filippo Crivelli, Roberto Leydi, Franco Fortini, Costantino Nigra, Maria Teresa Bolciolu, Giovanna Daffini, Sandra Mantovani, Caterina Bueno, Giovanna Marini, Hana Roth, Silvia Malagugini, Cati Mattea, Bruno Pianta, Michele L. Straniero, Duo di Piadena, Ivan Della Mea, oltre a quelli già citati, sono solo alcuni dei nomi conosciuti anche dal grande pubblico. Rientrano in questa ricerca molte delle canzoni che ancora oggi si sentono risuonare nell’aria, come, ad esempio quelle dedicate all’emigrazione “Le canzoni degli emigranti”* di cui ci occuperemo in altra sede, e quelle sulla condizione della donna: “La donna nella tradizione popolare”*; a cominciare da “Donna lombarda”* una canzone epico-lirica, fra quelle che ha suscitato maggiore interesse tra gli studiosi, così come ce la presenta Roberto Leydi*:
“Donna Lombarda”*
(“I canti popolari italiani”, a cura di R. Leydi)
"Dona lombarda, lombarda, dona lombarda
se vuoi venire a cenar con me” (bis )
“Mi venireva ben volentieri ma l'ho paura dello mio marì”
“Tuo marito fallo morire fallo morire che t'insegnerò.
Va ne l'orto de lu tuo padre, prendi la lingua dello serpentin.
Prendi la lingua del serpentino, butala dentro ne lu buon vin”.
E alla sera riva 'l marito: “o moglie mia pòrtami da ber”.
“Tu lo vuoi bianco tu lo vuoi nero”.
“Pòrtalo pure come piace a te”.
“O moglie mia come la vale che questo vino l'è intorboli?”
“Sarà la pompa dell'altro ieri e che l'ha fatto ma intorbolì”.
Ma un bambino di pochi mesi che apena apena cominciò a parlar:
“O padre mio no lo sta a bere che questo vino l'è avvelenà”.
“E all'onore di questa spada o moglie mia bévilo tu
E all'onore di questa spada donna lombarda devi morir”.
“Le comunità contadine – scrive Roberto Leydi* in “I canti popolari Italiani” - così come erano organizzate prima dello spopolamento di tante zone della campagna italiana, avevano una loro cultura compatta e antica. Si andava dagli usi e dalle tradizioni domestiche alle abitudini di lavoro e di divertimento, alle credenze ed alle superstizioni. Il complesso di tutte queste cose si può definire come cultura contadina, perché la `cultura' è quel complesso di nozioni e di regole su cui si fonda la tradizione e la vita organizzata di una società. Mentre la nostra esistenza è regolata da nozioni scritte (libri, leggi, informazioni dei giornali ecc.), la cultura contadina, tipica di un mondo in cui non si sapeva quasi mai leggere e scrivere, era orale, cioè tramandata attraverso la viva voce. Il canto popolare, usato dalle comunità in occasione di riunioni nei momenti di festa e riposo, ma anche talvolta sul lavoro, nei campi, era appunto una forma di 'letteratura' non scritta usata dal popolo”. (..)
“Un grande esperto di canti popolari vissuto nell'Ottocento, Costantino Nigra, riteneva che l'origine di “Donna lombarda” fosse antichissima. Infatti, la storia che viene raccontata in questa canzone ha dei singolari punti di contatto con quella della regina longobarda Rosmunda, la quale tentò di uccidere il marito Elmichi dandogli da bere una coppa di vino avvelenato; l'uomo, accortosi dell'inganno, con la minaccia della spada costrinse Rosmunda a bere anch'essa, ed i due morirono nella medesima ora, entrambi uccisi dallo stesso veleno. A parte i nomi, è la stessa vicenda che troviamo nel nostro canto: Nigra identificò senza alcun dubbio Rosmunda nella misteriosa donna 'lombarda' (=longobarda), e datò la canzone al VI secolo dopo Cristo, epoca in cui era avvenuto il fatto storico, ritenendo che il popolo lo avesse fatto suo ed avesse subito cominciato a cantare quei versi che ancora oggi sono vivi in tante parti d'Italia. Una identificazione, quella di Nigra, affascinante, ma che oggi non ci trova più molto convinti: infatti la storia di un avvelenamento che si conclude con la punizione dell'assassino non è un fatto che debba essere collegato ad una precisa realtà storica, e comunque non certo a un episodio così lontano: si tratta piuttosto di una storia esemplare, per nulla specifica”. (..)
“La canzone è probabilmente molto più recente di quanto credeva Nigra. Del resto, non è solo l'antichità ad interessarci: ci affascina la diffusione ampia di questo canto, che è stato registrato in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, in Emilia, in Toscana (ed anche in Puglia, in Campania, nel Lazio). Naturalmente, muovendosi nello spazio, viaggiando da luogo a luogo, il canto non è rimasto sempre uguale, ma ha subito diverse modificazioni. Per esempio, ogni comunità lo adatta al proprio dialetto; oppure si italianizza; e certe parole mutano, diventando magari incomprensibili. La cultura popolare orale (la cultura del popolo contadino dell'età pre-industriale, la cultura di chi non sa scrivere) affida solo alla memoria ed alla ripetizione il possesso delle nozioni; e, si sa, la ripetizione orale, a differenza della scrittura, non conserva le cose, ma le modifica continuamente. Queste modificazioni avvengono nel corso del tempo e nello spazio, durante la trasmissione da luogo a luogo, quando il canto passa dall'uno all'altro, come in una catena. Una stessa canzone, cantata dal popolo in luoghi diversi, può presentarsi diversa nella lingua e nel contenuto. Proprio in questa mutevolezza continua, in questa adattabilità alle più diverse situazioni, sta la vera natura del canto popolare”.
“I canti popolari sono un poco come la lingua che parliamo e come le parole che usiamo, le quali hanno un'origine, ed anche magari un autore, ma sono ormai diventate un bene di tutti. La versione di “Donna lombarda” che ho trascritto è stata raccolta in Liguria (a Ceriana, in provincia di Imperia) da Roberto Leydi. Il testo non è però in dialetto ligure, bensì in un italiano particolare, adattato alle esigenze di parlanti abituati al dialetto e non colti. Questo italiano può essere definito italiano popolare. Ci basti per ora frenare lo stupore davanti a forme come dona per donna, venireva per verrei, de lu tuo padre per di tuo padre, bùtala per mettila ecc. Apparentemente sono 'errori' o 'grossolanità'; in realtà è il modo con cui un canto popolare da centinaia di anni ripetuto in dialetto si è pian piano italianizzato, assumendo forme linguistiche che ancora risentono del dialetto di partenza. Anche nel contenuto si trova di che sconcertare chi non è abituato a questo tipo particolare di letteratura umile. (..) Davanti a testi di questo tipo, quindi, non ci deve guidare la ricerca del bello o comunque un atteggiamento simile a quello che usiamo nei confronti della letteratura colta. Dobbiamo invece pensare che stiamo esaminando un documento di un mondo lontanissimo dal nostro e governato da regole del tutto differenti”.
Eccone alcuni esempi:
“Mia mama ‘l vol ch’j fila”*
“E mi mama vol ch’j fila al lunez.
ma mi al lunez m’gratu le pulez
e ‘n po’ d’su-si e ‘n po’ d’lu-là
la mia mama
jé da sinha e da dizné
la mia mama vol ch’j fila e mi pos pà filé.
E mia mama vol ch’j fila al martéz
ma mi al martéz giogu le carte […]
E mia mama vol ch’j fila al mércul
ma mi al mércul vadu da Bertu […]
E mi mama vol ch’j fila al giobia
ma mi al giobia muntu ‘ns’la lobia […]
E mia mama vol ch’j fila al v’nner
ma mi al v’nner siasu la s’nner […]
E mi mama vol ch’j fila al saba
ma mi al saba ciapu la paga […]
E mia mama vol ch’j fila d’fésta
ma mi d’fésta stagu a la finestra […]”.
“Sciur padrun da li béli braghi bianchi” * (Sandra Mantovari)
“Sciur padrun da li béli braghi bianchi
fora li palanchi, fora li palanchi
sciur padrun da li béli braghi bianchi
fora li palanchi ch’anduma a cà.
A scuza sciur padrun
s’a l’em fat trivulèr
l’era li premi volti
l’era li premi volti
a scuza sciur padrun
s’a l’em fat trivulèr
l’era li premi volti
ch’a ‘n salevum cuma fèr.
Sciur padrun da li béli braghi bianchi … ecc.
Prema a’l rancàun
e po dopu a s-ciancàun
e adés ch’a l’em tot via
a’l salutem e po’ andém via.
Sciur padrun da li béli braghi bianchi … ecc.
Al nòstar sciur padrun
l’è bon com’è ‘l bon pan
da ster insima a l’erzan
a’l diz: «fè ander cal man».
Sciur padrun da li béli braghi bianchi … ecc.
E non va più a mesi
e nemmeno a settimane
la va a poche ore
e poi dopo andém a cà.
Sciur padrun da li béli braghi bianchi … ecc.
E quando al treno a s-ceffla
i mundèin a la stassion
con la cassietta in spala
su e giù per i vagon.
Sciur padrun da li béli braghi bianchi … ecc.”
Quelle dedicate alla nostalgia della lontananza dalla propria terra e il desiderio di tornare a casa delle mondariso:
“Amore mio non piangere”* (Giovanna Daffini)
“Amore mio non pianger
se me ne vado via
io lascio la risaia
ritorno a casa mia.
Ragazzo mio non piangere
se me ne vò lontano
ti scriverò da casa
per dirti che ti amo.
Non sarà più la capa
che sveglia a la mattina
ma là nella casetta
mi sveglia la madre mia.
Vedo laggiù fra gli alberi
la bianca mia casetta
e vedo là sull’uscio
la mamma che mi aspetta.
Mamma papà non piangere
non sono più mondina
sin ritornata a casa
a far la signorina.
Mamma papà non piangere
se sono consumata
è stata la risaia
che mi ha rovinata”.
Inoltre “Le canzoni del lavoro”* e quelle riferite al ‘Cantar Maggio’*, già riportate in altro articolo apparso su questo stesso sito, vanno qui citate quelle riferite ai “Canti dell’Osteria”*:
“Vinassa, vinassa” *(canto degli Alpini - trascr. Moretto)
“Là nella valle, c'è un'osteria
è l'allegria, è l'allegria
là nella valle, c'è un'osteria
è l'allegria di noi alpin!
E se son pallida né miei colori
no' vo' dotori, no' vo' dotori
e se son pallida come 'na strassa
vinassa, vinassa e fiaschi de vin!
Là sul Cervino c'è una colonna
è la Madonna, è la Madonna
là sul Cervino c'è una colonna
è la Madonna di noi alpin!
Là nella valle c'è un filo d'erba
l'è la riserva, l'è la riserva.
Là nella valle c'è un filo d'erba
l'è la riserva di noi alpin.
Là nella valle c'è la Rosina
l'è la rovina, l'è la rovina.
Là nella valle c'è la Rosina
l'è la rovina di noi alpin.
Là nella valle c'è un buco nero
l'è il cimitero, l'è il cimitero
Là nella valle c'è un buco nero
l'è il cimitero di noi alpin.
Là su quel monte c'è una lanterna
requiem aeternam, requiem aeternam,
Là su quel monte c'è una lanterna
requiem aeternam per noi alpin.”
E ovviamente quelle composte sulla scia di “Bella Ciao”* conosciuta in diverse versioni, quella di lavoro delle mondine e quella partigiana, senz’altro la più famosa della Resistenza italiana:
“Bella Ciao!”*
“Una mattina mi sono alzato
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
una mattina mi sono alzato
e ho trovato l’invasor.
O partigiano portami via
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
o partigiano portami mia
che mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e le genti che passeranno
ne diranno o che bel fior.
È questo il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
è questo il fiore del partigiano
morto per la libertà.”
E non possiamo dimenticare “I canti degli Alpini”* che tanta gloria hanno dato a questo nostro Settentrione, come del resto riporta un noto “Canzoniere” che si apre con questa didascalia: “I canti della montagna sono i canti della Patria, sono i canti che il padre insegna al figlio, che la madre canta, con lieve rossore di pudicizia, quando la figlia è lì ad ascoltare; ma sempre poesia, sempre nuova e sempre bella. ”
“Addio, mia bella, addio” *
(Canto degli Alpini)
“Addio mia bella addio,
che l'armata se ne va,
e se non partissi anch'io
sarebbe una viltà,
Il sacco è preparato
Sull’omero mi sta,
son uomo e son soldato
viva la libertà
Ma non ti lascio sola,
ma ti lascio un figlio ancor,
sarà quel che ti consola,
sarà il figlio dell'amor”.
“Sul ponte di Bassano” *
(Canto degli Alpini)
“Eccole che le riva
'ste bele moscardine,
son fresche e verdoline
colori no ghe n'à.
Colori no ghe n'emo
né manco gh'en serchemo,
ma un canto noi faremo
al ponte di Bassan.
Sul ponte di Bassano
là ci darem la mano.
Noi ci darem la mano
ed un bacin d'amor.
Per un bacin d'amore
successer tanti guai
non lo credevo mai
doverti abbandonar.
Doverti abbandonare
volerti tanto bene.
E' un giro di catene
che m'incatena il cor.
Che m'incatena il core
che m'incatena i fianchi
in mona tutti quanti
quelli che mi vuoi mal”.
Facciamo un salto cronologico e arriviamo ai periodi successivi alle due guerre mondiali per tornare a parlare di poesia e ai canti riferiti alla terra, ai lavori dei campi, ai raccolti ecc.; come quella che segue conosciuta in tutta l’area padana e che formano un capitolo a parte della nostra cultura popolare:
“La Pastora” *
(canto di montagna del '600 dal repertorio del Coro “Monte Cauriol” )
“La pastorella si leva per tempo
menando le caprette a pascer fora.
Di fora in fora la traditora
coi suoi belli occhi la m'innamora
e fa di mezzanotte apparir giorno.
Poi se ne gira presso la fontana
calpestando l'erbette oh tenerelle.
Oh tenerelle galanti e belle
sermolin fresco, fresche mortelle
e il grembo ha pien di rose e di viole.
E qualche volta canta una canzone
che tutto il gregge canta, e gli agnelletti,
e gli agnelletti fan gli sgamgetti
così le capre come i capretti
e tutto fanno a gara in lor danza”.
“L’uva fogarina” *
“O come è bella l’uva fogarina
o come è bello saperla vendemmiar
a far l’amor con la mia oi-bella
a far l’amor in mezzo al prà.
Diririndindin diririndindin
diriridindindindindindin
Teresina ‘mbriaguna
poca voia d’laurà
la sé tolta ‘na vestaglia
la gh’l’à ‘ncura da pagàr
cuzir la ‘n vol cuzir
filar la ‘n vol filar
el sol de la campagna
la diz che ‘ ghe fa mal.
Diririndindin diririndindin
diriridindindindindindin
O come è bella l’uva fogarina
o come è bello saperla vendemmiar..”
E le canzoni che mia madre a mo’ di ninna-nanna sempre cantava per farmi addormentare:
“La Viuleta”*
“E la Viuleta la va, la va,
la va, la va, la va, la va!
La va sul campo, la s'era insugnada
che gh'era 'l so Gingin che la rimirava!
La va sul campo, la s'era insugnada
che gh'era 'l so Gingin che la rimirava!
Perchè te mi rimiri, Gingin d'amor?
Gingin d'amor? Gingin d'amor?
Mi te rimiri, perchè tu sei bella,
e se tu vuoi venire con me alla guerra.
E mi con ti alla guerra non vo’ venir,
non vo’ venir, non vo’ venir.
Non vo’ venire con ti’ alla guerra
perché si mangia mal e si dorme per terra.
No, no, no, per terra non dormirai,
non dormirai, non dormirai!
Tu dormirai sopra un letto di fiori
con quattro bei Alpin, e lassa fa’ a lori!”
“La Rosina bella” *
“E verrà quel dì di lune
mi voo al mercà a compràa la fune.
Lune la fune e fine non avrà .
L'è la Rosina bella in sul mercà.
E verrà quel dì di marte
mi voo al mercà a compràa Ie scarpe.
Marte le scarpe, lune la fune,
e fine non avrà.
L'è la Rosina bella in sul mercà.
E verrà quel dì di mercole,
mi voo al mercà a compràa Ie nespole.
Mercole le nespole, ecc.
E verrà quel dì di giove
mi vò al mercà a compràa Ie ove.
Giove le ove, ecc.
E verrà quel dì di venere
mi voo al mercà a compràa la cenere.
Venere Ia cenere, ecc.
E verrà quel dì di sabato
mi voo al merca a compràa 'l soprabito.
Sabato 'I soprabito, ecc.
E verrà quel dì di festa,
mi voo al mercà compràa la vesta .
Festa la vesta,
sabato 'I soprabito ,
venere la cenere,
giove Ie ove,
mercole Ie nespole,
marte Ie scarpe,
lune la fune ,
e fine non avrà,.
L'e la Rosina bella in sul mercà.”
“Quel mazzolin di fiori”*
“Quel mazzolin di fiori
che vien dalla montagna
e bada ben che non si bagna
che lo voglio regalar.
Lo voglio regalare
perché l'è un bel mazzetto
lo voglio dare al mio moretto
questa sera quando vien.
Stasera quando viene
sarà una brutta sera
e perché sabato sera
lui non è venuto a me.
Non è venuto a me
l'è andà dalla Rosina
perché mi son poverina
mi fa piangere e sospirar.
Mi fa piangere e sospirare
sul letto dei lamenti,
cosa mai dirà le genti,
cosa mai dirà di me?
Dirà che son tradita
tradita nell'amore
e a me mi piange il cuore
e per sempre piangerà.
Abbandonato il primo
abbandonà il secondo
abbandono tutto il mondo
e non mi marito più”.
Mi scuso con gli assertori della filologia pura per aver qui trascritto canzoni non esattamente rispondenti agli originali e alle diverse forme dialettali che si parlavano e si continuano a parlare in Lombardia e soprattutto quelle ancora in uso in Emilia: diverse come sono diverse le inflessioni che di volta in volta ogni canzone ha assunto a seconda dei periodi in cui erano o tornavano in voga. Pensatele nella lingua e nella spontaneità musicale popolare emiliana che ha contribuito in modo determinante al modificarsi del gusto nel nostro paese e al sopravvento dell’abilità di molti suonatori che l’hanno sostenuta, fino all’avvento del ‘liscio’ che impera in tutta la Versilia.
Del resto come – annota Stefano Cammelli* – “..sia suonare uno strumento, sia le forme di canto, all’epoca potevano essere apprese solo tramite l’esperienza e l’ascolto diretto. Tutta la cultura musicale popolare era basata sull’elemento orale, sul suono suonato e sulla parola parlata, che non permettevano forme diverse di apprendimento di quello dell’ascolto, della pure attenta osservazione, di cui però non sfugge la sostanziale imprecisione e approssimazione. (..) Né può stupire la ripetitività di queste musiche, l’incessante ritornare su arie e variazioni già sentite, la loro apparente semplicità ben lontana comunque, dalla presunta facilità che certi inesperti attribuiscono alla musica contadina. (..) SE anche di un ballo è mai esistita una prima stesura musicale, essa è stata poi cambiata e modificata da ciascun suonatore, fino a giungere alle attuali, notevoli, diversificazioni pure fra quei balli che sembrano richiamarsi ad uno stesso tema.”
Se fino a ieri eseguire un brano strumentale, che fosse d’accompagnamento al canto o una musica cosiddetta ‘a ballo’, significava attenenrsi strettamente al testo o alla composizione primaria; oggi le possibilità di ‘variazioni’ sono infinite, vuoi per la contaminazione (rock, jazz, pop) esercitata nel tempo sui testi, vuoi per le nuove tecnologie elettroacustiche applicate anche agli strumenti tradizionali.
“Per esemplificare maggiormente questo processo di ‘creazione autonoma’ può essere utile analizzare un esempio relativamente recente, la storia del valzer “Speranze perdute”, uno dei più vecchi e conosciuti brani del liscio, conosciuto da tutti i suonatori”, i quali spesso vi apportano ‘variazioni’ virtuosistiche proprie, talvolta abbellimenti addirittura geniali cui ci hanno abituato, soprattutto, i vecchi suonatori di violino e stradaioli come ‘il Migliavacca’, nonché Melchiade Benni, che molto hanno influenzato la cultura del violino popolare emiliano. Tutte le musiche così interpretate o reinterpretate hanno mantenuta la caratteristica di spezzare continuamente la melodia del brano strumentale, raggruppando velocissimi gruppi di note ciascuno separato dall’altro, o di far saltare l’archetto sulle corde, particolare questo che le fa risultare sempre originali e quindi ‘vive’.
Come ‘vivi’ sono nel ricordo di chi ama questa terra d’Emilia recentemente sconvolta dal terremoto del 2012, e che ha richiamato intorno a sé tutti ‘i suoi figli’ nel riconoscimento e nella volontà di poter ‘ricominciare a sperare’. Molte sono state le iniziative a sotegno di questa speranza; non in ultima quella promossa da un numero di poeti, emiliani ed ospiti aggiunti, che hanno prestato il loro assenso alla pubblicazione di poesie ‘dedicate’ a questo terribile evento dal titolo “La luce oltre le crepe”* a cura di Roberta De Tomi e Luca Giglioli con prefazione dell’esimio Giuseppe Pederiali, i cui proventi sono stati devoluti a favore delle biblioteche modenesi colpite, sotto l’egida: ‘a profonda testimonianza e affinché nulla vada perduto’.
Acciò anch’io ho voluto dedicare un saggio (ahimè ancora inedito) cui ho lavorato con impegno e vero amore filiale, dal titolo: “Oralità e Scrittura nella Tradizione Poetica Italiana” con una analisi critica comparativa dei testi in esso contenuti, del quale riporto qui di seguito uno stralcio, in cui è fatto riferimento alla musicalità e dello spirito poetico emiliano, prendendo come spunto quanto riferito da Paolo Toschi* in apertura di “Il ciclo dell’uomo” del 1969:
«Il corso della vita si svolge, per il popolo, secondo una continua e fitta trama di forme tradizionali che ispirano, determinano e interpretano via via le azioni e le situazioni di cui è intessuta l’esistenza dell’uomo», e da allora questa realtà non è mai cambiata, almeno secondo la ‘teoria sociale’ intorno allo sviluppo della persona e della società:
‘E siamo stati come case’ di Luca Artioli*
E siamo stati come case
per un tempo senza tempo,
quand’era ancora Maggio …
–pietra dopo pietra –
nella storia che si salda
al ventre di ogni madre …
nella storia di ogni padre …
Il raffronto tra le case tirate su ‘pietra dopo pietra’ e fatalmente crollate, creano qui un fermo immagine di una immediatezza sconcertante, in cui lo sguardo costruisce e decostruisce per ricostruire mentalmente domani, quello che fino a un momento prima, era un ‘luogo dell’anima’ andato perduto dentro un nero profondo che sa di fumo di memorie, di travi carbonizzate, di mobilia cariche di ricordi, di immolazioni, lutti, orgoglio e solitudine … e siamo stati carne congiunta visceralmente alla madre, molecola nella storia del padre e del figlio del padre …
..in quell’abitare scomodo
nello stesso sacrificio.
Nel ricordo fa pensare a un nucleo numeroso, come un tempo era la composizione famigliare, in cui i conflitti interni, quando ce n’erano (e necessariamente c’erano), erano per lo più condivisione di uno stare tutti insieme con i diversi problemi che solitamente venivano risolti senza né vinti né vincitori, per così dire ‘alla pari’, tra fratelli e/o sorelle, senza rancore. Ciò che aveva significato di un ‘dare e avere’ e che nessuno doveva niente a nessuno, bensì solo le scuse ai genitori per aver alzato la voce; al figlio che chiedeva prima e nuovamente chiede – pietra dopo pietra – di ricostruire la casa crollata; alla terra per aver disprezzato i favori (il pane) che generosamente concede; e infine a Dio per aver imprecato “..per non farsi dimenticare”…
.. e di (poter) risalire da questo vuoto
e che poi sia sforzo leggero il futuro
quasi che fosse volo …
Ed ecco nella disillusione affacciarsi la speranza del superamento possibile del tempo, cioè entro “..un tempo senza tempo” smarrito nella sfera del tempo che forse non esistito, se non nel ricordo della stagione che più di tutte lo fa ricordare “..quand’era ancora Maggio”, la primavera, in cui tutto rinasce alla vita.
“Le case bambine” di Marzia Braglia*
Si chiamano: La Gnola,
la Disturbata, la Guidalina,
Patrinia, la Losca,
la Pitoccheria e Angelina …
le vecchie case
sparse nella valle
dormono e sognano
quand’erano belle.
Riposano nel buio perfetto
di una notte senza luna
e si rivedono bambine
baciate dalla fortuna.
Rammentano gelidi inverni
che segnavano ore noiose,
scolorivano i capelli
e appassivano le rose.
Vibra ancora la musica
fra le antiche mura
e i fantasmi ballano
nella notte oscura.
Sembra di vederle sullo sfondo di tele dipinte di Fattori, Signorini, Lega, Sernesi, Banti che dall’amata Toscana si spinsero alla Romagna e all’Emilia affermando che la ‘forma’ (oggettiva delle cose) in fondo non esiste, se non come ‘macchie di colore’ (da cui il nome del movimento detto dei Macchiaioli) distinte o sovrapposte ad altre macchie di colore, perché la luce, colpendo gli oggetti, viene rinviata all’occhio come immagine di puro colore. Due sono i motivi di questa scelta qui elaborata: per primo il riferimento alle cose ‘amate’ che, solo per il fatto che abbiano un nome, rivelano l’esistenza di una storia più o meno felice che stava nelle mani di chi le ha costruite per la felicità di qualcuno, non si costruisce una casa se non per soddisfare un bisogno e per accogliere i propri affetti. Il secondo, per quell’ “.. vibra ancora la musica e i fantasmi ballano” e che sta a significare che esse non sono più, forse andate distrutte con il terremoto che non le ha risparmiate allo scempio, insieme a quanti vi abitavano, con i loro ricordi, le rose che appassivano nei vasi, i frutti degli orti raccolti nel ‘coccio’ posato sulla tavola, e le loro padrone che invecchiando (come le rose) scolorivano i capelli. Ciò che rimane nel ricordo vivo dell’autrice, è la musica di un valzer lento come può essere lento il tempo trascorso “..di inverni gelidi che segnavano ore noiose”, e che all’improvviso subisce un arresto, per lasciare che i ‘fantasmi’ si ritrovino nella notte oscura e ballare ancora insieme … Addio Gnola, Disturbata, Guidalina, Patrinia, Losca, vecchie case incorniciate nel tempo, però bella la musica che vi ricorda!
“At to Final” di Maria Grazia Fabbri* (con traduzione a fronte).
La tua Finale (Finale Emilia).
Papà, è bèla passà tria n / Papà, sono già passati tre anni
da quand te andà via / da quando te ne sei andato /
e adèsa che è capità / e adesso che è successo /
stal brut lavor, t’am manc tant. / questo brutto lavoro,
mi manchi tanto” …
Pagina di diario, lettera, preghiera … tutte raccolte in una forma davvero delicata, che oso dire quasi emozionata, nel rammentare a chi, pur non essendo più viene messo al corrente di quanto accade nella terra dove forse è nato, certamente cresciuto e deve aver messo su famiglia. Ancor più si sente qui un attaccamento filiale profondamente partecipe dei sentimenti del padre e dei ricordi a lui legati, di una presenza che non si è mai trasformata in assenza neppure adesso che la rivolta della terra tenta di cancellare quei ‘luoghi della memoria’ che erano lì a rappresentare l’esistenza in vita di ambedue, padre e figlia, congiunti nell’amore per la propria piccola città, così grande da contenere tutto il loro mondo.
".. ma at fag na prumessa / ..ma ti faccio una promessa.
Appena la tera la lasa li ad tarmar ... / Appena la terra smette di tremare …
e prèda dop prèda / e pietra dopo pietra
con i nostar braz / con le nostre braccia
al tirem su al nostar paes … / lo tiriamo su il nostro paese …
adrà papà che al turnem a far / e at ve vedrai papà che lo torniamo a fare
ancora più bel. / ancora più bello".
Ben sappiamo che non c’è preghiera senza promessa, il laggio che si paga per ogni richiesta, tanto quanto sono disposte a pagare l’energiche donne emiliane capaci di una volontà ferrea e d’amore materno, pronte a combattere e di rivoltare il mondo per ideali di giustizia e di libertà, più che il ‘terremoto’.
Va detto che la poesia letta ‘in lingua originale’ rivela una maggiore espressività di toni, di sospensioni e di ritmi, per cui la traduzione, per quanto si voglia, non regge il confronto.
“Tsunami” di Mabi Col*
Rimesto nel paiolo briciole di vita,
pelo una patata
frammento inessenziale
d’universo,
penso a quello scoglio
malfermo e insicuro
che mi ospita,
pezzetto sperso
inesplorato e vuoto
di tempeste ignote,
elettromagnetiche speranze,
casa buia piena di misteri
in cui indifferente
rotola, rimescola e patisce
il nostro sasso
vivo e derelitto,
la nostra pentola
d’acqua e di canzoni
marmellata amara
d’assurde sensazione
cortocircuiti e minestre
ricordi astrusi da dimenticare
ansie e calligrammi.
Minuscoli coriandoli
D’avventura e sentimenti
Ci accapigliamo
In cerca di consensi,
mentre sopra di noi
s’abbatte l’orizzonte.
Poesia cosmica che riunisce il micro mondo di una cucina, qui immaginato (o forse vissuto) come un territorio di confine che rende il percorso dell’io poco avventuroso, scandito da ‘ansie come calligrammi’ del residuale, con il macrocosmo esistenziale “..in cerca di consensi”, dove l’essenza dell’io si perde di fronte all’evento conoscitivo, incerto e pericoloso, dello ‘tsunami’ che sopraggiunge nel momento quotidiano che è dato sottendere. Anche qui la metafora dello tsunami (tipico del maremoto) si sostituisce al terremoto derivato dallo scuotimento della terra, che non sembra scuotere però il calmo equilibrio dell’autore/autrice (non so), alle prese con i fornelli della sua cucina, quasi fosse un rito (e in parte lo è) ineluttabile dove si prepara il cibo per gli déi, dove l’io di fatto “..non conosce il pathos, l’aritmia dell’eros, la coscienza della morte”, (41). Neppure “..mentre sopra di noi / s’abbatte l’orizzonte” e tutto deve ancora accadere, mentre la pentola dell’acqua ribolle, e il cuore ispirato intona canzoni, certamente d’amore.
“… e non ci credi” di Claudio Porena*
Trabocca, goccia
dopo goccia, il catino
sotto il tetto che pende.
Ci si specchiano chine dalla sete
le macerie riarse, e tutto pare
inchiodato al suo posto: il lampadario
di Murano ormai spento,
il cassetto riverso, le tazzine
sul mobile di noce, la cornice
con la natura morta alla parete, le lunghe crepe
che fulminano il muro sulla porta.
Una lingua di vento
fischia attraverso
i frantumi di vetro fra le tende,
nel vano semivuoto
dove pare echeggiare sotto i piedi
lo scricchiolio, il fragore
delle maioliche cadute in terra
quando la Terra tremò il giorno avanti,
contro tutte le attese.
E dopo il terremoto
spunta il calvario, il momento dei pianti
che impregnano le rughe del paese
evacuato, infelice,
e che gonfiano gli occhi impolverati
e addormentati
nel risucchio del cielo.
È pallida la luna sulla siepe:
sbianca il cavo dei portici. La roccia
d’ogni casupola grida dolore
e dappertutto è lutto come un velo.
E si aspetta il mattino
..e non ci credi.
Il taglio fotografico delle ‘immagini’ verbali e sonore qui riportate rivela un’immediatezza rara nell’uso della parola, molto vicina alla ‘poesia automatica’ di stampo ‘futurista’. Indubbiamente l’osservatore coglie nei particolari ciò che finora è sfuggito a tutti gli altri: la dimensione onirica dell’evento sismico. Neppure stesse approntando una mostra fotografica egli dispone le opere in sequenza per così dire ‘alternativa’ alfine di creare una sorta di happening visivo dove tutto è detto e nulla è al proprio posto. Dove finanche gli spazi aperti dal sisma, illuminati del proprio caleidoscopio rotto, sono trasformati in immagini da osservare: allora si è risucchiati dal cielo nel taglio della finestra divelta e del muro crollato, dove la luna fa capolino dalla siepe dell’ ‘infinito’ leopardiano e “..sbianca il cavo dei portici”. Tuttavia lo sguardo attento dell’osservatore si sofferma su un’immagine in particolare: lì dove “alla parete, le lunghe crepe / che fulminano il muro sulla porta”, a dir poco strepitosa che potrebbe diventare il manifesto dell’ipotetica mostra ‘poetica’ sull’argomento. E quando tutto è pronto, “..e si aspetta il mattino”, arriva l’alba …
“..e non ci credi”.
Sospensione strepitosa, in cui la voce s’arresta in mancanza delle parole, in cui tutto è accolto nel silenzio onirico di un perché filosofico che aspetta una risposta, e che “..Una lingua di vento / fischia attraverso / i frantumi di vetro fra le tende, / nel vano semivuoto /.. contro tutte le attese”.
In conclusione riesco solo a dire che se la cultura di un popolo si misurasse sulle mode musicali e canzonettistiche di passaggio perderebbe ogni particolare significato poetico e letterario, mentre, al contrario la ‘poesia popolare’ non conosce alcuna forma di stasi o di annullamento, ed è per questo che di tanto in tanto assistiamo a una sua ‘rinascita’ riscontrabile nella sua continuità, seppure in alcuni periodi storici più lenta e difficile a causa della contaminazione di certe mode ‘inflazionistiche’ entrate di straforo nella sua evoluzione. È un fatto che quando si parla di cultura popolare cosiddetta ‘tradizionale’ si torna sempre a un passato remoto di dimenticata memoria, ma che altresì l’uso in voga della rivisitazione, del recupero, chiamiamolo anche del ‘revival’, sottolineano una certa continuità discorsiva con quei ‘valori’, mai completamente perduti, significativi di una cultura autonoma tipicamente emiliana e ovviamente italiana, formativa della realtà sociale che noi tutti ci troviamo a vivere …
..no, nessun viaggio ci porta così lontano
come il rimuginare della terra
di questa nostra terra d’Emilia
ché l’amore è canto
..no, nessun viaggio ci porterà lontano
così lontano da qui perché noi siamo
viaggiatori sulle ali del tempo
in cerca di un’ultima parola.
C’è ovviamente un’altra Emilia, tante altre Emilie che meriterebbero di essere citate: quella del Teatro, quella Letteraria e Artistica, quella Universitaria, delle Fiere, delle manifestazioni di piazza ecc. Ci sono le città importanti come Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Modena, nonché la vicina Romagna con Ravenna, Rimini, Riccione, Cesenatico, Cattolica e tante altre piccole comunità ugualmente importanti, con altrettante tradizioni, usi e costumi, musiche, danze e strumenti di cui si tratterà in altro luogo. Per il momento mi fermo qui col rinnovare l’invito a inviare a questa redazione i vostri racconti/ricordi ‘regionali’ che in seguito potreste vedere inseriti nei prossimi saggi/articoli di : “La Tradizione Italiana”.
Note bibliografiche:
“Folklore Italiano” - Paolo Toschi – Sansoni Edit. -
“I canti popolari Italiani” a cura di Roberto Leydi -
“Orsù, ben venga Maggio…: la tradizione in Italia – Saggio di Giorgio Mancinelli – Larecherche.it 2015.
“Emilia Romagna” a cura di Giuseppe Vettori – Lato/Side Edit. 1981
“La luce oltre le crepe” – raccolta poetica a cura di Roberta De Tomi e Luca Giglioli - Bernini Edit.2012
‘E siamo stati come case’ di Luca Artioli – poesia in “La luce oltre le crepe”, op.cit.
“Le case bambine” di Marzia Braglia – poesia in “La luce oltre le crepe”, op.cit.
“At to Final” di Maria Grazia Fabbri – poesia in “La luce oltre le crepe”, op.cit.
“Tsunami” di Mabi Col – poesia in “La luce oltre le crepe”, op.cit.
“… e non ci credi” di Claudio Porena – poesia in “La luce oltre le crepe”, op.cit.
Discografia:
“Almanacco Popolare” – canti e balli dell’Italia Settentrionale – Albatros LP8289
“Canti popolari Italiani” – gruppo dell’Almanacco Popolare – Albatros LP8089
“Siam venuti a cantar Maggio” – Canzoniere Internazionale – Cetra LP261
“Bella Ciao” – Il Nuovo Canzoniere Italiano – I dischi del Sole LP DS101/3
“La donna nella tradizione popolare” – a cura di Sergio Boldini – Zodiaco LP ZD4116
“Le canzoni del lavoro” a cura di Sergio Balloni – Signal LP SM3407
“Sebben che siamo donne” – Anna Casalino – Cetra LPP243
“Canti dell’Osteria” – M.Cipolla e il Gruppo Naviglio – UP LPUP5183
“I Viulan” Musiche tradizionali di Giorgio Massini – EMI-Odeon LP 054-18276
“Chants de mendiants” – La musica in Italia - Harmonia Mundi CD190434
“Bella Ciao” –collection – Harmonia Mundi CD 190734
“Il fischio del vapore” – F. De Gregori e G. Marini – Caravan CD 510218 2
“Vola vola vola” Canti popolari e canzoni – A. Sparagna e F. De Gregori – Parco della Musica – MPR 039CD.
“Gocce” Acqua per la Pace – Modena City Ramblers – Mercury CD Coop
Nota dell’autore: Parte dei contenuti e delle musiche e canzoni citate all’interno di questo articolo e facenti parte della ricerca filologica e musicale, sono state in parte utilizzate nella trasmissione radiofonica RAI-Radio3 “Cantarballando di Regione in Regione” in onda dal 21-03-1982 e che sono parte della ricerca filologica e musicale dell’autore.
*
 - Musica
- Musica
L’Albero di Canto : Emilia - La Tradizione in Italia
“L’albero di canto”* è un bellissimo brano strumentale suonato al violino da Raffaele Nobile polistrumentista e narratore che ‘girovaga’, si fa per dire, nelle lande settentrionali che ho preso qui ad esempio per narrare quest’oggi della nostra amabile terra: l’Emilia. Ma che anche ci parla della florida natura che ci circonda, della buona tavola, di alcuni strumenti tradizionali nonché della musica che riaccende i ricordi. I miei in particolar modo sono legati a un violino meraviglioso che in giovane età osservavo appeso sulla parete dell’ampia cucina economica a casa di un mio cugino acquisito, Gianni Migliavacca, in quel di Bosco di Corniglio, nell’appennino parmense, il cui suono ‘muto’ non ho mai potuto ascoltare perché il suo esecutore, Augusto Migliavacca, compositore del bellissimo ‘valzer’ e della famosa ‘mazurca variata’ che portano il suo nome, era ormai deceduto da un pezzo. Violinista dotato di notevole vena era nato nel 1838 non vedente, all'età di sette anni fu avviato allo studio del violino, e in esso trovò un'autentica fonte di vita, perfezionandosi sempre più fino a raggiungere un virtuosismo eccezionale che gli valse più tardi l'appellativo di "Paganini dei suonatori ambulanti" la cui padronanza dello strumento lo condusse ben presto all'attività di solista.
Visto anche che Augusto Migliavacca era in possesso di una discreta voce, cominciò ad abbinare il canto al suono del violino. Ancora molto giovane compì una tournèe (se così si può chiamare) attraverso vari caffè del Piemonte, e poi, per lungo tempo, accompagnato da uno stridulo suonatore di chitarra e per i successivi 15 anni, dal violinista Giuseppe Ferrari e dal violoncellista Bartolomeo Marchesi con i quali formò quel Trio Migliavacca che si aggirava per le vie, le piazze e i cortili di Parma, a proporre la propria musica. Notissime restano le sue tappe dinanzi al vecchio caffè Marchesi e nelle sale del Concordia e del Croce di Malta e che molto spesso prendeva parte alle feste in occasione di sagre e fiere nei paesi della provincia.
Egidio Bandini* su La Gazzetta di Parma del 05/07/2011 così lo ricorda (estratto dell’articolo):
“Pochi certamente conoscono «il» Migliavacca, ma moltissimi conoscono «la» Migliavacca, uno dei brani musicali più eseguiti al mondo, opera del compositore parmigiano. (..) Probabilmente, a parte la disfida con un analogo trio per accaparrarsi i migliori locali della città dove suonare, vinta per acclamazione da Migliavacca, Ferrari e Marchesi, nessuno si sarebbe ricordato del violinista cieco, se non fosse proprio per quella sua composizione che egli intitolò «Flora», ma che al Mondo tutti conoscono come la «Mazurka di Migliavacca»: pezzo di bravura assoluta, diventato celeberrimo nell’esecuzione per fisarmonica e che oggi, solo grazie all’amore per la musica dei maestri Eugenio Martani e Stefano Mora, si può ascoltare dalla voce del violino, come la suonava appunto Migliavacca con il suo trio (..) in un passato ormai lontano, al musicista che creò quella sarabanda di note, che comincia sempre e non finisce mai, diventata il cavallo di battaglia dei più virtuosi maestri di fisarmonica; che (..) morì in miseria da suonatore ambulante. Per questo vogliamo qui ricordarlo anno 2011, nel centodecimo anniversario della scomparsa, invitando tutti ad ascoltare la mazurka «Flora» o, come la intitolarono nella prima incisione su disco della Columbia nel 1927, «Migliavacca mazurka», confondendo il nome dell’autore con il titolo del brano. Sarà un tuffo nel passato per chi la conosce ed una scoperta entusiasmante per chi la ascolti la prima volta, immaginando di essere ai tavoli del «Caffè Marchesi» e di poter chiedere al Trio Migliavacca un bis che costa solo pochi centesimi”.
Sono queste pagine di vita vissuta che più altre ci permettono di catturare il ‘colore’ e il ‘profumo’ di una città e forse di un’intera provincia, quella Emiliana appunto, immersa nel cuore della pianura padana, terra di donne amabili e schietta generosità, di una cucina per ‘soli’ buongustai, ed anche di uomini di sani principi, lavoratori che sanno quando rimboccarsi le maniche in difesa della propria ‘comunità’ (vedi la Resistenza); con spirito di sacrificio e solidarietà (il terremoto del 2012); di contadini schietti, aperti al sorriso, quanto veri conoscitori e divulgatori di quell’opera lirica che ha dato i natali al più grande dei nostri compositori, Giuseppe Verdi, e al direttore d’orchestra che si conosca Arturo Toscanini, nonché a tutto uno stuolo di interpreti tra i più famosi al mondo, e che qui vale la pena ricordare come Tagliavini, Bergonzi, Raimondi, Pavarotti. Il Regio di Parma infatti non è solo un teatro d’opera, e non viene dopo La Scala di Milano, semmai permette agli interpreti verdiani l’accesso a quest’ultimo dopo aver riscosso il ‘benestare’ dal suo 'loggione' crogiuolo di raffinati intenditori.
Accade così che anche la musica colta, per dire quella più impegnata del teatro lirico, finisce con l'occupare un suo posto precipuo, onde recupeare ‘cori e arie’ apparse in balletti d'Opera, nonché pagine sinfoniche e cameristiche quasi dimenticate e che riascoltiamo, non senza provare un certo piacere per le nostre orecchie. Come ad esempio il “Concerto delle Dame di Ferrara”* (per soprano e clavicembalo) di Luzzasco Luzzaschi (1547-1607); i “Madrigali a cinque voci”* di Carlo Gesualdo (1561-1613); le “Canzoni e Moresche”* di Rolando di Lasso (1532-1594); le “Tarentule-Tarentelle”* del XV e XVI sec. ricostruite da Gregorio Paniagua che già appartennero, per quanto riguarda l’influena spagnola in Italia, all’area popolare laziale-partenopea; ma anche quel “Salterello Montanaro” ripico dell’appennino tosco-emiliano:
Dal “Concerto delle Dame di Ferrara” * di Luzzasco Luzzaschi:
(III)
Ch’io non t’ami, cor mio?
Ch’io non sia la tua vita, e tu la mia?
Che per nuovo desìo
E per nuova speranza, i’ t’abbandoni?
Prima che questo sia
Morte non mi perdoni
Che se tu se’ quel core, onde la vita
M’è si dolce, e gradita
D’ogni mio ben cagion, d’ogni desire
Come posso lasciarti, e non morire?
(VIII)
O dolcezze amarissime d’Amore
Quest’è pur il mio ben, più che languisco
Che fa meco il dolor se ne gioisco
Fuggite Amore amanti, Amore amico
O che fiero nemico
Allor che vi lusinga, allor che ride
Condisce i vostri pianti
Con quel velen che dolcemente ancide
Che par soave et è più pungente e crudo
Et è men disarmato allor ch’è nudo.
(XI)
Non sa che sia dolore
Chi dalla vita sua parte, e non more
Cari lumi leggiadri, amato volto
Ch’Amor mi diè
Sì tardo e fier destino
Sì tosto oggi m’ha tolto
Viver lungi da voi? Tanto vicino
Son di mia vita al termine fatale
Se vivo torno a voi, torno immortale.
Ma già il suono del violino impegnato in un ‘trescone’ ci invita a levar le gambe sull’aia in questa Emilia segnata dai solchi profondi dell’aratro, e da bei filari di olmi intrappolati nelle consuete armosfere di nebbia della bassa; mentre il canto di una ‘villotta’ ci consente una visione entusiastica di gruppi di giovani, ragazzi e ragazze in bicicletta dal sorriso cordiale e accattivante, sentimentale come può esserlo solo un possibile appassionato intreccio d’amore che sappia di una stanza calda o di una tavola apparecchiata. Qui la gente non perde occasione per adunate in allegria, riunendo attorno a sé parenti e vicini di casa, compagni di bevute e sconosciuti di passaggio, che si ritrovano a consumare insieme momenti di svago suonando e cantando, così come nel levare i piedi in una ‘contradanza’ alla francese, nel ‘trescone’ o nella ‘roncastalda’ al suono di una fisarmonica o di una chitarra (chitarrone?), o meglio ancora di un violino, il cui richiamo, da sempre, aspira al legame collettivo con la partecipazione attiva di tutti. In questo senso la ‘festa’ costituisce un insieme di valori condivisi e di esperienze vissute alla base di una vera identificazione sociale. Si può ben dire che l’Emilia è forse la sola regione che sia riuscita a conservare delle forme sociali comunitarie altrove divenute urbanamente formali. Qui, più che altrove, la funzione sociale dello stare insieme assume in vero l’aspetto di sollecitazione, di scambio, di presenza, è insomma un modo forse più sano di ‘vivere la vita’.
A tal proposito scriveva Enzo Biagi: “È certo una terra di epicurei, gli ultimi io penso; è lo stesso paesaggio che lo esige: branchi di maialetti o di faraone al pascolo, buoi che per l’imponenza suggeriscono l’accompagnamento col suono dell’organo, alberi carichi di frutti e, nel Po si cattura lo storione e certi pesciolini che per la sinuosità con cui si muovono li chiamano ‘puttana’ e li buttano in padella; e inoltre le anguille e i cefali della palude, e le lepri, le folaghe, i colombacci di passo, e poi tanti vini: dal lambrusco all’albana, all’abboccato sangiovese. Il cibo entra in tutto e condiziona la vita”. E al buon mangiare e bere, bene si addice il canto della ‘villotta’ che in Emilia è più che una semplice esecuzione di pregio: “..diventa un vanto” – aggiunge Sandra Mantovani – che il più delle volte risponde a un modello arcaico ancora oggi relativamente diffuso nelle contrade:
“Èn co de l’éra … o mio ben” * (Giulia Bontempi / Sandra Mantovani)
“Èn co de l’éra … In cima all’aia c’è un camino che fuma / è l’amore del mio bene che si consuma / che si consuma a poco a poco / come la legna verde sopra al fuoco. / In cima al fuoco c’è una piantina / e tutti i rametti chiamano Giovanni. / O Giovannino datemi la buona andata / la vostra gamba l’avete ancora malata. / Se mi marito voglio prendere un bifolco / e a ora di pranzo le ha fatto un solco / e a ora di merenda ne ha fatto un altro / quando è sera è più stanco degli altri. / Se mi marito voglio prendere uno grande / che mi farà ombra in mezzo al campo. / Se mi marito voglio prendere uno bello / non voglio guardare né il ricco né il poverello / òi siò!”
“Quèla che canta” * (Francesca Ghirelli)
“Quella che canta è una maritata / sentitela nella voce cos’è / sentitela nella voce e nelle pene / come la maritata non ha più bene.”
In un’antica ‘villotta’ si narra del bisticcio di due innamorati: “La mia morosa mi ha detto gnocco e io ci ho detto brutta crescentona”, al cui termine il fidanzato si presenta a casa dell’amorosa con un mazzo di fiori:
“Mamma mia vorrei, vorrei …” * (I Viulan / Coro Stelutis)
“Mamma mia vorrei, vorrei ...
Che vorresti fiôla mî?
Ah vorrei quel ch'è nell'orto
me lo dai o morirò.
Là int l ôrt ai é däl pair
se le vuoi te le darò.
Guarda bén che brutta mamma
non conosce il mal che ho.
Mamma mia vorrei , vorrei...
Che vorresti fiôla mî?
Ah vorrei quel ch'è nell'orto
me lo dai o morirò.
Là int l ôrt ai é däl próggn
se le vuoi te le darò.
Guarda bén che brutta mamma
non conosce il mal che ho.
Mamma mia vorrei , vorrei ...
Che vorresti fiôla mî?
Ah vorrei quel ch'è nell'orto
me lo dai o morirò”.
Alla ‘villotta’ spesso risponde con uno ‘strambotto’ tipico dell’area ferrarese in cui la disputa amorosa finisce con un ‘ballo’ detto ‘di Mantova’ che, a distanza di tempo ha assunto maggior valore e importanza culturale, sia per quanto riguarda la musica che l’accompagna, sia per quella specificamente coreutica. Conosciuto in numerose varianti nelle diverse aree tanto in pianura come in montagna, questo ballo ricorre in tutte le feste nel periodo di Carnevale.
“Ballo di Mantova” o “Mantovana” * (Maria Grillini)
“Fuggi, fuggi, fuggi dai lieti amanti
empia donna cagion de' pianti
che non già per esser crudele,
ma per esser ingrata ed infedele
ogni core t'ha in orrore
fuggi, fuggi, fuggi ché chi ti mira
per te vive, piange e sospira.
Fuggi, fuggi, fuggi ché la vendetta
fare l'Inferno dell'error tuo aspetta
Ma de l'abisso l'ardente foco
sia del tuo male castigo sì poco
Ah, qual ch'io ti desio
Fuggi, fuggi, fuggi via fiera peste
che il mondo tutto ai tuoi danni s'appreste.
Fuggi, fuggi, fuggi se fuggir nieghi
che così il Cielo, diva, ti leghi
Né mai possa pur muovere un passo
fatta di carne un rigido sasso
e infin ch'abbia la tua rabbia
Fugga, fugga, fugga chi brama pace
perch'ogni froda ascosa qui giace.”
In un altro testi più diffuso cantato ed eseguito da Angelo Branduardi*:
“Fuggi, fuggi ,fuggi da questo cielo
Aspro e duro spietato gelo (x2)
Tu che tutto imprigioni e leghi
Né per pianto ti frangi o pieghi
fier tiranno, gel de l'anno
fuggi, fuggi, fuggi là dove il Verno
su le brine ha seggio eterno.
Vieni, vieni candida vien vermiglia
tu del mondo sei maraviglia
Tu nemica d'amare noie
Dà all'anima delle gioie
messagger per Primavera
tu sei dell'anno la giovinezza
tu del mondo sei la vaghezza.
Vieni, vieni, vieni leggiadra e vaga
Primavera d'amor presaga
Odi Zefiro che t'invita
e la terra che il ciel marita
al suo raggio venga Maggio
vieni con il grembo di bei fioretti,
Vien su l'ale dei zefiretti”.
“Non è da escludere – riporta Stefano Cammelli* – che il suddetto ballo conoscesse numerose altre utilizzazioni non ancora meglio documentate e forse scomparse. La sua versione più originale si svolge attorno ad un solo danzatore che si finge morto (per amore), al quale fanno cerchio un gruppo di altri danzatori (uomini e donne) che toccandolo, sollevandolo in aria, rigirandolo, cercano di resuscitarlo. La situazione diviene facile pretesto per momenti di comicità e lazzi che durano per tutto il tempo di ballo, fino al ‘trescone’ finale; quando cioè il finto morto, svegliatosi, afferra una delle ballerine (la sua morosa) e danza con lei il ‘trescone’”.
“Il ‘trescone’ – ricordavano Alan Lomax* e Diego Carpitella* – che fecero le prime originali registrazioni ‘sul campo’ è una tipica danza di corteggiamento dell’Emilia Romagna la cui origine molto interessante, riporta al ‘thriskan’ ovvero l’antico termine germanico che significa ‘trebbiare pestando con i piedi’. Quando circa attorno l’Anno 1000 vi fu l’invasione germanica dell’Italia settentrionale, il termine assunse significato di ‘amoreggiare’. Gli italiani di allora la usarono anche in quanto ‘tresca’ per definire una relazione amorosa illecita come quella tra i soldati e le donne che li seguivano. Ed anche in quanto ‘intrigo’ di nozze in cui la compagnia raccolta nel canto, descriveva il corteggiamento amoroso che aveva condotto al matrimonio, mentre la coppia, al centro del circolo, lo drammatizzava nel ballo”. L’esecuzione del ‘trescone’ prevedeva un gruppo di strumenti tipici dell’area tosco-emiliana-romagnola, quali la fisarmonica, il violino, la chitarra e talvolta il mandolino in formazione orchestrale ch’era chiamata a rallegrare le feste, le sagre, in occasione di matrimoni, ma anche per il ritrovarsi tra amici all’osteria. All’occorrenza venivano levate forme di canto-solo o anche ‘corali’ nelle forme dello ‘strambotto’, del ‘contrasto’ o, a secondo della ricorrenza, della ‘serenata’:
“Scarpulèn d’un bel scarpulèn” * (Bruno Manfredi)
“Scarpulèn d’un bel scarpulèn la mia scapeta / e la voresti tu rangiar la mia scarpeta / e si, si, si cat la rangerò perché sei bella / e se la forma non c’entrerà c’è un bel martello / e sotto il ponte di Garagna c’è un’osteria / e la c’è da bere e da mangiar / c’è da bere e da mangiar tutto è pagato”.
Parlare allora di ‘balli’ s’intendeva spesso l’insieme di ‘danze’ etniche entrate nel patrimonio culturale delle nostre realtà regionali in tempi più lontani, alcune delle quali altresì andate perdute e con esse i passi che le figuravano, ma delle quali ci è rimasto il ricordo delle musiche strumentali che le accompaggnamento, spesso riusate tanto nella musica colta che in quella popolare. Il recupero delle quali, in qualche caso è stato possibile grazie ad alcuni ricercatori impegnati sul territorio, quanto anche ad eccezionali strumentisti che hanno ricreato, almeno in parte, quella musica che oggi siamo in grado di ascoltare. Scrive ancora Stefano Cammelli*:
“Se quanto detto precedentemente sul ‘ballo’ poteva sembrare arbitrario, la scoperta del canto arcaico detto “Ballo di Baraben” lascia pochi dubbi. L’informatrice Maria Grillini, ottima ballerina di balli montanari, afferma ch’era cantata dai ballerini in movimento ‘..girando attorno al morto con ambedue le mani tra i capelli’. È a tutti noto che è questo il simbolo ‘classico’ attraverso cui si rappresenta il ‘pianto funebre’. Un analisi, inoltre, del testo, ce ne da ulteriori conferme: viene infatti descritta una veglia notturna a metà della quale vi è la distribuzione di castagne e nespole. L’usanza di fare la treccia durante la veglia era, nelle famiglie più povere, un modo per fare pagare agli invitati ciò che essi mangiavano. All’interno della veglia, introdotta dalla morte di Baraben cui viene allestita la camera ardente, si registra l’acquisto di carne che verrà servita agli invitati. Tanto il Paciucci che il Trebbi-Ungarelli entrambi ricercatori, parlano del ‘pranzo rituale funebre’ come di una tradizione ancora viva”:
“Ballo di Baraben” *(canzone a ballo)
“E ‘l Baraben l’è mort
sufìa l’e la crida
e c’la n’a gnanc un solde
da comperai la zira …
cumpre un taì di cheren
i’o de quater baioc
la mi compre l’ira
me l’o compre a l’ngros.
E ‘l Baraben l’è mort
e a una braze di manali
ca li voio spaier
an so quanti ragazi
che me va d’invider.
O tra da meza veia
o tra da mezanot
i’e un panierin di nespel
con tre castagna cot.
E ‘l Baraben l’è mort la la la …”.
Di questo stesso ballo esistono molte versioni strumentali per violino e per fisarmonica, anche se quest’ultima ne ha mutato la tonalità, adattandola a una musicalità più moderna, e la si ritrova tra i balli in voga nelle balere. Oggi è però il ballo cossiddetto ‘liscio’ a farla da padrone nell’area emiana-tosco-romagnola. Certamente il genere più seguito non soltanto dagli anziani, ma che raccoglie molti giovani frequentatori delle balere, entusiasti dell’atmosfera ricreata della ‘festa’; decisamente valido per la varietà degli strumenti usati, per la fantasmagoria delle note, nonché per l’utilizzo di ritmi più attuali che ne fanno un campione di successo e, ovviamente, d’incassi; e che riesce a mettere tutti d’accordo nel ritrovarsi insieme nella magica affermazione della musica. “Oggi non è più così”, dicono gli anziani, lasciandosi andare ai ricordi di gioventù, anche se la loro non risale a più di 40 o 50anni fa. Corrado Ferretti, un gentile signore ‘parmense doc’ oggi in pensione, ha di recente inviato alla nostra redazione un articolo molto significativo su come scorreva la vita quotidiana della sua fanciullezza nei ‘borghi’ del centro storico di Parma:
«Già alla buon’ora del lunedì passavano le lavandaie con le carrette ricolme di panni che si recavano alle rive del Taro, lì dove l’acqua rasentava l’argine; o appena dietro il Dazio dove scorreva un piccolo ruscello d’acqua sorgiva. Subito dopo, a poco a poco, s’incominciavano a sentire i rumori delle diverse attività: il martello del fabbro, la sega del falegname, il richiavo dei venditori di rane spellate e altri come l’arrotino e il salire delle saracinesche dei negozi intorno alla Piazza Garibaldi. Era quello per tutti loro l’avvio della giornata lavorativa. Ma non per noi ragazzi che s’iniziava a schiamazzare e a correre avanti e indietro per i borghi chiamandoci l’un l’altro. Si giocava dalla mattina fino a sera (senz’altro poco studio!). C’era chi di noi imparava allora ad andare in bicicletta, cadendo immancabilmente e sbucciandosi le ginocchia. Ricordo che per consuetudine le mamme, e più spesso le nonne, ci gridavano contro dalle finestre aperte:”Stasera lo dirò a tuo padre/madre quando l’arriverà a casa, vedrai, vedrai!”; oppure ci raccomandavano: “..e non correre, che altrimenti sudi e ti ammali!”».
«Di alcuni ricordo ancora i nomi mentre di altri solo il loro soprannome: Fabri, Romanine, Giacca, Cicle, Bignoghe, Corde, Bocillo, Scannagril, Omino, Riccio, Bombolo, Vito, Pieròto, e ancora Guglielmo, Silvio, Ernesto che dicevamo ‘mangiava il cavallo pesto’, il Giacca bello come Tyron Power. E poi c’erano le ragazze: Mirella, Naldina, Marisa, Anna Violi, Anna Barbieri, Egle, Rita, Anna Musetti, tutte o quasi che pendevano per lui. Allora si giocava con le spade di legno e i finti schioppi, alla ‘cavallina’, a ‘pio-pes’, alla ‘palla stregata’, ‘palla prigioniera’, al ‘gerlo’ a ‘magìa’ (testa o liscio), e non mancavano le ‘figurine’ e il gioco dei ‘sinalcoli’. Le ragazze invece giocavano a ‘mondo’, all’ ‘anello’, alla ‘campana’ disegnata col gesso sull’asfalto della strada, alla ‘corda’. Immancabilmente verso mezzogiorno passava il vigile urbano e metteva fine ai giochi, in primis quelli con la palla cercando di sottrarla ai ragazzi più scaltri che se la passavano l’un l’altro talvolta mettendolo alla berlina, facendosi poi rincorrere fino al solaio delle loro case».
«Molti sono gli aneddoti delle ‘marachelle’ combinate da noi ragazzi in barba all’autorità del vigile e altre che riguardavano per lo più gli avvenimenti del giorno: c’era Romano che raccontava di possedere il tesoro nascosto di Kammamauri, il personaggio di Emilio Salgari, cui ovviamente nessuno di noi credeva. C’era Marién che alla domanda di dove prendesse il gesso per disegnare le sue interminabili campane sulla pavimentazione stradale, sosteneva di aver nascosto due quintali di gesso in Cittadella. Michele diceva che Gigi barava alle carte vincendo ogni volta i giornaletti di tutti gli altri ragazzi, ed erano: Sciuscià’, ‘Zorro’, ‘Pecos Bill’, ‘Gordon’, ‘Mandrake’, ‘Pantera Bionda’ grazie anche alla madre che segnava i punteggi. A Borgo Onorato, già Borgo della Gallinella, ad esempio, c’era la Doris che spesso sbraitava contro la mamma di Rita e Giuseppe volendo sapere dove fossero andati i ragazzi per avere notizie di suo figlio Romanine. E quella rispondeva che erano andati sulla strada liscia con i carrettini a cuscinetti per poter correre meglio sul marciapiede a mattonelle con inciso C.P.U.T., da noi ribattezzato ‘Cane Pelato Unto Tagliato’ che non voleva dir niente, ma che ci faceva tanto ridere».
«Ricordo che Menegalli il falegname aveva costruito un carretto di legno più grande, grazie al quale si guadagnava qualche amlire in più facendo fare a noi ragazzi un giro intorno all’isolato fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena, con buona grazia di Don Paolino, il nostro parroco che nell’attesa che noi ragazzi arrivassimo fin là, si gustava la sua sigaretta in santa pace, per poi scortarci tutti a dottrina. E che dire della mattina prima della Messa in cui il sagrestano, da noi benevolmente soprannominato Zorro, si aggirava nelle strade per incontrarci e scegliere i chierichetti che avrebbero dovuto servir messa ‘nei modi dovuti’ – diceva. Ma ecco che una volta suonata la campanella d’inizio della celebrazione, immancabilmente succedeva qualcosa. C’era sempre tra noi qualcuno che borbottava: “..lo faccio io, lo faccio io” e finiva che nel momento in cui Don Paolino saliva i gradini dell’altare, ecco si faceva a gara per togliergli il cuscino sotto il tabernacolo, creando non poca difficoltà al parroco, il quale, spazientito, tirava infine un calcio mandando a finire il cuscino chissà dove. Per non dire dell’uso del turibolo da cui partivano mozziconi d’incenso incandescenti che una volta aggiustata la mira, finivano per planare sul tappeto sotto l’altare che solo il pronto intervento del sagrastano riusciva a evitare pericolose bruciature. Al rientro nella sagrestia venivamo subito ammoniti da Zorro che gridava: “Se fossi io il parroco non vi farei più entrare in chiesa!”. Al che Don Paolino pronto metteva fine alla diatriba e tolti i paramenti sacri, afferrava una manciata di caramelle dicendo: “Ma siiv propria di bargnociò!”.
«Nelle sere invernali nella bassa la nebbia la faceva spesso da padrona e noi si stava in casa senza uscire ma, allorché si sentiva il sopraggiungere del carretto che vendeva i ceci caldi presso l’Osteria Emiliana, ecco si usciva tutti quanti dalle case e mentre alcuni di noi tenevamo impegnato l’uomo a preparare i cartocci, altri alzavano il coperchio della caldara e rubavano i ceci col mestolo oppure a manciate senza essere visti ma spesso bruciacchiandosi le dita. Io m’inebriavo di quei profumi che vorticavano nell’aria facendomi quasi impazzire dalla voglia di assaggiare del buon ‘culatello’ o di ‘prosciutto dolce’ di Parma sulle fette ancora calde della ‘torta fritta’ e perché no ‘un toc de parmisan'. Ma anche dei sapore di cibi più semplici come le polpette di cavallo della Gerali, della 'vecchia', della polenta, della frittata, del minestrone, dei sughi fatti in casa dalla Norina e delle patate fritte della Velia».
«Bel luogo d’incontri l’Osteria Emiliana, così piena di vita e di pregiudizi. Gli uomini vi facevano una capatina seguita da una bevuta prima di rientrare a casa dopo il lavoro. Altri i più vecchi si abbandonavano ai tavoli dietro il fumo di qualche sigaro o della pipa, mentre altri ancora intavolavano un gioco delle carte o della morra, mentre ‘al mat sicure’ s’intrufolava nei portoni aperti delle case a mangiare ciò che si portava dietro in uno scatolone. Poi, quando finalmente per molti era ormai l’ora di ritirarsi per cena, alcuni di loro come Stopài e la Straséra restavano a consumare qualcosa da Gradalé fino ad esser ciucchi, anche se a dire il vero tenevano il vino ch’era una meraviglia e a notte trovavano sempre la strada di casa. Il tutto accompagnato da romanze verdiane che tutti conoscevano a memoria. Anch’io come tutti i buon emiliani me ne intendo di musica e devo dire che oltre all’organo di chiesa mi piaceva il suono delle nuove campane che con una grande funzione presieduta dal nostro amato Vescovo, Monsignor Evasio Colli, furono consacrate e fatte suonare a lungo con immenso piacere della nostra gente».
«Va detto che ‘in quegli anni’ alcuni di noi già suonavano davvero bene; come Vito e Teresa (sua sorella) ad esempio, ritenuti provetti suonatori di fisarmonica a livello nazionale; come del resto era Trioscé, soprannominato così perché d’inverno aveva un appuntamento fisso con le gambe rotte a causa della ‘blisgarola’. Cicle invece suonava il clarinetto e faceva già parte della Banda di Parma; Corde si dava da fare alla batteria, mentre Fabri era già provetto suonatore di chitarra classica. Alcuni di loro nel periodo estivo, tra cui Pino e Luminoso, intrattenevano noi più giovani in un caldo solaio, esibendosi nel teatro dei burattini allo scopo di ‘ramarci’ qualche spicciolo per comprarsi le prime sigarette. A quel tempo per noi ragazzi era di rigore portare i calzoni corti sia d’estate che d’inverno con qualche toppa qua e là sul sedere, senza vergognarci, perché all’epoca non c’era niente di cui vergognarsi, tanto i disastri della guerra avevano disseminato miseria dappertutto».
«Ma il clou della giornata arrivava con la sera, quando tutti facevano ritorno dal lavoro con la stanchezza addosso e ci si lasciava prendere dalla malinconia. Dopo cena le madri e le nonne a loro volta madri, prendevano le sedie e scendevano in strada a fare ‘conversazione’; mentre noi ragazzi, instancabili com’eravamo, coglievamo l’occasione del buio per giocare a nascondino. Come un rito che si ripeteva da sempre anche le ragazze scendevano a giocare con noi e c’era sempre qualcuna di loro che correva dagli adulti a lamentarsi di noi per averle tirata la sottana: “Mamma, quei ragazzi non ci lasciano stare!”, ed ecco che un’altra madre prontamente rispondeva in nostra difesa: “Anca lor ien petégli”. Poi, una mattina che ero particolarmente assonnato, avvertii il rumore di molti portoni aprirsi dietro la spinta disordinata dei ragazzi e delle ragazze più grandi che in sella alla loro bicicletta partivano per una gita, era quella la prima volta che uscivano tutti insieme dal borgo, destinazione montagna. Erano attrezzati con zainetti in spalla che lasciavano intravedere filoni di pane imbottiti di salumi e marmellate, c’era finanche il Pieròto con una sporta in pelle ricolma di latte i cui manici stavano appesi al manubrio come un trofeo».
«Rammento che mi alzai di scatto, quasi spaventato, e mi accorsi che nell’inconsapevolezza del passare degli anni forse ero rimasto indietro. Fu lì che per la prima volta compresi che i tempi erano davvero cambiati e che la bicicletta ormai avrebbe rimpiazzato tutti i nostri miseri giochi divenuti improvvisamenti obsoleti. “L’età matura era ormai alle porte” – mi dissi non proprio convinto e mi rattristai non poco. E adesso che l’età ha aggiunto molti lustri al mio novero degli anni, mi ritrovo spesso a domandarmi il senso di una frase ascoltata molto tempo prima, quella volta in cui Bignoche disse alla mamma di Corde, di dirgli che quella sera gli elefanti erano rosa, e la mamma di Corde che mentre saliva le scale di casa, diceva fra sé: “Cosa mai vorrà dire che gli elefanti stasera sono rosa?”».
(continua)
Note bibliografiche:
“L’albero di canto” - elab. di Raffaele Nobile – LP Madau D-05
“La mazurka del violinista cieco” - Egidio Bandini - articolo apparso su La Gazzetta di Parma del 05/07/2011.
“Racconto” - Corrado Ferretti, (inviato alla redazione 15.08.2014
Discografia:
“Concerto delle Dame di Ferrara” - Luzzasco Luzzaschi (1547-1607) – CD Harmonia Mundi – 901136.
“Madrigali a cinque voci” - Carlo Gesualdo (1561-1613) – CD Harmonia Mundi -901268.
“Canzoni e Moresche” - Orlando di Lasso (1532-1594) – CD Harmonia Mundi 901591.
“Tarentule-Tarentelle” del XV e XVI sec. – Atrium Musicae de Madrid dir. Gregorio Paniagua – CD Harmonia Mundi 90379.
“Chominciamento di gioia” - Angelo Branduardi – CD La Voce del Padrone 489890 2.
“Musiche e canti popolari dell’Emilia” (antologia in 4 vol.) a cura di Stefano Cammelli
Albatros VPA 8278-9 / 8403 / 8414 - Documenti originali del folklore musicale europeo.
“Folklore musicale italiano” a cura di Alan Lomax e Diego Carpitella – 2LP PULL QLP107/8.
*
 - Fede
- Fede
PAPA FRANCESCO - ‘Laudato sì’ / seconda parte
PAPA FRANCESCO: Enciclica ‘Laudato sì,’ / Seconda parte
Nella ‘prima parte’ di questa recensione si poneva l’accento sul recupero della ‘bellezza’ ricevuta in dono senza nostro merito alcuno che andiamo disperdendo sullo sfondo di un’epoca (quella attuale) che ci sfugge di mano, e ci vede incapaci di gratitudine davanti al grande progetto di Dio. '‘Dio (nella sua onnipotenza) si compiace di salvare con la grazia quello che è perduto per natura, per mostrare che non vuole distruggere, ma riparare (..) sperimentando la dura fatica della gioia misericordiosa (in quanto a noi donata), (..) basta meditare la vita del nostro Salvatore per comprendere che l’origine di tutti i nostri errori sta nell’aver confuso il giudizio di Dio con la sua pietà’. E, come pur dice l’amico Nicola Aurini, nell’aver riversato la drammatica storia del ‘figlio’ all’interno di una ‘fiaba’ che ci raccontiamo da tempo ormai, in cui la giustizia divina, quantunque occulta, cessa d’essere irreprensibile e diventa criticabile, o almeno discutibile per la scorrettezza di chi invece è ‘chiamato’ a divulgarla.
Non c’è che dire, è da sempre la qualità di chi dimentica e non ricambia, propria dell’ingratitudine umana, tipica del trascurare ciò che di bello, di buono, di ben fatto si ridesta alla sua ‘eccellenza’ primaria, al calore (dell’amore) e al candore (dell’anima) del primo apprendimento che abbiamo definito ‘cristiano’, nel ripetersi del gesto costitutivo della creazione e che, pur nelle sue accezioni, chiamiamo ‘forza generatrice’, ‘potenza creativa’, ‘natura’ o come si vuole. Tuttavia se l’attribuiamo a un atto di fede per quel Dio Pantocratore che governa l’ampia estensione del cosmo il concetto non cambia. Ed è questa la ragione per cui noi, che pure abbiamo fatto della leggerezza la nostra filosofia di vita, non abbiamo finora trovato ‘altro’ con cui sostituire quanto postulato in valori e riflessioni.
Acciò l'idea odierna di un ‘Dio lontano e inavvicinabile’ che raggiunge l’ossessione del nostro tempo, in qualche modo accentua il ‘sacro tremore della grazia ricevuta’ (in illo tempore), che pure richiamava alla serenità del vivere, alla fiducia e perfino a quella prima innocenza della fede che (oggigiorno) seppure offuscata, non è mai andata perduta per intera’. Ed è a quella originaria ‘innocenza’ che le parole di Papa Francesco ‘simili a falde misteriose che solcano il profondo e l’infinito’, oggi attingono, riproponendoci l’immagine del Cristo amorevole e a noi più che mai vicino, nel momento in cui si è chiesto di ripristinare la ‘cura della casa comune’ allo stesso modo (ampliato) in cui si era già espresso il suo grande predecessore: San Francesco d’Assisi.
Ma la gratitudine non sembra prediligere neppure il nostro tempo se, al contrario noi, sembriamo capaci solo di arrabattarci a sopravvivere, qua e là sperperando l’intera nostra eredità, meravigliosa quanto pesante, che piuttosto trasformiamo in una sorta di demerito senza responsabilità, di volgarità senza dignità e senza alcuna moralità, che più infatti ci mortificano. A tal proposito le parole di San Paolo risuonano più che mai inappuntabili: “Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di tutti gli uomini”. Dov’è allora quella ‘bellezza’ che abbiamo avuta in dono (prestito)? Come possiamo salvaguardarla e restituirla alle generazioni che verranno? Come possiamo tornare a vivere il nostro tempo (questo tempo) con la coscienza e il rispetto che merita?
Le risposte a questi interrogativi non sono ‘espliciti’ nell’Enciclica di Papa Francesco, per quanto vengano fatti alcuni importanti riferimenti nelle due ‘preghiere’ che chiudono il messaggio papale e che rompono lo schema dell’emergenza che ci attanaglia per riprendere il dialogo con Dio lì dove l’abbiamo abbandonato. Papa Francesco insiste sul fatto che una dottrina nulla dice se non la si pratica: “..dovremmo agire piuttosto che attendere, dovremmo pensare invece di supporre, dovremmo riprendere ad ascoltare anziché blaterare e, infine, dovremmo salvarci da noi stessi.” Il nostro ‘viaggio interiore’ incomincia da questi pochi propositivi intendimenti: “ridefinire gli obiettivi di vita che ci siamo preposti, (sapere cosa vogliamo); recuperare le motivazioni che ci spingono ad agire, (le pulsioni interiroi); lasciar emergere la parte più profonda e creativa della nostra persona, (alfine di ricostituire in noi l’essere integrale purificato ch’è in noi); restituire allo ‘spirito’ quell’amore ch’è in Dio, affinché guidi la nostra anima nel viaggio che dobbiamo intraprendere, come riscatto alla paura della morte.
Forse non ce ne siamo accorti ma “..stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a tutto ciò senza stare a pensare a quello che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. (..) Separato dall’etica, ogni momento, dificilmente sarà capace di autolimitare il proprio potere”. Acciò non occorre farsi santi o eroi per superare gli ostacoli della vita: “L’ideale non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità per scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose”. Come insegnava San Bonaventura: “La contemplazione è tanto più elevata quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre creature”. (..) Quindi c’è un mistero da contemplare in una foglia , in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. (..) Un’espressione di questo atteggiamento è fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Propongo ai credenti che riprendano questa preziosa abitudine e la vivano con profondità. Tale momento della benedizione, anche se molto breve, ci ricorda il nostro dipendere da Dio per la vita, fortifica il nostro senso di gratitudine per i doni della creazione, è rafforza la solidarietà con i più bisognosi”.
Perché, infine: “la cura per la natura è parte di uno stile (etico) di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione”. Per quanto i ‘passi’ sopra riportati invitino ad esplicitare la fede con ‘l’agire piuttosto che attendere’, “la spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo (consumismo). (..) La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. (..) Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. (..) Ciò significa apprezzare ogni (singola) persona ed ogni cosa, imparare a familiarizzare con gli altri e le realtà più semplici, e saperne godere”.
“D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé stessa. E parte di un’adeguata comprensione della spiritualità consiste nell’allargare la nostra comprensione della pace, che è molto più dell’assenza di guerra. La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato (etico) unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. La natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé. Questo incide sul modo in cui si tratta l’ambiente. Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e svelata».”
John Stuart Mill, interpellato sul significato dell’etica applicata alla scienza, scriveva che l'uomo è sovrano su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente e, per quanto la scienza non abbia ancora dimostrato il contrario, assistiamo al subentrare della bioetica ad occuparsi dei grandi interrogativi che ruotano intorno alla persona, a partire dal rispetto della vita umana nel suo significato più profondo. Incentrato tutto sul problema della salvaguardia dell'individuo, il nostro tempo si interroga sui limiti; la ricerca scientifica migliora la qualità di vita dell'uomo, traccia un cammino fatto di conquiste verso la cura delle malattie più insidiose, cerca i presupposti per insegnare agli individui come curarsi e come concepire la propria salute. (..) Prevede dunque l'interazione dell'etica con le scienze, in una modalità più moderna rispetto a quella tradizionale e religiosa, con lo scopo di affrontare e valutare anche a livello morale alcuni processi medici quali il trapianto di organi, l'eutanasia, la fecondazione artificiale e tanti altri. (..) Pur tuttavia la bioetica viene definita come un'area di ricerca che grazie a diverse discipline su cui si basa pone come «oggetto dei suoi studi l'esame sistematico della condotta umana nel campo della scienza della vita e della salute.»
In fatto di 'bioetica e religioni' una premessa è necessaria, che segna alla radice il dibattito in atto in vari paesi del mondo, e riguarda il concetto di Creato: “Quasi tutti i credenti di qualsiasi fede religiosa condividono l'idea che ciò che ci circonda viene da un atto di creazione, cioè da un intervento divino, sovrannaturale. Tale impostazione iniziale, come conseguenza, porta alle problematiche che coinvolgono la bioetica, che a loro volta hanno ripercussioni su alcune tra le questioni più significative della vita umana (nascita, sessualità, morte). Sono evidenti quindi le notevoli connessioni di questi temi con la religione ed altrettanto evidenti le cause delle reazioni dei non credenti al riguardo. (..) Nei paesi di tradizione cattolica è rilevante il ruolo ricoperto dalla bioetica cattolica ufficiale - cioè quella contenuta nei documenti del magistero della Chiesa, nelle opere degli autori che risultano in sintonia dottrinale con essi e nella comunità scientifica che ad essa fa riferimento e che si muove all'interno del paradigma della sacralità e indisponibilità della vita, sostenendo che la persona umana, come non è la creatrice della vita, così non ne è la proprietaria.»
All'idea della sacralità e indisponibilità della vita si connettono la proibizione dell'aborto, l'illiceità del suicidio 'consapevole' ed il rifiuto dell'eutanasia. «La bioetica cattolica sostiene che ciascun essere umano ha il diritto/dovere alla vita, intendendosi, con questa definizione, la forma di vita umana dal momento del suo concepimento a quello della sua morte naturale.» Ora, per quanto si può essere d’accordo o meno con queste posizioni ‘utilitaristiche’ e ben anche che studiosi di buddhismo, confucianesimo, cristianesimo, ebraismo, induismo, islamismo e taoismo si sono pressoché cimentati con la bioetica cattolica ufficiale sin dai suoi inizi, offrendo, in molti casi, contributi di rilievo, San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c’è di buono nelle cose e nelle esperienze del mondo: “..si trova eminentemente in Dio in maniera infinita o, per meglio dire, Egli è ognuna di queste grandezze (eccellenze) che si predicano».
E aggiunge: «..non è perché le cose limitate del mondo siano realmente divine, ma perché il mistico sperimenta l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri (del creato), e così sente che Dio è per lui tutte le cose». Dacché l’importanza dei Sacramenti quale modo privilegiato in cui la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbracciare il mondo su un piano diverso». (..) Ecco che allora il senso ‘etico’ della vita si sposa con «..l’acqua (del battesimo), l’olio (della cresima), il fuoco spirituale (che unisce gli sposi), sono assunti con tutta la loro forza simbolica (sprigionante vigore e bellezza nella lode levata al Signore); la mano levata che benedice è strumento stesso dell’amore di Dio e insieme riflesso della vicinanza di Cristo che è venuto ad accompagnarci nel cammino della vita».
Tuttavia è «nell’Eucaristia che il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia (l’atto del dono che si rinnova), che tende a manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell’Incarnazione attiva ciò che ‘in illo tempore’ era chiamato ‘rito antropofagico’ in cui è raggiunta attraverso un frammento di materia (rappresentata dall’ostia consacrata), la nostra nascosta intimità (l’anima), in quanto centro traboccante d’amore e inesauribile di vita. (..) L’Eucaristia dunque, in quanto fonte di luce, unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. In ciò il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna al suo Creatore in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eucaristico la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sue nozze, verso l’unificazione con il Creatore stesso».
A fronte di ciò come non avallare le parole dell’eccellente sociologo Zigmunt Bauman per il quale «..ognuno di noi è artista della propria vita: che lo sappia o no, che lo voglia o no, che gli piaccia o no. Essere artista significa dare forma e struttura a ciò che altrimenti sarebbe informe e indefinito. Significa manipolare probabilità. Significa imporre un ‘ordine’ a ciò che altrimenti sarebbe ‘caos’: organizzare un insieme di cose ed eventi che altrimenti sarebbe caotico (casuale, fortuito e dunque imprevedibile), rendendo così più probabile il verificarsi di certi eventi anziché di altri. (..) organizzare o ‘gestire’ significa mettere assieme e coordinare risorse che altrimento rimarrebbero separate e sparse. (..) Per esprimere ciò spesso parliamo della necessità di ‘organizzare le cose’, o addirittura (alludendo all’arte della vita), di organizzarci, e presumiamo sempre (e a volte esplicitamente) che è proprio questo che serve se vogliamo ‘fare’».
Sebbene il riferimento non sia così esplicito nell’Enciclica di Papa Francesco, credo sia infine questo il principio cui Egli fa riferimento nelle sue numerose ‘omelie’ pubbliche, in cui non si esime dal riconoscersi dentro una stessa realtà ‘liquido –moderna’ in cui la ‘grazia’ è inseparabile dalla vita comune e comunitaria, sebbene l’amore (per quanto grande) non promette il raggiungimento della felicità ma ne riscatta il senso. “La felicità – per richiamare la diagnosi di Kant – non è un ideale della ragione, ma dell’immaginazione. (..) Così come l’amore (in Cristo) è qualcosa che richiede di essere ‘creato’ e ricreato ogni giorno, ogni ora; che ha bisogno di essere costantemente risuscitato e riaffermato e richiede le dovute attenzioni e cure.
In linea con la crescente fragilità dei legami umani, con l’impopolarità degli impegni a lungo termine, con l’eliminazione dei ‘doveri’ dai ‘diritti’ e l’elusione di ogni obbligo che non sia verso se stessi”, si tende a rifugiarsi nel ‘nichilismo’ soggettivo, in quello ‘scetticismo’ che viola ogni paradigma, per cui l’essere umano ha significato intrinseco di etrne ‘bellezza’. In ciò l’Enciclica ‘Laudato sì’ di Papa Francesco, respinge il pregiudizio che non ha mai abbastanza prove per convincersi della certezza di una realtà che scavalca ogni prevaricazione, ogni abuso di potere, ogni malvessazione, e si leva in assoluta onestà spirituale (integrità morale e civile) al di sopra di ogni altra alternativa. “Non interpreta la propria superiorità come motivo di gloria personale (papale) o di dominio irresponsabile (della Chiesa), ma come una diversa capacità che a sua volta impone una grave responsabilità che deriva dalla sua fede”.
Bibliografia /Letture:
Papa Francesco, “Laudato sì” Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura di Carlo Petrini. San Paolo Edizioni 2015
Mario Pomilio, “Il quinto evangelio” – Rusconi Libri 1975
Zygmunt Bauman, “L’arte della vita” – Laterza Editori 2009
Marcel Mauss, "Saggio sul dono" - Einaudi
K.G.Jung, "Il simbolismo della Messa" - Bollati Boringhieri
Giorgio Mancinelli propone inoltre di leggere i seguenti testi. Cliccando sui link qui sotto è possibile visualizzare il testo / recensione de “Il Libro della Gioia” di Papa Francesco, pubblicato sul sito LaRecherche.it:
http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=393&Tabella=Saggio http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=397&Tabella=Saggio
*
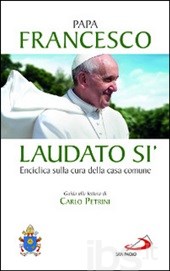 - Religione
- Religione
PAPA FRANCESCO: Enciclica ‘Laudato sì,’
Salutiamo con ritrovato fervore ‘eucaristico’ la nuova Enciclica di Papa Francesco sia che ci professiamo cattolici o laicali, in ragione della rinnovata ‘mensa cristiana’ cui per la prima volta siamo tutti invitati. Ciò dico perché a differenza dei vari ‘congressi’ di approfondimento e riflessione cui la Chiesa ha svolto decidendo ‘ad imprimatur’ per tutti quanti noi, questa volta cristiani e non siamo chiamati ad entrare nella ‘casa comune’ che Papa Francesco, come già il suo predecessore e ispiratore (Francesco d’Assisi), sta cercando di erigere ‘mattone su mattone’ per dare slancio innovativo alla comunità cattolica. Non già recupero dell’antica fede, la quale resta comunque a fondamento dell’ampia costruzione cattolico-cristiana, quanto invece, propria del ‘riconoscimento’ nei termini dell’epistemologia evoluzionistica, cioè nel tentativo di affrontare le questioni da un punto di vista evolutivo della fede al passo coi tempi.
“Laudato sì, mì Signore …” cantava San Francesco d’Assisi nel richiamare l’attenzione dei confratelli in povertà ch’era del Cristo e dei suoi discepoli; fatto questo che Papa Francesco va ripetendo, seppure con parole diverse, sostenendo di dover prendere le parole di Cristo, riportate nei Vangeli, come “..esempio e non come un precetto”, poi aggiungendo che non se ne può fare una dottrina applicabile alla Chiesa d’oggi, poiché “..il Cristo non ci ha lasciato delle dottrine da seguire, ma una vita da imitare”, recuperando un dire colloquiale che si rivela efficace parimenti a ciò che è l’idea comune in fatto di religione e che Papa Francesco sembra voler ripristinare in seno alla Chiesa (o almeno ci sta provando). E cioè a quella Chiesa che San Francesco d’Assisi evocava, quella dei primordi, cui dalla morte di Cristo fino al 1200 s’ispirava.
Del resto la bella frase rispresa (forse) da un apocrifo e molto discussa in seno alla Chiesa imperante d’allora: “..sappiate che la nostra non è una religione, ma un servizio” che, sebbene non presuma, no, ch’essa si trovi nei Vangeli, pure è come se vi fosse. O almeno che si vorrebbe vi fosse, perché è qui ed oggi che essa troverebbe la sua massima applicazione, proprio quando tutto attorno: costituzioni, leggi, summit, congregazioni, conferenze episcopali ecc. assumono un aspetto anacronistico, se solo si tiene conto delle problematiche (un tempo sconosciute ma prevedibili) cui la società odierna e la stessa Chiesa (se fosse stata al passo coi tempi), avessero acuito quella lungimiranza che “a dispetto dei santi” ha portato i popoli all’accolturazione e “grazie a Dio” a riconoscere ciò che è ‘giusto’ e ‘ legittimo’ nel diritto alla sopravvivenza (ambiente, popoli, razze animali ecc.) questa ‘sì corporea e ancor più spirituale’ ch’è prioritaria all’essere umano ma, e soprattutto, attinente alla salvaguardia del “creato” in quanto “bene comune” da tutto ciò che è riconosciuto come distruttivo in modo estremo: dalle guerre nucleari alle conflagrazioni batteriologiche.
«La nozione di ‘bene comune’ coinvolge anche (e soprattutto) le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disxconoscimento di un destino (?) comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale (leggi spartizioni, appropriazioni indebite, muri divisionali, confini ecc.).
Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di una questione di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno.»
Nulla da eccepire, ma non è certo per caso che ciò che oggi avviene in fatto di vigilanza, protezione, tutela, difesa del patrimonio ambientale naturalistico rivolto allo studio delle ecologie rinnovabili, in quanto materia di dibattito continuo in seno agli stati, non si riesca di trovare un accordo su nulla o quasi, o che si cerchino soluzioni in percentuale su ‘quanto’ e su ‘come’ ridurre gli effetti nocivi sul suolo, nell’aria, nell’acqua, quando dovrebbe essere pacifica una risoluzione che vieti il costante disfacimento di tutto questo. Sì, ben vengano l’Expo di Milano 2015 a sottolineare che la fame nel mondo si può combattere riducendo gli esuberi e riciclando gli sprechi degli alimenti; o riprendendo le disposizioni FAO e dell’ONU sugli aiuti alle popolazioni in difficoltà; la risoluzioni di RIO, di Roma, di Tokyo ecc. ma se ad essi non seguono fatti ‘concreti’ staremo qui a parlarne fino alla fine dei giorni di vita del pianeta: quanti? Per adesso non è ancora esploso, ma la strada da percorrere, a detta degli scienziati che studiano certi fenomeni, non siamo poi così lontani.
Sì, ben venga una ‘Enciclica’ come questa che nell’ ‘intendimento’ papale funge non come messaggio quanto come ‘richiamo’ «..a ristabilire un rapporto che si è interrotto forse anche a causa di alcune prevedenti intrepretazioni della dottrina. Credere che l’uomo debba dominare la natura, e disporne a suo piacimento, non deve indurre a pensare che questo atteggiamento consenta ogni tipo di scempio.» Tuttavia va qui ricordato (al Papa in primis e alla Conferenza Episcopale della Fede poi) che il riconoscere una casuale non assecondata da una necessaria rettitudine di comportamenti, ha come effetto una caduta dell’insegnamento che si vuole infondere. Non è nell’ imprimatur papale discernere ciò ch’è giusto da quanto viene taciuto ciò che può anche essere sbagliato?
Se non fosse perché Papa Francesco ispira una certa religiosa fiducia e il suo impegno a ‘cambiare certe cose’ è sotto gli occhi di tutti, penseremmo che da ‘bravo gesuita’ che ha individuato (non sottovalutato) la possibile caduta di credibilità verso la Chiesa e nei suoi ‘imprenditori della fede’ che operano nell’ombra, quasi stenteremmo a credergli ma, poiché infine noi tutti siamo ‘peccatori’ e vogliamo dare pace alla nostra anima, lo assecondiamo e corriamo tutti ad ascoltare (e a leggere) le sue parole con remissione verso quella ‘verità’ di cui sappiamo essere investito e che oggi gli permette di sedere sul soglio pontificio. Ripeto, se non fosse così, per quelle parole che gli sentiamo pronunciare e ripetere all’infinito (necessarie quanto mai perché non siamo più abituati ad ascoltarle), saremmo portati a pensare che l’attività del ‘cenobio vaticano’ per quanto riguarda il libro dell’odierno ‘Catechismo’ in vigore e questa stessa prima ‘Enciclica’ papale, non siano che delle belle ‘favole’ a misura di semplici creduloni (leggi incolti privi di conoscenza e di cultura; ed anche di increduli, ineducati, scettici, empi, miscredenti), quanto basta per una diaspora senza possibilità di ritorno.
Può sembrare casuale ma non ritengo lo sia, che un libro dopo vent’anni che giace nella mia biblioteca si apra all’improvviso, proprio in concomitanza con i fatti sopracitati: si tratta de “Il quinto evangelio” di Mario Pomilio (Rusconi Editore 1975), “un’opera originalissima per tema e per struttura” in cui si narra a posteriori, non senza una accertata ‘storicità’ dei fatti, di ciò che riguarda la sensibilità religiosa di oggi. Incredibile a dirsi ma vi si ritrova una certa affinità fra luoghi comuni (del comune pensare di oggi) con quello che accadeva nel primo medioevo quando la Chiesa divulgava la sua ‘verità’ dagli altari tempestati di ori e gemme preziose mentre la ‘gente comune’ faceva la fame per le strade e moriva di stenti per le malattie. Oggi, a differenza di allora, la fame persevera in gran parte del mondo e la gente mupore lo stesso di stenti, mentre sugli altari si chiede l’impegno comunitario (monetario ed economico) per il sostentamento delle anime, ma non si vuole ‘partecipare’ (vedi il pagamento dell’ICI) come contributo alla debacle sociale di cui, almeno in parte, può dirsi responsabile.
Senza necessariamente lasciarsi guidare nelle scelte e nei dissensi di questo scritto, riporto qui di seguito un passaggio del libro sopracitato che ritengo sia efficace quanto accattivante alla comprensione. Il dialogo si svolge fra l’abate benedettino di Sulmona e il priore degli agostiniani (pag.110): “Sì, certo: voi improvvisate la vostra vita religiosa, noi probabilmente la regoliamo troppo; voi molto vi fidate della naturale bontà, e per il resto fate come chi crede che lo Spirito coi suoi doni, sia sempre in procinto di bussare alla vostra porta. Convinciti però : noi non siamo buoni. Al massimo nasciamo innocenti, o forse pavidi. E se non operassimo a modificare la natura mediante l’assiduità di un’obbedienza e d’una regola, saremmo persi”. Ci sarebbe qualcosa da aggiungere riguardo l’etica trascurata all’epoca e quanto invece di ‘etica’ dice la presente ‘Enciclica’:
«D’altro canto, è preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti (pavidi) difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica (incoerenti), mentre a volte applicano questi medesimi principi (pusillanimi) alla vita umana. (..) Come spesso abbiamo visto, la tecnica separata dall’etica, difficilmente sarà capace di autolimitare il proprio potere. (..) Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo oientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: a che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti (leggi chiamati) in questa vita? Per quale scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi?»
Ma queste non sono forse le domande di sempre, le stesse che si sono poste i nostri predecessori e che continuano a porsi gli studiosi d’ogni epoca? Quali risposte hanno dato gli antropologi, quali i filosofi, gli eremiti e i santi, che non siano già contemplate nei Vangeli? Foss’anche in quelli ‘apocrifi’ che tanto hanno da insegnarci in fatto di ‘umanità’ e, cosa molto trascurata (volutamente) dalla Chiesa, in fatto di ‘comunicazione’? C’è più ‘etica’ in essi di quanta ce ne immaginiamo, in quanto tendenti alla salvaguardia della concettualità mentale delle persone semplici che (fin da sempre) andavano alla ricerca di risposte ‘elementari’ (in quanto era il massimo dell’insegnamento che avevano ricevuto); facili (in quanto comprensibili); chiare (nel senso di manifeste). E la celebrazione della Messa (seppure in latino) era quanto di più ci si aspettava da un Dio celeste che, benché lontano, (con pochi ieratici gesti e talvolta con brevi incomprensibili frasi), rendeva manifesti i limiti di un ‘dramma’ consumatosi in illo-tempore che riscattava all’umanità l’esigenza della ‘sua’ e ‘nostra’ presenza sulla terra. Ponendo, al tempo stesso, il ‘fio’ d’un possibile ‘castigo-ricompensa’ alla sopravvivenza dell’intero creato.«Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra.»
Ma la dignità umana (da sola) a quanto pare non basta, c’è necessità di fare ricorso a un’etica deontologica del vivere che abbracci sì la ‘conoscenza’ di ciò che ci circonda (il creato) ma, anche la ‘sapienza’ di amministrare ciò che ci è dato (l’intelletto). Allorché l’impegno civile e politico implichi uno stile di «..vivere insieme e di comunione. (..) Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati (e lo siamo tutt’ora) nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà; è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra (scontenta) superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione (decostruzione?) di ogni fondamento della vita sociale (comunitaria), finisce col metterci gli uni contro gli altri nella difesa dei singoli interessi, provocando il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà che impedisce lo sviluppo di una vera (autentica) cura dell’ambiente.»
«Questo vuol dire che coltivare un’identità (un’etica) comune, (..) ci si prende cura del mondo e della qualità della vita in senso di solidarietà e allo stesso tempo di consapevolezza di abitare una ‘casa comune’ che Dio ci ha affidato (..) che vive tra noi e in ciò che ci circonda.» Questo il messaggio complessivo di questa prima Enciclica il cui scopo è indicarci la retta via «..per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, quale intensa ed estrema esperienza spirituale». Allora sì, ‘cè ancora un ‘mistero’ che possiamo contemplare, quello stesso che già San Francesco ci ha indicato e che l’odierno Papa Francesco slla sua scia va ribadendo: “..la necessità di non separare le creature del mondo dall’esperienza di Dio nell’interiorità”.«Quindi c’è un mistero racchiuso in una (ogni) foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L’ideale non è solo passare dall’esteriorità all’interiorità (di noi stessi) per scoprire l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose e nelle altre creature.»
Una Enciclica dunque che non è solo un messaggio, ma che avvicinandosi più d’ogni altra cosa scritta alla preghiera orale si fa portatrice di pace e di serenità in questo mondo attuale dilaniato da mille contrasti. Ma che è e vuole anche essere un invito rivolto “a tutti gli uomini e donne di buona volontà” affinché ci si adoperi per un mondo migliore.
Citazioni tratte da:
Papa Francesco, “Laudato sì” Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura di Carlo Petrini. San Paolo Edizioni 2015
Mario Pomilio, “Il quinto evangelio” – Rusconi Libri 1975
(continua)
Giorgio Mancinelli propone inoltre di leggere il saggio/recensione de “Il Libro della Gioia” di Papa Francesco, pubblicato sul sito LaRecherche.it seguendo i seguenti link qui sotto riportati:
http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=393&Tabella=Saggio
http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=397&Tabella=Saggio
*
 - Cinema
- Cinema
’LA SCATOLA DEI SOGNI’ – parte seconda
DAL ‘WEST END’ LONDINESE A ‘BROADWAY’ NEWYORKESE SULLA SCENA DEL GRANDE MUSICAL.
Sebbene il ‘successo’ altro non sia che un effimero legato alla genialità di pochi individui capaci di mettere a frutto la propria creatività ed il personale impegno, allora quel ‘pizzico di follia’ che talvolta ci coglie, va necessariamente attribuito a quel che pure alimenta la nostra gioia di vivere e che ci concede quell’affermazione che, in un campo o in un altro, abbiamo fortemente desiderato o, quantomeno, elargendoci un dono inaspettato della cieca fortuna. Che ben venga dunque parlare di ‘successo’ come di un’emozione procurata da un sentimento come l’amore per ciò che si fa. Allora l’amore che cos’è? Null’altro che la moneta di scambio che permette a ognuno di “poter fermare la pioggia o di cambiare il flusso della marea”, o forse nulla di tutto questo e, al tempo stesso, la migliore dimensione possibile di noi medesimi, la cui ricerca è di per sé già un clamoroso ‘successo’.
È in questa dimensione, allo stesso modo anticonformista e rivoluzionaria di qualsiasi schema si voglia qui attribuirgli, che vedremo orientarsi le attuali produzioni teatrali dal West End londinese ai palcoscenici della newyorkese Broadway, qui volutamente non distinguibili l’una dall’altra. Bensì accomunate dalla stessa grande qualità organizzativa, produttiva e registica che vede inoltre un numero esorbitante di maestranze altamente qualificate, tra cui sceneggiatori, musicisti, coreografi, scenografi, tecnici di scena, maestri di trucco e parrucco, in alcuni casi prestati dal cinema e viceversa, che hanno raggiunto fama internazionale. Una gara interessante dunque tra due centri di produzione dello show-business (buz) che hanno fatto del Musical un ‘mestiere’ qualificato e qualificante di dimensioni stratosferiche, che ogni anno offre lavoro a migliaia di nuovi e giovani talenti, fra attori, ballerini,secondi e terzi ruoli, tutti animati dal desiderio di raggiungere quel ‘successo’ sul quale hanno ampiamente fantasticato.
Tuttavia, credetemi, non è affatto una coincidenza se, per così dire ‘a fare il teatro’ siano invece loro, i grandi finanziatori, magnati del dollaro e della sterlina che, investendo su questo o su quello ‘spettacolo’ in un gioco vorticoso di interessi, decretano il ‘successo’ di certe mega-produzioni, contrassegnate fin dall’inizio, dalla ricerca affannosa di nuovi e capaci talenti, le maestranze migliori, i nomi più prestigiosi fra compositori e arrangiatori musicali, produttori e registi, art-director e casting-review, scenografi e sceneggiatori, tecnici e architetti delle luci, visagisti e parrucchieri che operano nell’ombra dello show-business e che curano l’intera produzione della ‘grande macchina’ del Musical.
Per quanto il ‘successo’ non sia poi sempre così scontato, molto dipende dal divertimento offerto al pubblico, dagli attori più o meno bravi che vi prendono parte, dal nome del coreografo che cura i numeri di ballo, dal maestro concertista e dal direttore d’orchestra. Ciò nonostante va detto che una siffatta forma di spettacolo non scaturisce dal nulla. È infatti noto che la forma più composita ed eterogenea del Musical ha nel tempo adattato alle proprie necessità produttive, le bizzarrie delle mode che, a loro volta, si sono susseguite nelle società industrializzate e meccanizzate. Utilizzando a sua volta la letteratura popolare e quella aulica, la musica classica e quella tradizionale, l’operetta a lieto fine e la ‘light-opera’. Giungendo fino a scandagliare nelle pagine del jazz fino al rock e oltre, con la pretesa che tutto quanto fa spettacolo potesse entrare a far parte dello show-business sempre alla ricerca affannosa del ‘successo per il successo’.
E che successo!, se solo si pensa ai costi e ai ricavi che comunque consta di milioni di dollari di investimento. Il Musical quindi come quint’essenza di una vita attiva che, in ognuna delle due città citate, contrassegna un costante fermento di idee, di maestranze, di corpi e di volti in cui l’illusione dorata di entrare in una ‘scatola dei sogni’ che si apre al mondo finisce per essere realizzata in pieno. E non senza quel ‘pizzico di follia’ che per la durata di due ore o poco più, trova la sua più grande affermazione nel meraviglioso ‘abbraccio’ con la gente, giovani e vecchi d’ogni età.
Scenografie sfarzose dai colori squillanti, giochi di luci sfavillanti, musiche e canzoni accattivanti che fanno a gara con l’eleganza della moda e le qualità interpretative di attori/attrici di un certo richiamo, sono la cornice edulcorata di quel ‘successo’ che da sempre arride a uno stuolo di musicisti virtuosi, presentatori, showman e showgirl, cantanti e ballerini, circensi e donne favolose che ogni sera attendono l’applauso del pubblico. È così che il West End nel cuore di Londra e la favolosa Broadway a New York aprono il sipario dello ‘show-business’, con le sue scenografie da favola, le coreografie scintillanti, le musiche effervescenti, le scritte luminose multicolori che si rincorrono sui cartelloni pubblicitari, il carosello dei taxi che scaricano il folto pubblico davanti alle entrate dei teatri per assistere al più grande spettacolo di sempre, il più sensazionale degli spettacoli, il così detto ‘Musical!’.
Cambiano i tempi e i luoghi, i costumi e le mode, i personaggi, le musiche e i ritmi che di volta in volta accompagnano le emozioni e le passioni umane; ora trasformati in canzoni di successo, in numeri coreografici di particolare pregio; ora in esibizioni di un qualche virtuosismo strumentale che hanno il solo scopo di sottolineare, esaltandoli, quelli che sono i momenti ‘clou’ di ogni rappresentazione. Nonché dare forma a quei leit-motiv dai risvolti sentimentali, per questo straordinari, che insieme compongono l’anima del Musical.
È qui che si rappresentano i ‘drammi’ e le ‘favole belle’ del tempo, con gli amori, gli affetti, le passioni, le pulsioni sessuali in cui si disciolgono i sentimenti, con il fine ultimo dello svago, dell’intrattenimento, dello ‘spettacolo per lo spettacolo’, onde per cui citare solo alcuni e trascurarne altri può sembrare anacronistico, come pure non è opportuno tirare in ballo statistiche di alcun genere. Purtroppo una scelta andava comunque fatta, se non altro per un problema di ‘pagine’ possibili da occupare ma a un’arida elencazione ho preferito citare solo alcuni titoli rappresentativi di altrettanti Musical di successo.
Qualcuno di voi lettori si starà chiedendo se per il piacere di un romantico revival o semplicemente per senile nostalgia? Nulla di tutto ciò. Immagino basterà qui ricordare alcune delle musiche e delle canzoni famose che di volta in volta hanno fatto il giro del mondo per rendervi conto del ‘successo’ che il Musical (vero e proprio) ormai da qualche anno sta ottenendo anche in Italia. Successo che è mia intenzione argomentare in altro luogo da questo, con articoli mirati sulla ‘Rivista’ e sullo spettacolo musicale più in generale che anche da noi si compone di tanti nomi prestigiosi, una lista traboccante di stelle, più brillanti di quelle del firmamento che s’accendono ogni sera sui palcoscenici del mondo.
Fra i numerosi musical andati in scena nel West End londinese dall’inizio del ‘900, solo pochissimi sono quelli ripresi all’epoca dal cinematografo nascente e sopravvissuti alla dimenticanza del tempo. Tra questi va qui citato l’ormai celeberrimo “No, no Nanette” (1925) il musical di Youmans - Harbac - Caesar che segnò il passaggio dall’Operetta propriamente detta al Musical, il cui successo mi permette qui di ripercorrere alcune importanti tappe della sua storia. “Tea for two”, (“Tè per due”) è indubbiamente il brano più conosciuto, ma non il solo. Molte altre sono però le canzoni rimaste di quegli spettacoli che pure hanno conservata intatta tutta la verve e la freschezza che le animava, nonché lo charm del tempo, e forse per qualcuno anche una certa superficialità che nell’allegrezza generale alludeva a una qualche forma di felicità.
Sempre da “No, no Nanette” ricordiamo “I want to be happy with you” la cui interpretazione di (Irving Caesar e Otto Harbach) rimarrà per sempre nella storia del ‘grande’ Musical di quei tempi, ahimè assai lontani. Ma nulla è lecito rimpiangere se lasciamo libera la fantasia e, facendo un passo indietro, apriamo le orecchie all’ascolto di “Alice Blue Gown” tratta da “Irene” (1919), una felice commedia brillante di Joseph McCarthy e musiche di Harry Tierney, cantata da Edith Day interprete della ‘prima’ messa in scena. O di quel “La canzone del deserto” (1926) dal musical omonimo di Otto Harbac e Oscar Hammerstein sulla musica di Sigmund Romberg.
Né deve meravigliare se nello stesso anno “Show Boat” (1927) un ‘kolossal’ del Musical americano andato in scema a Broadway sbarca nel West End sulle rive del Tamigi e ottiene uno successo strepitoso da mandare in visibilio critici e pubblico per il suo allestimento scenografico e coreutico, con le straordinarie musiche di Kern e le canzoni di Hammerstein II°, basato sul romanzo di Edna Feber. Così il critico Alfred Swan si espresse dopo la prima: “Il musical presenta personaggi assolutamente credibili e appassionanti in una vicenda seria e commovente, ambientata in luoghi pittoreschi, e tutto trova nell’andamento e nei versi e della musica una risonanza melodica perfetta”.
“Old man river” è solo una delle canzoni che va qui ricordata per la sublime interpretazione di Paul Robeson. La ‘storia’ (in breve) narra di un giocatore d’azzardo che unitosi a una compagnia teatrale in viaggio su un battello in navigazione lungo il Mississippi, s’innamora della primadonna e dopo alcune peripezie, infine la sposa, dando così una svolta onorevole alla sua vita. Ripreso una prima volta per il cinema dallo stesso Ziegfeld nel 1929, venne in seguito filmato nel 1951 e diretto da George Sidney per la MGM, con la partecipazione di splendidi attori quali Howard Keel, Kathrin Greyson e Ava Gardner, mentre le coreografie erano dell’ormai già noto Robert Alton.
Innovativo e unico nel suo genere “Pal Joey” (1940) di Rodgers & Hart, con la famosa canzone di successo “Zip”, si pone a capostipite del cambiamento portando in scena aspetti della vita privata di una società decisamente rinnovata, la cui formula stravolge gli schemi tradizionali del Musical. A seguire “South Pacific” (1949) di Rodgers e Hammerstein, da cui la popolare “Bloody Mary”, che ottenne il Premio Pulitzer per la sua componente drammatica. E finalmente “Guys and Dolls” (1950), di Frank Loeser e Joe Scorling che, per la prima volta portò in scena aspetti della malavita newyorchese, vista attraverso l’ottica del reportage di cronaca. Qualcuno immagino ricorderà più facilmente la versione cinematografica titolata “Bulli e Pupe” interpretato da Frank Sinatra, Marlon Brando e l’allora giovane ma già bellissima Jean Simmons.
Ancora di quegli anni sono i ‘capolavori’ del genere musicale legati ad altrettanti successi di critica e di pubblico che hanno riempito le sale dei teatri e quelle dei cinema di tutto il mondo:
“The Carousel Valzer” da “Carousel” (1945) di A. Newman
“Shall we dance” da “The King and I” (1951) di Rodgers e Hammerstein II°.
“Strangers in paradise” da “Kismet” (1953) di Edward Knoblock e musica di André Previn, composta sulle “ Danze Polovesiane” di Borodin.
“The boy friend” (1954) di Sally Wilson improntato sulla scia della ‘nostalgia’.
“I could have a danced all night” dallo strepitoso “My fair Lady” (1956) di Frederick Loewe e Alan Jay Lerner.
“Edelweis” da “The sound of music” (1959) ancora una volta firmato dalla fortunata coppia Rodgers e Hammerstein II° poi divenuto, come tanti altri qui citati, un film di successo dal titolo “Tutti insieme appassionatamente” e con il quale si chiude un’epoca ‘sentimentale’ che pure è considerata ‘d’oro’ del Musical delle origini.
Come è possibile rilevare dalla lista sopra riportata, sono passati alcuni anni e la guerra ha fatto i guasti che tutti conosciamo. Molto si deve alla buona volontà di impresari e registi, attori e attrici, nonché di prestigiosi musicisti (superstiti) che hanno svolto in ambito teatrale, ma anche in ambito cinematografico, un vero e proprio recupero di moltissimo materiale musicale e di allestimenti precedenti con i quali si è riusciti a ricreare la ‘magica’ atmosfera di certe produzioni del passato, capaci ancora di regalarci in modo strabiliante, vuoi nello stile, nel suono, nella ricerca dei costumi, che nelle coreografie, molta della creatività di cui il mondo del Musical era ed è ancora oggi capace.
Così anche il Musical inevitabilmente, si è adeguato alle nuove tendenze, alle artificiosità delle mode, alle tecnologie che avanzano e che hanno permesso al Musical la sua evoluzione. Negli anni ’60 e ’70 il Musical-Show abbandona l’illuministica visione di un mondo di favola per affrontare nuove e inusitate tematiche. Nulla è lasciato al caso, dalla tensione causata dai problemi razziali, alle ostilità di una possibile guerra futura, dallo scandalo procurato dalle prime nudità, alle ‘accuse’ di alcuni accadimenti sociali e di cronaca.
Ai nomi di Herbert, Loewe, Gershwin, Kern, Berlin, Porter, Rodgers, Hart, Coward, Simon tra americani e inglesi dei primordi, si sostituiscono Robert E. Griffith, Harold S. Prince, Leonard Bernstein, Stephen Sondeim, Galt MacDermott, Jerome Ragni, James Rado, Jerome Robbins, Bob Fosse, Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, Stephen Schwartz, Shapiro, Miller e numerosi altri. Ma è con “Fidler on the roof” (1964) di Jerry Bock e Sheldon Harnick con le coreografie di Jerome Robbins che, con le sue 3.442 repliche filate, riesce a battere ogni record d’incassi e, in ragione del quale si apre la nuova grande stagione del Musical moderno.
Tuttavia l’ondata ‘sentimentale’ dei primordi non si arresta e, come è ovvio che accada, la sua eco risale fino agli anni ’60 e i primi anni ’70. Sulla stessa scia per così dire ‘del cuore’ troviamo “Mame” (1966) di Jerry Hermann e Jerome Lawrence in cui si narra di una anziana ‘Zia’ che riesce a portare lo sbandato nipote protagonista della storia, sulla retta via. Per arrivare infine ad “Annie” (1977) da cui la splendida “Tomorrow”, una favola per bambini di Charles Strouse e Martin Charmin che non dispiace affatto ai grandi che gli decretano un discreto successo, ripetuto negli anni a seguire come ‘classico’ da riproporre nel periodo natalizio.
Ma come sappiamo i periodi storici si intersecano. La stessa ‘modernità’ non arriva da una fonte che sgorga improvvisa. Prima accade o è sempre accaduto qualcosa e il genio si sprigiona all’interno della società in cui vive e della quale riesce a trovare la sintesi, quando finanche arrivi a confutarne l’essenza. È il caso strabiliante di “West Side Story” (1957) di Robert E. Griffith e Harold S. Prince, con le musiche del grande compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, le canzoni di Stephen Sondheim e le coreografie dell’allora coreografo di successo Jerome Robbins.
La storia è un rifacimento della tragedia di William Shakespeare ‘Romeo e Giulietta’. Il tema tragico, la musica sofisticata e le istanze sociali rappresentate, segnarono il linguaggio musicale del teatro anglofono che in precedenza si era dedicato, tranne rare eccezioni, a temi più leggeri. Il conflitto tra bande rivali fa da sfondo a questi ‘Romeo e Giulietta’ in panni moderni, trasferito per l’occasione nella periferia di New York. La vicenda acquisisce veridicità soprattutto per l’ambientazione scenografica e le magistrali coreografie di Robbins, focalizzate nell’ambiente che circonda i protagonisti, tuttavia senza sacrificare la drammaticità del testo. Il finale della vittoria da parte della banda dei ‘leali’ sulla banda ‘scorretta’ e per questo nemica è scontato, ma ciò che rimane è in fondo lo specchio di una società che sta cambiando, della quale si avvertono i sintomi di una ribellione che non avrà più fine.
Le musiche, scritte da Bernstein, rappresentano un ‘cult’ della scena musicale mondiale. Tra le canzoni si ricordano "Something's Coming", "Maria", "America", "Somewhere", "Tonight", "Gee, Officer Krupke", "I Feel Pretty", "One Hand, One Heart" e "Cool". Nel 1961 la United Artists ne realizzò una versione cinematografica per la regia di Jerome Robbins e Robert Wise che debuttò nelle sale il 18 Ottobre. Il film vinse dieci Academy Awards cinematografici, tra i quali quello per il miglior film. Mai un film musicale aveva ricevuto così tanti riconoscimenti. Nel 1981 va in scena allo Sferisterio di Macerata per la coreografia dello stesso Robbins con Josie de Guzman, Ken Marshall, Debbie Allen, Sammy Smith, Jake Turner ed Arch Johnson per il Broadway theatre. Nel 1984 Bernstein decise di ri-registrare il musical, dirigendo una sua composizione in prima persona per la prima volta. Nota come una "versione operistica" di West Side Story, vide la partecipazione di Kiri Te Kanawa nel ruolo di Maria, José Carreras in quello di Tony, Tatiana Troyanos come Anita, Kurt Ollman come Riff mentre Marilyn Horne canta "Somewhere" nel ruolo di un personaggio secondario ("Anybody"). Questa versione ha vinto un Grammy Award nel 1985.
Prima ancora che qualcuno si ponga la domanda sulla possibilità di una ‘moralità’ latente, esplode “Hair” (1968) di Rado, Ragni, MacDermot. La data è quella della contestazione giovanile che subitanea trova sbocco nel mondo contemporaneo con la forza rivoluzionaria e tuttavia innovatrice della protesta giovanile. Ma “Hair” non è semplicemente un Musical di successo che porta in scena gli enzimi rivoltosi di una gestione dell’opinione pubblica che rimette in discussione le scelte politiche della democrazia nel mondo, “Hair” scuote la gioventù di allora fino alle fondamenta verso nuove e inusitate esperienze, fino a diventare, successivamente, il manifesto della ‘new-generation’ nel riscatto della propria libertà d’espressione.
Il brano “Ain’t got no” segna la rivolta di quanti verranno in seguito appellati come ‘figli dei fiori’ per il loro estroverso e popolare modo di vestire che interrompeva la grigia austerità delle classi sociali ‘superiori’ e della elite economica ai governi dell’epoca. Eppure “Hair”, per quanti hanno avuto modo di vederlo a teatro, (ricordo che esiste una versione cinematografica di grande impatto emozionale), conteneva ed affermava un messaggio di pace e di fraternità universali. Sicuramente in negazione di quella guerra ‘non necessaria’ che il popolo americano era chiamato (non si sa bene da chi) a combattere per risolvere la problematica stabilità della democrazia nel mondo e ristabilire la necessaria pace.
Non spetta a me polemizzare sulla validità di certi stereotipi o di riscrivere la storia, tuttavia “Hair” confermò la sua controtendenza allo ‘status quo’ con almeno due brani di forte impatto musicale: “Acquarius” e “Let’s the sunshine” divenute in breve l’inno dei giovani di tutto il mondo che decretarono negli anni a venire e con successo un’autentica svolta sociale. Il successivo “Godspell” (1971) di Stephen Schwartz e John L. Tabelak, con la suggestiva “Day by day”, non può che confermare l’esito della nuova stagione del Musical, ormai avviato alla ricerca di altri territori incontaminati di esplorazione. Non è un caso che vengano approfonditi aspetti insoliti della religiosità in crisi al momento e la Bibbia e i Vangeli ne fanno in parte le spese in chiave critica, filtrati attraverso le esigenze della musica e le contraddizioni del rock.
Uno stratosferico successo arrise a “Jesus Christ Superstar” (1971) l’opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice che affronta l'ultima settimana della vita di Cristo mescolando diversi episodi ripresi dal Nuovo Testamento prima di morire crocifisso. Gesù vi è rappresentato come una figura che ha molto di umano e poco o nulla di divino e manifesta di fronte alla morte i dubbi e la paura tipicamente umani, mentre Giuda Iscariota, figura cardine della narrazione, diventa il vero protagonista del film, razionale e coerente, non traditore, ma vittima suo malgrado, come il suo maestro, di un disegno del destino più grande di lui. Dal Musical sarà presto tratto un film (1973) con lo stesso titolo che si sposta ‘in esterni’ utilizzando mezzi e tecnologie di ultima generazione e di sorprendenti effetti di ripresa. Oltre alla memorabile “Ouverture” orchestrata da André Previn, e l’accattivante “Superstar” che fa da leit-motiv all’intera opera, vanno ricordate almeno altre due canzoni di sicuro impatto emozionale: “Strange Thing Mystifying” (Qualcosa che non mi convince), e “Everything's Alright” (Va tutto bene), “Hosanna” e l’accorata “I Don't Know How To Love Him” (Non so come amarlo), nonché la strepitosa ‘J. C. Superstar’.
Con “A chorus line” (1975) di Michael Bennet e Edward Kleban su musiche di Marvin Hamlisch, il mondo ‘dietro le quinte’ del Musical vince la sua battaglia sul cinema. Il brano “One” che fa da accompagnamento all’intero spettacolo fornisce qui l’occasione per salutare il folto pubblico del film-musicale senza rancore di sorta, accreditandosi un ulteriore Premio Pulitzer per il ‘dramma’. Altri ne erano stati già assegnati ai Musical: nel 1931 a “Off the I sing”, nel 1949 a “South Pacific”, nel 1959 a “Fiorello” e ancora all’esilarante “How to succed in business without really trying” nel 1961. Indirizzato alle giovani schiere di quanti tra ballerini e cantanti si presentano al ‘casting’ di un teatro ogni qual volta viene annunciato un nuovo spettacolo o la ripresa di uno già consolidato nel tempo. “Lascia ch’io balli per te …”, è infatti la canzone chiave che i ragazzi del ‘coro’ cantano al loro debutto sul palcoscenico di “A chorus line”.
Per quanto il suo copione affronti temi ripresi dalla realtà, lo spettacolo entra di forza nelle aspettative e nei desideri di quelle giovani generazioni che hanno formalizzato il cambiamento sociale e culturale della scena teatrale e musicale degli anni a venire. Numerose sono anche le novità in sede scenografica che risulta svuotata per lasciare spazio alle persone fisiche assurte al ruolo soggettivo/oggettivo dei personaggi dello spettacolo che stanno realizzando. Diverso risulta infatti l’approccio psicologico improntato sulla messa in scena del loro dialogare sulle rispettive esigenze e proprie aspirazioni a confronto con le disillusioni che lo show-business non risparmia loro e che, spesso, sfociano in amarezza e abbandono.
Ma cos’è “A Chorus Line”? È la cosiddetta “linea del coro” invisibile all’occhio dello spettatore in cui si pone frontalmente sulla scena la schiera dei ballerini. Entrarvi a far parte è il primo passo verso la carriera, il raggiungimento agognato dai molti del ‘successo’, che potrebbe segnare per ognuno una svolta nel lavoro e nella vita. Come ha scritto E. Kleban autore delle canzoni – “In ‘A Chorus Line’ ho voluto dare alle parole uno spazio misurato all’interno del testo e della costruzione musicale senza badare al fine ultimo dell’intrattenimento. Tale che a volte è difficile stabilire dove un motivo ha inizio o termina l’altro, da “I hope I get it”, “At the Ballet”, “Nothing”, e la bellissima “What I did for love”, nonché la ‘parade’ di “One” e “Let me dance for you”, appunto “Lascia ch’io balli per te..”.
“Fin dall’inizio di questa produzione – ha detto M. Hamlish – in occasione di una intervista, ho capito che la musica doveva essere in parte caratterizzata sugli interventi dei singoli attori-ballerini, che avrebbe dovuto sottolineare le loro diverse aspirazioni e, al tempo stesso, catturare il momento ‘clou’ dell’insieme del ballo finale. È quanto ho cercato di fare con la musica usando una tecnica di lavoro diversa da quella che più spesso mi sono trovato ad usare ad esempio per la colonna sonora di un film. C’è molta più musica in uno show che in una pellicola. La musica occupa qui un posto preponderante insieme alla coreografia e in nessun caso si distacca da questa.”
Il 1978 è l’anno di “Evita” portato in scena ancora una volta dalla coppia Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. La storia è un esempio, forse il primo in assoluto, di Musical anticonformista sulla vita reale di un personaggio famoso salito alla ribalta delle cronache mondiali: Evita Duarte Perón, moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón. Successivamente trasferito in film con il titolo di “Evita” (1996) diretto da Alan Parker, con Antonio Banderas e Madonna, non verrà accolto con la stessa emozionale infatuazione che molto toglie alla bellezza e alla forza scenica che aveva contraddistinto l’opera teatrale. Tuttavia lo spettacolo è assicurato, vi sono momenti in cui la scena è invasa di una tale potenza emotiva da fondersi tutt’uno con gli spettatori partecipi della platea.
Tra le canzoni più famose “Don't Cry for Me, Argentina” (Non piangere per me, Argentina) cantata da Evita dal balcone della Casa Rosada il giorno della proclamazione dell'elezione a presidente (17 ottobre del 1945) del marito, e rivolta al suo paese e alla sua gente è senza dubbio uno dei brani più acclamati che si ricordino nella storia del Musical. “Oh What a Circus” e “High Flying Adored”, nelle quali il famoso Che racconta con toni caustici la carriera di Eva; “Santa Evita”, “Another Suitcase in Another Hall”, “On This Night Of a Thousand Stars”, allo stesso modo offrono momenti musicali e coreutici di una ‘bellezza’ straordinaria mentre accompagnano l’apparire in scena di Evita in mezzo alla folla dei ‘descamiciados’ e, ancora, quando si affaccia al balcone della Casa Rosada per placare la folla preoccupata per la sua prossima fine.
Ma se finora ho volutamente trascurato il rapporto che da sempre lega il musical-show con il film musicale cinematografico e viceversa, e sebbene l’interesse e il successo che il pubblico riserva a entrambe le espressioni siano fonti inesauribili di grande portata culturale che economica, va qui detto che il Musical ha acquisito nel tempo una propria identità strutturale che va riconosciuta di altissimo livello. Vuoi linguistica che musicale, vuoi coreutica che scenografica spettacolari, che oggi non possiamo fare a meno di denominare come ‘autentica forma artistica’ a sé stante, in quanto arte di ‘vero e proprio’ intrattenimento spettacolare, e per questo straordinariamente impegnativa per chiunque voglia trovarvi accesso, che non trascura nessun aspetto produttivo.
Altri Musical oltre a quelli citati che sono ancora in scena frequentemente nei teatri di West End e Broadway dalla loro ‘prima’ apparizione con qualche saltuaria interruzione sono: “Mame” (1966) – “Sweet Charity” (1966) – “Cabaret” (1966) – “Joseph and the amazing Technicolor dreamcoat” (1968) – “Rocky Horror Show” (1973) – “Lenny” (1974) – “Chicago” (1975) – “All that Jazz” (film 1979) – “Cats” (1981) – “Little Shop of Horrors” (1982) – “Starlight Express” (1984) – “Les Miserables” (1985) – “The Phantom of the Opera” (1986).
C’è però un altro filone spesso trascurato di cui necessita parlare che è quello afro-americano del ‘Gospel’, del ‘Blues’ e del ‘Jazz’ che si apre con “Cabin in the Sky” (1940) di Vincente Minnelli e Busby Berkeley, musicato da Harold Arlen. Successivamente, in un periodo in cui molto raramente attori afro-americani riuscivano ad avere una parte di una qualche importanza nelle produzioni hollywoodiane, la MGM produsse un importante film con un cast tutto di neri. “Stormy Weather” (1943) dal titolo di una canzone omonima del 1933. Il film diretto da Andrew L. Stone raccoglie una ventina di numeri musicali con la bellissima “Stormy Weather” cantata da Hethel Merman e ‘Aint Misbehavin’ cavallo di battaglia di Fats Waller.
Ma è con il già citato “Porgy and Bess” (1959) di G. Gershwin (vedi la ‘prima parte’ apparsa su ‘LaRivista n.1’ e l’articolo dedicato a questo autore in larecherche.it), che a partire dall’Opera lirica e quindi dalla successiva pellicola cinematografica che si spalancheranno le porte a tutta una serie di spettacoli teatrali e film-musicali interpretati da afro-americani per lo più improntati sulla vita di personaggi autentici della scena del Blues e del Jazz. Successivo è un altro film che prende il titolo da una canzone di successo: “Lady sings the blues” (1972) diretto da Sidney J. Furie, un film sulla drammatica esistenza della cantante ‘blues’ per eccellenza, la straordinaria Billie Holiday, interpretato inoltre che da Diana Ross, da Billy Dee Williams e Richard Pryor.
“Sophisticated Ladies” (1981) titolo ripreso da una canzone famosa, diventa un Musical-Show di tutto rispetto. Andato in scena a Broadway al Lunt-Fontanne Theatre aprì nel mese di Marzo dello stesso anno e si chiuse nel Gennaio del 1983, dopo ben 767 performance. Il Musical concepito da Donald McKayle fu diretto da Michael Smuin, con le coreografie di McKayle, Smuin, Henry LeTang, Bruce Heath e Mercedes Ellington. Scenografie di Tony Walton, costumi disegnati da Willa Kim e le luci di scena di Jennifer Tipton. Nel cast figuravano: Gregory Hines, Judith Jamison, Phyllis Hyman, Hinton Battle, Gregg Burge, and Mercer Ellington. La ‘colonna sonora’ includeva: "Mood Indigo," "Take the "A" Train", "I'm Beginning to See the Light", "Hit Me With a Hot Note and Watch Me Bounce", "Perdido", "It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)", "I Let a Song Go Out of My Heart", "Old Man Blues", "In a Sentimental Mood", "Sophisticated Lady", "Don't Get Around Much Anymore", "Satin Doll", and "I Got It Bad and That Ain't Good", che rappresentano il ‘meglio’ della produzione artistic di Duke Ellington.
In quanto brano strumentale “Sophisticated Lady” non è solo uno standard jazz, composto nel lontano 1932 da Duke Ellington; il testo fu aggiunto in seguito da Irving Mills e Mitchell Parish, è il ‘pezzo’ che in qualche modo segna la storia del Jazz, per essere stato suonato e cantato dai più grandi interpreti che si conoscono, da Billie Holiday ad Ella Fitzgerald a Frank Sinatra e un’infinità di altri. Ellington stesso ebbe a dichiarare che il testo era "meraviglioso ma non del tutto aderente alla mia idea originale." Si tratta di uno dei brani più famosi ed eseguiti di Ellington. Registrata per la prima volta su vinile nel 1933 con a-soli di Toby Hardwick (sax contralto), Barney Bigard (clarinetto), Lawrence Brown (trombone), e lo stesso Ellington al pianoforte, “Sophisticated Lady” entrò in classifica il 25 maggio e vi rimase 16 settimane, arrivando alla terza posizione, cosa questa che segnò un record per quei tempi.
Hardwick e Brown dichiararono in seguito di avere contribuito alla composizione della melodia, una rivendicazione che molti biografi hanno giudicato credibile. Nessuno dei due però fu mai accreditato come coautore e di conseguenza nessuno dei due ricevette royalties. Nel 1944, il regista Otto Preminger avrebbe voluto "Sophisticated Lady” come tema conduttore del suo film “Laura” (in italiano “Vertigine”), ma il direttore musicale Raksin, pensava che non fosse adatta e scrisse un tema alternativo, che sarebbe anch'esso diventato un successo e un famosissimo standard. Nel 1956 Rosemary Clooney ne registrò una sua versione per così dire ‘sofisticata’ con lo stesso Ellington, entrata poi nell'album “Blue Rose”.
In un suo articolo per il Time di New York, Frank Rich scrisse, che "..la pulsione musicale e nuova al Lunt-Fontanne, è una celebrazione di Ellington che non finirà finché ha presa sul pubblico con la sua capacità dinamica. Non è un divertimento perfetto - salviamo per più tardi i difetti - ma sostiene con abilità la resa del pubblico e, chiaramente, la musica ne approfitta, fino a viziare il divertimento. Quello che c’è di più di altri musical è che opera su una scala veramente grande.”
“Round Midnight” (1986) è un film diretto da Bertrand Tavernier ispirato alla vita dei jazzisti Lester Young e Bud Powell ed ha come unico protagonista la musica jazz. Il film a suo tempo vinse un discreto numero di premi, tra cui l'Oscar alla migliore colonna sonora nell'edizione del 1987, grazie anche all’ottimo lavoro di Herbie Hancock. Il film ebbe un discreto successo per lo più tra gli addetti ai lavori. Comunque vi si ascolta della buona musica. Il successivo “Dreamgirls” (1981) è il celebre musical di Michael Bennett insieme produttore, regista e coreografo, all’epoca uno dei più acclamati ma anche il più giovane sulla scena artistica statunitense. Vi si narra la storia della frenetica corsa verso il successo delle Dreamettes, un trio di cantanti afroamericane, ispirate alle vere Supremes, gruppo che vedeva come voce solista Diana Ross, che decretarono il trionfo della ‘black music’ nel panorama USA degli anni ‘60/’70.
Considerato dalla critica il ‘miglior musical show’, vinse ben sei Tony Awards per la sua originalità nel pur vasto panorama della scena teatrale di quell’anno. Andato in scena prima a Broadway si pose subito all’attenzione internazionale per la capacità di penetrazione sul pubblico più giovane. L’accattivante musica di Henry Krieger creata su testi di Tom Eyen scalò le vette delle classifiche internazionali. Si può ben dire che in “Dreamgirls” ogni ‘momento’ era già creato con il preciso scopo di farne un successo. Tant’è che appena in scena si pensò subito di farne un film. Quando si dice la forza dello show-business! Tuttavia il film arriverà parecchi anni dopo per la regia di Bill Condon: “Dreamgirls” (2009) ma i tempi erano ormai cambiati, la musica era cambiata, e il successo non arrise allo stesso modo come per il Musical del 1981. Comunque resta il fatto acclarato che “Dreamgirls” continua a mietere successi e ricevere premi a non finire anche a distanza di molti anni dalla sua andata in scena.
Sulla stessa linea di fuoco si muove l’altro prestigioso coreografo Bob Fosse facendo un passo oltre il più giovane collega, cioè più in là dell’aspirazione al successo per tuffarsi, non senza amare considerazioni nella professionalità raggiunta. Due capitoli diversi, dunque, della storia del Musical moderno che si fondono all’insegna del rinnovamento della scena teatrale-musicale internazionale. Ma se “Dreamgirls” di Bennett rappresenta il ‘sogno’ insperato di alcune ragazze che vedono nel ‘successo’ la sospirata realizzazione nella vita, “All that Jazz” di Fosse, ne è la sua conclusione amara. E poiché nel Musical “..nulla avviene per un semplice giro di fortuna – dice Bennett sembrando che ha ben appreso la lezione di Fosse – occorre impegno nella professione che si svolge, impegno che significa sacrificio, a volte sofferenza, privazione, e il successo se vi sarà, è quanto meno frutto di quello show business che produce stelle dal buio e trae oro dalla plastica”.
Comprensibile se non altro, per il fatto che il ‘pubblico’ vero e unico signore (perché pagante) continua ad avere voglia di ‘divertimento’ superando i problemi e le crisi economiche, le beghe politiche, la noia e l’ozio dei periodi peggiori, e s’accalca entusiasta ad acclamare gli spettacoli che più di altri offrono della buona musica. Un successo questo del Musical che sembra non avere mai fine, al quale la critica ha messo la sua bella targhetta: “Show business it’s just a show business”. Si può essere d’accordo oppure no, tutto sempre dipende da ciò che si vuole diventare nella vita, dal traguardo che ci si pone davanti, e qualche volta bisogna anche saper rinunciare. Come dire che tutto e tutti hanno la possibilità di entrare nel Musical in un modo o nell’altro: come autore, cantante, coreografo o ballerino di fila, l’importante è volerlo …
In fondo “That’s All Musical!”
Nota d’autore: altri Musical importanti qui trascurati saranno trattati direttamente sulle pagine della rivista larecherche.it con articoli singolarmente appropriati durante i mesi successivi all’uscita del n.2 de LaRivista.
*
 - Musica
- Musica
Cantos a Kiterra / La Sardegna – La tradizione in Italia
“… forse perché il tempo qui scorre più lento
ed il vento di novembre ti soffia nelle orecchie
… non so se sono gli odori oppure la luce abbagliante di giugno
oppure quelle strade sempre più lunghe, pare non finiscano mai
ma tutte inesorabilmente ti portano verso lo stesso luogo
… il mare, quel mare da dove arriva la gente di fuori
quel mare che quando parti, ti separa dalle strade, dal tempo, dal vento di quest’isola
… ma tutto questo è già entrato dentro il tuo cuore.”
(Enzo Favata – “Voyage en Sardaigne 1997”)
Un viaggio all’insegna del Jazz, quello offerto da Enzo Favata che s’articola sulle note di molti strumenti tipici (corno da caccia, benas doppie in osso, flauto basso); e più moderni (sax soprano, sopranino e contralto, live electronics) da lui stesso suonati con ineguagliabile maestria e che non stravolgono del tutto i brani originali scelti come fondo ereditario di una tradizione millenaria che si tramanda e si ripete con rinnovato interesse dal popolo che verosimilmente l’ha prodotta. Come pure scrive Roberto Leydi (*) “Va infatti tenuto presente che una serie di processi di stilizzazione hanno trasformato in senso moderno musiche e balli dalle radici etniche più antiche, tanto da rendere ormai inavvertibili, o quasi, l’arcaicità e i caratteri originali. (..) si può qui citare la Sardegna dove il cosiddetto ‘ballo tondo’ si mantiene in relativa integrità e funzionalità anche là dove gli strumenti antichi sono usciti dall’uso, per essere sostiruiti da altri più moderni.” Tuttavia in questo scritto il Jazz è solo il pretesto – non certo per Favata e gli altri che lo hanno seguito o forse preceduto: da Pino Masi a Franco Madau, da Suonofficina ai Tazenda a Paolo Fresu – per tornare a parlare di Sardegna e delle sue tradizioni popolari, lì dove la terra circondata dal mare circoscrive non un’isola ma un continente musicale vero e proprio, con un suo clima ventoso, la sua natura selvaggia, la sua fauna speciale, i suoi odori di sottobosco, la sua gente così diversa e fiera ch’è quasi impossibile trovare al di là dell’orizzonte d’acqua che la circonda.
Acciò, scrive Diego Carpitella: “… la musica sarda si configura nell’ambito del folklore italiano come un microsistema, un universo sonoro ben circoscritto entro cui si dispiegano l’abilità e la fantasia dei cantori e degli strumentisti popolari. (..) Ciò che oggi intendiamo come ‘popolare’ è tutto quello che appartiene a una determinata fascia e zona della nostra cultura (almeno con una deriva linguistica comune) con caratteristiche mentali ed economiche precise: è la zona della comunicazione orale mediante cui pastori, contadini, pescatori, artigiani si tramandavano, o si tramandano, un patrimoinio espressivo: il cosiddetto floklore”, anche se con ciò si sottintende una questione teorica e storica abbastanza complicata. Cioè questi canti, balli, recitazioni, lamenti, ninnenanne, etc.; compresi tra “il miele e le ceneri”, sono ancora funzionali o sono ormai irremidiabilmente memorizzati. Non è stato avviato finora un inventario in tal senso: ma si potrebbe dire che il grado di funzionalità è direttamente proporzionale all’intercambiabilità dell’informatore. (..) In tal senso il diagramma folkloristico italiano è abbastanza discontinuo: in ogni caso la Sardegna è l’unica regione d’Italia in cui esistano cooperative di canto, a livello pastorale, contadino e artigiano. Nell’ambito di questo microsistema si dispiega un fare musica in cui la norma tradizionale è rispettata, la funzione (qualsiasi essa sia, sentimentale, ideologica, magica, etc.) predomina, ed il valore estetico (..) la ‘bellezza’ di taluni documenti – tutti registrati sul campo, secondo i dettami delle ricerche etno-antropologiche – coincide con chi sa intonare a giusto registro, a giusto volume, con chi sa trovare la metrica delle parole più adatta alla ritmica dei suoni, inventando e variando”.
E aggiunge: “Seguendo il criterio dei modi di esecuzione (che fino a quando la tradizione è tradizione sono rigorosamente rispettati), si tratta quindi di impiego di frequente di notemusiche e canti polivocali e polifoniche, liturgiche e processionali. Si tratta quindi, di musiche ad occasione determinata, anche se lo stile della polifonia non si discosta da quella profana, salvo l’impiego più frequente di note tenute. In tal senso la polifonioa sarda è uno degli esempi più interessanti, di sincretismo musicale: infatti il melodizzare modale, di estrazione chiesastica, si è innestato in una tessitura polifonica autoctona, dando luogo a dei risultati unici nel quadro della religiosità popolare italiana. La funzionalità attuale di alcune di queste musiche è riscontrabile soprattutto durante le processioni e i riti della Settimana Santa. Canti ad una o a due voci alterne a quelli accompagnati da strumenti: il setaccio, il tamburello, le launeddas, la chitarra. Si ha così un crescendo del volume sonoro. Molti di questi canti sono ad ‘occasione determinata’: ninenanne, duruduru, lamenti funebri), nel senso che l’espressività è strettamente connessa ai comportamenti. Altri canti, invece sono ad occasione indeterminata (mutos, mutettu, boghe in re, ballu)”.
Ma lasciamo per un momento la musica e continuamo il nostro viaggio letterario la cui attualità dei testi (di Enzo Favata e Ulrich Ohlshausen*), qui riproposti, proseguono il ‘cantare poetico’ dei grandi sardi che li hanno preceduti: Grazia Deledda, Giuseppe Dessì, Salvatore Satta, Gavino Ledda, Michela Murgia Zedda, solo per citarne alcuni che mi tornano alla mente insieme ad altri a noi più vicini, per addentrarci nel ‘mèlos’ tipicamente sardo che ci giunge allorché arrivati e ci confonde quasi a non lasciarci più andare. Del resto andare dove? Una volta qui giunti ci si rende conto fin da subito che non c’è un altro luogo dove andare, quasi si fosse giunti a un mondo estremo. La Sardegna non come già passato millenario ma dentro il tempo presente; un po’ come dire che il Jazz non è la musica del futuro bensì è dentro questo mondo etnico che lo rappresenta, in grado di avvalorare l’interscambio culturale che va avanti ormai da più di vent’anni con un consenso unanime e con le innumerevoli emozioni che la tradizione sarda trasferisce direttamente al mondo con la sua placidità, con l’ostentazione calma di chi sa di ‘esserci’ e in qualche modo di ‘essere’ fuori dal mondo.
“Di fretta (qui) non si va, da queste parti / rallenta i tuoi giorni, straniero che corri / la fretta è una peste, lascia sempre affamati / ascolta i silenzi, goditi il vento / i giochi di urla, di dita mostrate / i numeri oscuri gridati nell’ombra / piano piano, a pagu a pagu / qua si invecchia in millenni / apposénta, ascùtta, sèzzi, citti / mangia poco e mai sotto il sole / guarda il mare, e i veli e le facce / non correre, non urlare, non cercare / fatti guardare / uno, duo, trese, quattru, kimbe.” (Enzo Favata op.cit.)
Il ricordo risale a moltissimi anni fa allorché presi parte all’Ottobrata Iglesiente che ogni anno si tiene ad Iglesias (nel cagliaritano) e che s’inserisce nel solco della tradizione a ‘sa festha manna’ legata ai festeggiamenti in onore della Madonna del Buoncammino, a cui è dedicata la chiesa che sta sul colle omonimo. La nascita dei festeggiamenti religiosi risale alla fine dell'Ottocento, sulla scia dell’Ottobrata la festa profana in occasione della quale si svolgeva non solo la fiaccolata verso il colle, ma anche ‘is fogaronis’ (i fuochi), con una rassegna enogastronomica di prodotti tipici locali con bancarelle, ‘paradas’ e ‘glorieddas’ oggi organizzata dalla Pro Loco Sarda in collaborazione con la Coldiretti Sarda. Abbinate alla manifestazione hanno luogo inoltre alcune importanti iniziative come "Autunno in Fiera" con la partecipazione di artigiani e produttori del territorio provenienti da tutta l’isola; nonché una mostra di arte urbana e sport di strada con giochi antichi riservati ai bambini e ai ragazzi che solitamente si tiene nel chiostro di San Francesco. Per tutto il periodo inoltre sono aperti e visitabili gratuitamente tutti i siti di interesse della città grazie all'iniziativa "Visit Iglesias" giunta alla sua seconda edizione; in particolare si potrà visitare la mostra fotografica dal titolo "IntusINmente" presso il Museo dell'Arte Mineraria. La giornata della domenica solitamente dedicata ai festeggiamenti religiosi, si esibiscono ‘cori’ e ‘danze’ del folklore sardo in abiti tipici riccamente ricamati e ornati e che rappresentano l’occasione, insieme alle manifestazioni processionali per la Settimana Santa, di avere accesso alla tradizione più antica sull’ornamento e l’uso del ricamo dell’isola.
Si scopre così il perché di una musica come ‘memoria del tempo’, quell’autentico carattere ‘magico-rituale’ che risiede nell’arcaico suono degli strumenti sardi, e il ‘potere esorcizzante’ insito nell’uso della voce dei ‘cori’ che si ripercuote su ogni manifestazione della festa: “Voci potenti (intervallate) da silenzi lunghissimi / tremori studiati nei canti di gruppo / amuleti di bronzo e durezze di accenti / popolo scuro di pelle e pensieri / amori incupiti da leggi incomprese / fatto in Sardegna: come uguale da sempre / come se il vento portasse il carattere / come amare il pensarsi immutati / come una sorte che nessuno ha voluto / come mancanza di sogni migliori / popolo duro nemmeno vincente / gente difficile: / carbone negli occhi / contenti di niente.” (Enzo Favata op.cit.)
“Non potho reposare”
“Non potho reposare amore e coro
Pensende a tie so donzi momentu
Non istes in tristura prenda e oro
Ne in dispieghere o pensamentu
Ca t’amo forte t’amo, t’amo, t’amo.
Si m’essere possibile d’anghelu
S’Ispiritu invisibile piccavo
Sas formas e furavo dae chelu
Su sole sos isteddos pro tene
Pro poder dispensare cada e bene”.
“Non posso riposare, amore e muore, / pensando a te sto in ogni momento; / non essere triste, o brama d’oro, / né in dispiaceri o ripensamenti, / perché ti giuro che te solo bramo, perché t’amo forte, t’amo, t’amo, t’amo. / Se mi fosse possibile, dell’angelo / lo spirito invisibile prenderei, / le forme ruberei dal cielo / del sole, delle stelle e formerei un mondo / bellissimo per te, / per poter saper scegliere il bene dal male.”
Ma non è l’unico volto della gente Sarda aperta al dialogo con il forestiero e orgogliosa del suo entourage isolano, al punto che chi entra nel suo itinere amicale lo è per sempre, comunque vadano le cose della vita. E questo perché il suo parlare ha limiti e confini senza sbavature, non conosce se.. o forse.., ma va diretto al senso, al significato profondo della parola detta o data: punto d’onore da cui non si prescinde. La lingua sarda infatti è riconosciuta una vera e propria lingua a sé nel panorama delle lingue etniche dell’area mediterranea, sebbene con inflazioni dell’italiano (latino) e del portoghese più autentico, più duro e ostico d’ogni altra lingua che s’affaccia da questa parte del mare. Ancora oggi per il sardo doc infatti mettersi in mare, o comunque viaggiare fuori dell’isola, ha significato di andare verso il continente ‘questo sconosciuto’, quasi come gettarsi fra le braccia di un despota che distrae la mente dalle ‘rocciose convinzioni interiroi’ e ne condiziona il fato. Può sembrare strano come il ‘fato’ è sull’isola di carattere stoico in ogni sua accezione di coraggioso, forte , eroico, impassibile, imperturbabile, decisamente virile. Non necessariamente legato alla casualità o, come si vorrebbe, al destino che invece ha un’altra origine.
Nel linguaggio comune moderno il termine è stato sostituito da quello di destino che nell'antichità però differiva nel suo significato da quello di fato. Questi infatti, indica l'essere sottoposti a una necessità che non si conosce, che appare casuale e che pure invece guida il susseguirsi degli eventi secondo un ordine non modificabile. Il destino invece può essere cambiato poiché esso è inerente alle caratteristiche umane: «faber est suae quisque fortunae» (Ciascuno è artefice della propria sorte.) L'unico artefice del proprio destino è dunque l'uomo stesso: concezione questa ricorrente nella mentalità romana, che si contrappone all'idea del fato, dominante nel mondo classico, che implica spesso rassegnazione e passività di fronte al corso necessitato degli avvenimenti e considera invece l’essere umano responsabile e protagonista delle sue azioni e della lotta contro il bisogno e la miseria, (..) quindi immanente alle cose umane e quindi indagabile e conoscibile attraverso un'analisi razionale che renda possibile l'azione del ‘libero arbitrio’.
“Libertà e necessità non si contraddicono bensì allo stesso modo le azioni volontarie degli uomini, in quanto derivano dalla loro volontà, derivano dalla libertà; e tuttavia, in quanto ogni atto della volontà umana, e ogni desiderio ed inclinazione, deriva da una causa, e questa da un'altra causa, in un catena ininterrotta il cui primo anello è nelle mani di Dio, causa prima, esse derivano dalla necessità.”
(Thomas Hobbes, 'Leviatano', Editori Riuniti, 1982)
Un altro aspetto relega i sardi (una volta superata una certa ostilità consolidata nel tempo da chi sempre e solo ha preso, o portato scompiglio nella tranquilla vita isolana) ad essere un popolo accogliente con un forte senso dell’ospitalità, tale da essere ritenuta ‘sacra’ in seno alla famigliarità che esso dona, nel senso del rispetto verso la persona, verso la vita umana e la natura ‘forte e dura’ che la contiene. In questo caso silente eppure comprensiva di ciò che l’altro è portatore e intenzionalmente portato a offrire di se stesso, ed ‘ricevere con semplicità ciò che riceve in ‘dono’: “..contento di niente” – scrive Favata – ma che è un niente carico di pampini voluttuosi, di fregi preziosi, di odori e sapori inconsueti, di silenzi incommensurabili eppure pregni di suoni. Acciò l’origine oscura delle ‘is launeddas’ uno strumento musicale a fiato policalamo ad ancia battente, costituito da tre canne: ‘tumbu’, ‘mancosa manna’ e ‘mancusedda’ di origini antichissime in grado di produrre polifonia. Diffuso in tutta la Sardegna è oggi suonato con la tecnica della respirazione circolare ed è costruito utilizzando diversi tipi di canne, usato dai pastori che ne trasfusero il suono in ‘voce’ che avrebbe fatto loro da ‘compagno’ nella solitudine dei pascoli, talvolta molto lontani dalle proprie abitazioni, per così dire mettere in risalto i propri umori e le aspirazioni, i desideri, i sogni e gli ideali che li accompagnavano.
Nonché utilizzato nelll’accompagnamento al ‘ballu’ che sembra essere forgiato sulla musica stessa dello strumento un tempo tipico dell’area mediterranea simile all’’aulos’ dell’antica Grecia, prima ancora presente nelle pitture murali egizie e mesopotamiche e che si perde nella preistoria della musica, ma che trova qui in Sardegna una conferma archeologica risalente all’antico popolo nuragico presente sull’isola da almeno 3.000 anni che ne testimonia la presenza. Datazione questa ricavata da un bronzetto nuragico raffigurante un uomo che suona lo strumento. Anche per questo il ‘ballu’ vanta una maggiore sopravvivenza e ricchezza di ‘nodas o picchiadas’ (frasi musicali), pur rivelando una sua specificità, deve essere necessariamente ricondotto ai balli orgiastico-cultuali in cerchio attorno agli officianti o al fuoco dei riti primitivi e questo è dimostrato dal fatto che, in epoca storica, l'occasione di ballo era indissolubilmente legata al ciclo dell'annata agraria, svolta nei sagrati delle chiese o d'antichi siti sacri.
Ne è un esempio il suono riflesso nel tradizionale ‘su ballu tondo’, una danza che si svolge in cerchio, nucleo del repertorio dei suonatori di ‘is launeddas’ di gran lunga il più ricco dal punto di vista musicale che si conosca in tutta l’area mediterranea e non solo. Nell’uso il ‘ballu’ aveva inizio la domenica sul sagrato dopo la Messa nel giorno di festa, o nelle adiacenze delle abitazioni dai famigliari e vicini, vestiti degli abiti tradizionali. Quindi si faceva ritorno a casa per il pranzo domenicale, che poi veniva ripreso a una certa ora del pomeriggio fino a tarda sera. I suonatori erano ingaggiati da giovani di anno in anno dopo la mietitura. Ma spesso – se la memoria non m’inganna – bastava talvolta l’intonazione di un gruppo di cantatori ‘sus tenores a ballu’ per eseguirlo in rapida successione: svolto su una serie di temi principali eseguiti su una sequenza fissa, ognuno dei quali veniva ampliato e variato. L’occsasione del ‘ballu’ rappresentava nei centri comunitari dell’isola l’unica possibilità di contatto tra i giovani; fungeva cioè da ‘sblocco’ psicologico della consueta separazione dei sessi, seppure con alcune differenziazioni a seconda della possibilità di accesso agli estranei al gruppo d’origine o famigliare.
Dal punto di vista sociologico, il repertorio sardo in fatto di canto con accompagnamento strumentale si può suddividere in almeno tre gruppi principali: uno di canti e danze tradizionali; un secondo in canti monodici e polivocali; il terzo in canti liturgici e processionali. Iniziamo da i ‘muttus’ e ‘muttettus’, un genere questo preferibilmente usato nelle serenate, il cui testo in forma ‘lirica’ è di regola improvvisato, il cui contenuto varia secondo l’utilizzo che ne viene fatto. Un esempio è se la serenata è dedicata alla bella di turno o se sivuole stuzzicare il suo desiderio sessuale, come in questa “Aperimi sa janna” (aprimi la porta..):
“Aperimi sa janna, o fresca rosa
che sto tremando come foglia di canna.
Tu sei nel tuo letto e ti riposi
mi lasci fuori della porta.
La porta non l’apro fin quando
il sole non sarà alto sul mare …”
La serenata, così come il ballo collettivo, è sempre stata una forma socialmente accettata: l’uomo per l’occasione si dichiara alla ragazza appunto con una serenata ma se non è assiduo nell’andare a cantare sotto la casa dell’amata, si pensa che il suo interesse è vicino a venir meno. La ragazza dal canto suo non deve mostrarsi, ma può accendere la luce nella sua stanza per far capire che è sveglia e che accetta con gratitudine l’omaggio fattole. Solitamente la serenata consta di due parti, la prima diretta alla ragazza, la seconda rivolta ai genitori di lei per chiedere loro scusa per il disturbo arrecatogli.
Il canto ‘a tenores’: trattasi di un canto d’origine pastorale molto antico, conosciuto e sviluppato soprattutto nella Barbagia nelle regioni limitrofe. Si suppone che esso sia nato per riprodurre i suoni più tipici della campagna sarda (belati, muggiti, richiami, sonagli, ecc.). ‘Su tenore’ è composto generalmente da quattro voci: ‘sa oghe’, ‘sa contra’, ‘su basu’, ‘sa mesuoghe’. Le tre ultime voci intervengono nel canto con dei fonemi quando ‘sa oghe’ finisce di scandire la parte letteraria (spesso creativa a responso). È un canto ancora molto radicato nel mondo pastorale del centro della Sardegna. Con esso, oltre ai ritmi non danzabili (‘a sa seria’, ‘a mutos’, ‘a boghelonga’, ‘gosos ecc.) si possono eseguire anche ritmi danzabili come ‘a ballu tundu’, ‘passo torrau’, ‘balle a trese’ ecc.; così come ‘su tenore’ rimpiazzava un tempo gli strumenti musicali. In tal modo invece di danzare al suono degli strumenti musicali, la gente danzava attorno a ‘su tenore’. Di ‘su tenore’ si servono anche i poeti estemporanei ancora molto popolari in Sardegna; da cui la vicinanza agli stili contemporanei del Jazz e del Blues.
Leggiamo qui di seguito un brano per così dire ‘epico’ la cui memoria risale alla tradizione popolare: (Enzo Favata op.cit.)
“..se hai occhi davvero vedi i cavalli al galoppo,
curri dimoniu, ché la notte è vicina,
banditi e fantini, signori e predoni,
i cavalli al galoppo senza sella,
né Dio curri dimoniu,
ché la giustizia è veloce che la fame da fretta,
che se ci prendono è forca che non perdona,
che la mia bella m’aspetta che la notte ci è amica,
ci guida e protegge al galoppo lontano …”.
E il seguente brano dall’intento ‘magico-rituale’:
“Il re delle Janas ha un piffero d’oro / il re delle fate ha un viso di moro / di amanti ne ha cento che stregano e incantano / dell’aquila ha gli occhi, del cinghiale il coraggio / è un bimbo felice, è il vecchio più saggio / ha il viso coperto di mantelli neri / è un re senza armati, è il re dei misteri / ha un regno segreto oltre i monti e le stelle / è il re delle Janas, delle fate più belle”:
In italiano il termine in lingua sarda ‘domus de janas’ è stato tradotto in ‘case delle fate’. Nel dialetto delle zone interne dell'isola, dove il significato del termine non è ancora scomparso, per indicare un uomo o donna dal fisico minuto (la dimensione è circa quella di un bambino pre-adolescente) si dice ‘mi pàret un'òmine jànu’ (mi sembra un uomo janu). Le ‘domus de janas’ in altre zone dell'isola sono conosciute anche con il nome di ‘forrus o forreddus’, sono delle strutture sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi concentrazioni costituite anche da più di 40 tombe. A partire dal Neolitico recente fino all'Età del Bronzo antico, queste strutture caratterizzarono tutte le zone dell'isola. Ne sono state scoperte più di 2.400, circa una ogni chilometro quadrato, e molte rimangono ancora da scavare. Sono sovente collegate tra loro a formare delle vere e proprie necropoli sotterranee, con in comune un corridoio d'accesso (dromos) ed un'anticella, a volte assai spaziosa e dal soffitto alto.
Con le Janas siamo entrati in quell’aspetto magico-rituale tutt’ora molto sentito in tutta l’isola ‘degli isolani’ quando si tratta dell’affascinante e inarrestabile percorso della conoscenza difficilmente sondabile. Sì, in qualche modo, si guarda anche al passato al quale tutto ciò è indubbiamente legato, ma dal quale si cerca di conservare tutto quello in cui con amore, orgoglio e passione ci si può riconoscere. È questa la ‘verità della terra’ così viva da queste parti, particolarmente nel cuore dell’isola’ in quanto palpitante testimonianza del forte legame ancora esistente fra le antiche e le nuove generazioni. Non esiste luogo dove bellezze naturali, grandiosità e fascino dei monumenti prenuragici, come appunto sono le ‘domus de janas’, e le testimonianza della civiltà nuragica, quella dei ‘nuraghes’ veri e propri, forse le rovine più antiche del mondo si sposano col vento che da millenni segna il loro destino. Qui, le sfumature di colori, i miti e le leggende ad essi legate, destano ancora oggi emozioni e suggestioni, evocano memorie arcaiche, dipingono una realtà intima e intangibile, che diventa occasione di conoscenza profonda.
Tutto ciò si avverte soprattutto per l’avvicinarsi alla preparazione dei riti della Settimana Santa, in cui tutte le attenzioni sono dedicate principalmente alla festa religiosa della Pasqua, la più importante ricorrenza festiva dell’anno, molto sentita dagli isolani in tutta la Sardegna. Scrive Fanco Stefano Ruiu (*): “In quasi tutti i paesi dell’interno infatti, nei giorni di Giovedì e Venerdì santo si rinnova il ‘Mistero della Passione’ che viene coralmente vissuto con la visita ai Sepolcri e con la partecipazione a ‘s’Iscravamentu’, consistente nel pietoso rito della deposizione del Cristo dalla Croce. Sono momenti di intensa suggestione, accompagnati dal lamento dei canti magistralmente eseguiti dai cantori delle confraternite. Sono queste associazioni di volontariato che, con devozione, perseverano nel tramandare un patrimonio di antiche di antiche memorie di cui si sentono insostituibili depositari. Il giorno di Pasqua a Nuoro – ad esempio – fra il gioioso rintocco delle campane a festa si svolge la processione solenne de ‘s’Incontru’. I simulacri del Cristo Risorto e della Madonna partono per due diversi Oratori, per poi ricongiungersi, al termine di un breve girovagare per le vie del paese, e formare un unico corteo. All’uscita dalla chiesa il rituale scambio degli auguri ‘a largos annos chin salude’, per molti anni con tanta salute”.
“Dio ti salvi o Maria / che grazie abbiamo da chiederti / figlie da crescere e vedere sposate, mariti amati che sani che sani rimangano / giovani uomini da non perdere in guerra, triste la sorte di chi muore lontano / grazie chiediamo alla Madre / volti tirati da assenze pesanti, da povertà ancora vive / visi segnati da veglie paurose, odii covati per motivi da nulla / grazie chiediamo in silenzio / a lai che protegge e sa leggere i cuori / che capisce la rabbia e le accuse e le scuse / che sa perdonare anche i mali peggiori / che Dio ti conservi, oh donna pietosa / che vegli su di te come pure sui tuoi figli”. (Enzo Favata op.cit.)
Fra le tante pietanze occasionalmente preparate nella ricorrenza della Pasqua sono le tipiche ‘Sas Pizzinnas d’ovu’: figure artistiche realizzate in pasta dolce e destinate ai bambini in forma di uccellini, pulcini di diversi volatili sulle quali l’usanza prevede l’inserimento di un uovo, simbolo di fecondità. Ancora a Nuoro la Sagra del Redentore in Agosto è un forte richiamo pe migliaia di tutisti attratti dalla coloratissima sfilata formata da circa tremila costumi provenienti da ogni parte della Sardegna. Si tratta di una delle sagre tradizionali più attese che si rinnova annualmente da più di cento anni e si distingue per l’alto valore religioso che si manifesta anche nella compostezza e il fascino dei costumi millenari. Ma ben altro ci/vi aspetta in tutta l’isola, a cominciare dalla esibizione di ‘Parillas’ una corsa di cavalli abbinata che richiama una grande partecipazione di folla. Così come l’autunno vi aspetta in Barbagia, il cuore pulsante della Sardegna: un cammino incantato, da settembre fino alla fine dell’anno, tra le bellezze di ben ventotto paesi di montagna che aprono le proprie Cortes in un percorso ricco di meraviglie e di fascino per emozioni indimenticabili a cavallo tra i ‘Fuochi di Sant’Antonio’ a Gennaio, a carattere votivo ma ugalmente capaci di rapirvi l’anima durante le notti ‘infuocate’ dalla presenza dei ‘Sos Mamuthones’, per le maschere che incontrerete, per i sogni che vivrete ad occhi aperti, dei quali porterete per sempre il ricordo delle antiche tradizioni di questa terra.
Nonché del ‘Carnevale Barbaicino’ di Mamoiada, ricco di atmosfere suggestive, impreziosito da eventi come la sfilata appunto dei Mamuthones, personaggi arcaici rivestiti di pellicce d’animale e maschere sul volto, cadenzata dal cupo suono ritmato dei campanacci, portati a spalla in gran numero dalle maschere che conferiscono ai danzatori un significato per niente casuale e tantomeno effimero: “..Le maschere cupe, le loro movenze, i suoni lugubri che ne fanno da contrappunto, incutono rispetto e, al tempo stesso, metteno a disagio. Assistendo a una loro esibizione non è difficile immedesimasi in quel lembo di antiche tradizioni che le stesse intendono e riescono ad evocare. Recenti studi, coralmente recepiti, collocano l’origine delle maschere del Carnevale barbaricino nel tempo delle religioni misteriche e dei riti dionisiaci. Logico pensare che i riruali proposti siano quanto rimane di antiche manifestazioni propriziatorie sopravvissute nel tempo, legate alla fertilità e all’alternanza delle stagioni. (..) Le maschere a loro volta sono attorniate dagli ‘Issokadores’, questi sfilano senza campanacci indossando il costume tradizionale sardo e recano in mano una fune detta ‘sa soca’ , con la quale riescono a catturare gli spettatori che a un certo punto vengono tirati al cospetto ravvicinato delle maschere, tra lo spavento e talvolta la paura che questi incombono”. (*) (F. S. Ruiu op.cit.)
Pastori, cavalieri, maschere e santi sono le tracce antichissime di tradizioni che il tempo non ha intaccato: tra le tantissime vanno citate la Sartiglia di Oristano, la Sagra di Sant’Efisio patrono della città di Cagliari, la Faradda dei Candelieri a Sassari, il Carnevale di Bosa famosa per le sue lavoratrici impegnate al ‘tombolo’, dove è possibile incontrare merlettaie centenarie che ancora operano i loro stupendi pizzi senza tempo. La Regata di ‘Is Fassois di Santa Giusta’ in provincia di Oristano cui protagoniste sono le antiche imbarcazioni palustri. Va detto che fin dall’alba dei tempi la terra sarda ha raccolto le genti del ‘mare nostrum’, mentre il suo popolo ha impersonato nei secoli uno spirito fiero, sviluppando una cultura unica e seducente, la cui natura si cerca di conservare, lì dove è stato possibile finora, con la creazione di Oasi, Laghi e Stagni, Ploaghe vulcaniche, Riserve e Parchi, Arcipelaghi Marini Naturali abitati solo ed esclusivamente da animali non privati del loro habitat.
“In su Monte e’ Gonare” (‘muttos’ popolare): Canta una sirena sul monte e canta l’anima del poeta esibendo il suo forte desiderio, immedisimandosi con la natura che lo circonda:
“In su monte Gonare
Falat una sirena
E canta notte e die.
In su monte Gonare
Sì no mi dana a tie
Mi truncu cachi bena
E mi lasso irbenare”.
“Sul monte Gonare / Si posa una sirena / E canta notte e giorno. / Sul monte di Gonare / Se non mi danno te / Mi taglio qualche vena / e mi lascio svenare.”
Non in secondo piano c'è la gastronomia offre quanto di meglio si possa apprezzare sulla tavola: dalla cucina del mare che si coniuga con i profumi dell’entroterra, alla frugalità delle tradizioni di montagna incorniciata del ‘mirto’ tipico di questa egione da cui viene ricato anche un prezioso liquore. Formaggio pecorino, pane ‘carasau’, e dolci particolari come ‘i sospiri di Ozieri’, i ‘malloreddus’ (tipo di pasta), il ‘poceddu au carraxiu’ (porcellino cotto sotto terra con foglie d’alloro e altri profumi), aragosta alla Vernaccia tipico sardo, come lo sono il vino Cannonau di Nuoro, il Vermentino di Gallura per gustare i quali bisogna avventurarsi in originali percorsi gustativi, allo stesso modo come tutta l’isola richiede di essere visitata ‘per itinerari’ e non solo per la vastità territoriale ma per le cose che ci sono da vedere, momtagne da scavalcare come il Monte Luna e il Gennargentu, piane da valicare come la distesa iglesiente e boschi secolari come quello di Laconi, olte a un’infinità di altri possibili itinari irrinunciabili per incontrare nei piccoli centri tradizioni arabo-spagnole- medievali:
“Dalle finestre vedi la Spagna profonda, se hai occhi davvero e non ti fermi alle spiagge, maiorchini arrafoni e frati di Murcia, i soldati del Rey che mostrano al sole gli scudi, la Senora de Laconi e i suoi armati carogne, i patiboli pronti per i ribelli straccioni, la bella trassata per sua eccellenza il barone, (..) curri, che la notte ci è amica, ci guida e protegge al galoppo lontano dal Rey dalla legge. Un po’ di Genova e Marsiglia / nei pochi porti e nel contrabbando del nord / nell’eleganza del marmo, Pisa / e Catalunya nella fortezza d’Alguer / Cagliari amante di tutti / i nobili ne fanno un salotto / africani di Pegli / nelle piccole isole del sud: (Sant’Antioco e San Pietro), siamo come continente / dimentichi di non esistere, di contar così poco / che Dio ci corra vicino / ora e sempre lontana tenga la fame / che troppo ci ha fatto penare, soffrire, morire / ora e domani / che Dio ci corra vicino, la fame tenga lontana”. (Enzo Favata op.cit.)
“Procurade moderare” è un tipico canto di contestazione politico-sociale cominciata e mai terminata contro i soprusi degli invasori; oggi diventato l’inno per eccellenza della ribellione della gioventù sarda:
“Procurate moderare
barone sa tirannia
si no pro vide mia
torìa des a pe in terra.
Dichiarada est sa gherra
contra de sa prepotenzia
chi cuminza sa passenzia
in su populo a mancare.
Tribagliade tribagliade
sos poveros de sa bidda
pro mantenere in zittade
sos caddos de istalla
custu populo unde’ s’ora
d’istirpare sos abusos
a terra sos malos usos
gherra, gherra a s’egoismu”:
“Cerca di moderare barone questa tirannia, altrimenti in fede mia tornerai con i piedi in terra. Dichiarata è la guerra contro la prepotenza, e comincia la pazienza nel popolo a mancare. Questo popolo (dice) ché giunto il momento d’estirpare gli abusi (verso questa ) a terra, il malcostume e guerra all’egoismo”:
Notevoli sono le ninnenanne sardi, ne esistono a migliaia, prese talvolta come fondo musicale per tiritere senza senso letterario ma molto, molto musicali. Come in questa forma popolare che non ha un’occasione-funzione determinata. Solitamente eseguita in diversi modi (voce femminile, voce maschile e coro), si presenta come un insieme di versi stereotipi che accavallandosi propongono le rime con funzione simile a quella strutturale del ‘mutettu’:
“Iandimironnai”
“De mari benit bentu
Cun grandini de oru
E acqua fini fini
Chi fessid’ e ddu sciri
Iat a mandai su coru
Aundi est pensamentu.
Su mari est prenu prenu
De barchittas de oru
Beneittu terrenu
Aundi ad’essi coru.
Unu moru uno moru
Uno moru in cadena
Ascurta cossu coru
No dde lesses in pena”:
“Dal mare viene il vento / con grandine d’oro / e pioggerella sottile / se lo sapesse / mandeebbe il cuore / dove è il suo pensiero. / IL mare è pieno / di barchette d’oro / sia benedetta la terra / dove si trova il mio cuore. / Un moro un moro / un moro in catene / ascolta questo cuore / non lasciarlo in pena”.
Il dramma della vita dura della gente sarda è messo in risalto in questo canto disperato e al tempo stesso accorato del pastore che vaga per le campagne e i boschi in attesa di una risposta che giustifichi ai suoi occhi il perché di una vita così dura e grama , priva d’amore, che solo il canto sofferto può addolcire le sue pene, i suoi affanni ma che pure non gli permette di frenare il pianto che sgorga con impeto come una sorgente d’acqua limpida sgorga da una roccia:
‘Disispirada’
“Per istos buscos solu
Ohi solu
Per amenas campagnas delirende
Oh! delirende
Triste chene consolu
Consulo
Semper de bene meu preguntende
Oh! preguntende
Cantu po abblandare
Ogni pena ogni affannu
Ogni dolore
Me candu ant’accabbare
Sas furibondas dies
De amore
Oh! de amore
Ah! deo già so intantu
Formande largos rios de piantu
E narende in su Cantu!
Ohi! Cantu!
Oh! Coro ite triste
Triste piantu”.
“Solo fra questi boschi / Sempre solo! / Fra le amene campagne delirando / Delirando! / Triste senza consolazione / Sempre chiedendo del mio bene / Sempre chiedendo / Canto per addolcire / Ogni pena, ogni affanno / Ogni dolore. / Ma quando finiranno / Le giornate tormentate / Dell’amore. / Oh! dell’amore / Ah! Ed io intanto sto / Formando ruscelli di pianto / E dico col canto / Ohi! Col canto / Oh! Il cuore tanto triste, / Triste pianto”.
Un esempio di canti religiosi di contenuto agiografico e affini alla ‘lauda’ per la forma e il contenuto, i ‘gosos’ sono dedicati ai Santi e alla Vergine, ecc.; particolarmente interessanti sono quelli per la Settimana Santa, con ‘gosos’ distinti per le diverse giornate che hanno mantenuto stretti legami con i ‘gozoz-gois’ spagnolo-catalani. L’esempio qui riportato proviene da Fonni nel nuorese:
“Gosos”
“Pro fizu meu ispiradu
A manos de su rigore
Sett’ispadas del dolore
Su coro mi an trapassadu
Truncadu porto su coro
Su pettus tengo frecciadu
De cando mi an leadu
Su meu riccu tesoro
Fui’ tant’a cua ch’ignoro
Comente mi es’ faltadu
Sett’ispadas del dolore
Su coro mi an trapassadu
In breve ora l’an mortu
Pustis chi l’an catturadu
Bindigh’ oras est istadu
A sa rughe dae s’ortu
E bendadu l’ana mortu
Cun sos colpos che l’an dadu
Sett’ispadas del dolore
Su coro mi an trapassadu
Morte non mi lesses bia
Morte no tardes piusu
Ca sende mortu Gesusu
Non pode’ viver Maria
Unu fizu chi tenia
Sa vida li an leadu
Sett’ispadas del dolore
Su coro mi an trapassadu”.
“Per mio figlio spirato / Tra i tomenti / Sette spade di dolore / Il cuore mi han trapassato. / Spezzato ho il cuore / Il petto trafitto / Da quando mi han tolto / Il mio ricco tesoro / Con tale inganno che ignoro / Come mi è mancato. / Sette spade… / IN breve l’hanno catturato. / Quindici ore è stato / Alla croce, dall’orto. / Bendato l’hanno ucciso / Coi colpi che gli han dato. / Sette spade… / Morte, non lasciarmi viva / Morte più non tardare / Perché, morto Gesù / Non può vivere Maria. / Un figlio solo che avevo / Gli han tolto la vita. / Sette spade…”.
Gli esempi sarebbero tanti, addirittura infiniti, ma tanto basta per dare un’idea di ciò che la musica e il canto sardi hanno dato e possono dare alla tradizione popolare attiva nell’isola con i suoi interpreti più impegnati e che più rispondono alla richiesta internazionale esportando e invitando artisti d’ogni parte del mondo per esperienze che arricchiscono entrambi i contribuenti. Anche qui i casi da citare sarebbero moltissimi ed altrettanti gli artisti da ricordare; molti sono i musicisti che fanno uso di strumenti tipici all’interno di gruppi musicali contemporanei o pema della artecipano a incisioni discografiche di pregio. Ciò malgrado le loro apparizioni sui media italiani siano molto limitate, e non ne capisco il perché. Forse per una forma di snobismo verso una tradizione che non conosce confronto e diciamolo pure non è accessibile a tutti. Basterebbe però creare momenti di ascolto, per esempio nelle scuole, dove potrebbe essere davvero istruttivo avvicinare i giovanissimi alle culture presenti nel nostro paese e ovviae anche al problema della ‘incomprensione’ verso l’altro, il diverso, il migrante, accompagnato da illustrazioni e invitando alcuni musicisti ‘in vivo’ che possono mostrare l’uso di certi strumenti tipici (d’oni regione) e narrare le lor esperienze musicali in gio per il mondo.
Il mio pensiero va comunque a ritroso a voci che pure hanno segnato momenti straordinari nel panorama musicale italiano e non solo: Maria Carta, Andrea Parodi, Alfonso Lara, Gli Aggius, Tenores di Bitti, e ai Suonofficina con Alberto Gabiddu, la strepitosa Elena Ledda, Mauro Palmas e gli altri componenti. Ringrazio inoltre Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, e ovviamente Enzo Favata e tutto il suo gruppo.Agli scomparsi Roberto Leydi e Diego Carpitella e al pittore sardo Vittorio Maccioni originario di Carbonia che a suo tempo mi ha inviato questa poesia:
“Quattro pareti oscure,
quattro punti cardinali:
Est, Ovest, Sud e Nord
che sono solo stati
tutto il mio regno,
viaggi, popoli,
danze e canti
felicità, piaceri e sole
tanto sole da illuminare
la mia stanza umida e sconcia
queste quattro pareti
oscure”. (Vittorio Maccioni 1967)
Ringrazio inoltre l’Assessorato per lo Sviluppo Economico della Regione Sardegna, le Provincie di Nuoro e di Cagliari per aver contributo alle informazioni turistiche. Ovviamente molto c’è ancora da dire e spero di poter in futuro ritornare su questi passi e illustrare altri aspetti di questa incommensurabile cultura dalla quale tutti abbiamo ancora molto da apprendere.
Bibliografia essenziale:
AA.VV. “Ichnussa: la Sardegna dalle origini all’età classica”, Garzanti edit. 1985
Francesco Alziator, “IL folklore sardo”, La Zattera ediz. 1957 e “La Collezione Luzzietti di Costumi Sardi Nella Biblioteca Universitaria di Cagliari”, De Luca Editore 1963
Giovanni Lilliu, “La civiltà dei sardi: dal Neolitico all’età dei nuraghi”, Eri Ediz. 1963
L. Zeppegno / C. Finzi, “Alla scoperta delle antiche ciciltà in Sardegna”, Newton Compton edit. 1977
Fulco Pratesi e Franco Tassi, “Guida alla natura della Sardegna”, A: Mondadori edit. 1977
Dolores Turchi, “Leggende e racconti popolari della Sardegna” 1984; e “Maschere, miti e feste della Sardegna” Newton Compton edit. 1990
Raffaele Pettazzoni, “La religione primitiva in Sardegna”, Carlo Delfino edit. 1993
Enzo Favata e Ulrich Ohlshausen – “Voyage en Sardaigne 1997” – libretto incluso in CD
Roberto Leydi, in Libretto “Serie Regionale”, inserito nella produzione dei Dischi del Sole.
Diego Carpitella, Libretti d’accompagnamento alle registrazioni effettuate ‘sul campo’ e inserite nella produzione degli album discografici “Musica Sarda” vedi disc.
Thomas Hobbes, “Leviatano”, Editori Riuniti, 1982
Fanco Stefano Ruiu, “Feste e Sagre: il profano nella provincia di Nuoro”, Edizioni Solinas 2007
Discografia:
“Musica Sarda” vol. 1 / 2, a cura di D. Carpitella , Pietro Sassu e Leonardo Sole, Albatros: Documenti Originali del Folklore Europeo LP - VPA 8150
“Is launeddas” Ricerca su uno strumento musicale sardo – registrazioni sul campo da Andreas Fridolin Weis Bentzon. LP Dischi del Sole – DS 529/31
“La Sardegna: Canti e musica dei pastori”, Coro di Neoneli – LP Arion – Farn 1100
“Gli Aggius Coro del Galletto di Gallura”, - LP Dischi del Sole – DS 131
“Iandimironnai”, Elena Ledda e Suonofficina, – Key Record - LP KE 1002
“Dies Irae”, Maria Carta, – RCA LP TPL1-1169
“Ottana”, Franco Madau – Madau Dischi – LP D-002
“Cantendu sa storia nosta”, Franco Madau - Madau Dischi LP D001
“A morti sa tirannia” : Canzoni di opposizione, Franco Madau – Ariston AR/LP 14012
“Pingiada” , Suonofficina, Semi e Fiori – Cetra LPP 385
“Alla ricerca della madre mediterranea”, Pino Masi, CRAMPS – LP 5401
“Armentos” , Andrea Parodi e Al di Meola, per “Midsummer Night in Sardigna”, CD Helikonia / RAI Trade 2005
“Murales”, Tazenda, CD Visa Record 1991
“Cantos a Kiterra” , prefazione di Andrea Parodi, CD / Book – Amiata Records 1999
“Sonos”, Elena Ledda & Suonofficina, CD Biber Records 1989
“Nottes de Incantu”, Maria Carta, CD/2 recording Arts 50-03, 2005
“Intonos”, Tenores di Bitti Polifonia sarda, CD roots 1994
“Voyage en Sardaigne”, Enzo Favata, CD Edizioni Musicali Robi Droli – Il Manifesto 1997
“Made in Sardinia”, Enzo Favata, CD 114 Il Manifesto 2002
“La Sardegna in Jazz”, Paolo fresu, CD/ Libro – Condaghes Ediz. 2004
“Mistico Mediterraneo”, Paolo Fresu, A Filetta Corsican Voices, Daniele di Bonaventura, CD ECM2203, 2011
*
 - Musica
- Musica
SÜDTIROL / ALTO ADIGE – La tradizione in Italia
Un suono arcaico trova oggi nuova risonanza fra le valli e i massicci delle montagne: è il ‘Corno delle Alpi’, il più originale strumento musicale giunto fino a noi a testimonianza di remoti insediamenti agricoli celtici e medievali. La sua dimensione, fra i tre e i quattro metri circa di lunghezza, lo destinava un tempo ai grandi spazi prospicienti le vallate, favorevoli a rimandarne l’eco, in modo che i pastori e i boscaioli sparsi nelle ‘malghe’ (pascoli d’altura) ne fossero allertati. Sia che si trattasse del richiamo per la transumanza degli armenti o di un qualche accadimento inatteso; sia in occasione delle molte feste che si tenevano, e che si tengono ancora in concomitanza del variare delle stagioni, vuoi per una sagra culinaria o per un raduno alpestre; vuoi per la vendemmia o la fiera annuale, o propriamente per le ricorrenze religiose come la Pasqua e l’Avvento.
Testimonianze più arcaiche, legate alla fine dell’inverno e al sopraggiungere della primavera, rivelano usanze popolari che si celebrano all’insegna della più antica tradizione contadina, all’orché i primi timidi fiorellini fanno la loro apparizione sui pendii e nelle ampie vallate, e qui raccolti per la festa detta del ‘Calen de Marz’ che cade il primo giorno di Marzo, in cui i più giovani si riversano sui prati con campanacci e ‘sapugn’ a risvegliare l’erba dopo il lungo sonno dell’inverno, intonando la nota filastrocca:
“Erba fora-de che l’è marz.”
La tiritera si lega ad alcune leggende che parlano di folletti dei boschi e di straordinari abitatori delle montagne, i tradizionali ‘Perchtenlauf’ o anche ‘Klaubaufgehen’: strane creature che attraversano in gruppi, cosiddetti ‘Passen’, i villaggi del Tirolo, travestiti con pellicce e maschere terrificanti scolpite nel legno e facendo uso di campanacci che portano appesi facendoli risuonare ad ogni passo per cacciare gli spiriti cattivi dell’inverno. Spesso questi vengono anche invitati ad entrare nelle case e prima di andarsene, non senza aver ricevuta un’offerta in grappa o altro, ringraziano con un chiassoso concerto. Quando durante le notti silenziose si sentono grida raccapriccianti, suoni di campane ed un gran frastuono si annuncia la notte del Klöckeln in Val Sarentino. Accade che nei giorni precedenti l’ ‘avvento’, questi si riuniscano per cantare le loro canzoni dall’antica melodia. Molto tempo fa questa tradizione si ripeteva in molte zone dell’arco alpino, ma nei tempi moderni essa è stata dimenticata. Solo di rado si incontrano luoghi dove viene praticato qualcosa di simile che però ha poco in comune con la tradizione. Ed anche se questa tradizione può far paura, si tratta di una delle usanze più note del Tirolo che viene festeggiata da secoli.
Qui, fra boschi sempre verdi e nevai ad alta quota, sono rintracciabili numerose varietà di piccoli fiori bianchi che s’affacciano timidi sul finire dell’inverno e per questo anche detti bucaneve, che anticipano l’arrivo della nuova stagione. Nonché erbe medicamentose utilizzate per gli scopi più diversi, la cui conoscenza rientra nel patrimonio della cultura montanara: “splendida di certi arcaismi e viva di motivi di ingenua bellezza”. Così scrive Alfredo Martinelli (1), scrittore alpigiano, nel suo “La voce del passato”, in cui rinverdisce il ricordo del pastore Sagoma conoscitore delle erbe più strane, che raccoglieva appena spuntate in montagna, per farne decotti che d’incanto liberavano le persone dai più oscuri malanni. E di come, con uguale ammirevole maestria, fabbricava fischietti con la corteccia degli alberi, con i quali suonava bizzarre melodie raccolte dai soli animali cui si rivolgeva, e che questi accorrevano or l’uno or l’altro, secondo l’altezza e il timbro del suono.
Ovviamente si può non credere a certe trasposizioni orali di racconti nati dalla spontaneità popolare, tuttavia essi rientrano in quella pseudo-cultura che certi luoghi da sempre offrono alla meditazione, onde diventa salutare ristabilire il contatto smarrito del proprio essere con l’armonia della natura che lo circonda. Quella stessa armonia che ha dato origine alla leggendaria figura dell’Homo Selvaticus, primitivo abitante delle montagne e dei boschi che vive negli anfratti rocciosi. Le storie che lo riguardano, comunemente descritto come irsuto e con capelli e barba lunghi, si tramandano da tempo immemore nella tradizione orale che lo vuole conoscitore di segreti arcani, purtroppo non pervenutici, ma che trovano riscontro nei simboli iconografici diffusi in tutto l'arco alpino e nelle canzoni-ballate di stampo medievale. L’Uomo Selvatico compare inoltre tra le pagine dell’‘Orlando Innamorato’, il poema cavalleresco di Matteo Maria Boiardo (2) che nella VII ottava del canto XXII I, così lo descrive:
«Questo era grande e quasi era gigante,
Con lunga barba e gran capigliatura,
Tutto peloso dal capo alle piante:
Non fu mai visto più sozza figura.
Per scudo una gran scorza avia davante,
E una mazza ponderosa e dura;
Non aveva voce de omo né intelletto:
Salvatico era tutto il maladetto. »
E nel XXIII,6 (libro primo)
«Abita in bosco sempre, alla verdura,
Vive de frutti e beve al fiume pieno;
E dicesi ch’egli ha cotal natura,
Che sempre pi piange, quando è il cel sereno,
Perché egli ha del mal tempo alor paura,
E che ‘l caldo del sol li venga meno;
Ma quando pioggia e vento il cel saetta,
Alor sta lieto, ché ‘l bon tempo aspetta.»
Soprattutto lo si ritrova in quelle zone più isolate in cui l’ ‘om pelos’ dei dialetti trentini è anche una ‘maschera’ lignea dalla funzione catartica, quasi sempre di capro espiatorio, che personifica il lato oscuro e incontrollabile della natura aspra dei luoghi. Sebbene l'origine della ‘maschera’ risalga a tempi molto più antichi, l’Homo Selvaticus non ha mai subito la trasposizione da figura atavica e inquietante dell'immaginario popolare alpino a maschera teatrale, se non in spettacoli occasionali nei periodi carnevaleschi.
Un tipico esempio di vita basata su tenaci valori tradizionali è la cosiddetta ‘transumanza’ che vede ogni anno oltre 180.000 capi di bestiame, fra capre, mucche, pecore e cavalli, trascorrervi il periodo estivo sulle ‘malghe’ d’alta montagna. Avviene così che a partire da metà settembre la ‘transumanza’ coinvolge tutta l’area di riferimento, comprendente il Sud Tirolo e l’Alto Adige, le Valli di Tures e Aurina, la Valle Isarco e la Val Venosta col Parco Nazionale dello Stelvio; le valli dell’Alta Badia e dell’Alta Val Pusteria comprese nel Parco delle Dolomiti, con i suoi picchi del Catinaccio, le Tre Cime del Lavaredo, l’Alpe di Siusi e l’Altipiano dello Sciliar e investe di fatto tutte le comunità alpine; allorché gli animali, vengono avviati sulla strada del ritorno nelle valli di appartenenza, per passare l’inverno nelle proprie stalle. Fatto questo che aiuta economicamente i contadini che altrimenti dovrebbero acquistare di che nutrirli mentre, se gli animali restassero a valle, e l’erba fresca dei prati andrebbe sprecata consentendo alle ‘malghe’ di inselvatichire.
Il ritorno del bestiame a valle è una componente fissa delle tradizioni contadine che viene festeggiata con ricorrenza annuale nei ‘masi’ (sorta di rimesse agricole) sparsi in tutta l’area alpina; così come nei villaggi piccoli e grandi, comprese le piccole cittadine valligiane più conosciute come luoghi di vacanza invernale per via dei loro comparti-sciistici più frequentati d’Europa; ma che stanno conoscendo una forte rivalutazione anche in estate, proprio per la bellezza degli scenari naturali e dei numerosi confort che la montagna estiva offre in sé: dal trekking, al climbing, alle gite in bike, all’alpinismo vero e proprio. Ma non solo, perché oggi la trasformazione dei ‘masi’ in località agrituristiche, permette la degustazione di prodotti naturali selezionati, una enogastronomia fra le più rinomate e, non in ultimo, il venire a contatto diretto con la cordialità amichevole e pressoché ospitale degli altoatesini e sudtirolesi. Non a caso lo slogan che più ricorre nel comune parlare quotidiano, quasi fosse un ritornello, è:
“Venire come ospite … partire come amico.”
Ma torniamo per un momento alla festa organizzata per la ‘transumanza’ dove, per l’occasione, le mucche ma anche gli agnelli delle capre e delle pecore vengono adornate con campanelle, fiori, fiocchi e stemmi colorati che ne dichiarano l’appartenenza. E mentre a valle, la gente richiamata dal suono dei corni alpini, aspetta il rientro dei contadini e dei pastori dalle alture di montagna; nelle baite e nei ‘masi’ ci si prepara alla grande festa con cenoni e danze collettive a suon di ‘jodler’ e musica popolare. Donde si può ben comprendere come qui la vita si svolga nell’intima prossimità con le tradizioni, animate dallo spirito schietto e generoso di chi vive al cospetto possente e spettacolare della montagna, il cui rispetto dei certi valori ancora oggi conferisce loro dignità e prestigio. Dipende infatti dalla presenza di queste montagne l’indole paziente e forte degli alpigiani, capaci di avvalersi al meglio delle risorse di un territorio non proprio favorevole, fino a convertirlo in uno dei comparti turistici oggi di maggior pregio.
Lo conferma la presenza numerica dei ‘masi’ che la collettività ha trasformato in vere e proprie oasi di benessere contadino. La ‘cura’ migliore è appunto data dal cordiale benvenuto che la famiglia altoatesina offre ai suoi ospiti che annualmente giungono in questi luoghi – “..per passare una vacanza in piena tranquillità” – si usa dire nella Valle dell’Adige e nel Südtirol, che non vuole essere soltanto uno slogan, bensì si pone all’evidenza come autentica possibilità di rigenerazione salutare. “Da secoli, l’agricoltura altoatesina ha modellato un paesaggio culturale originale e molto vario che costituisce la base ideale per rigenerare e ritemprare il corpo e lo spirito. Nel rispetto pieno di concepire la vacanza, l’agriturismo nei ‘masi’ altoatesini è considerato come una riuscita combinazione tra agricoltura e salute, un reale esempio di ‘turismo’ alternativo. Più di 300 giorni di sole l’anno, offre l’apportunità di conoscere una ricca varietà di colture e di prodotti che ne derivano. Questo si riflette anche nella grandissima scelta di ‘masi’ per i giorni più belli dell’anno, che s’aprono su scenari incantevoli e spesso incontaminati, l’uno diverso dall’altro, tra valichi alpini e alte vette innevate dove alcuni animali vivono in assoluta libertà”. (3)
Ce ne sono di più antichi con annesso allevamento di bestiame; e vinicoli dove è possibile assistere o partecipare alla vendemmia e alla produzione del vino; come pure conoscere l’attività produttiva di una moderna azienda frutticola e apprezzare appieno la realtà della vita contadina. Acciò l’organizzazione del Gallo Rosso offre il proprio sostegno ai contadini promuovendo quei ‘masi’ che ne portano il marchio che li contraddistingue, e che operano nel rispetto della natura e in difesa del proprio territorio, in rappresentanza dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi con il Dipartimento all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano che gestiscono un costante controllo dell’attività agroalimentare e di agriturismo a garanzia di genuinità dei prodotti e di ricettività turistica in tutta la regione.
Per quanti vi giungono perché rapiti dall’esclusiva bellezza della natura, c’è qui la più ampia scelta di parchi, di riserve naturali, di laghi e torrenti d’acque pure, che basta solo pronunciarne i nomi per riportare alla memoria percorsi che si estendono tra cime e valli, malghe e campi arati, filari di viti e frutteti, osterie e cantine di degustazione, passeggiate ad alta quota e un salutare vivere all’aria aperta. “Per cui trascorere le proprie vacanze in uno dei ‘masi’ Gallo Rosso significa ‘sentirsi a casa propria’, godere del vero riposo, lasciarsi incantare da saporiti menu contadini e, al tempo stesso, fare l’esperienza più autentica, cioè scoprire l’Alto Adige nella sua forma più pura … un vero spettacolo per i sensi.” (4) Ed è a questo primario concetto, riguardoso della natura e della sua sostenibilità che si rifanno alcune regole fondamentali che tutti dovremmo rispettare, per cui ogni singola traccia è la testimonianza della cultura e della storia del luogo in cui si dimora. Ciò vale per le baite, i sentieri contrassegnati, i ponticelli e le staccionate di legno, i prati e i campi coltivati, che non devono mai essere intenzionalmente danneggiati; ne vale della nostra tranquillità e quella degli animali che vi dimorano, la loro come la nostra sopravvivenza.
Non di meno della bellissima natura della regione, vale la pena conoscere quanto questa mette a disposizione del visitatore e turista interessato, in fatto di rivisitazioni storiche nelle sue città, feste e palii di contrada o anche rallegrarsi delle sue tradizioni popolari come, ad esempio: assistere a uno spettacolo del proverbiale ‘teatro dei burattini’, con le sue storie antiche e pur sempre nuove che esperti cantimbanchi narrano con maestria d’attori consumati per la gioia non solo dei bambini. E perché no, abbracciare le diverse opportunità offerte dall’arte, a cominciare con la visita dei centri storici e dei borghi antichi di Bolzano, Merano, Chiusa, Brunico, Vipiteno e magari conoscere il Museo Archeologico dell’Alto Adige, il Museo Civico di Bolzano; il Museo Etonografico Ladino a San Martino in Badia, e proseguendo la visita di abbazie e chiese, rocche e castelli di straordinaria importanza artistica. Come, ad esempio: Castel Roncolo nei pressi di Bolzano; la chiesetta di Sant’ntonio Abate in quel di Pelugo; il Duomo gotico della bellissima e principesca Merano degna di una sosta prolungata.
Tuttavia, se il troppo ‘visitare’ stanca, ci sono comunque tanti hotel quanti ‘masi’ di montagna a riequilibrare l’armonia dello ‘star bene’, che si tocca con mano nella convivenza quotidiana con le genti di qui, spontanee e calorose nei modi, al contempo affidabili e sincere nelle azioni. Infinite come si è visto sono le occasioni di svago, in quanto ad elencarle tutte, dare loro un nome, è qui pressoché impossibile, il calendario è fitto di appuntamenti per tutti i gusti. Numerose sono le attività e gli sport messi a disposizione del ‘tempo libero’ in ogni stagione, tali da riempire l’intero calendario annuale, come assistere a tornei di schacchi; praticare il tennis e il golf, il ciclismo e lo sci estivo; come pure impegnarsi nelle feste di piazza e far visita ai numerosi mercatini tipici della ‘cultura artigiana’; o assistere a concerti di musica classica e di jazz, a balli folkloristici cui prendere parte, rievocazioni storiche, teatro lirico, fino ad assistere a spettacoli di folklore con canti e balli nei costumi tradizionali ed esibizioni di jazz, o prendere parte alla formazione dei ‘cori alpini’ che si formano in tutta l’area alpestre. D’estate se ne contano a migliaia, in ogni paese e quasi in ogni contrada.
I canti popolari dedicati alla montagna sono spesso rapportati alla forza poetica delle voci naturali: “spontanee d’incontaminata freschezza”, inneggianti alla natura, a dimostrazione di una chiara vocazione montana che si esprime anche nella creatività dei numerosi cori di montagna. Il repertorio spazia dai canti alpini a quelli tradizionali, in una varietà e qualità d’interpretazione invidiabile, a cui la partecipazione attiva dei villegianti contende il proprio primato con le bande musicali: “A differenza dei cori - scrive Roberto Leydi (5) – che privilegiano i sentimenti di gruppo e vocazioni privatistiche, la Banda si proietta nella comunità, diventando non soltanto supporto musicale della pubblica celebrazione, ma anche strumento di coesione sociale”. Si pensi che solo in Alto Adige si contano almeno 211 bande musicali: i componenti sono tutti vestiti con un particolare costume tipico per suonare alle feste religiose e alle feste di paese. Complessivamente sono circa 10.000 le donne e gli uomini altoatesini che fanno parte di una banda musicale (in tedesco Musikkapelle). Praticamente ogni piccolo paesino ha la sua banda in costume tipico, diversi di vallata in vallata e decorati differentemente per distinguersi da località a località. I colori dei costumi tipici non sono usati a caso, ognuno ha il suo significato.
In Val Sarentino, ad esempio, la banda rossa attorno al cappello indica che il ragazzo è ancora celibe, la banda verde indica che è sposato. I costumi sono ancora oggi una produzione artigianale: cappelli, scarpe, Lederhosen (pantaloni di pelle) sono l'opera minuziosa di specialisti della pelle, del Loden (lana cotta) e di altre stoffe. E con il ritorno ai costumi folkloristici, torna in voga il ‘jodel’ il canto tradizionale tirolese ch’è possibile ascoltare passeggiando per le Alpi. Questo si avvale di una esecuzione originaria e una tecnica vocale senza testo che consiste nel passare dal registro di petto al falsetto con salti di diverso intervallo percettibile da grande distanza. Un tempo, questo era uno dei mezzi di comunicazione di pastori e boscaioli. Ciò spiega perché il ‘jodel’ rispecchia una grande tradizione nei Paesi alpini, infatti: “..si distingue tra il grido di gioia (jauchzer), un grido acuto, che inizia all'estremità superiore della voce maschile e finisce con un respiro di esultanza, e il ‘jodel’ naturale a una o più voci, una melodiosa sequenza di sillabe senza accezione. Accanto ad antichi tipi di ‘jodel’, è noto anche quello cantato, una strofa di canzone popolare ripresa nel refrain dello ‘jodel’ stesso dai cantanti girovaghi e dal canto dei vaccai, tipico della canzone tradizionale dei pastori alpini.” (6)
Quelle qui di seguito elencate sono solo alcune delle tante manifestazioni organizzate ogni anno nella regione Südtirol / Alto Adige:
‘Tradizionale Mercato del Pane e dello Strudel’ a Bressanone.
Si tiene in ottobre per la soddisfazione dei tantissimi amanti di questo alimento così semplice e sano ma tanto ricco di sapore, presente in tutte le nostre tavole, come sono numerosi anche gli amanti dello strudel, tipico dolce altoatesino, anche lui dalle mille varianti. Quella del pane in Alto Adige è una vera e propria cultura. Ne esistono centianai di tipi diversi: dal pane nero, al pane integrale, a quello con il finocchio, al pane con i semi di girasole o quelli di papavero. Un’intera manifestazione ancora non basta per riuscire ad assaggiarli tutti. I panettieri in piazza Duomo durante i tre giorni della manifestazione illustreranno le varie tecniche di lavorazione e cottura del pane con marchio di qualità altoatesino, un viaggio nel passato che ci permetterà di scoprire piccoli trucchi e segreti per la riuscita di un ottimo pane!
‘Festa della castagna’ a Foiana-Tessino.
La “Keschtnfeschtl“ più comunemente conosciuta come la Festa della castagna di Foiana, si tiene in ottobre e si inserisce in una festosa rassegna animata dalle varie associazioni del paese che offrono ai visitatori allettanti appuntamenti culinari che ruotano attorno alla castagna e alle caldarroste, ma mantengono vivo il legame con le più antiche tradizioni contadine. In questi antichissimi castagneti può sempre capitare di imbattervi in un “Saltner“, antico custode dei boschi, che invita gli escursionisti a rispettare queste piante, ricordando loro che le castagne sono proprietà dei contadini.
Per l’occasione il servizio forestale organizza escursioni guidate lungo il sentiero didattico sul castagno dell’ Alto Adige; si tratta di un percorso didattico, articolato in diverse stazioni in parte interattive, dove il visitatore potrà apprendere ogni sorta di informazioni e curiosità sul castagno. Non mancano infatti leccornie a base di castagna, di miele e di altri prodotti naturali della cucina altoatesina e dei caratteristici oggetti dell‘antico artigianato tradizionale, come ad esempio, la fabbricazione del ‘Keschtnriggl’ l’utensile usato per la manifattura altoatesina che ha regalato il nome all‘intera rassegna. Si tratta di un curioso cesto ovale intrecciato con legno di castagno e nocciolo, che in passato veniva utilizzato per sbucciare le caldarroste e che, dopo essere state arrostite sul fuoco vivo vengono scosse al suo interno, ottenendo che la buccia si stacchi da sola dalla polpa e cada attraverso le apposite fessure sul pavimento. Da non mancare una visita al museo degli usi e costumi contadini che apre le porte dell‘antica stube della panificazione in cui si trova il forno, che ancora oggi viene acceso per sfornare un gustoso pane di farina di castagne. Momenti di intrattenimento offerti dalla Banda Musicale di Foiana e da altri musicisti popolari completano la cornice di questa antica e sepre bella festa d‘autunno.
‘Festa dell’uva’ a Merano.
La Festa dell’Uva, che si svolge ancora ad ottobre, è senza ombra di dubbio l’evento del calendario più radicato al territorio e più tipicamente sudtirolese. La kermesse, la cui prima edizione risale al lontano 1886, rappresenta un omaggio alla viti-vinicoltura che tanta parte gioca nel paesaggio e nell’economia locale. La manifestazione, che si celebra in occasione della chiusura della vendemmia, cade sempre il terzo week end di ottobre. I festeggiamenti iniziano la mattina del venerdì, con la cerimonia di inaugurazione, fra spuntini e brindisi, mentre le bande diffondono ritmi e arie fra le strade del centro. Di questo passo si prosegue per tutta la giornata successiva mentre la domenica, tradizionalmente baciata dalla clemenza del tempo, si raggiunge il culmine. Epicentro della festa è la terrazza del Kurhaus sul Lungo Passirio, dove si alternano le performance di diverse bande musicali. L‘apice della giornata è in programma nel primo pomeriggio, quando il corteo tradizionale percorre le vie del centro. Alla sfilata partecipano circa una quarantina di gruppi tra fanfare e bande, danzatori e figuranti in costumi tipici, carrozze d‘onore e carri allegorici. L’ormai classico incontro internazionale nella città delle terme è assicurato da grandi concerti sinfonici, musica da camera ed un angolo dedicato alla sperimentazione; il tutto nell’atmosfera Jugendstil di Merano.
‘Festa dello speck’ a Funes.
La Val di Funes, con le sue alte vette dolomitiche e i numerosi sentieri in quota, costituisce un paradiso non solo per alpinisti ed escursionisti di tutto il mondo, ma anche per gli amanti della natura che giungono qui per assaporare la magia del silenzio e ammirare le verdi distese dei prati, le specie rare di piante e animali, il paesaggio di straordinaria bellezza offerto dal Gruppo montuoso delle Odle con le sue imponenti cime e torri rocciose, dette anche le ‘montagne pallide’ per via della loro consistenza calcarea, che l’Unesco ha accolto nel 2009 nell’elenco dei paesaggi più belli al mondo proclamandole ‘patrimonio naturale dell’umanità’. Qui, nei villaggi delle Alpi le antiche tradizioni e usanze sono ancora molto sentite. Numerosi gli eventi e le manifestazioni che offrono un’interessante scorcio nella cultura e negli usi e costumi della Val di Funes, nonchè un diversivo per adulti e ragazzi. La musica, le feste di paese, i cortei in costume, le processioni, il tradizionale pascolo di alta montagna in autunno e la famosa ‘Festa dello Speck’ costituiscono un’attrazione che richiama visitatori da paesi vicini e lontani. La festa si tiene ogni anno in ottobre e rappresenta un appuntamento da non perdere per chi ama lo speck e i piatti con esso preparati. Gli scorsi anni i partecipanti sono riusciti a comporre il piatto di speck più lungo delle Dolomiti (533 metri), ad innalzare una corona di speck alta 7 metri e a costruire un tetto con il prezioso salume - un piccolo cielo di speck. Musica, mercatino di prodotti artigianali, produzione di miele locale, pane fresco appena sfornato faranno da contorno a questa golosa festa. Musica, mercatino di prodotti artigianali, produzione di miele locale, pane fresco appena sfornato sono assicurati e, naturalmente, avviene anche l’incoronazione della regina dello speck.
‘Festa del ringraziamento’ in ottobre a Bolzano.
La festa, che si svolge nella centrale Piazza Walther a Bolzano, è organizzata dal marchio Gallo Rosso e dal Bauernbund, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti, e si avvale della presenza di almeno 50 coltivatori di varie associazioni che portano dai loro campi frutta e verdura, succhi e sciroppi, erbe aromatiche e distillati, formaggi e salumi, nonché prodotti vitivinicoli sponsorizzati dal marchio Gallo Rosso che ne garantisce l’alta qualità. L’evento si presenta ‘tra la fiera e la festa’ che negli hanni passati ha visto una grande partecipazione di pubblico in quanto è volta a far conoscere i numrosi prodotti di alta qualità e l'artigianato contadino altoatesini attraverso il contatto diretto col mondo agricolo: “il meglio che l'Alto Adige può offrire in termini di prodotti della terra, presentato da chi con le proprie mani ne ha costante cura”. L’invito a conoscere, degustare, acquistare i prodotti offerti, è rivolto quest’anno da Franz Mulser della malga Gostner Schwaige sulle Alpi di Siusi, nel parco del Palais Campofranco, dove, insieme ai contadini e le contadine si potranno scoprire e deliziose specialità della cucina sudtirolese
‘Cavalcata Oswald von Wolkenstein’
Si tiene in maggio a Fiè allo Sciliar un torneo a squadre che unisce i paesi di Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar. Per l’occasione le squadre si cimentano nel passaggio degli anelli, nel galoppo con ostacoli, nel labirinto e nel passaggio fra porte. Un viaggio nel passato, fra dame e cavalieri, in un mondo incantato. Il concorso prevede poi un ricco programma di contorno: festa medioevale, sfilata, concerti, dimostrazioni ed esibizioni di artisti e di musicisti, mostre e spettacoli teatrali.
L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano offre molteplici pacchetti speciali per chi arriva in città in occasione del Jazzfestival, di Bolzano Danza e del Bolzano Festival Bozen che si offre in estate a un susseguirsi di eventi musicali e danzanti, al fine di soddisfare pienamente le esigenze degli ospiti, da fine Giugno fino al mese di Settembre, la città offre biglietti a prezzi ridotti per concerti, spettacoli ed eventi vari, organizzati durante le occasioni speciali:
‘Festival delle Bande Musicali a Bolzano’
Il programma prevede un weekend all'insegna del folclore, capace di trasmettere alcune delle tradizioni più autentiche che contraddistinguono l'Alto Adige. In Sttembre diversi corpi bandistici, di cui quattro bolzanini, si esibiscono nel centro storico di Bolzano, nei loro costumi tipici di produzione artigianale e realizzati con particolare cura e dedizione per il dettaglio. Il repertorio delle bande spazia dalle marce più allegre ai classici Walzer, fino alle Ouverture e alle composizioni contemporanee, il tutto per un grande e unico tripudio di colori e di note musicali. Anche in questo Bolzano ha conquistato un posto di rilievo nel firmamento europeo della musica, grazie ad eventi di respiro internazionale quali il Jazzfestival, la Bolzano Danza e il Bolzano Festival Bozen. Proprio da qui partono le tournée estive della European Union Youth Orchestra e della Gustav Mahler Jugendorchester, occasioni uniche per giovani pianisti che muovono i primi passi verso una carriera mondiale.
‘Südtirol Jazz Festival Alto Adige’
Grande apertura in giugno a Castel Firmiano. La manifestazione musicale che porta artisti di fama internazionale a esibirsi sui diversi palchi altoatesini. Il programma si svolge dalla fine di giugno alla prima metà di luglio, con decine di concerti in tutta la provincia, all'aperto o all'interno di sale prestigiose, cornici storiche, piazza e strade.
‘Bolzano Danza’
uno degli appuntamenti clou nell’estate culturale cittadina. Per due settimane, nella seconda metà di luglio, la città si propone come una grande vetrina artistica dal respiro internazionale. Autori di spicco della scena mondiale, compagnie nazionali e progetti speciali hanno consentito alla kermesse di diventare negli anni un punto di riferimento importante nel panorama della danza europea. Grazie al suo binomio che da sempre lo caratterizza – spettacoli da un lato, corsi formativi dall’altro – il festival è frequentato da professionisti e appassionati di ogni stile di danza, che hanno così la “scusa” per raggiungere Bolzano nel pieno dell’estate. Al cartellone di spettacoli si affiancano laboratori per i più piccoli, cui sono dedicati speciali pacchetti dedicati alla danza creativa.
‘Mercatini di Natale’
Il fascino delle città del Südtirol, è reso ancora più speciale nel periodo natalizio dalla presenza dei tanti mercatini di Natale, alcuni dei quali espongono il marchio Gallo Rosso. Per l’occasione alcune città vengono riccamente addobbate in ogni angolo ed offrono ai visitatori varie possibilità di svago e l’occasione per gustare specialità tipiche come i ‘kiachln’ e gli ‘spatzln’, buonissimi dolci e vin brulé:
Mercatino di Natale di Vipiteno:
pini e abeti sono considerati simboli della vita e della pace natalizia; se ne trovano di maestosi, decorati per tradizione con mele, noci, biscotti di panpepato e con i tradizionali addobbi in legno che li fanno aparire ancora più festosi e sfavillanti. Intorno ad ogni albero le bancarelle offrono una grande varietà di addobbi per imprezosire il vostro albero di Natale. Ci si può lasciare sedurre da profumi, dal fascino e della musica e tuffarsi nella tradizione senza fretta, semplicemente seguendo il ‘percorso prenatalizio’ predisposto per incantare, facendo appello alle sue favolose attrazioni.
Mercatino di Natale a Brunico:
qui ci si può lasciar affascinare dall’atmosfera festosa, dal luccichio e dal profumo degli abeti, assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè e del té bollente, mentre si passeggia attraverso i banchetti artisticamente decorati e le leccornie esposte, per i quali grandi e piccini impazziscono. Qui si possono gustare le specialità tirolesi come “tirtlan”, “niggilan” e patate ripiene al forno e moltissime specialità culinarie tipiche del luogo. Il commercio però non è tutto, al centro del Mercatino di Natale a Brunico si ha occasione di conoscere il vero artigianato e le tradizioni della terra: dalle decorazioni per l’albero di Natale, ai giocattoli in legno, all’oggettistica in pelle, vetro e ceramica. È con questo spirito che alcuni artigiani mostrano ogni anno ‘dal vivo’ come vengono realizzati i prodotti tradizionali dell’Alto Adige. Il cui obiettivo è rendere il periodo dell’Avvento indimenticabile e ricco di fascino.
‘Mercatino dell‘Avvento a Glorenza’:
Un alone di romanticismo avvolge il piccolo borgo di Glorenza, quando i suoi abitanti cominciano a decorarne le mura in vista del Natale ravvivato dai canti festosi di grandi e piccini, sparsi sotto i portici e fino alla piazza principale. Non mancano momenti di musica, in un borgo intriso di odori e sapori di mela, cannella e dei tradizionali dolci Lebkuchen. Le storiche mura faranno da scenario per la rappresentazione di concerti d'Avvento con cori e fiati provenienti dalla Val Venosta e dintorni.
Note:
(1) Alfredo Martinelli, “La voce del passato”, Edizioni Piccolo Tibet – 1978.
(2) Matteo Maria Boiardo, “L’Orlando Innamorato”, nuova edizione BUR 2011.
(3/4) “Agriturismo in Alto Adige e Süd Tirol: le vacanze diverse”, a cura di: Gallo Rosso – Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Catalogo 2015.
(5) Roberto Leydi, “Italia” vol.2 Documenti originali del folklore musicale europeo. – Serie Albatros-Vedette, Milano 1969.
Per tutte le altre info contenute nel testo wikipediaitalia.it
Discografia:
Jozsef Molnar, “Corno delle Alpi”, Ducale FD 334 / Lp
Coro Rhoen della Val di Non, “La Val de Non”, Ariston, ARP/Lp 14003
Coro della SAT, “Gente nostra”, RCA Pl 31300
Coro della SAT, “La montanara”, RCA NL 33115 / Lp
Coro della SAT, “Canti del Trentino”, RCA Tnl1 3100 / Lp
Coro della SAT, “Canti degli Alpini”, Emi-Odeon Lp 054-17092
Si ringraziano per la gentile collaborazione prestata: L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano; L’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi – Gallo Rosso nelle persone della dott.sa Martina Mair e dott.sa Hanni Margit di Agriturismo in Alto Adige – Südtirol.
*
 - Musica
- Musica
Sri Lanka/Ceylon : Musica e danze dell’Isola Splendente
MUSICA E DANZE DELL’ISOLA SPLENDENTE
Ceylon, che da qualche decennio ha ripreso il suo antico nome di Sri Lanka ovvero ‘Isola Splendente’, è un'isola tra le tante sperdute nell’Oceano Indiano che riporta alla memoria ‘la via del tè’ con le sue coltivazioni arrampicate lungo i pendii e l’operosità di genti affabili e cordiali che congiungono le mani all’altezza del viso, nel quotidiano saluto rivolto al sole del mattino, con l’augurio di benvenuto indistintamente a tutti gli ospiti e i turisti che vi giungono. È questo un paese che per molti secoli ha visto il fiorire di molte culture legate a diverse confessioni religiose: Induista, Buddista, Cristiana (minoritaria) e Musulmana, in stretto contatto fra loro e tutte vissute nella serenità e nella dolcezza tipica dei popoli orientali, nel rispetto reciproco dei singoli costumi tradizionali.
Il mio ricordo è quello di un’isola felice, di gente cordiale e ospitale, tuttavia quanto sta avvenendo in questi ultimi anni segnati da lotte intestine di tipo tribale che attribuisco a prese di potere religiose e di supremazia economica quasi inspiegabili, mi lascia sgomento. Malgrado ciò, il ricordo del viaggio riaccende in me una sensazione di piacevolezza incantata, di un ‘paradiso’ che la tavolozza della natura incornicia di colori: la foresta e il mare, il fiume e la montagna, gli uccelli e i le varietà di fiori che d’improvviso accendono gli alberi e le siepi ovunque si guardi. Nonché l’andare mesto dei bonzi questuanti avvolti in tuniche arancione, i pescatori di perle e le raccoglitrici di te, i tagliatori di caucciù, i grandi bufali che arano la terra e gli elefanti che trasportano gli enormi tronchi destinati alla lavorazione del legno; i bambini che fanno il bagno nei ristagni d’acqua piovana, le donne in sari multicolori, che poi è il loro abito tradizionale.
Ecco, in questa cornice meravigliosa, lontana dall’esplosione industriale ed edilizia della capitale Colombo, caotica e sovrappopolata, l’isola offre l’opportunità per un felice incontro con la sua gente ricca di spiritualità e ospitale sopra ogni cosa, ciò che rappresenta la grande l’eredità della loro antica cultura, per lo più manifestata nei fasti e negli splendori dispiegati durante le grandi festività religiose, fra le più rappresentative di tutta l’Asia e certamente le più evocate. Soprattutto quella in occasione della ‘Esala Perahera’ che si svolge a Kandy, città custode della cultura singalese, in onore della sacra reliquia ‘del dente di Buddha’, per la quale ogni anno giungono fedeli provenienti da tutto il mondo.
La musica è parte attiva nella vita culturale dell’isola a sostegno delle diverse tradizioni, alle quali pur secondo le diversificazioni delle genti disseminate dalla pianura alla montagna, alle quali tutto il popolo è chiamato a partecipare, come ci ricorda questo canto popolare:
“O Pañcasikha il passo delle vostre corde è in armonia con il tono della tua voce e viceversa, il tono della tua voce non trascende quello dei vostri accordi e viceversa”.
Il brano d’apertura dell’insieme strumentale rituale che ha la funzione di attirare buoni auspici su tutta l’assemblea riunita per l’occasione della festa, è nell’originaria lingua singalese il ‘Magul Bera’, che da inoltre il nome all’insiem e: uno o più strumenti a corde suonati con l’archetto, altri a fiato, a sonagli, e un certo numero di tamburi comunemente percossi con il palmo e con le dita delle mani.
Cosa comunemente passa oggigiorno per musica singalese non è ovviamente la musica originale che si poteva ascoltare fino a qualche decennio fa, fondata sulla musica più antica. Già nel 19° secolo, in un momento di contatto con le culture occidentali, questa era stata contaminata dalla musica indiana del Nord, introdotta per colmare il divario tra i due periodi di distacco dal mondo cosiddetto ‘civilizzato’ in ragione delle lunghe lotte intestine. La musica così introdotta si è dunque mescolata con il jazz occidentale e il rock, ma solo per rendere comprensibile il guazzabuglio che passa per essere musica singalese. L’autenticità della musica singalese per essere notata va riferita al ‘Kavi pal’ e al ‘nelun Kavi’ del contadino tradizionalista non sofisticato. Vi è attualmente uno sforzo da parte degli studiosi in questa materia che potrebbe portare all’evolversi della situazione, cioè il recupero della musica costruita sui resti della musica più antica.
Scandite dal ritmo dei tamburi, le danze singalesi sono strettamente connesse con i rituali religiosi, nelle quali i danzatori eseguono movimenti vigorosi in sequenza di giravolte e capriole nell’aria ed esibirsi nell’imitazione di questo o quell’animale tipici della fauna isolana. Un esempio originale è la ‘danza del pavone’ preso ad emblema del moderno Sri Lanka e animale semi-fantastico della mitologia locale, così detta perché nella fantasia popolare ‘il pavone’ trasporta la divinità Skanda. Un altro esempio è la danza ‘Panthero Natuma’ eseguita al suono del tamburo ‘pantheru’ che si vuole abbia accompagnato i guerrieri Sinhala nella battaglia, incitante e prorompente insieme.
Il massimo del coinvolgimento arriva con la danza detta ‘Raksha’ o ‘del diavolo’, normalmente eseguita per ultima e che crea il momento di maggiore tensione della cerimonia. È questo il momento in cui la simulazione della maschera multicolore ad esso intitolata, fa tremare tutti coloro che vi prendono parte e gli astanti che vi assistono, entrambi esorcizzati dalla possessione. Per l’occasione il danzatore ‘Raksha’ si esibisce in evoluzioni vorticose che talvolta raggiungono il sovrannaturale e che, accompagnate dal ritmo assordante dei tamburi sublimano la sua danza prorompente e violenta.
Le danze femminili sono invece tutt’altra cosa e suggeriscono quanto di più bello si presenta in natura. Ce ne sono di ‘primaverili’ legate alla stagione della fioritura; oppure sacre, esibite durante il rituale nella cerimonia di ‘donazione’ alle divinità, delle spezie e dei profumi durante la processione verso i templi maggiori. Presumibilmente importate dall’India del sud le danze singalesi insieme agli strumenti che le accompagnano fanno la loro apparizione in alcuni bassorilievi presenti nelle vestigia reali disseminate sull’isola, risalenti a prima della presenza cristiana, rintracciabili fra le rovine di Anuradhapura e nei reperti conservati nel locale Museo Archeologico.
I monaci buddisti del passato considerarono queste danze con equanimità e permisero di continuare l'adornamento dei luoghi sacri con sculture e dipinti in cui sono ritratti danzatori e musicisti, incluse danzatrici coi seni nudi. In alcuni esempi furono i monaci stessi artisti o scultori, nonché gli architetti di alcune costruzioni architettoniche come il Ruvanvǟlisǟya e Lõvamǟhǟpǟya. La maggior parte delle antiche rappresentazioni qui esistenti di musica e danza vengono da edifici religiosi. Le sculture e i disegni di musicisti e ballerini provenienti da varie parti del paese danno alcuni indizi preziosi circa la natura e le modalità delle danze, la forma degli strumenti, e di come venivano utilizzati.
In particolare in un bassorilievo trovato ad Embekke rivela l’esistenza sull’isola di un’altra danza ‘dei bastoni’ eseguita con l’utilizzo di corti bastoni di bambù che i danzatori percuotono incrociando i passi, rintracciabile anche in altri paesi dell’estremo Oriente, in Thailandia e Cambogia. I suonatori di tamburo che appaiono nei bassorilievi sono certamente i più frequenti ma non mancano suonatori di liuto, di flauto di legno, finanche di maracas e castagnette talvolta sostituite da piccoli cimbali metallici o da conchiglie; e ancora vi figura la ‘conchiglia marina’ per lo più usata per richiamo; una sorta di ‘tromba’ piccola e corta, il ‘flauto’ con tanto di testa e coda modellato sulla figura del serpente che pure si rifà ad un’altra danza rituale il cui testo recita così:
“Rimani per vedere la leggiadria sua danzare / Le fasi del ballo, i loro lunghi occhi viola / Striati di collirio, e le loro belle orecchie ornate / Con placche lucide d'oro lavorato / Tenute e ritorte con gli odorosi fiori. Le ballerine disposte , le fiamme tremolanti / Che assomigliano a lampade accese, / E che portano sulle loro membra / La lucentezza di ornamenti e gioielli / Dirigi lo sguardo di traverso sulle loro mani / Ora alzate e ora rilasciate / Nella cui cintura si piegano sui fianchi larghi r/ Dove trova riposo e diffusione d’onda il tempo. Nota tutte le bellezze delle ragazze danzanti / Il posarsi dei loro piedi di loto sulla terra / Che ad ogni battuta misurano tintinnante il suono / Col tintinnio costante delle loro cavigliere d'oro, / E l’archi di gemme sparse che circondano i loro fianchi larghi ed equi.”
Ma torniamo per un momento nella città di Kandy che, come ho già detto, è la città custode della cultura tradizionale singalese, ed entriamo nel massimo tempio buddista Delada Maligawa in occasione della festa denominata ‘Esala Perahera’. Si tratta di un grande tempio fatto di legno massiccio che il tempo ha reso più duro della pietra su cui è costruito, con ampie volte interne contenenti più piani aperti e fughe di travi e balaustre robuste, che si tengono insieme ad incastro. Forte è l’aroma di incensi profumati e delle candele di sego che si consumano all’interno, olii e resine pregiate che servono a mantenere il legno affinché non secchi e si spacchi, per cui serve una continua manutenzione cui adempiono i bonzi e gli addetti al tempio.
Di tanto in tanto il suono di un gong o talvolta di una campana a martello da il via ai ‘canti sussurrati’ delle preghiere che la sacralità del luogo accoglie con profonda mestizia. ‘Esala Perahera’ è una ricorrenza annuale buddista che evolutasi col passare del tempo di un sincretismo religioso complesso e imperscrutabile che si ripete per la durata di dieci notti consecutive senza interruzione e che termina col plenilunio d’Esala, cioè d’Agosto. In quell’occasione la sacra reliquia del ‘dente di Buddha’ è portata in processione solenne per le strade di Kandy con grande partecipazione popolare. Quella che ripropongo qui di seguito è la descrizione di una sequenza terminale della più grande festività che si tiene sull’isola in onore del dio indù della guerra Kataragama, alla luce di innumerevoli torce, allorché i ‘frustatori’ a torso nudo annunciano l’inizio della processione con lo schiocco di lunghe strisce di cuoio (appunto le fruste) che percuotono l’aria per scacciare i demoni presenti.
Nel prosieguo, al suono di flauti e tamburi avanzano a piedi i notabili seguiti dai più celebri danzatori di Kandy che si esibiscono in danze rituali. Al loro seguito giungono gli elefanti riccamente ingualdrappati che trasportano sul dorso il loro carico le cariche più alte della città con indosso tuniche completamente bianche. Il momento più emozionante è raggiunto dall’entrata del grande elefante dalle lunghe zanne d’avorio che avanza lentamente su di un bellissimo tappeto bianco che viene svolto poco a poco sotto le sue zampe. Elegantemente ‘addobbato’ e imbiancato di gesso, il grande elefante avanza lento dentro la notte anticipato e seguito da numerosi portatori di torce; ad esso è lasciata l’incombenza di recare sul dorso la cassa dorata contenente la sacra reliquia di Buddha, che ondeggia spostandosi tra i gruppi dei cantori, dei tamburini e dei flautisti che mescolano i loro suoni alle grida e al vociare gaudente degli astanti.
L’odore dell’incenso bruciato è così forte che quasi stordisce mentre s’ode qualche barrito fra i sessanta elefanti che seguono la processione, la maggior parte dei quali portano delle piccole lampadine elettriche attorno alle orecchie e lungo le proboscidi, noché di numerosi sonagli e campane intorno al collo. I lenti movimenti degli elefanti e i costumi dei danzatori ricamati d’oro e di lustrini che brillano alla luce delle torce, creano uno straordinario ‘balletto’ notturno di luci e colori. È questo il momento in cui la musica palpitante di ritmi rende la cornice ancor più suggestiva, pulsante quasi, magica. I suoni particolari degli strumenti artigianali ricavati da legni, scatole metalliche, semi e grani essiccati, dai corni di bufalo e dalla insostituibile chitarra portata sull’isola da colonizzatori, ravvivano costantemente l’atmosfera assecondando l’accompagnamento dei canti tradizionali entrati nella tradizione e secolarizzata all’interno di questa antica cultura.
Diversi riferimenti riportati nel Mahǟvamsa indicano che gran parte delle antiche danze sono di natura mimetica con risvolti di sequenze umoristiche.. Si vuole che gli dèi e i danzatori che accompagnavano il re Pandukǟbhaya fossero solo uomini. Bhatikabhaia (19 b. C. - 9 d.C.) che gli succedette, ordinò diverse danze mimiche in onore della Grande Thǘpa. Più tardi Mahǟdǟthika Mahǟnǟga (a.C. 9 -21) commissionò un certo numero di danze mimiche per completare il lavoro di Ambatthala Thǘpa e Mihintale a conferma di quanto si è detto. Da un fregio a Yapahuva si denota la rappresentazione di una divertente scenetta danzata dove il ballerino ha una mano sulla testa e l'altra sul gluteo. La particolarità di queste danze è data da un unico movimento di 'oscillazione’ da e verso la gamba destra piegata al ginocchio.
Il danzatore può qui aver accresciuto la natura ridicola della sua danza con il dondolio della testa, ma si vuole che in passato a questi danzatori particolarmente bravi così come gli strumentisti particolarmente dotati, fosse proibito lasciare l’isola affinché non si perdesse memoria della tradizione classica di queste culture. La letteratura dal canto suo fa riferimento alla musica vocale introdotta in tempi pre-cristiani, e spesso nelle canzoni si fa ricorso all'idioma nativo. Anche i versi del ‘Tunsarana’ di data recente sono cantate nella lingua dell’abitante del villaggio, che si rifà ad una melodia originaria. Questa musica cosiddetta appunto di ‘villaggio’ rappresenta il sopravvivere miracoloso di una cultura più antica che ha conservato, nonostante l'abbandono, la sua originalità e che potrebbe diventare la vera musica originale del paese.
Tuttavia non quella che avrebbe potuto essere se, a suo tempo, la musica antica fosse stata sostenuta e incoraggiata, cioè favorita dallo studio e insegnata nelle scuole. Oggi nell’epoca dei grandi mezzi di comunicazione e il logorio dei media che vanno sconvolgendo le zone più remote del paese, anche quel poco che restava dell’antica musica singalese sembra essere condannata a scomparire. Ciò nonostante e malgrado tutto quanto avviene di scontri etnici in questa parte del continente indiano, quel che rimane è ancora il fascino dell’oriente a venirci incontro con la sua naturale bellezza di benvenuto e la straordinaria ospitalità delle sue genti. In questi termini dunque, le danze, così come gli strumenti originali e la musica dei canti-poemi tramandati nella forma orale, continuano a rapire l’orecchio dell’ascoltatore.
In Sri Lanka Amaradeva è quasi un sinonimo di ‘musica’, tradotta nel suo ‘squisito’ senso migliore. La vita musicale dello Sri Lanka è dominata da questo geniale esecutore che rappresenta una confluenza dinamica del meglio della musica Orientale. Ma Amaraeva non è soltanto un musicista professionale ma, piuttosto, un genio che esulta nello sforzo creativo senza fine, per cui è essenziale re-inventare e raffinare la sua espressione musicale. Strumentalmente parlando cresce accanto al suo violino-giocattolo sul quale biascicò le prime note musicali quando era ancora nell’infanzia, al quale dedicò e si dedicò tale ardore che la musica gli è entrata nelle vene. Successivamente, suo padre fabbricò un violino appositamente per lui ed egli si nutrì di quel suono fino a fare di sé un tale incipiente talento che lo portò in età più matura al Bathkanda Institute of Music in India: un centro di pellegrinaggio fervente per aspiranti musicisti.
Per Amaredeva la musica è una lingua universale che non conosce barriere di sorta, nazionali o linguistiche. La ‘musica’, egli dice, unisce le persone e la ‘grande musica’ unisce le persone con grandezza. Nel suo record speciale che rappresenta il meglio delle liriche che lo compongono, si scontrano le vecchie e più giovani generazioni di musicisti dello Sri Lanka. Amaradeva prova sontuosamente che una traduzione raffinata di lirica in stile classico possa vincere anche per acclamazione popolare.
Come abbiamo pututo constatare nulla o quasi sembra cambiare sotto il cielo luminoso e leggendario che continua a meravigliarci con il suo esistere a contatto di una natura lussureggiante. Così come la natura è il tema di ogni composizione che, con grande semplicità continua a parlarci con la lingua semplice dei colori, del ‘cobalto’ e lo ‘smeraldo’ del mare, dei ‘verdi’ misteri della foresta, dell’ ‘opale’ scorrere dei fiumi, del sereno ‘cristallino’ defluire della vita dei pescatori e delle raccoglitrici ‘ambrato’ del tè; così come dell’amore contemplativo che si riflette nelle piccole gioie del quotidiano, che speriamo non vada definitivamente perduto. Numerose sono le ‘ninne-nanne’ tipiche che si cantano ovunque al calare del sole con le mani giunte come in preghiera, affinché il giorno risorga l’indomani, alba dopo alba, a inondare di luce questa che significativamente è conosciuta come l’ ‘Isola Splendente’.
I suoni e le danze, gli strumenti e i canti sopracitati sono in parte raccolti nei seguenti Lp cui hanno preso parte i migliori strumentisti classici:
W. D. Amaradeva, Wimala Amaradeva, Premasiri Khemadasa, Sarath Dasanayake, Somadasa Elvitigala, Sanath Nandasiri, Nanda Malini Gokula, Neela Wickramasinghe e altri.
Inoltre a registrazioni sul campo di Noel Bryan Ranasinghe e da Gerard Krémer.
“Songs & Rhythms of Sri Lanka” – Wickremesooriya & Co – Colombo Sooriya LP2
“Amaradeva Sri Lanka’s maestro of classics” - Tharanga Recording Studio Colombo, A0015
“Ceylon” – Noel Noel Bryan Ranasinghe – Arion FARN 1085 – Collana Universo del Folklore
“Musica sacra di Ceylon” – reg. dal vivo di G. Krémer – Arion FARN 1098
Collana Universo del Folklore
*
 - Musica
- Musica
Con il Popolo del Nepal/Tibet affinché nulla vada perduto.
Quaderni di Etnomusicologia XIV – Nepal e Tibet: Impressioni di Viaggio.
“Con il Popolo del Nepal e del Tibet affinchè nulla vada peduto”.
Nei giorni della spaventosa catastrofe del terremoto che sta sconvolgendo le popolazioni nepalesi e tibetane, voglio qui ricordarne l’antica cultura tradizionale, riconosciuta quale patrimonio universale dall’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la salvaguardia della memoria dell’intera umanità, attraverso un excursus musicale e canoro, ahimè limitato alla mia scarsa conoscenza della lingua, quale contributo alla conservazione del grande insegnamento che noi tutti abbiamo ricevuto e dobbiamo trasmettere in eredità alle generazioni future.
“Namaste, è il saluto cordiale che nella lingua Nepali significa: 'saluto la scintilla divina che è in te.' A chiunque abbia visitato questa regione alle pendici dell’Himalaia, non può essere sfuggita l’atmosfera decisamente particolare che vi si respira: siamo alle soglie del Tibet, paese di misticismo e di arcana magia ancora avvolto di mistero, ed il medievale Nepal, pregno di tradizioni ad esso comuni, focolaio religioso dove Buddismo e Induismo si mescolano ai non ancora scomparsi riti primitivi Bön di cui l’intera regione, ne riflette tangibilmente gli influssi”.
Così descrive l’amico Fabrizio Cassano (*), le sue ‘prime impressioni’ di viaggio in questa regione denominata ‘il tetto del mondo’ situato fra Cina e India, e da piccole appendici montuose della catena himalayana, come gli stati del Ladak, del Sikkim e del Buthan. La posizione geografica e soprattutto la morfologia del territorio (che va qui ricordato include l’Everest – Sagarmatha in nepalese, la più alta cima del mondo con i suoi 8.498 mt.), da sempre conteso fra le grandi potenze politiche Cinese e Indiana, ha fatto sì che le popolazioni di vallate anche contigue parlino dialetti e abbiano usi, tradizioni, modalità di canto assai differenti fra loro. In ognuna di queste ‘microculture’ troviamo influssi proveneinti dalle zone e dai ceppi etnici più diversi, la cui origine non è facilmente identificabile o databile nel tempo.
I nepalesi, come del resto anche i tibetani sono popoli di discendenza mongola del ceppo tibeto-burmese, di religione Induista per la maggior parte, e Buddista per la parte minoritaria. Tendenzialmente nomadi vivono per lo più in piccoli villaggi sparsi sull’altopiano himalayano costruiti ai limiti delle foreste, dove praticano la pastorizia, che rimane la loro primaria risorsa economica, assieme all’agricoltura e il turismo montano che si è andato sviluppando negli ultimi venti anni. Fatta eccezione per le piccole comunità, quali appunto gli Sherpa, adattatisi all’ambiente proibitivo in zone dell’Himalaya impossibili tali da scoraggiare qualsiasi insediamento e che oggi fanno da guida agli scalatori di tutto il mondo.
La difficoltà già esistente nelle comunicazioni interne e lo scarso interesse economico nel territorio, che pure aveva permesso a quest’area geografica di conservare una sua configurazione originaria, benchè di stampo medievale: “come un mosaico di piccoli staterelli che il tempo trascorso non ha sconvolto nel suo abitudinario quotidiano”, ha di fatto complicato nel tempo uno sviluppo omogeneo urbanistico delle aree interessate non permettendo ad esse il formarsi di un sentimento nazionale che includesse i vari gruppi presenti sul territorio.
“Nelle sterminate pietraie dei monti troverai uno strano mercato: vi puoi barattare il vortice della vita con una beatitudine senza confini.“ (Milarepa)
Per quanto fino a ieri, se si esclude la capitale Khatmandu e qualche altra piccola città limitrofa dove lo sconvolgimento etnico causato dall’arrivo di quelle popolazioni subentrate, come ad esempio la gran parte del popolo titbetano in fuga dall’oppressione esercitata dalla Cina hanno retto ai colpi di un’interazione forzata; era ancora possibile distinguere usi e costumi autoctoni rispettivi di entrambi i popoli a livello culturale e religioso, la cui tenuta assicurava una costante reciprocità comunitaria in grado di ottemperare alle difficoltà da affrontare. Ciò che oggi si pone fin troppo forte come rischio disgregante delle etnie autoctone da parte delle grandi potenze, o comunque di finire sotto una medesima autorità dominante, è l’annullamento delle antiche culture, sì da costituire una seria preoccupazione per la loro salvaguardia.
A cominciare dalla protezione delle diverse forme orali e linguistiche, fino alla custodia del loro prezioso patrimonio musicale e canoro, cui l’intervento del terremoto, forse il più forte che la storia dell’Himalaya ricordi, sta certamente contribuendo a rendere difficili se non impossibili:
“Katmandu è oggi una città devastata. L'epicentro del sisma è stato registrato tra la capitale del Paese e la città di Pokhara, una zona ad alta densità di popolazione ed edifici. Si continua ancora a scavare tra le macerie in una corsa contro il tempo per trovare qualche superstite, mentre si lavora tra quel che resta della torre di Dharahara, uno dei monumenti più importanti di Kathmandu, patrimonio Unesco. Dalle sue macerie i soccorritori hanno estratto 250 cadaveri. La torre di nove piani, alta quasi 62 metri, era conosciuta come Bhimsen Tower ed aveva già subito gravi danni durante il terremoto del 1934, ma poi era stata restaurata e riaperta al pubblico. Era il luogo in cui andare per ammirare il panorama sulla valle, simbolo della religiosità nepalese. La Durbar Square (piazza reale) di Kathmandu è rimasta gravemente danneggiata. Le fotografie che arrivano dalla piazza mostrano danni pesantissimi a molti palazzi, cortili e templi che l’Unesco definiva il cuore “sociale, religioso e urbano” di Kathmandu. Il palazzo reale Basantapur Durbar (Nautale) è in buona parte collassato. Monumenti come il tempio di Kumari e il Taleju Bhawani, tra gli altri, sono parzialmente collassati. Parzialmente distrutti anche il tempio di Jay Bageshwori a Gaushala e il templio di Pashupatinath. Sono stati riportati danni anche per quanto riguarda il complesso religioso di Swyambhunath, il palazzo di Gorkha e il grande stupa di Boudhanath. Anche le piazze reali di Bhaktapur e Patan hanno un volto spettrale, con palazzi e templi ridotti in macerie”. (cfr. L’Huffington Post 28 Aprile 2015).
“Si avverte nell’aria qualcosa di impalpabile – scrive ancora Cassano – una sensazione in principio grave e profonda che progressivamente si sovrappone alle immagini dettate da un razionalismo quasi esasperato, frutto di un certo tipo di esperienza mistica e contemplativa suggerita dalla natura stessa dei luoghi”; riflesso questo di uno sguardo che levatosi, si fa sempre più attento e quasi intimorisce davanti alla maestosità dei picchi altissimi e dei ghiacciai perenni che in qualche modo alterano l’immaginario del visitatore trasferendolo quasi, verso un ‘oltre’ agognato e irraggiungibile, se non con la meditazione e il transfer, il cui ‘mistero’ è fortemente impregnato di religiosità.
Questo il senso dei numerosi stupa (tempio-pagoda) la cui forma architettonica si vuole abbia avuto origine in questi luoghi, e il cui significato è rappresentativo di quanti raccolti in preghiera levano le mani verso la ‘santità’ dell’eletto, illuminati dalla ‘conoscenza suprema’:
“Questa montagna innevata è l'ombelico del mondo, un luogo dove danzano i leopardi delle nevi. La vetta della montagna lapagoda delle trasparenze cristalline è la bianca e scintillante dimora di Dhemcog.” (Milarepa)
Pur essendo uno Stato di dimensioni medio-piccole, il Nepal presenta una notevole varietà di climi ed ambienti naturali, comprendendo territori che spaziano dalla pianura del Gange alla catena montuosa dell'Himalaya. Tre dei quattordici 'ottomila' del pianeta sono interamente compresi in territorio nepalese: il Dhaulagiri, l'Annapurna ed il Manaslu. Altri quattro sono invece condivisi con la Cina: l'Everest, il Lhotse, il Makalu ed il Cho Oyu. Infine il massiccio del Kangchenjunga è condiviso con l'India insieme a numerose altre che superano i 7000 metri. La lingua ufficiale parlata in tutta l’area geografica è il Nepali d’origine sanscrita, inoltre ad alcuni dialetti originari di zone a più bassa intensità di popolazione, come il Newari tipico del gruppo Newars.
Tutto il territorio idrografico del Nepal trae origine dallo scioglimento delle nevi dei ghiacciai e nevai della catena dell'Himalaya, e talvolta addirittura dallo stesso altopiano del Tibet che, conseguentemente tributa la sua portata d'acqua al bacino del Gange. Questo per la necessità contestuale di suddividere il territorio almeno in due aree di influenza (in realtà sarebbero molte di più) e di condivione della cultura musicale e vocale che si estendono da est a ovest presenti in Nepal: quella cosiddetta del Gange, dove più sono evidenti gli influssi indiani; e quella sub-himalayana o tibetana tesa alla ricerca e all’ascolto di una ‘realtà’ diversa ricca di suggestioni e di messaggi trascendentali.
Come pure scrive Giovanni Monti (**):
“E durante questo giro finalmente senti quello che non riuscivi a sentire, comprendi e ammiri questo popolo che vive su una terra che non gli può dare niente; che ha poco ed è stato privato anche di quello, ma ha una dignità di vestire e vivere come un principe le occasioni per ribadire il suo credo e le sue tradizioni; indomito pur se oppresso, comprendi nello stesso tempo che nonostante freddo, fame, fatica e mal di montagna, questo sarà veramente, anche per te, il viaggio della vita”.
Considerando la forte influenza tibetana custodita in estremo isolamento per migliaia di anni sulle altitudini elevate dell’Himalaya ed entrata nei costumi religiosi nepalesi, non possiamo scindere da ciò che rappresenta la devozione sciamanica e tantrica dei monaci tibetani che fa parte della loro iniziazione religiosa. Tradizionalmente i monasteri buddisti, i grandi centri del sapere e dell’arte, presentano una cultura musicale certamente unica, strettamente legata a uno stile rituale diverso da quello rintracciabile in altre civiltà e in altre culture. Da una parte abbiamo il buddhismo tantrico, suddiviso in varie scuole di pensiero: l’Hinayana (piccolo sistema); il Mahayana (grande sistema); il Vajryana (veicolo adamantino o tantrico, intesi come veicoli per attraversare il fiume delle reincarnazioni e giungere sulle rive del Nirvana. Ed è a quest’ultimo che le ‘sette’ stanziali dell’Himalaya aggiunsero i riti magici e le stregonerie appartenenti alla precedente religione etnica Bön di tipo sciamanica, citata dall’amico Cassano.
Oggi sparse nel mondo esistono molte ‘sette’; una in particolare detta dei Nyingmapa dai ‘berretti rossi’ (gli Anziani) spesso in contrasto con i Gelugpa (i Virtuosi) dai ‘berretti gialli’ i cui monaci fanno voto di castità, alla quale appartiene il Dalai Lama che esercita il potere temporale, riconosciuto dalle molte popolazioni che abitano nelle regioni del Tibet e del Nepal, dove i monaci vivono per lo più nei monasteri o quello che resta di essi, con a capo un ‘Tulku’, cioè un monaco ‘reincarnato’ che ha scelto di tornare sulla terra per aiutare gli altri monaci nel loro accompimento. Prima che questi muoia, lascia le indicazioni per individuare il fanciullo nel cui corpo si reincarnerà il lama defunto, il quale, una volta individuato il fanciullo viene condotto nel monastero per essere opportunamente educato.
"Inginocchiati dove altri si sono inginocchiati, perché Iddio è presente dove tutti hanno pregato" (Ramakrihna)
Va qui considerato che rimane assai difficile per il ricercatore che non conosca profondamente suddetta cultura e nemmeno la lingua (poiché una comunque non basterebbe), rintracciare il cardine di smistamento delle diverse culture. Pertanto il fine che qui di seguito propongo è di accostamento a quell’unica cultura universale che accoglie in sé tutte le forme distinguibili: la musica.
“La musica ritenuta ‘sacra’ è parte dell’iniziazione dei monaci. Il novizio infatti, nei primi anni di vita monastica, viene adibito a funzioni minori, tipo quella di servire il tè; in seguito alla sua promozione diviene suonatore del ‘grande tamburo’, utilizzato nelle cerimonie e le processioni per ritmare il passo di marcia; quindi potrà suonare le ‘grandi trombe’ telescopiche, e più tardi gli ‘oboi’. Nel cerimoniale tibetano, detto ‘puja’, la funzione combinata della musica e del canto è essenziale. Per questo fin dalla più tenera età i monaci coltivano la propria voce al fine di emettere suoni molto bassi e in un modo assai particolare in modo da poter raggiungere qualità vocali rimarchevoli. Nel tantrismo infatti l’elemento sonoro e il soffio sono le energie fondamentali creatrici dell’universo. Per questo viene attribuita grande importanza ai ‘mantra’, sorta di formule sacre che solo pronunciate, permettono di penetrare l’’assoluto’. Tali formule sono scritte su rotoli di pergamena che i monaci legono durante il cerimoniale. Il mantra è ritenuto una parte del potere divino e la sua pronunciazione conferisce ai monaci un potere soprannaturale.”
La narrazione cui sopra è parte di note contenute in una raccolta di ‘fotografie sonore’ registrate sul campo da Gérard Kremer. (***)
Quella qui sotto riportata è stata effettuata nel tempio nepalese di Swayambunath, vicino Katmandu: “Un monaco all’alba è raccolto in preghiera all’interno del tempio le cui pareti sono ricoperte da pitture su tessuto ‘tankas’ e da immagini simboliche di forma circolare ‘mandala’, e pronuncia le formule sacre dette ‘mantra’, quindi lancia un richiamo sonoro continuo prodotto per mezzo di grosse ‘conchiglie marine’ forate, agli altri monaci per invitarli a raccogliersi in preghiera intorno a lui. Il cerimoniale dura circa tre ore e viene interrotto a metà per servire il tè tibetano (salato e mescolato con burro di yak) insieme a una specie di pane. Inoltre vengono usati due tamburi a due pelli denominati ‘rna’ appesi come due ‘gong’, dei ‘cimbali’ scavati semisferici ‘rollmo’ che rimandano un suono più o meno modulato dal movimento delle mani, e una campanella ‘drill-bu’ famosa per la purezza del suo timbro. Nel corso della cerimonia ci si sposta all’esterno dove i monaci usano suonare due ‘trombe’ lunghissime almeno tre o quatrro metri, di rame rosso rivestito d’argento.”
Diversamente il rituale raccolto da Fabrizio Cassano a Khatmandu nel piccolo tempio induista alla Lamaseria di Bodanath: “Qui, al termine della giornata, numerosi sono i nepalesi che dedicano una parte della serata alla preghiera: c’è chi preferisce raccogliersi in solitudine, mentre altri invece preferiscono farlo in setta comune. In entrambi i casi la musica è l’elemento indispensabile alla recitazione dei versi liturgici che, per l’occasione vede l’uso di un ‘armonium’, una ‘tabla’ e varie coppie di ‘cimbali’. Il canto serale è solitamente di ringraziamento, non solo verso la divinità strettamente invocata, quanto verso tutti gli dèi, in un abbraccio corale senza limiti. Preludio all’azione sacra è la purificazione del sito, cioè l’eliminazione di tutte le forze e di tutti gli influssi negativi che possono impedire il compimeto del rituale o offendono la sacralità del luogo. (..) Verso le ore 18.00 il ‘tamburo grande’ risuona chiamando a raccolta i monaci al tempio che riunitisi danno avvio all’atto di culto collettivo scandito da strumenti appositi alla liturgia che accompagnano il canto: alcuni ‘tamburi su pertica’ ‘lag rna’ o ‘rna c’un’, ‘trombe lunghe’ di tipo telescopico ‘raag duun’ e piatti larghi in coppia ‘sbug tshal’.”
“Il rituale è così suddiviso: s’inizia con preghiere ‘gsol k’a’ rivolte alle divinità; devozioni per i ‘gsin po’ equivalenti dei defunti; e altre preghiere di cui beneficiano coloro che hanno accumulato un ‘karma’ peccaminoso ‘bson-smon’. A cui segue il culto vero e proprio introdotto dalla solenne declamazione della triplice formula detta del ‘rifugio’ nel Buddha, nella Dottrina, nella Comunità; poi vengono ripetuti: il voto di aspirazione all’illuminazione e il riconoscimento delle ‘quattro immensità’. Seguono l’atto di venerazione, l’offerta alla/e divinità, il riconoscimento delle proprie colpe, l’espressione di giubilo per le buone azioni compiute dalle creature e dai Buddha di predicare la dottrina, la preghiera di Bodhisattva di rinunciare al loro ingresso nel Nirvana, e di continuare l’opera di redenzione nel mondo e di far partecipare tutti gli esseri viventi al frutto delle loro buone azioni”.
Diversi sono gli strumenti usati nelle feste popolari e nelle processioni rituali, ma anche nella vita quotidiana durante i giorni di mercato, ad esempio dai venditori di ‘sarinda’ (sorta di ragni commestibili), ma che è anche il nome di uno strumento musicale che viene proposto ai pellegrini che salgono ai templi, di cui Cassano inoltre ci racconta:
“Salendo verso lo Stupa di Swanayampur si è verificato l’incontro con un cantastorie girovago dal nome indiano ‘baul’, esecutore delle storie del Ramayana, l’epopea classica induista, ne approfitta per ironizzare sui costumi che in Nepal regolano i rapporti prematrimoniali. Il canto, divenuto una sorta di ballata popolare e che andrebbe affidato a una coppia di voci che si alternano a seconda le necessità del testo”:
“Quanto sei bella, / gli dèi ti hanno creato / e tua madre ti ha cresciuta, / ma chi ti ha donato quei bei vestiti che indossi? Tu invece non sei bello, / perciò non farmi di queste domande / ed evita ogni commento su di me. Come ti chiami? Dov’è la tua casa? Sita (divinità moglie di Rama) è il mio nome, / ma se vuoi sapere dove abito, / rischi di metterti nei guai. Sono un guerriero, / il mio nome è Rama (sposo divino di Sita) / e la mia casa sta ad Ajudhya (Nord dell’India). / Se il tuo nome è Sita e tu lo vuoi, / ti porterò laggiù con me. Posso essere tua, / ma solo se tu mi sposi, / mangerò nel tuo stesso piatto / e verrò a vivere con te. Sposarti sì, ma senza corteo né fasti, / altre donne sarebbero felici / di venire con me anche senza sposarmi, / ma tu mi piaci più di loro, / così ti metterò il ‘sindur’ (polvere di colore rosso che l’uomo appone sulla fronte della giovane moglie all’atto del matrimonio) / con grande rispetto. / E ti chiamerò Sita / quando ti affaccerai alla finestra.”
Un brano strumentale conosciuto col titolo “Come è bello il tuo volto” figura tra quelli più esegui durante le cerimonie nuziali la cui origine Newari, riporta alla cultura Newars presente in Nepal, offre qui l’occasione per introdurre un elemento musicale di grande rilevanza: la ‘banda’. Proprio come avviene in India, anche qui le famiglie, per celebrare un matrimonio, fanno intervenire un insieme bandistico per rallegrare gli invitati e tutta la comunità per tutta la durata dei festeggiamenti:
“Il primo giorno, al suono di clarini, trombe, tromboni ‘raag dunn’, tamburi ‘tabla’, tamburelli ‘chakra’, cimbali, piatti e sonagli vari ‘sbug-tshal’, la banda è in uso recarsi in corteo, seguita dagli invitati, dalla casa del promesso sposo a casa della ragazza dove s’intratteneva per qualche tempo nell’allegria generale. Percorso che rifarà il giorno dopo in senso inverso, onde prendere parte alla cerimonia vera e propria. Questi cortei arrivavano un tempo a coinvolgere un numero illimitato sia di musicisti che di partecipanti e più spesso l’intero villaggio. Lo spunto di questa usanza è presumibilmente tratto dalla festa in onore di Mahakali ‘il Guardiano della Legge’.
Annota Stefano Castelli (****) che: “L’area centrale sub-himalayana, che ospita i gruppi Newari e Tamang, è da sempre considerata il centro culturale e politico del paese: qui troviamo le città imperiali di Bhadgaon, Patan, Kathmandu, qui l’importante tempio hindu di Pasupatinath e lo stupa buddhista di Swayambh (oggi sembra distrutti), meta di molti pellegrinaggi proveneitni anche dal Tibet e dalla lontana Cina. Qui è naturalmente presente una grande varietà di temi, di modalità di canto, di tipi di scale, da quelle pentatoniche cinesi a quelle di sole sette note dei ‘raga’ indiani, introducendo nuove note di passaggio e nuove combinazioni nei canti ancorati alla tradizione più antica, quasi tribale, nella quale il soprannaturale e il magico si presentano come sottofondo costante a ogni azione della vita quotidiana. Il confronto non è mai con il nemico di classe, bensì con un oscuro mondo di spiriti; il desiderio di protezione fa sì che il monaco sia al vertice della scala sociale. Anche le canzoni d’amore sono permeate da questo sentimento del mondo, come lo sono le modalità di canto.” “Come di consueto, nei luoghi ove il potere ha la propria sede il contrasto fra coloro che lo detengono e le classi subalterne viene naturalmente accentuato, con tutte le conseguenze di ordine culturale che da ciò discendono: ed il cantare di questa zona mette in luce piuttosto gli sviluppi storici e sociali vagliati criticamente più di quanto non faccia quello di una località più isolata. Vicini ad una capitale inoltre, a causa dei commerci e dei pellegrinaggi, gli apporti culturali sono decisamente più diversificati e intensi. Si comprende allora come la recitazione ipnotica di un ‘mantra’, la sua struttura ripetitiva e orecchiabile, che tendeva all’ascolto di una realtà ‘diversa’, sia oggi divenuta appannaggio quasi esclusivo di gruppi di professionisti, pagati per suonare una realtà folklorica sclerotizzata dentro ‘canzoni da divertimento’ ormai lontana da coloro che ne sono stati i creatori. E privilegi il fatto sociale rispetto a quello più specificatamente musicale, che diventa comprensibile soltanto alla luce dei perché di una musica che un tempo coinvolgeva la totalità dell’individuo, quali il bisogno di comunicare qualcosa di spirituale o ancora, per raggiungere, attraverso di essa, la comprensione di realtà trascendentali.”
I testi qui sotto riportati sono traduzioni di autentiche liriche nepalesi trascritte e tradotte da originali in sanscrito-tibetano da Stefano Castelli. La lingua usata è letteralmente corrotta e deformata a fini spesso umoristici dal cantore:
“Padma Sambhava” Padma = Loto / Sam = Parole dolci / Bahva = Essere, idea; il racconto ripete il nome del fondatore e diffusore del Lamaismo, nell’VIII sec. D.C., forse la più importante figura dopo Gautama nella religione lamaista del Nepal:
«Padma Sambhava non può mangiare / perché tutti gli portano / incenso e fiori, / ma niente cibo./ Anche quando qualcuno / gli porta offerte di riso / e cose buone / i preti, dicendo ‘Hum Ha Hum’ (invocazione sacra Buddhista), / se le mangiano tutte loro.»
La storia di Padma Sambhava, personaggio molto caro alla tradizione popolare, è un classico ‘mantra’ (nenia-preghiera religiosa) con evidenti scopi ironici che, lungi dall’apparire una figura austera, è portatore di una sorta di humor tipico della cultura contadina, umana e religiosa insieme che, nel momento in cui la classe sacerdotale acquista il potere secolare, in netto contrasto con la predicazione del Maestro, la combatte demitizzandola. Solitamente narrata dalla voce di un Lama, la storia si sposta dalla sua nascita mistica fra i petali del fiore di loto, alla sua adozione da parte del re di Passim, alla sua cacciata dalla corte, fino al suo trionfo ed ai suoi miracoli.
“Jhayangri” (Terapia sciamanica); ripete le formule della terapia sciamanica in uso nel quadro religioso-culturale del Nepal, dove gli Jhayangri occupano un posto a sé, poco note alla cultura occidentale. Una sorta di presenze strane, inafferrabili soprattutto a causa della loro vita solitaria, degli atteggiamenti di netto rifiuto che assumono nei riguardi di chi li avvicini, specie se con intenti di studio, sembra per non farsi rubare il potere magico, e infine a causa della riluttanza degli informatori locali a parlare di questi argomenti che definiscono ‘pericolosi’ senza tuttavia darne una spiegazione. Sono taumaturghi-asceti vaganti per le montagne, portatori di un singolare patrimonio culturale, in parte mututato dalle culture sciamanico-animiste presenti nel Tibet occidentale, in parte autoctono, presenti come un momento di accentuato sincretismo creatosi attraverso il ‘ponte’ della civiltà Malla che regnò sulla parte occidentale dei due paesi dall’ XI° al XIV° secolo).
Inoltre alle succitate qualità, si riconoscono influenze indiane ed altre provenienti dalla zona del Ladakh e del Kashmir. La terapia Jhayangri si basa su quella più antica dei Bön sugli spiriti del bene ‘pho.lha’ e del male ‘dGra-lha’ coesistenti in ogni essere umano, fuggenti da difese volute dal Cielo contro le malvage influenze dei ‘Klu’, dei ‘gNyam’, dei ‘Sa-bdang’ ed in generale di tutti i demoni e spiriti della terra e dell’acqua, infatti (il ‘dGra-lha’, lo spirito nemico non è necessariamente negativo, anzi è un complemento indispensabile a quello del bene. Si pensi al Tao. Quando i due spiriti protettori se ne vanno dal corpo per una qualsiasi ragione, allora la persona si trova esposta alle malattie. Lo sciamano in questi casi agisce chiamando il proprio spirito amico ‘lha’ per farsi indicare i colpevoli e richiamare nel corpo la coppia protettrice. Per i Jhayangri lo spirito benevolo è quello che vive nel loro grande tamburo ‘dyangro’, aiutato se necessario dal suono di ‘gong’ e ‘cimbali’, il che segna una differenza molto importante fra questa ed altre cure sciamaniche nelle quali viene utilizzato soltanto il piccolo tamburello Sivaita ‘danaru’.
Questa forma di magia non possiede le formalizzazioni rituali di altri ‘sistemi’, non essendo stata istituzionalizzata e assorbita da religioni di stato; come per esempio lo è stato il Bön da parte del Lamaismo e del Padmaismo, e forse per questo, e grazie ai numerosi innesti culturali, ha mantenuto una vitalità e una forza espressiva uniche nel proprio genere. Il Jhayangri non cade quasi mai in trance profonda ma, con fluidità, si sposta di continuo dal mondo materiale a quello spirituale, sempre attentissimo ai minimi segnali che possono giungergli da ognuno di questi due mondi, adottando varie tattiche a seconda delle necessità.
All’inizio si limita a chiamare il proprio spirito guida con il ‘dyangro’, poi, non sembrandogli ciò sufficiente, soffia del ‘prana’ (soffio vitale) infuocato sul malato con istrionismi da mangiafuoco. Dopo una trance più lunga delle altre, decide di aiutare il ‘dyangro’ con un piccolo gong legato sotto l’ascella e con vari cimbali e sonagli legati sul corpo, mimando l’avanzata dei bellicosi spiriti del bene per intimorire i maligni che hanno preso possesso del corpo del malato.
Leggiamo qui di seguito il contenuto di due canzoni d’amore dei Tamang delle colline. Nella prima, intitolata ‘La Rani della Jungla’ si narra (in prima persona) la storia del protagonista che cammina nella foresta e si guarda intorno:
"La Rani della Jungla": Che se guarda in alto vede una giungla oscura, mentre in basso non può vedere niente a causa del buio e della vegetazione. C’è un fiume e l’acqua che scorre, e lui vede, in alto come una visione di donna e se ne innamora. È la ‘Rani’ della jungla e volgendosi dalla parte dell’Himalaya la scorge ancora e ancora, sopra la montagna, sotto un albero ecc.. Ma il suo amore non ha speranza perché egli è un semplice uomo mentre lei è una divinità della foresta. Accade così che per amore di lei gli si spezza il cuore e nessun sarto lo potrà ricucire.
"Canzone d’amore del montanaro", in essa si narra di un montanaro che andando in pellegronaggio sulle vette innevate e impervie dell’Himalaya non sa se gli spiriti dell’aria lo lasceranno tornare vivo al proprio paese d’origine. Perciò pensa di ravvisare la sua innamorata del suo possibile ritorno con le parole che seguono:
“Se non muoio prima , timanderò una lettera / nella quale metterò il mio ritratto / e vedendolo tu sarai felice / e (spero) il tuo cuore sarà felice.”
I brani che seguono (tradotti dalla lingua Nepali) appartendono a una stessa cultura: il primo ripropone il tema tipico del corteggiamento amoroso, d’appartenenza dei Jhyaure della regione Newari (Nord di Khatmandu), dal contenuto divertente che i nepalesi utilizzano per ballare e cantare insieme nelle case soprattutto la sera, dopo una giornata di lavoro, per andare a letto contenti.
"Lhasa Gita" - Jhyaure serale: “Sono un tibetano che vive (va) a Lhasa, / io non so niente e non so danzare, / e non so suonare il tamburo. / Non ti posso dare cesti pieni d’oro, / ma se tu vuoi puoi darmi il tuo cuore puro. / Se vorrai venire con me, / io ti regalerò tutta la mia vita.”
"Jhyaure del Dharma" (legge morale): Si usa cantare durante la stagione delle pioggie per passare il tempo durante le lunghe giornate in cui non si può lavorare. Al solito tema del corteggiamento si aggiungono in alcune versioni due strofe che avvertono ironicamente:
“..di non badare troppo alle ragazze, / perché se non si segue il Dharma / e se non si prega abbastanza, /si andrà certamente all’inferno.”
Il canto successivo ancora in nepali, suona come un programma libertario, le parole sovrapposte alla musica di un precedente canto di ispirazione nazionalista che riferiva come, in tempi remoti, il Nepal avesse potuto conservare la propria indipendenza grazie al sovrannaturale intervento di Krsna che difese il paese dalle invasioni di re indiani desiderosi di conquiste. Il nuovo testo sulla falsariga dell’altro invece, racconta:
"Sunna na sunna na": “Ascolta i miei fratelli dei villaggi, / c’è un despota che opprime la gente / giorno e notte, / e per questo la gente soffre. / Per causa sua la gente è affamata, / e vuole ch’egli se ne vada, / perché vuole essere libera./ Bisognerebbe invece essere tutti uguali, / e distribuire in parti uguali le fatiche, / la terra e il pane, / e i risultati del lavoro, / in modo che tutti abbino a mangiare bene, / che si riposino e siano felici.”
“Se sapessimo che siamo destinati a diventare ciechi stanotte, dedicheremmo un autentico ultimo sguardo a ogni filo d'erba, a ogni nuvola, a ogni granello di polvere, a ogni arcobaleno, a ogni goccia d'acqua: a ogni cosa.” (Pema Chödrön)
"Non voltarti, non distrarre la tua mente. E tutto quello che penserai e dirai, sia quello che hai conosciuto da te stesso. Non voltarti.." (Milarepa)
Con l'augurio di ritrovare presto la felicità invocata nel canto, abbraccio le popolazioni dell’Himalaya e le ringrazio per il loro altissimo contributo culturale. Saluto inoltre tutti coloro che in questi giorni si prodigano negli aiuti umanitari e contribuiscono alla salvaguardia del patrimonio monumentale e culturale di questo paese con le parole di un grande viaggiatore italiano:
«Qualcuno mi ha domandato che cosa interessa a noi del Nepal. Ed io rispondo: dove c'è un uomo, uno solo, lì siamo anche noi, dove c'è memoria di un passato lì troveremo la modulazione nuova delle stesse illusioni, l'inveramento diverso, ma non discordante, degli archetipi dello spirito umano.» Giuseppe Tucci - “Nepal: alla scoperta del regno dei Malla”
Note e discografia:
(*) Stefano Cassano – “Impressioni di un soggiorno in Nepal”, Ducale FD 353
(**) Giovanni Monti – aviatore e viaggiatore italiano in Wikipedia, alla voce “Milarepa”.
(***) Gérard Kremer – “Musiche Sacre dei Monaci Tibetani”, Arion FARN1054
(****) Stefano Castelli – “Canti Popolari Nepalesi”, Albatros VPA 8383
E inoltre: Deben Bhattacharya – “Song and Dance from Nepal”, Argo ZFB 92 Peter Crossley-Holland – “Tibet vol.1/2” – Albatros VPA 8449
"Tibet: The Monastery Monks", A World of Music - CD MAW 020
"Tibet & Mongolia - suoni e misteri dal cuore dell'Asia" - Collana Musiche dal Mondo - CD Amiata Records
Bibliografia:
Karna Sakya e Linda Griffith, "Fiabe di Kathmandu" - Arcana Ed. 1988
Clifford Thurlow, "Fiabe Tibetane", Arcana Ed. 1986
*
 - Musica
- Musica
‘Orsù, ben venga Maggio…’ la tradizione in Italia
“Ecco il ridente Maggio
ecco quel nobil mese
che viene a dare imprese
ai nostri cuori.
È carico di fiori
di rose e viole
che fa risplender al sole
ogni riviera”. (1)
‘Calendimaggio’ o anche ‘Cantar Maggio’ è la festa che ancora oggi riversa nel risveglio della natura l’aspettativa umana del bel tempo e dell’arrivo della buona stagione dopo il freddo e le avversità dell’inverno. Viene ricordata con questo nome con iniziative diverse in ogni nostra singola regione e in alcune regioni europee come simbolo della rinascita primaverile, e sono spesso gli alberi (ontano, maggiociondolo) che accompagnano i ‘maggerini’ e i fiori (viole, rose), citati nelle strofe dei canti, e con i quali i partecipanti si ornano. In particolare la pianta dell'ontano, che cresce lungo i corsi d'acqua, è considerata il simbolo della vita ed è per questo che è spesso presente nel rituale. Tuttavia trattasi di una festa testimoniata nel floklore dalla sopravvivenza di culti agrari di fertilità e come allegoria di più antichi riti pagani riferiti alla fecondità. Si tratta di una celebrazione che risale a popoli dell'antichità molto integrati con i ritmi della natura, quali Celti, Etruschi e Liguri, presso i quali l'arrivo della bella stagione rivestiva una grande importanza:
L’uso di ‘piantare il maio’ o ‘il maggio’ apriva la porta “..all'Equinozio del Primo Maggio già verso la fine di Aprile. Per San Giorgio (23 Aprile) era usanza presso gli Slavi della Carinzia guarnire un albero tagliato alla vigilia e portarlo in processione insieme con un fantoccio (che poteva essere anche un fanciullo), ricoperto dalla testa ai piedi di fronde di betulla, anche detto il Verde Giorgio. L'albero veniva gettato poi nell'acqua affinché procurasse pioggia e quindi favorisse la crescita dei frutti e del foraggio. Anticamente le festività coprivano un ampio periodo comprendendo anche banchetti e notti danzanti. (..) La notte del 30 aprile si susseguivano in un'atmosfera orgiastica, banchetti e danze che terminavano con l'espulsione rituale dei morti, ovvero con l'avvento della «nuova vita». Sulla notte vegliava la Grande Madre della fertilità che dominava allo stesso modo il destino dei semi e quello dei morti” (2).
“Ben venga Maggio, e Maggio ll’è venuto
eccolo Maggio arrivar pian piano
con l’acqua in grembo e lle mezzine ‘n mano;
eccolo Maggio, fa fiorì lle zucche
date marito alle belle, datelo alle brutte;
fiore di Maggio, fiore di gaggìa
siete i più belli che nella festa sia”. (3)
“Il Cosmo è simboleggiato da un albero; la divinità si manifesta dendromorfa; la fecondità, l'opulenza, la fortuna, la salute - o, a uno stadio più elevato, l'immortalità, la giovinezza eterna- sono concentrate nelle erbe e negli alberi; la razza umana deriva da una specie vegetale; la vita umana si rifugia nelle forme vegetali quando è interrotta innanzi tempo con malizia; in breve, tutto quel che «è», tutto quanto è vivente e creatore, in uno stato di continua rigenerazione, si formula per simboli vegetali. Il Cosmo fu rappresentato in forma di Albero perché, come l'albero, si rigenera periodicamente. La primavera è una risurrezione della vita universale e di conseguenza della vita umana. Con quest'atto cosmico tutte le forze di creazione ritrovano il loro vigore iniziale; la vita è integralmente ricostituita, tutto comincia di nuovo; in breve, si ripete l'atto primordiale della creazione cosmica, perché ogni rigenerazione è una nuova nascita, un ritorno a quel tempo mitico in cui apparve per la prima volta la forma che si rigenera.” (4).
Così ‘Piantare il Maggio’ era significativo dell’appendere un ramo verde d’innanzi alle case delle fanciulle cui si voleva rendere omaggio, solitamente da parte dei giovani che s’accompagnavano con strumenti e canto:
“Siam venuti a cantar Maggio
e qui siam venuti e qui cantemo.
Ragazzette che dormite
sulle piume riposate
le finestre vostre aprite
c’è la luca a farvi luce.
Ragazzette pomposelle
che di festa vi vestite
vi mettete le sottanelle
di tre sorte ricamate e tre colori.
. . .
Ecco Maggio rose e fiori”. (5)
Per l’occasione della festa era in uso nominare la ‘Regina di Maggio’, la ‘Regina dei Fiori’ o spesso la Coppia Sacra: il Re e la Regina che aprivano la processione questuante e benedicente insieme all'Albero di Maggio decorato. I riti primaverili prevedevano che si recitassero ‘i maggi’ in forma poetica o di brevi rappresentazioni teatrali sul tema dell’amor cortese abbinato a due melodie dal ritmo piuttosto marcato e allegro, con la prima ripetuta due volte, a svolgere la funzione di ritornello. È il caso di ‘Kalenda Maya’ scritta in lingua d'oc, parlata nel XII secolo nella Francia del sud, la Provenza. Il testo è del trovatore provenzale Rambaut de Vaqueiras: (6)
'Kalenda Maya'
Ni fueills de faia
Ni chans d'auzell ni flors de glaia
Non es qe.m plaia,
Pros dona gaia,
Tro q'un isnell messagier aia
Del vostre bell cors, qi.m retraia
Plazer novell q'amors m'atraia
E jaia,
E.m traia
Vas vos, donna veraia,
E chaia
De plaia
.l gelos, anz qe.m n'estraia.
Calendimaggio
nè foglie di faggio
nè canti di uccelli, né fiori di gladiolo
mi sono graditi,
o nobile e felice signora,
finchè io non abbia un rapido messaggero
della vostra bella persona a raccontarmi
nuovi piaceri porteranno Amore
e gioia;
e mi reco
da voi, vera donna,
e lasciatemi schiacciare
e colpire
il geloso, prima che io parta da qui.
Ma bell'amia,
Per Dieu non sia
Qe ja.l gelos de mon dan ria,
Qe car vendria
Sa gelozia,
Si aitals dos amantz partia;
Q'ieu ja joios mais non seria,
Ni jois ses vos pro no.m tenria;
Tal via
Faria
Q'oms ja mais no.m veiria;
Cell dia
Morria,
Donna pros, q'ie.us perdria.
Mia bella amica
per Dio non sia
che uno fuori per la gelosia mi derida a mio danno
otterrebbe caro prezzo
per la sua gelosia
se ci fosse come da separare due amanti;
da allora non sarei mai felice un'altra volta
nè conoscerei felicità senza di voi
prenderei
una strada tale
da non essere mai visto da uomini ancora;
quel giorno in cui ti perdo
morirò,
donna coraggiosa.
Con er perduda
Ni m'er renduda
Donna, s'enanz non l'ai aguda
Qe drutz ni druda
Non es per cuda;
Mas qant amantz en drut si muda,
L'onors es granz qe.l n'es creguda,
E.l bels semblanz fai far tal bruda;
Qe nuda
Tenguda
No.us ai, ni d'als vencuda;
Volguda,
Cresuda
Vos ai, ses autr'ajuda.
Come potrei perdere
o ritrovare
una donna, prima di averla avuta?
nè un uomo nè un amante
è così solo per immaginazione;
ma quando un corteggiatore si trasforma in amante
grande è l'onore che ha accumulato,
tale è la fama prodotta da un dolce sguardo;
nuda
non vi ho ancora tenuta
mai, nè altri ti hanno vinto;
vi ho desiderata
obbedita,
senza alcun premio.
Tart m'esjauzira,
Pos ja.m partira,
Bells Cavalhiers, de vos ab ira,
Q'ailhors no.s vira
Mos cors, ni.m tira
Mos deziriers, q'als non dezira;
Q'a lauzengiers sai q'abellira,
Donna, q'estiers non lur garira:
Tals vira,
Sentira
Mos danz, qi.lls vos grazira,
Qe.us mira,
Cossira
Cuidanz, don cors sospira.
Proverei difficilmente gioia
se mi separassi da voi
mio Bel Cavaliere, nella disperazione,
da quando non si rivolge da nessun altra parte
il mio cuore né mi lascia andare via
il mio desiderio, perché non desidera altro.
I lusinghieri, lo so, sarebbero soddisfatti,
mia donna, altrimenti non troverebbero pace.
Un uomo tale vedrebbe
ascolterebbe
la mia disavventura, che sarebbe indetta per voi per questo
perché lui vi guarda
e considera
nella sua presunzione, per cui il mio cuore sospira.
Tant gent comensa,
Part totas gensa,
Na Beatritz, e pren creissensa
Vostra valensa;
Per ma credensa,
De pretz garnitz vostra tenensa
E de bels ditz, senes failhensa;
De faitz grazitz tenetz semensa;
Siensa,
Sufrensa
Avetz e coneissensa;
Valensa
Ses tensa
Vistetz ab benvolensa.
Così gentilmente fiorisce
splendendo sopra a tutto,
nobile Beatrice, e così gentilmente cresce
la vostra virtù;
secondo me
la vostra signoria è adornata con ricco
e giusto discorso, senza dubbio.
Voi siete la fonte di graziose gesta;
sapienza,
grazia
avete,con conoscenza;
virtù
impossibile da contraddire
voi vestite con gentilezza.
Donna grazida,
Qecs lauz' e crida
Vostra valor q'es abellida,
E qi.us oblida,
Pauc li val vida,
Per q'ie.us azor, donn' eissernida;
Qar per gencor vos ai chauzida
E per meilhor, de prez complida,
Blandida,
Servida
Genses q'Erecs Enida.
Bastida,
Finida,
N'Engles, ai l'estampida.
Graziosa donna,
ognuno prega e proclama
la vostra virtù, che dà un tale piacere;
e colui che ti dimentica,
giudica poca cosa la vita
e così io vi adoro, distinta donna;
da quando vi ho scelto come la gentilissima
e la migliore, virtuosa signora,
vi ho blandita
e servita
voi più gentilmente di quanto Eric fece con Enid.
Ho composto
e finito,
o Dame Inglesi, l'estampida.
Si vuole che durante la funzione ‘magico-propiziatoria’ del ‘Calendimaggio’ si svolgesse una ‘questua’, durante la quale si ricevevano in cambio doni di genere alimentare come uova, vino, cibo e dolci. I ‘maggianti’ cosiddetti coloro che andavano a bussare alle porte delle case per ringraziare, cantavano strofe benauguranti agli abitanti delle case che visitavano:
“E qui semo venuti e qui cantemo
‘sti nobeli signori salutemo
prima saluto lo capo de casa
e ci si po’ cantà la ‘mprovvisata
poi saluto lo capo maggiore
e ci si po’ cantà quattro canzone.
Se ci date anche un prosciutto
pure quello lo pijamo
c’è un compagno tanto ghiotto
se lo magnerebbe tutto
e vi dico io chi è quello
que che porta il canestrello” (7)
La tradizione narra che questi giovani e giovinette, più spesso figlioli e figliole di contadini o comunque in età da marito, fossero benaccolti dalla gente, soprattutto se accompagnavano la processione che attraversava il villaggio dopo la benedizione dei campi, detta anche delle ‘rogazioni’, di stretto riferimento alle festività cristiane di origine assai più recenti; cioè dopo che il processo di cristianizzazione non era riuscito a sradicare del tutto quelle pagane. A detta tradizione si devono l’offerta dei ‘rami di pesco’ che sono i primi a fiorire e l’omaggio delle cosiddette ‘violacciocche’ che appunto fioriscono a fine Aprile e per tutto Maggio; l’uso di omaggiare i bambini con uova di cioccolato; l’innalzamento dell’ ‘albero di maio’ sulla piazza del villaggio attorno al quale s’intrecciavano danze con nastri colorati e fiori simbolo dell’avvenuto risveglio della natura, in ricordo della profondità delle sue radici nella tradizione popolare:
“Entriamo in questa bella aia
dove è tanto bello entrare
chiediamo alla padrona
se vuol lasciarci cantare
Ben venga Maggio.
Siamo venuti a cantare
a casa della brava gente
sono arrivate delle ragazze
che loro non pensavano.
Sul nostro Maggio
c’è il fiore del gelsomino
è la primavera
col fiore di rosmarino.
Siamo in privamera
i fiori son già tutti fioriti
gli uccelli tutti cantano
fa piacere a sentire.
Davvero non volete credere
che’l Maggio è già arrivato
fatevi dalla finestra
e lo vedrete addobbato.
Non volete poprio credere
che Maggio sià gia venuto
fatevi sulla porta
e lo vedrete fiorito..” (8)
È interessante notare come elementi religiosi cristiani si siano innestati su riti pagani di fecondità portatrici di fecondità per quelle padrone più generose e castigo a quelle avare:
“Ringraziamo la padrona
che ha pagato con bei doni
il Signore le dia grazia
la mantenga in salute.
Se siete proprio contenti
che abbiamo cantato bene
quest’altranno ritorneremo
ci troveremo di nuovo insieme.
Signora la padrona
se lei non ci da niente
preghiamo la Madonna
che le faccia cadere un dente.” (9)
Più dura è invece l’invettiva verso il ‘padrone’ della cascina che non dona niente a chi s’affaccia a chiedere la questua:
“Ecco chiuso il nostro canto
s’era aperto in Paradiso
e con lacrime di pianto
si congiunge gioia e riso
e con feste ed argomento
cambio sòno ed instrumento. (..)
Chi v’entrasse la vorpe ni’ pollaio
che vi mangiasse tutte le galline
che v’entrassero i ladri ni’ granaio
che vi muffasse i’ vin nelle cantine .
Un accidente a ‘l padre e uno alla figlia
e i rimanente a tutta la famiglia”. (10)
Notevoli sono gli ‘stornelli di questua’ tipici del ‘cantar maggio’, pregnanti di significati e ricchi di ricchi di espressioni verbali dialettali entrate nella tradizione, quali – ad esempio – articola Graziella di Prospero (11) nel rituale saluto d’inizio:
“Appena arrivo la chiedo la licenza
se in questo loco ce se po’ cantare.
Se in questo loco ce se po’ cantare noi canteremo
sennò famo le scuse e ce n’annamo.
Ce so’ venuta da ‘n lungo viaggio
porto la nova ch’è fiorito Maggio.
A me d’intorno li coglio li frutti
a mano a mano ve ringrazio a tutti.
La bonasera ve la do in tre modi
coll’occhi, colla lingua e co’ lo core.
Pe’ prima cosa io voglio dà un saluto
io voglio saltà il padron de casa.
E mo’ benedico la cammera e la sala
lu lettu dove dorme la padrona.
E disse lo marito alla moiera
‘arzate moglie mia Maggio è fiorito.
Arzate moglie mia Maggio
ha misse le foglie.
E disse la moglie a lo marito
‘arzate marito mio Maggio è fiorito.
Arzate marito mio
che Maggio è ben sfiorito.
E Maggio se ne va pe’ le ripette
le voglio salutà ste ragazzette.
Tutte quante
quelle da sedici anni a li ventisette.
Questo è lu cantu ch’abbiam trovà
D’annà giranno la notte pe’ le ova.
Pe’ dì chi nun ce l’ha
se le aritrova.”
La frase di chiusura ricorre in molti canti di questua e il termine ‘ova’ dono magico per eccellenza) sta a simboleggiare la richiesta di un compenso più generico e voluttuoso.
“La viola, e che ci à fatte Maggio / che n’à passate / ca l’arboscello tuo / non à fiorito.” (12)
Come riferisce Roberto Leydi (13): “Quest’ultima questua è ripresa da una registrazione ‘sul campo’ fatta da Sandro Portelli nella zona di Labro, in Sabina, e la si deve probabilmente alla vicinanza con l’Umbria dove è molto diffusa. L’usanza del ‘cantar maggio’ è di fatto presente in Italia nell’area compresa fra l’Umbria, la Toscana settentrionale e in tutto l’Appennino Emiliano, diversificato nel Maggio di questua (stornello, poesia lirica), Maggio serenata (canto appassionato con accompagnamento strumentale), Maggio drammatico (rappresentazione), con ricchezza di forme e gare rituali fra il ‘re e la regina di maggio’, in quelle regioni dove, appunto, si svolgono gli eventi più rappresentativi e significativi dell’anno”.
Allo spettacolo teatrale vero e proprio cui sono legate molte manifestazioni che anticipano e percorrono tutto il mese di Maggio con eventi anche spettacolari, è dedicato un intero album (Lp) registrato ‘dal vivo’ da Gastone Venturelli (14) che lo ha realizzato in occasione della Prima rassegna del teatro popolare e promossa dal Comune di Buti, dalla Comunità montana Monti Pisani nel 1978. L’album contiene recitativi, marce processionali, arie e cori che sia maschili che femminili che si alternano fino a costruire una ‘battaglia’ finale molto suggestiva. Strumenti come la fisarmonica, chitarra, clarinetto e violino si alternano nell’accompagnamento dei recitativi e delle arie e si propongono, anche senza l’ausilio della parte visiva, come documento interessante per la sua unicità, nel quadro di una conoscenza dei diversi modi comunicativi dello spettacolo popolare, così come sebbene solo in parte, è ancora vivo nel nostro paese.
L’unicità di questi spettacoli è data da alcuni ‘esempi’ di testi narrativi entrati nella tradizione come “Pia de Tolomei”, “La Gerusalemme Liberata”, e il Maggio di Antonio Foscarini, raccolti in Toscana e in Emilia che ci rendono partecipi di una tradizione ‘viva’ ancora ai giorni nostri almeno in una ventina di località comprese nelle provincie di Pisa, Lucca, Massa, Modena e Reggio Emilia. “Ma antichi o recenti che siano – scrive in proposito Gastone Venturelli – i ‘maggi’ sono sempre composti nello stesso metro (quartine o quintine di ottonari) e con un medesimo linguaggio (letterario e arcaizzante, assai vicino alla lingua dei grandi poemi cavallereschi del Rinascimento: Tasso e Ariosto sono, non a caso, le letture predilette dei contadini toscani). E i copioni, manoscritti in quadernetti scolastici e conservati nelle case di quei popolani che cantano o hanno cantato nel ‘maggio’ subiscono continue e vistose modificazioni. Se si accettuano le composizioni più recenti, ben di rado conosciamo il nome degli autori dei ‘maggi’: furono parroci di paese, ex seminaristi, ma più spesso contadini, artigiani, cavatori. I manoscritti circolano anonimi o con il nome del copiatore; e i copiatori raramente ‘copiano’: quasi sempre rielaborano il testo che hanno sottomano. Così la creazione di un singolo si muta via via e diventa, col tempo, creazione anonima e collettiva”. (15)
“Lo spettacolo, completamente gestito da popolani, si svolge per lo più all’aperto, in una piazza del paese o in una radura silvestre non lontana dall’abitato… con i ‘maggianti’ in uno spazio centrale e il pubblico tutt’intorno a 360 gradi. I costumi indossati sono per lo più gli stessi tramandati dalla tradizione, qualsiasi sia la vicenda che si rappresenti, lontani da qualsiasi riferimento spaziale e temporale, che si cerca di renderlo sempre più bello con aggiunte di nastri colorati, specchietti, coccarde. Nessun realismo: re Artù è vestito con gli stessi abiti che l’anno precedente erano serviti per Priamo o per Salomone. Soltanto nelle località più a sud, le stese dove il Maggio si canta in teatro, si preferisce prendere i costumi alla sartoria teatrale e vestir i personaggi con qualche attenzione alla storicità della vicenda presentata. Anche per quanto riguarda il canto, la gestualità e la tecnica di rappresentazione, le due aree si comportano in modo assai diverso fra loro. La trascrizione dei testi si basa, per quanto possibile, sui normali simboli dell’alfabeto italiano in modo che tutti, anziani e giovani, autoctoni e visitatori possano seguire la rappresentazione”. (16)
Col nome di ‘Maggiolata’ si indica uno spettacolo itinerante di questua, che si svolge la notte tra il 30 Aprile e il 1Maggio. Nella provincia di Siena essa è attestata solo a Vivo d’Orcia, dove si svolge saltuariamente, e a Castiglion d’Orcia, due piccoli borghi medievali alle pendici del monte Amiata. Realizzata da un gruppo di cantori (dieci al massimo), tra cui si distingue il ‘capomaggio’ che dà via al canto, accompagnati da un complesso di strumenti a fiato, che include: trombe, clarinetti, sassofono, trombone, bombardino, basso in fa, ecc.. Il gruppo dei cantanti-suonatori muove dal paese verso la campaga alternando a ogni quartina un’aria solo strumentale. Qui entra nelle case dove canta la ‘maggiolata’ ricevendone in cambio vino e alimenti che vengono consumati sul posto; e soldi che verranno successivamente utilizzait per un pranzo finale per tutta la compagnia. Il giro della campagna si protrae fino a notte tarda; quindi il grupppo rientra in paese per concludere l’azione-spettacolo dopo il sorgere del sole. I testi cantati sono tradizionali: si tratta di quartini di ottonari, con la ripetizione del verso iniziale, in cui si fa lode della primavera e della campagna, si augura prosperità ai contadini, si canta l’amore e la bllezza delle ragazze. Ci sono poi strofe da cantare solo durante il giro della campagna e altre durante il giro nel paese. In campagna, in attesa dello spuntar del sole si canta:
“Spunta l’alba e si veste il sole
se le mette le scarpe d’oro
sulla bocca c’ha un bel fiore
spunta l’alba e si veste di sole.” (17)
Il significato della ‘Maggiolata’ va però ricercato nel corso dei secoli, come si è detto nei riti agrari più arcaici, tuttavia la festa presenta oggi diverse manomissioni, nel senso che si è modificata e si intreccia con la storia culturale delle clessi egemoni. Per quanto, essa ha conservato, nelle aree in cui sopravvive, il carattere della cultura contadina della comunità ivi insediata. La pratica di celebrare il ‘primo maggio’ con l’esecuzione del ‘cantarmaggio’ come la quasi totalità dei nostri antichi riti, va inesorabilmente scomparendo: ormai defunzionalizzato sopravvive ancora nelle regioni dell’anconetano e del fabrianese (Marche)in forma memorizzata, a causa delle trasformazioni profonde della società ed in particolare della polverizzazione della civiltà contadina che ne proseguiva la tradizione. Proprio per evitare o almeno frenare questo rapido declino, il Comune di Morro d’Alba (An) con la collaborazione del Gruppo di canto popolare La Macina (18) da qualche anno sta chiamando a raccolta, la terza domenica di Maggio, gli autentici esecutori provenienti da tutta la regione, per ricantare in questo piccolo comune della Vallesina la tradizione del Cantarmaggio, in una festa locale allo scopo di rendere ‘viva’ la festa fra le genti:
“Cari ssignori vi saluto a tutti
vi canto unà storiella e ppure ‘i fatti
maggio che ci porta fiori e frutti
noi li ‘rcojeremo dopo fatti.
Avede visto sul calà del sole
quando fece partenza maggio-aprile
aprile gli donò rose e vviole
e maggio se n’aveva da nutrire.
La primavera ci convien a lodare
e maggio che cci fa tanti favori
giovani e vecchi fanno rallegrare
villani artisti poveri e signore.
. . .
È questo un mese che ogni frutto allegra
pure a la fava je fa fà lla tega
‘sse donne cure giù co la pannella
e ‘tte le frega tutta la più bella..”. (19)
Non potevano mancare strofette scurrili o banalmente oscene care ai beoni che se la spassano dietro a un bicchgier di vino:
“Vedi llo vino tuo comme s’inpiccia
prende su ‘n testa pare ‘na gramaccia
l’hai fatto co’ ‘na vita carpeticcia
e se ne bevi un pò gira la testa.
E sse ne bevi un po’ de ‘sti sciroppi
non vedi più né fratte ripe e fossi
ma se lo fosso è grande non si scopre
farrai ‘na tiritoppola sotto e sopre.
Se ‘cci dade ‘l bon vi’ ‘l cor cci batte
se non ce lo voi da’ porta ‘lla botte
le forme di formaggio venghi ‘ntatte
vi lascio come maggio a bbona notte”. (20)
La festa del ‘Calendimaggio’ è ricordata ad Assisi ed è forse quella più sfarzosa per via che ci viene direttamente da epoca rinascimentale. “I preparativi della festa – scrive Mario Colangeli (21) – cominciano tre o quattro mesi prima e vedono in lizza due parti avverse: la ‘parte di sopra’ e quella detta ‘di sotto. La sfida consiste nel rappresentare meglio alcuni episodi della vita dell’epoca. La manifestazione solitamente ha inizio il 29 Aprile con la consegna delle chiavi della città ad un Maestro di Campo che assume simbolicamente i poteri della città. Il 30 Aprile sulla piazza del Comune , i due quartieri della città, i nobili della parte di sopra e quelli della parte di sotto, seguiti dagli armigeri, dagli artigiani e sbandieratori, gareggiano in giochi d’armi medievali. La gare infine si chiude con la proclamazione di Madonna del Maggio, anche detta della primavera. L’indomani, Primo di Maggio sfilano i cortei delle due contrade, composti da circa cinquecento figuranti per ricevere gli applausi e le ghirlande di fiori offerti dalla cittadinanza in festa”.
Chiude la festività un evento ‘teatrale’ spettacolare che prende a soggetto fatti di cronaca cittadina o la vita religiosa, trasformati per l’occasione in episodi di grande attualità, grazie anche alla rivisitazione dei testi che più spesso prendono di mira le autorità e il potere, pur sempre con garbo e rispetto. In particolare vanno qui ricordati “Il Capitan dè Neri”, “La Mea”, “Storia della Cecilia” egregiamente riproste da Caterina Bueno (22): etnomusicologa e cantante italiana il cui lavoro di ricercatrice ha avuto una notevole importanza dal punto di vista culturale, consentendo di recuperare molte canzoni popolari toscane e dell'Italia centrale, tramandate oralmente fino al ventesimo secolo.
“L’edizione di quest’anno ad Assisi si svolge nei giorni 6-7-8-9 maggio 2015. Si tratta di un’edizione che, pur nel rispetto della tradizione, armonizza lo svolgimento organizzativo, ampliando anche la godibilità della festa, passando da tre a quatto giorni. Questo il programma: - mercoledì 6 maggio – ore 16.00 Consegna delle chiavi e Bando di sfida/ ore 21.30 Scene Parte De Sopra; - giovedì 7 maggio - ore 15.30 Elezione Madonna Primavera e giochi medievali, ore 21.30 Scene Parte De Sotto; - venerdì 8 maggio – ore 15.30 Manifestazione medievale (fuori abbonamento)/ ore 21.00 Cortei storici della notte; - sabato 9 maggio – ore 15.30 Cortei storici del pomeriggio/ ore 21.30 Sfida tra i Cori delle due Parti e Assegnazione del Palio. La manifestazione, come di consueto, verrà proiettata in differita in piazza del Comune”. Info: www.calendimaggiodiassisi.com
Le feste del Calendimaggio, a seconda della località in cui si svolge questa festa troviamo forme e nomi differenti:(da Wikimedia)
•Calendimaggio ad Assisi (PG)
•Calendimaggio a Vernasca (PC), in val d'Arda
•Cantar Maggio su tutta la Montagna Pistoiese, dove per tutto il mese si svolge il Festival del Maggio Itinerante,
•Carlin di maggio a Corte Brugnatella in val Trebbia, (PC)
•Cantamaggio a Prataccio, provincia di Pistoia
•Santa Croce, in una zona compresa fra i comuni di Brallo di Pregola, Bobbio e Corte Brugnatella, nelle province di Pavia e Piacenza
•E bene venga maggio a Monghidoro (BO)
•Galina grisa o Galëina grisa in val Tidone, a Pianello Val Tidone o a Cicogni, frazione di Pecorara, (PC) e a Romagnese (PV)
•Maggio a Santo Stefano d'Aveto (GE)
•Cantamaggio a Terni (TR)
•Maggiolata a Firenze (FI)
•Pianta dal Macc a Canzo (CO)
•Cantar le uova nell'Alessandrino
•Seveso, nella frazione di San Pietro, è presente nella prima domenica e nel primo lunedì di maggio una festa detta di Calendimaggio.
•La Maggiolata a Castiglione d'Orcia in provincia di Siena nella notte tra il 30 aprile e il 1º maggio
•Ecco Maggio giù ppe'r piano... a Badia Prataglia la notte tra il 30 aprile e il 1º maggio (AR)
Note:
1) ‘Siam venuti a Cantarmaggio’. Canzoniere Internazionale - Fonit Cetra n.29 lpp 261, 1974
2) Alfredo Cattabiani, ‘Calendario: le feste, i miti, le leggende, i riti dell’anno’ Mondatori 2003
3) 'Maggiolata' in Toscana vol.1 - Grosseto - Siena - Cetra 'I Suoni' SU 5004 - a cura di Diego Carpitella, 1980
4) Mircea Eliade, ‘Trattato di storia delle religioni’, Torino, 1970
5) Canzoniere Internazionale – op.cit.
6) 'Kalenda Maya' - Angelo Branduardi, in 'Chominciamento di gioia' - La Voce del Padrone CD,1996 e in Raimbaut de Vaqueiras, in’ Scenari: la musica dalle origini al Cinquecento’ -La Nuova Italia, 2005
7) Canzoniere Internazionale, op. cit.
8) 9) ‘Cantè Magg’, ‘Cantè i öv’ in ‘Feste calendariali e canti popolari dell’Albese’ – Gruppo Spontaneo di Magliano Alfieri – Albatros VPA 8415, 1978
10) Canzoniere Internazionale, op. cit.
11) ‘Stornelli di Questua del Maggio’, in ‘Tengo ‘no bove se chiama Rosello’, Graziella di Prospero - Fonit Cetra n.32 lpp 273, 1975
12) 13) Roberto Leydi, ‘I canti popolari italiani’, Mondadori, 1973; ‘Musica popolare e musica primitiva’, Torino-Eri, 1959
14) 15) 16) ‘Il Maggio’ in Toscana e in Emilia, in ‘Lo spettacolo popolare’, a cura di Gastone Venturelli – Albatros VPA 8411,1978
17) 'Maggiolata' in Toscana - Grosseto - Siena - vol.1 Cetra 'I Suoni' – op.cit.
18) 19) 20) ‘Cantamaggio’, in ‘Io me ne vojo andà pel mondo sperso..’ – La Macina – Madau Md =15, 1984
21) Mario Colangeli, Anna Fraschetti, ‘Feste e Sagre Popolari nel Lazio’ – Casa del Libro 1989
22) ‘Se vi assiste la memoria’, Caterina Bueno - Fonit Cetra n.28 lpp 263, 1974
Discografia:
•1974 – ‘Siam venuti a Cantarmaggio’. Canzoniere Internazionale - Fonit Cetra n.29 lpp 261
•1974 – ‘Se vi assiste la memoria’ , Caterina Bueno - Fonit Cetra n.28 lpp 263
•1975 – ‘Stornelli di Questua del Maggio’, in ‘Tengo ‘no bove se chiama Rosello’, Graziella di Prospero - Fonit Cetra n.32 lpp 273
•1978 – ‘Cantè Magg’, in ‘Feste calendariali e canti popolari dell’Albese’ – Gruppo Spontaneo di Magliano Alfieri – Albatros VPA 8415
•1978 – ‘Il Maggio’ in Toscana e in Emilia, in ‘Lo spettacolo popolare’, a cura di Gastone Venturelli – Albatros VPA 8411
•1980 - 'Maggiolata' in Toscana vol.1 - Grosseto - Siena - Cetra 'I Suoni' SU 5004 - a cura di Diego Carpitella
•1984 – ‘Cantamaggio’, in ‘Io me ne vojo andà pel mondo sperso..’ – La Macina – Madau Md =15
•1988 – ‘Il Maggio’, in ‘i fioo e r’amur’, Vox Blenii – VB 375
•1989 – ‘Canti e musiche popolari dell'Appennino pavese’, in ‘I canti rituali, i balli, il piffero’, a cura di Aurelio Citelli e Giuliano Grasso -- ACB
•1990 – ‘Antologia’, Ciapa Rusa — Robi Droli
•1995 – ‘In festa’, Micrologus …
•1996 – 'Kalenda Maya' - Angelo Branduardi, in 'Chominciamento di gioia' - La Voce del Padrone CD
•2000 – Eva Tagliani. ‘La voce delle mascherate’, a cura di Aurelio Citelli e Giuliano Grasso -- ACB
•2000 – ‘Ori pari Tendachent’ - Folkclub etnosuoni
•2001 – ‘Balla Ghidan’, Gruppo Ricerca Popolare - Voxi de Zena
•2003 – ‘Acqua foco e vento’, Riccardo Tesi e Maurizio Geri — Il manifesto
•2004 – ‘Ariondassa’ - Folkclub etnosuoni
•2004 – ‘Lune’- Riccardo Tesi, Maurizio Geri e Banditaliana -Suppl. de ‘Il Manifesto’
•2005 - 'Kalenda Maya', di Raimbaut de Vaqueiras, in’ Scenari: la musica dalle origini al Cinquecento’ -La Nuova Italia
•2007 – ‘Sentré’ - Musiche selvagge - ACB
•2008 – ‘E l'è arrivà il mese d'aprile’ Cori spontanei dell'Appennino piacentino –Soprip
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Musicologia XIII - la Musica Contemporanea
Il grande ritorno sulla scena del nome di John Cage era inevitabile perché come ho detto all’inizio e mi piace qui ripeterlo, egli non è stato solo un compositore e teorico musicale e va considerato una delle personalità più rilevanti e significative del Novecento per quanto la sua opera è centrale nell’evoluzione della musica. Segna per così dire una sorta di ‘porta d’accesso’ dalla musica esplicitamente strumentale dell’800 e metà del ‘900, alla musica elettronica contemporanea. Allo stesso modo che da Debussy a Stravinskij in poi la musica ‘sinfonica’ o ‘classica’ che si voglia dire, aveva ormai dischiuse le porte alla sperimentazione e, poiché tutto deve necessariamente aver avuto un inizio, è questo il caso di attraversare insieme quei ‘passaggi’ che ne hanno permesso l’evoluzione. Molti degli ascoltatori contesteranno che si tratti di una evoluzione, tuttavia si dice evoluta una determinata funzione che superi la ristretta dimensione precostituita pur conservando gli elementi essenziali che la costituiscono. Per cui ciò che riguarda il campo del ‘sonoro’ la musica elettronica è parte costitutiva della ‘musica’, al pari del rumore ‘noise’ che ascoltiamo in ogni momento della nostra vita, o di quegli effetti sonori ‘in presa diretta’ che esaltano soggettivamente la ‘bellezza’ e/o la ‘bruttezza’ di una pellicola cinematografica o un reportage d’ambientazione, rivolto alla natura che ci circonda.
Non a caso si è qui citato Debussy, compositore e pianista francese nonché considerato uno dei massimi protagonisti, insieme a Maurice Ravel, dell’ ‘impressionismo musicale’, una corrente di musica colta sviluppatasi in Europa (in particolare in Francia) tra il 1870 e il 1920, avente alcune analogie con l’omonima corrente pittorica e inoltre strettamente legato alla ‘poetica simbolista’ facente capo alle idee compositive di alcuni specifici compositori, come appunto Debussy, Ravel, Satie. Rudolph Réti, noto analista musicale (oggi lo diremmo un critico), dichiarò l'impresa di Debussy come la sintesi della "tonalità melodica" a base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica". Corrente questa che segnò una svolta decisiva nell’andamento generale della musica ‘romantica’ di fine ‘800. Ciò nondimeno se vogliamo, e lo vogliamo, tornare sull’argomento ‘ambient’ si dovrebbe iniziare da quel “Quadri di un’esposizione” del 1874 suite per pianoforte a soggetto del russo Modest Petrovič Musorgskij diventata, oltre che un pezzo forte del repertorio di molti pianisti, l'oggetto di un gran numero di strumentazioni, specie per orchestra, da parte di altri compositori e musicisti: la versione più nota e più eseguita di queste, è senza dubbio quella orchestrale di Maurice Ravel.
In breve: “La suite è composta da quindici brani, dieci ispirati ai quadri e cinque ‘Promenade’ (passeggiata), che rappresentano il movimento dell'osservatore da una tela all'altra. Le Promenade (non tutte intitolate così nell'originale, ma chiaramente riconoscibili) presentano sempre lo stesso tema, con variazioni più o meno sensibili, quasi a far risaltare i diversi stati d'animo che pervadono il compositore per il quadro appena visto. La ripetizione del tema funge inoltre da elemento di coesione in una composizione altrimenti episodica, basata sui forti contrasti tra un soggetto e l'altro. L'opera presenta caratteri fortemente sperimentali. In particolare, il pianismo di tipo percussivo taglia completamente i ponti con la tradizione romantica, aprendo le porte alla musica del Novecento. Non meno moderno si presenta il linguaggio armonico, grazie all'uso massiccio di pedali e accordi dissonanti. Nei paragrafi seguenti vengono descritti i singoli movimenti, e, se si sono conservati, sono mostrati i lavori dell’architetto Viktor Aleksandrovič Hartmann che li hanno ispirati” (fonte Wikipedia).
Ancor prima c’era stato George Frideric Handel con la su “Water Music” del 1717 composta per Giorgio I re d’Inghilterra che amava ‘cavalcare in barca’ sul Tamigi da Whitehall a Chelsea accompagnato da un’orchestra di almeno cinquanta musicisti e che aveva commissionato all’allora compositore di corte, considerato uno dei più grandi musicisti tra XVII e XVIII secolo, e in assoluto tra i più importanti della storia della musica. La citazione si avvale di una rutilante ricerca interpretativa di brani che trovano una collocazione anzi tempo riconducibile al discorso primario d’una continuità ‘ambientale’ in musica nel riconoscimento inclusivo dei molti ‘poemi sinfonici’ a questo dedicati. Una derivazione diretta della musica a programma che fu una delle forme predilette dai musicisti romantici, come ad esempio Hector Berlioz nella sua “Sinfonia fantastica” del 1830; Franz Liszt che ne coniò il termine in “Les préludes” del 1856; Pëtr Il'ič Čajkovskij “Ouverture 1812” (1880); Camille Saint-Saëns “Danza macabra” (1874); Richard Strauss “Morte e trasfigurazione” (1889) e “Così parlò Zarathuštra” (1896); Jean Sibelius “Finlandia” (1899); Sergej Rachmaninov “L'isola dei morti” (1907/8); Arthur Honegger “Tre movimenti sinfonici” (1923/33); fino al più attuale Gesualdo Coggi “Risplende il dì” (1965); e tra gli altri: Borodin, Smetana, Dvorak. Ma come definire allora le opere di tanti altri compositori che talvolta fecero del ‘poema sinfonico’ una composizione musicale, solitamente in un solo movimento, parte di una sinfonia di più ampio respiro? Come Ottorino Respighi che nella “Trilogia romana” (1916/28) comprendente “I pini di Roma”, “Le fontane di Roma”, “Feste romane”, volle rendere omaggio a luoghi od occasioni particolari.
Ciò detto per introdurre almeno due straordinarie composizioni di Claude Debussy: “La Mer” del 1903/5, musicalmente simile al ‘poema sinfonico’ ma di carattere ‘impressionista’. Nonché le sue “Images’ del 1894/1901-7, dal titolo di quattro suite (pubblicate dopo la morte dell’autore) per piano-solo poco conosciute e quindi poco eseguite che” forniscono un’interessante testimonianza della ricerca espressiva che il compositore porterà a compimento nelle opere successive”. Ancor più li suoi famosi “Etudes” del “Preludes” del 1915, 12 studi per piano considerati largamente i suoi tardi capolavori di grande difficoltà interpretativa, e che lo stesso Debussy descrisse essere: "un avvertimento ai pianisti di non prendere la professione musicale a meno che avessero mani straordinarie". Fatto questo che conferma la posizione di Debussy in qualità di ‘riformatore’ della scena musicale del ‘900, la cui ricerca superava in efficacia e in attualità i pur straordinari “Etudes” e “Nocturnes” 1829/30 di Frederick Chopin spesso ‘impegnativi’ dal punto di vista tecnico, ma non impossibili.
Le ragioni perché Erik Satie rientra in questa lista sono tra le più svariate, in quanto è un personaggio stravagante “dalle pose originali e dai comportamenti bizzarri” spesso sottolineati dai cronisti del suo tempo. Compositore e pianista francese, Satie conduceva una vita da bohémienne durante la Belle Epoque, malgrado ciò aveva accesso presso la élite parigina che lo invitava alle numerose soirée dopo teatro e lo indicava come sofisticato interprete della ‘eccentricità’ tutta francese espressa in abiti e cocktail, musica e gioielli, belle donne e sensualità. Questi i temi cui egli dedicava maggiore attenzione e per cui componeva le sue musiche accattivanti, intrattenendosi al piano nelle feste cui prendeva parte. Inoltre compose anche musica per un balletto dal titolo “Jack-in-the-box” del 1899 il cui spartito fu ritrovato solo dopo la sua morte e che Darius Milhaud, compositore e pianista, uno dei rari amici col quale Satie non litigò mai, riuscì a recuperare un suo manoscritto e più tardi lo orchestrò. Una delle numerose idee fisse di Erik Satie era il numero tre, un'ossessione mistica; forse una reliquia del simbolismo trinitario associato all'Ordine cabalistico dei Rosacroce del quale Satie aveva fatto parte in gioventù.
Molte delle sue composizioni sono raggruppate in cicli di tre, e tra queste le “Trois Gymnopédies” del 1888 che è forse il componimento per cui viene spesso ricordato, assieme alle sue canzoni, i valzer, alle sue “Gnossienne”, alle “Pièces froides” e “Pieces humoristiques” e le straordinarie “Danceries” contenenti canzoni divenute presto popolari, come “La Diva dell’Empire” e “La belle excentrique” che invece si riferisce alla bella ‘eccentrica’, la ballerina Caryathis, immortalata da uno splendido poster di Léon Bakst. In certo qual modo Erik Satie va considerato un benefattore ironico e beffardo la cui espressività in musica, almeno nelle composizioni più lunghe come “Cinemà” del 1924, o quelle per orchestra, si rileva nei suoi ‘sketch’ musicali che fanno da sfondo a un genere non poi così lontano dalla ricerca qui affrontata, certamente più vicina di quanto siamo portati a pensare all’esistenza di altri ambiti di ricerca, che vanno per così dire ‘oltre la musica’. con l’avvento del XX secolo la sperimentazione in musica giunse a un punto di rottura con la precedente che tutti ne furono influenzati: si pensi alla ricerca nel Jazz di Igor Stravinskij; al pioniere dell’etnomusicologia Béla Bartok; a Franz Lizst, a Johannes Bhrams, all’evoluzione dell’opera lirica con Giacomo Puccini; e ancora a Manuel de Falla, a Gian Francesco Malipiero delle ‘colonne sonore’.
Di tutto questo molto rimane mentre altri, ahimè non citati in questo contesto, che portò a un’autentica ‘evoluzione’ in musica e, il cui risultato è a portata d’orecchi di tutti, a quella contaminazione di stili che superato il periodo cosiddetto del ‘futurismo’ si approprierà della scena musicale e che porterà alla globalizzazione. Davvero eclatante fu la ricerca fonetica del ‘Futurismo’ e dei futuristi, iniziata dall’eclettico Giuseppe Tommaso Marinetti, fondatore del movimento, il cui “Manifesto” risuonva tutt’altro che espressione intellettualistica e cerebrale di una moda fine a se stessa. Legata a un periodo storico-politico ancora non ben definito e non molto studiato, il movimento futurista trova oggi un terreno più fertile di allora, per le sue applicazioni nell’arte così denominate: aeropittura e ceroplastica, scultura, architettura, all’esito stimolante del “Fotodinamismo” del 1911 di Anton Giulio Bragaglia. Come pure in letteratura: nella lingua, la poesia, il teatro, il balletto e al ‘varietà’ nello spettacolo; ma anche in cucina, in viaggio, la politica e la questione femminile, l’etica e la morale, nella stampa e nel fotodinamismo. Nonché nella esclusivistica espressione di ‘musica futurista’ con gli ‘intonarumori’ che Luigi Russolo, compositore e pittore futurista, chiamò “L’arte dei rumori” nel libercolo delle Edizioni Futuriste del 1916. “Il testo è realmente rivoluzionario: nella musica si arriva a quella eversione delle forme il cui analogo letterario è appunto costituito dalla distruzione della sintassi delle ‘parole in libertà’. (..) Russolo si avventura sul cammino d’una ricerca che spezza i vincoli dei ‘suoni puri’ per dar finalmente diritto di cittadinanza al ‘suono-rumore’, che non si limita ad imitare la natura meccanica dei suoni, ma intende “..intonare e regolare armonicamente e ritmicamente i più svariati rumori, incasellandoli peraltro in varie famiglie: (rombi, fischi, bisbigli, stridori, percussioni, voce, ecc.). Si apre così in tal modo un varco inedito – che prelude alla moderna ricerca della musica concreta ed elettroacustica – la cui originalità nel tempo non sfuggirà ai vari Stravinskij, Varése, Honegger, Lutoslawski, Mayuzumi, Penderecki, Cage”. (in “Storia del Futurismo” di Claudia Salaris Editori Riuniti 1985).
“Il compositore su cui Marinetti fa affidamento nei primissimi anni è Francesco Balilla Pradella, compositore e musicologo italiano, autore del “Manifesto dei musicisti futuristi” del 1910 dedicato ai giovani, ferocemente critico verso l’establishment composto da critici, editori, conservatori, accademie e autori di successo; e “La distruzione della quadratura” del 1912 a favore del ‘modo enarmonico’ e dell’uso dell’irregolarità ritmica che crea il ‘nuovo ordine del disordine’. Si tratta ancora una volta dunque di reagire al principio di autorità e di cercare strade libere dai vecchi obblighi. (..) I risultati ottenuti da Balilla Pratella futurista datate tutte al 1912 come “L’inno alla vita”; “Musica futurista per orchestra”; “L’aviatore Dro” vengono considerati oggi piuttosto modesti. La sua vena lirica infatti si manifesta con maggiore autenticità nei lavori successivi, ispirati ai canti popolari e tuttavia destinati a rimanere al di qua di quella soglia rivoluzionaria che Marinetti gli indica nelle sue lettere ‘ruggenti’, spronandolo ad osare di più per poter gareggiare con gli altri musicisti europei”. (in “Storia del Futurismo” di Claudia Salaris Editori Riuniti 1985). Le critiche successive alle clamorose quanto tumultuose ‘prime’ apparizioni in pubblico degli ‘intonarumori’, simili a grosse scatole con tromboni e manovelle, li definiscono ‘misteriosi arnesi’ e non risparmiano neppure i provetti esecutori chiamandoli ‘arrotini della musica’ di una ‘intolleranza incondizionata’.
La ricerca fonetica acustico - musicale dei futuristi non ha del tutto concluso il suo corso espressivo nell’arte. Molto probabilmente senza il ‘movimento futurista’ non ci sarebbe stato tutto quello che è venuto dopo. Se è vero che una sorta di rivoluzione in musica fosse nell’aria, certamente lo spostamento d’interesse verso le espressioni del Futurismo non avrebbero dato i risultati che poi hanno dato. Cioè quel ‘dinamismo’ tipico della ricerca che prima o poi, per forza di cose, scaturisce in qualcosa di inconsueto, di innovativo come la scoperta di altri ambiti di ricerca, spingendo il proprio proiettarsi in avanti ‘oltre’ la dimensione di partenza. Gli esempi sono altrettanto ‘illuminanti’, si va dal “Profilo sintetico musicale” del 1923 per piano e voce, di F. T. Marinetti, al “Aeroduello” (dinamo sintesi) del 1935 di Luigi Grandi; da “Otto sintesi incatenate” del 1925 per pianoforte su testo di Marinetti, a”Pupazzetti” del 1915 di Alfredo Casella, “..per pianoforte a quattro mani eseguita su rullo ‘Stek’ con meccanica automatica”. Ma non siamo ancora del tutto ‘fuori di testa’ se si pensa che Ferruccio Busoni e Domenico Alaleona avevano prematuramente teorizzati quelli che sarebbero stati “I moderni orizzonti della tecnica musicale: teoria della divisione dell’ottava in parti uguali (bifonia, trifonia, tetrafonia, esafonia, dodecafonia)”, e successivamente illustrati sulla “Rivista musicale italiana” del 1911.
Si pensi che nelle conclusioni del “‘Manifesto tecnico’ vengono enunciati almeno due principi fondamentali: 1) Bisogna concepire la melodia quale una sintesi dell’armonia, considerandole definizioni armoniche di maggiore minore, eccedente e diminuito come semplici particolari di un unico modo cromatico atonale. 2) Considerare la enarmonia come una magnifica conquista del futurismo. Si propugna inoltre il dominio ritmo, come ‘ritmo libero’ e con la fusione dell’armonia e del contrappunto, creare la polifonia in senso assoluto”. Molte altre risultano ancor più ‘fuori’ se si ha la pazienza di ascoltare la ‘musica’ e di leggere le ‘note’ che spiegano il contenuto del prezioso cofanetto “Futura” (7Lp) pubblicato dalla Cramps Records nel 1978, un’antologia storico critica della poesia sonora a cura di Arrigo Lora-Totino con la presentazione di Renato Barilli. Non da meno “Musica Futurista” (2Lp) l’antologia sonora a cura di Daniele Lombardi con testo introduttivo di Luigi Rognoni, pubblicato da Fonit-Cetra nel 1986, in cui la poesia in quanto verbalizzazione astratta di ‘parole in libertà’ trova un terreno fertile per essere capita meglio ma anche che è più facile ascoltarla che leggerla. Mentre per la musica, è più facile assistere a una lezione di Freud o Einstein, a dimostrazione del fatto che la si può ascoltare come musica, ma che musica non è. Almeno non lo è se la riferiamo alla natura. Piuttosto la si può definire ‘linguaggio di forze artificiali rumoreggianti’ creata dagli uomini, pur rivelando un proprio linguaggio efficace, in quanto assieme di emozioni e sensazioni che da essa scaturiscono e che infine saremo riusciti ad afferrare.
Proseguendo sulle ‘braci ardenti’ della sperimentazione giungiamo però a trovare la risposta che si cercava fin dall’inizio alla insita domanda “..dov’è la musica, dove sta andando, come sta cambiando?”: “the music is changing!” ovvero la musica sta cambiando siamo già ‘oltre la musica’: a partire da Igor Strawinskij, Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki, Toshiro Mayuzuni, Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, Toru Takemitsu, Paul Hindemith, Anton Webern, Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, Arnold Schonberg e, ovviamente altri ancora, hanno contrassegnato ‘tappe importantissime’ della ricerca in musica, prima, durante e dopo l’avvento del ‘futurismo’, per poi sfociare inevitabilmente in quella avanguardia elettronica e tecnologica che oggi, anno 2015, sta nuovamente rivoluzionando la dimensione ‘sonoro-musicale’ di più largo consumo e che possibilmente schiuderà ancora ‘altre’ dimensioni future. Tuttavia non siamo ancora alla conclusione che già altri compositori si affaccia sulla scena, rispettivamente Pierre Schaeffer e Pierre Henry, le cui ricerche convergono in una medesima e per cui si riferisce qui di entrambi per dato corpo alle stesse esperienze.
Compositore e allievo di Olivier Messiaen e Nadia Boulanger, Pierre Henry già collaboratore del Club d'Essai, fondato da Pierre Schaeffer presso la RTF francese, col quale ha scritto la “Symphonie pour un homme seul” del 1949-50. È considerato uno dei teorizzatori della ‘musica concreta’ basata su suoni pre-esistenti, uno dei primi modelli di manipolazione del suono per fini compositivi (in questo caso magnetofoni) e che fu probabilmente la prima ‘scuola’ di musica elettronica. La possibilità di registrare il suono anche su nastro, ampliava di fatto gli orizzonti musicali a confini mai intravisti prima. Tale musica si collocava in contrapposizione all'idea di ‘astrazione’ che secondo Pierre Schaeffer caratterizzava l'approccio musicale dominante (musica elettronica, musica strumentale). Cioè, il pensare la musica per criteri astratti (armonia, contrappunto, notazione, dispositivi logici, etc.) piuttosto che elaborarla concretamente attraverso il suono e l'ascolto. Schaeffer parlava di ‘musica concreta’ intendendo il suono nella sua completezza; ovverosia il fatto di ascoltare il suono in tutti i suoi aspetti (attacco sonoro, durata, inviluppo, densità di massa sonora, andamento, timbro, frequenza, ampiezza etc.). I suoni possono provenire dalle fonti più varie della realtà acustica (rumori, strumenti tradizionali, voci e molti altri) e in gran parte dei casi vengono captati con un microfono, che non ne tralascia la risonanza ottenuta, in un dato punto dello spazio. A differenza della musica elettronica ‘pura’, la musica concreta non è basata su sonorità ottenute direttamente da frequenze elettroniche.
Pierre Schaeffer fu ingegnere musicale all'interno degli studi della società radiotelevisiva francese (RTF). Questa attività gli permise di utilizzare il vasto archivio discografico della radio e di cominciare a fare esperimenti sul suono ed il rumore, ma soprattutto cominciò a maturare dei nuovi metodi compositivi, come dimostrarono i suoi saggi “Introductrion à la musique concrète” e “A la recherche d'une Musique concrète”. Lo stesso Schaeffer fu autore, nel 1948, del primo brano di musica concreta, “Étude aux chemins de fer”: un breve studio sul ritmo per giradischi che riproduce i suoni provenienti da un treno in movimento (fischi, suoni di vapore, e altri). Ad esso seguirono negli anni dal ’48 al ’50 altre composizioni non troppo diverse e sempre di breve durata quali “Étude aux tourniquets”, “Étude au piano I (Étude violette), Étude au piano II (Étude noire), ed Étude aux casseroles (Étude pathétique)”. Durante questa fase, Schaeffer lavorò quasi completamente da solo. A partire dal 1949, Schaeffer iniziò una collaborazione con Pierre Henry che fruttò composizioni più lunghe, ambiziose (e, a detta di molti, più mature) quali la “Symphonie pour un homme seul”. Iniziata nel 1949 e terminata l'anno seguente, (sebbene sia stata oggetto di più revisioni) essa è un altro esempio di musica concreta in cui suoni strumentali si mescolano a suoni presi dalla vita quotidiana di un uomo (respiri, passi, fischi, porte che sbattono ecc.). La ‘musica concreta’ di questo periodo è poco o per nulla strutturata e meno ‘rigida’ di quella che seguirà.
Nel 1951, in seguito all'introduzione di nuove apparecchiature, Schaeffer, Henry e il fisico Andrè Moles fondarono il Gruppo di ricerca di musica concreta (futuro Gruppo di ricerche musicali) che era finanziato dallo studio parigino RTF, e fu il primo studio costruito per comporre musica elettronica. “Noi abbiamo chiamato la nostra musica concreta, poiché essa è costituita da elementi preesistenti, presi in prestito da un qualsiasi materiale sonoro, sia rumore o musica tradizionale. Questi elementi sono poi composti in modo sperimentale mediante una costruzione diretta che tende a realizzare una volontà di composizione senza l'aiuto, divenuto impossibile, di una notazione musicale tradizionale. Fra i nuovi macchinari erano inclusi magnetofoni e quattro apparecchiature speciali: la prima controllava i suoni nello spazio esecutivo, la seconda era un registratore in grado di riprodurre riverberazioni, mentre le ultime due permettevano di variare la velocità di riproduzione del nastro e di "trasporre il materiale registrato su ventiquattro altezze" (esse erano nominate rispettivamente pupitre de relief spatial, il morphophone, e le phonogènes). I magnetofoni, che da ora rimpiazzarono il giradischi, permisero al compositore di suddividere i suoni in più parti al fine di adoperare solo quelli necessari alla composizione.
Nello stesso periodo, che vide anche emergere altri studi di musica elettronica, altri musicisti iniziarono a comporre seguendo la stessa filosofia. Fra essi il già citato Karlheinz Stockhausen, che realizzò nel 1955 la prima composizione di musica concreta a presentare sonorità provenienti da segnali generati elettricamente: “Gesang der Jünglinge im Feuerofen”, mentre “Desert” del 1954, una composizione di Edgar Varèse per fiati e percussione, viene considerata il primo capolavoro di questo metodo compositivo. In seguito all'uscita di Henry dal GRMC, che decise di fondare lo Studio Apsome nel 1958, Schaeffer intraprese, ispirandosi a Varèse, un percorso di ricerca molto più rigoroso e meno ‘empirista’ di quello dei suoi primi lavori. Da questo momento, i membri della ‘scuola’ francese si concentrarono maggiormente sull'analisi dei suoni registrati e iniziarono a comporre una musica realizzata da suoni "presi così come vengono percepiti". Di questa fase, caratterizzata da composizioni più astratte rispetto a quelle degli esordi, si ricordano il lunghissimo “Traitè des objets musicaux”, terminato nel 1966 (ma iniziato quindici anni prima) e registrato da Schaeffer con musicisti quali Abraham Moles, Jacques Poullin più altri ricercatori. A differenza di Schaeffer, Henry proseguì gli ideali originari della musica concreta ‘spontanea’ degli esordi.
Con “Variations pour une porte et un soupir” del 1963 e, successivamente con “Messe pour le temps present” composta con Michel Colombier per il coreografo Maurice Béjart, e contenente il brano "Psyche-Rock”, utilizzato poi nella colonna sonora di « Z » di Costa Gravas del 1969; “Messe de Liverpool” del 1967 registrato dal vivo in occasione dell’inaugurazione nella Cattedrale Metropolitana del Crist-Roi di questa città; nonché “Musique pour une Fete” del 1971 in occasione della Festa dell’Umanità tenutasi alle Tuileries di Parigi e danzata dal Ballet du 20° Siècle di Maurice Béjart, siamo di fronte ad una vera e propria apoteosi celebrativa di questa musica che s’avvia alla sua esperienza conclusiva a partire dai primi anni settanta, periodo in cui i compositori, interessati ad approfondire l'analisi dei suoni con nuovi mezzi, iniziarono ad adoperare apparecchiature quali sintetizzatori e computer e perciò detta ‘progressiva’ e che da questo momento in poi abbraccia ogni genere musicale che si avvale della strumentazione elettrificata e delle apparecchiature elettroniche nel mixage. Questo fenomeno ebbe come principale conseguenza quella di annettere il concetto di ‘musica concreta’ a quello più generale di ‘musica elettronica’.
Due altre esperienze, separate tra loro da anni di vuoto portano alla ribalta gli Eela Craig, un gruppo rock austriaco degli anni 1970 e 1980, che ha unito ‘progressive rock’ con influenze jazz e di musica classica e testi cristiani. Il nome della band pur senza significato nota riprende il discorso abbandonato da Henry delle ‘Messe’, infatti il loro album più importante “Missa Universalis” del 1978 è confluita in quella New Age di più largo consumo. L’altra esperienza di un certo livello, maturata a cavallo tra gli anni ‘60 e il 1980, è senza ombra di dubbio quella di Hans Werner Henze compositore tedesco vissuto in Italia, noto per le sue opinioni politiche marxiste e il loro influsso sulla sua opera. Il suo stile compositivo abbraccia il neo-classicismo, il jazz, la tecnica dodecafonica, lo strutturalismo e alcuni aspetti della musica popolare e del rock. Allievo del compositore tedesco Wolfgang Fortner, nelle sue prime composizioni utilizzò la tecnica dodecafonica come ad esempio nella “Prima Sinfonia” e nel “Concerto per violino e orchestra” del 1947. In seguito però si ribellò agli obblighi dello strutturalismo e dell'atonalità, al punto che nella sua opera "Boulevard Solitude" del 1951 sono presenti elementi riconoscibili provenienti dal jazz nonché dalla canzone francese dell'epoca.
Henze è inoltre un orchestratore molto raffinato, la cui tecnica si è sempre tenuta aggiornata nel corso degli anni. Nonostante le varie e differenziate influenze stilistiche ricevute, la sua musica ha come costante il ‘lirismo’ sempre molto teso, come nel caso di “Voices” del 1973 per voci liriche e orchestra. Composta tra gennaio e giugno 1973 l’opera raccoglie 22 canzoni di indipendenti tra loro e che possono essere eseguite singolarmente, e con modifiche alla strumentazione. Scritte per mezzosoprano, tenore, operatore di elettroniche e 15 strumentisti in tutto il mondo che suonano approssimativamente 70 strumenti diversi: dalla radio a transistor e microfoni, al collage su nastro di vari rumori: spari, colpi, giochi vocali, commentari, discorsi presidenziali, una sinfonia di Sibelius e suoni di polizia attraverso megafoni. Va detto che Henze è stato uno degli orecchi più eccellenti per le sonorità strumentali fra i compositori di oggi, non ha usato mai lo stesso suono come fine. Infatti “Voices” è un insieme di brani musicali composto come una piece teatrale, che confronta l'ascoltatore con situazioni concrete. Non è un strumento per fantasticare sull’evasione dalla realtà, bensì uno stimolo per aumentare le abilità critiche e l'impegno sociale dell'ascoltatore. Henze ha inoltre scritto musica per balletto e colonne sonore, tra cui il brano "Fantasia per archi" incluso nel film "The Exorcist" del 1973, di William Friedkin; opere liriche e ben dieci sinfonie, concerti per pianoforte, il che ha fatto spesso citare i nomi di Alban Berg o di Karl Amadeus Hartmann come suoi possibili predecessori morali.
È del 1973 l’uscita di un cofanetto (3Lp - RCA) “La Musica Nuova”, realizzato da Bruno Maderna e Severino Gazzelloni con i solisti dell’Orchestra Sinfonica di Roma. L’ampio apparato di note e immagini che l’accompagna è curato da Massimo Mila, noto musicologo italiano, autore fra l’altro di una “Breve Storia della Musica” del 1965, numerosi saggi, monografie, articoli e carteggi sulla musica moderna. La particolarità di questa operazione è nel dimostrare come la musica cosiddetta ‘moderna’ utilizzando l’apparato ‘sinfonico’ diventi appetibile anche per l’orecchio meno abituato o diversamente educato a recepirla. Tra gli autori presi in considerazione figurano infatti molti di quelli che, strada facendo, abbiamo incontrato fra le righe della musica elettronica: K. Stockhausen “Kontra-Punkte”; K. Penderecki “Aux Victimes de Hiroshima”, “Threne”; E. Brown “Available Forms 1” e “Rimes”; P. Boulez “Sonatine”; R. Haubenstock-Ramati “Interpolation”; B. Maderna “Concerto per oboe e orchestra”; L. Nono “Y su sangre yà viene cantando”; K. Fukushima “Hi-Kyo”; L. Berio “Serenata 1” per flauto e 14 strumenti; H. U. Lehmann “Quanti”. Tutte composizioni queste di autori più o meno noti che è possibile ascoltare in siffatta versione sinfonica solo in questa ‘edizione speciale’, mentre quella originale eseguita dai singoli compositori vede l’utilizzo di apparati sonori diversi e che pertanto risulta necessariamente diversa all’ascolto.
Ecco quindi che infine siamo giunti alla conclusione del ‘giro armonico’ intrapreso e che si è avvalso della musica come anche delle parole; al dunque possiamo ben dire che il movimento cosmico delle ‘sfere sonore’ pur cambiando si ripete come ieri, l’oggi, il domani; come nella vita la nascita, la morte e, nel caso della materia musicale, di una possibile resurrezione. Ciò che rimane di ogni cosa terrestre è comunque l’infinita ambizione dell’uomo che alimenta la corsa verso il futuro, mentre l’eco ripete l’accordo fissato su una nota sola: la musica altro non è che l’espressione sonora della follia (caos) trasformata in saggezza (condiscendenza) seppure mediata dalla accettazione /comprensione ‘fisica’ del rumore e del suono presenti in natura. Un macrocosmo sonoro che non possiamo tralasciare un istante di esaminare, controllare, collaudare per una sorta di rischio effettivo di venire travolti per effetto d’inquinamento acustico e, al tempo stesso, che dobbiamo imparare a governare per la capacità di questo di stravolgere gli equilibri umani che il ‘caos sonoro’ può determinare.
Acciò mi trovo in pieno accordo con ciò che ha detto Walter Marchetti il compositore italiano che adottò l'estetica dadaista di John Cage e fu pioniere della musica interattiva e concreta. Lo stesso che nel 1964 formò il gruppo ZAJ (una sorta di versione europea di Fluxus), con Juan Hidalgo a Madrid. Le sue registrazioni includono: “La Caccia” (Cramps, 1974), “In Terra Utopicam” (Cramps, 1977), che contiene tre composizioni, “Per La Sete Dell'Orecchio” (Cramps, 1984), “Da Nulla e Verso Nulla” (per marimba, maracas e nastro magnetico) e il collage di registrazioni di campo “Natura Morta” (Cramps, 1989), “Vandalia” (Cramps, 1989) a cui appartiene il notevole collage "Le secche del delirio - per porci e pianoforte", “The bird of Paradise” (Alga Marghen, 1994), il concerto concreto in cinque movimenti “Antibarbarus” (Alga Marghen, 1998), la colossale sonata per pianoforte “Nei Mari Del Sud” (Alga Marghen, 1999), “De Musicorum Infelicitate” (Alga Marghen, 2001), che include "Ten pieces in the form of mournful variations". Ma infine tutto questo bla, bla, sarebbe servito a poco se adesso non dicessi ciò che non ho ancora detto, cioè in che cosa mi trovo d’accordo col maestro: “..che la musica, macerie di tutte le idee, fa da sfondo ad un incendio che non rischiara ancora il mondo”.
*
 - Società
- Società
’NON SOLO MIMOSE’ 8 Marzo festa delle Donne
Festival Letteratura Milano
8 Marzo alla Biblioteca Chiesa Rossa - ore 19.00 ingresso libero.
Una serata 'non solo mimose', per comprendere e ricordare il vero significato della ricorrenza dell’8 marzo. Si parlerà di Donne, naturalmente. Di “Pazze, sognatrici, rivoluzionarie…” Di cantanti, ballerine, matematiche, scrittrici, scienziate, prostitute, curanderas, calciatrici, pilote d’aereo, schiave, rabdomanti, giornaliste, vagabonde, suore, filosofe, poetesse, amanti, guerrigliere… 'Volubil sempre come foglie al vento' (Boccaccio)
Tutto quì, sicuro che si vuole/debba solo parlare di loro?
Ci si può sempre offrire in ostaggio ... du, du dù!
Per loro la vita può essere ripartita in tre fasi: 'sognare l'amore, praticare l'amore, rimpiangere l'amore. Prima il bacio e poi le unghie'. (di anonimo)
Ma infine è sempre quello: l'amore, e non è poco se sono sempre loro a praticarlo, non vi pare?
Come dire che è 'la regina del mondo e la schiava di un desiderio!' (Balzac)
Di fatto ciò non è una colpa.
Certo che no, ma suona come un atto d'accusa contro l'egoismo, l'individualismo eccessivo, la trascuranza e la nullità di certi uomini.
Quindi è colpa degli uomini se le donne sono ... come sono?
Loro però, a differenza degli uomini, sono sempre disposte a perdonare .. non a dimenticare.
Dunque, il loro maggior nemico non è l'uomo (questo sconosciuto) bensì, 'quella pietà che gli fa fare la maggior parte degli spopositi che fanno'. (Baretti)
Buono a sapersi, quindi per l'8 Marzo regalerò a tutte 'non solo mimose' ma opere di 'pene'...
pardon, intendevo bene.
Ecco, l'unico merito di un uomo è il buon senso ... quando ce l'ha.
Pertanto, messi da parte i più virili pensieri, resto a disposizione limitandomi a godere di sentirle pronunciar parola in un qualche balzello letterario.
Auguri dunque Donne, che Marzo lustri per voi donne i fiori più belli, 'non solo mimose'.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Musicologia XIII - la Musica Contemporanea
MUSIC OF CHANGES / LA MUSICA CONTEMPORANEA
È accertato che la musica scaturisce immagini in quanto fonte di emotività costante proveniente dal subconscio uditivo capace di connubi differenziati modificati e trasmessi attraverso ultrasuoni che l’orecchio percepisce ed elabora in qualità di suono. Parliamo dunque di suono-visivo nel processo graduale di crescita e di esplorazione sonora. Gli esperimenti fatti nel campo della musica-visiva avanzati dai ricercatori all’inizio del Novecento sono indubbiamente molteplici e spaziano in molte applicazioni, coadiuvate dall’avanzamento incessante della tecnologica. Nel campo dell’arte – ad esempio – ciò appare assai evidente negli abbinamenti con la visual-art: scultura-musicale, pareti che vibrano ed emettono suoni diversi, parti meccaniche in movimento, architettura-fonetica ecc. ecc. che hanno segnato alcune ‘stagioni’ dell’arte contemporanea, e che oggi costituiscono il nostro bagaglio sonoro-musicale più avanzato.
Alcuni esempi eloquenti sono, a mio avviso, quelli proposti da John Cage, compositore, teorico musicale e scrittore statunitense, considerato una delle personalità più rilevanti e significative del Novecento la cui opera è centrale nell’evoluzione della musica contemporanea. Dapprima con “Imaginary landscape n.1” del 1939 e “Tuned Space” del 1950 costruito sull’idea per un’architettura in musica e, successivamente, con il ‘progetto’ di ‘un ambiente di suono e nebbia per un’isola svedese intitolato “Island Eye Island Ear” del 1958(?) nato dalla collaborazione con David Tudor anch’egli pianista e compositore, che John Cage ha dato il via a quella che sarà l’autentica rivoluzione estetica in musica, sconvolgendone da cima a fondo l’impianto strutturale mettendo in discussione i fondamenti della percezione uditiva. Ma è con “4’33’’ del 1952 ‘interamente immerso nel ‘silenzio’ che è possibile dire che Cage ha investigato tutto o quasi di quanto la sua apertura totale in musica poteva suggerire alla multimedialità ‘riconducendo il suono dentro il silenzio cosmico iniziale’. In questo modo “Io decido che ciò che ascolto è musica – disse in occasione della presentazione pubblica del brano 4’33’’. È l'intenzione di ascolto che può conferire a qualsiasi cosa il valore di opera. (..) Cerco di pensare a tutta la mia musica posteriore a 4'33’’ come a qualcosa che fondamentalmente non interrompa quel pezzo”. Con questa affermazione ripresa da Robert Rauschenberg, il pittore che nel 1951 produsse una serie di quadri bianchi che cambiano a seconda delle condizioni di luce dell'ambiente di esposizione, che Cage in breve rivoluziona il concetto di ascolto musicale, dando luogo a un’autentica rivoluzione estetica a dimostrazione che ogni suono, anche la più banale emissione sonora, può essere musica.
Altro esempio è dato da “Picture Music” di Klaus Schulze del 1973, musicista e compositore tedesco, il quale, dopo aver inciso un primissimo album (demo) entrò a far parte dei Tangerine Dream, poi degli Ash Ra Tempel, formazioni storiche degli anni ’70; per poi passare negli anni ‘80/’90 a composizioni più surreali ed eclettiche. Oltre ad essere considerato uno dei musicisti più rappresentativi dello stile ‘kraut-rock’ Schulze è il riconosciuto pioniere di molti generi e stili della musica elettronica e, sebbene la sua musica sia spesso cambiata nel corso dei decenni, è ricordato soprattutto per alcuni album del genere ‘ambient’: “Irrlicht” del 1972 e “Timewind” del 1975, sono dischi di una miscellanea organica pazzesca. Fra i due c’è “Cyborg” del 1973 e successivamente “Dune” del 1979, anche questo straordinario per le sue stratosferiche ‘visioni’ e aperture verso spazi sconosciuti. Risale invece al 2008 “Virtual Outback” contenuto insieme ad altri brani nei due cofanetti “Contemporary Works” (2000-2007) e “La Vie Electronique” (2009-2013) in cui Schulze esprime al meglio il senso del suo lavoro di costante ricerca: “Auguro a tutti una piacevole esplorazione di se stessi, non riesco a esprimerlo al meglio con le parole, perché non sono un poeta ma un musicista”. Il critico musicale Piero Scaruffi è riuscito a riassumere i tratti distintivi dello stile del musicista in questo modo: “Schulze cesellò (..) un'estetica che eredita dai ‘raga’ il senso del tempo, dal ‘jazz’ la spontaneità e dai sinfonisti tardo-romantici un vizio di grandeur. (..) Con lui l'organo da cattedrale, i ritmi sintetici, i timbri del synth, la suite di mezz'ora e più, diventano non più esperimenti d'avanguardia, ma stereotipi di consumo”. Inutile dire che in molti hanno seguito le sue impronte cosmico - immaginarie che hanno apportato nella musica cambiamenti fino allora inusitati e inimmaginabili.
Tuttavia il genere ‘ambient’ (d’impatto ambientale), si è sviluppato più tardi con Philip Glass compositore statunitense, autore di musica contemporanea, è solitamente considerato tra i capofila del minimalismo musicale avendo egli collaborato con vari artisti della scena ‘ambient’ (tra cui Brian Eno) e pop-rock (tra cui David Bowie, di cui ha adottato i temi di "Heroes" per comporre l'omonima sinfonia). Esaurito il periodo di massima produzione minimalista, contrariamente agli autori succitati, si è progressivamente emancipato, scegliendo uno stile di più facile fruizione, post-minimalista, meno rigoroso e spesso volto verso la tradizione ampliando al massimo le possibilità espressive offerte dalla tonalità, e accogliendo sempre più suggestioni dalle culture musicali extraeuropee, interesse del resto già manifestato all'inizio della carriera collaborando con il musicista indiano e compositore Ravi Shankar. Impossibile in questo contesto citare le sue composizioni, tuttavia una in particolare risulta essere di inequivocabile impatto ambientale: “Uakti” ‘aguas da amazona’ (musica per balletto) in cui Glass affronta lo straordinario contatto avuto con l’acqua dei numerosi rio e dei grandi fiumi continentali brasiliani, dal Tiqué al Tapajòs, allo Xingù, dal Rio Negro al Rio delle Amazzoni. Quello di Glass non abbraccia semplicemente un mondo musicale originale, bensì spazia attraverso un ‘universo’ di sperimentazioni che, partendo dalla musica sinfonica giunge fino ai nostri giorni. Il nome UAKTI è preso da una leggenda tipica della foresta amazzonica: UAKTI era il nome di una creatura enorme con tanti buchi sul corpo la quale, ogni qualvolta attraversava la foresta, il vento attraversava il suo corpo dando adito a particolari suoni (di strumenti) che sono poi quelli della foresta stessa, creatrice di ‘sound’ e di originali leggende.
Come la creatura leggendaria, UAKTI la magia della musica comincia con la costruzione degli strumenti esotici che il gruppo degli UAKTI (dall’omonima leggenda qui ripresa da Glass) suonano, vengono creati con materiali d’uso: tubi, occhiali, metalli, pietre, gomma e ovviamente acqua. Ciò che si presenta all’orecchio dell’ascoltatore è davvero una musica insolita catalogabile forse alla New Age (solo perché fa moda) per impatto musicale, ma c’è molto di più in essa che in qualunque altra musica del genere, c’è lo spaziare in anfratti originati dalla memoria ‘liquida’ dell’acqua, il suo scorrere negli anfratti segreti della terra che risaliti in superficie attraversano e bagnano il nostro stesso corpo. Un’esperienza unica questa che Glass ha così descritto: “Anni fa quando io incontrai UAKTI, considerai la loro musica e lo spettacolo offerto dai loro strumenti un contributo unico e bello da suggerire al mondo della sperimentazione. Divenni amico con tutti i musicisti, in special modo quando conobbi l'orecchio straordinario di Marco per quanto riguardava il colore e la composizione. Fui perciò molto lieto quando alcuni anni più tardi mi proposero una collaborazione. Si trattava di musica per un balletto commissionato dalla Società di Balletto Grapo Corpo della loro città, Belo Horizonte. Questo CD rappresenta un vero ‘melding’ (fusione) della mia musica con le loro sensibilità. Per me è una delizia ed un piacere riascoltare oggi il risultato che ciò ha prodotto”.
Si rende qui necessario fare un passo indietro e recuperare uno dei ‘mostri sacri’ della sperimentazione elettronica: Brian Eno, compositore e produttore discografico britannico considerato per definizione colui che ha gettato le basi della musica ‘ambient’ (spunto preso da ‘Imaginary Landscape’ di Cage) e in quanto precursore di altri generi quali New Wave, World Music e New Age. Al tempo stesso rendendola accessibile alla grande massa rock che, con i Pink Floyd di “Ummagamma’ del 1969 e poi di “Meddle” del 1971, fino a “Pulse” del 1975, già lasciava intravedere i possibili sbocchi che la musica elettronica avrebbe avuto in seguito. “Discreet Music” del 1975, “Ambient 1: Music For The Airports” del 1978 e “Music For The Films 1-2-3” del 1978-1980, non sono solo dischi eccezionali e imprescindibili per chiunque voglia approcciarsi al genere. A partire dal 1980, infatti si afferma definitivamente il concetto di "musica ambientale" con la collaborazione di David Byrne dei Talking Heads con il quale compone, nel 1981, “My Life in the Bush of Ghosts”, considerato uno dei migliori lavori della musica contemporanea, sia in senso pionieristico nel ricorso che si fa all'elettronica e ai campionamenti, sia perché diventa influente per lo sviluppo della futura World Music, di cui oggi si disconosce l’origine.
Negli anni successivi in effetti, il processo di comprensione della musica elettronica da parte del vasto pubblico non c’è mai stato, malgrado la credibilità culturale che oggi gli si voglia dare. In realtà l’aspetto commerciale ha preso il sopravvento e l ‘artefice’ di tanto sconvolgimento è andato incontro al pubblico per colmare la grande differenza che li teneva separati. Anche per questo la musica-visiva ha dovuto farsi portatrice di una certa comunicabilità che non aveva. Ha dovuto cioè ricercare quei simboli dell’espressività sonora che non gli appartenevano, quel certo vibrare connaturato e istintivo con la propria ‘anima mundi’ di ancestrale memoria che dava fondamento all’idea di musica nel suo insieme. A ciò molto è servito l’abbinamento con la cinematografia di genere documentaristica e del reportage ‘ambientale’, attraverso la quale l’occhio e l’udito potevano viaggiare insieme dalle profondità oceaniche fin dentro gli spazi siderali. Considerando che, altrimenti avrebbe rischiato di trovarsi in una posizione senza istituzione, altresì di proiettare, sé medesima, nella falsa realtà delle esigenze di moda e di costume, nel totale fallimento di poter raggiungere un’espressione artistica propria consona con il futuro che l’attendeva.
La porta musicale del passato remoto che a un certo momento sembrava essersi chiusa definitivamente, si spalancava di nuovo lasciando entrare il trapassato destinato ad una sua invasione di campo con il recupero delle sonorità etniche recuperate alla memoria e che un tempo avevano funzionato come cassa di risonanza nella comunicazione di massa. Ecco allora fare ritorno della ‘lingua dei tamburi’, sebbene rielaborata attraverso le nuove tecnologie, quella stessa che in alcuni rituali africani era in grado di scaturire tali forze evocative da stravolgere gli equilibri psico-fisici di intere masse di popolazioni che, in tal modo, tornavano ad appropriarsi di una sorta di ‘power’ incontrollabile e pericoloso che in passato molti studiosi e missionari erano giunti a proibirne l’uso. Un effetto simile nell’utilizzo della musica si riscontra nelle pratiche magiche e superstiziose in uso nell’odierno Brasile, con effetti extrasensoriali e parapsicologici su alcuni individui praticanti il culto della ‘macumba’ e legate al simbolismo di ‘umbanda’ attiva nei processi di reincarnazione e nel cannibalismo spirituale. Oppure, diversamente, nell’uso di tecniche vocali entrate nell’uso ‘mistico’ del trascendimento come nei ‘Canti rituali dei Monaci tibetani’, nel ‘Pansori’ Koreano, e nella liturgia turcomanna dei Dervishi ruotanti.
Superfluo dire che l’utilizzo scientifico della ‘musica’ e del ‘suono’ più in generale è tutt’ora oggetto di studi approfonditi che in qualche occasione hanno permesso di raggiungere applicazioni terapeutiche rilevanti nella diagnostica medica, nelle psico-patologie negli ambienti di lavoro e agonistico - sportivi; così come nell’elettroacustica alla ricerca di nuovi e idonei linguaggi di comunicazione, dall’apprendimento mentale simultaneo fino a quello simbiotico extrasensoriale attraverso il medium della musica. Come del resto è spiegato in “Musica e psiche” di Augusto Romano – Boringhieri 1999; e in “Musicofilia” di Oliver Sacks - Adelphi 2007 (vedi recensione in larecheche.it). Ma non solo, molto ci rivelano le diverse forme di happening collettivo e di training sonoro recuperate dalla tradizione del passato, come ad esempio in Spagna nella ‘petenera’ flamenca, e nelle ‘saetas’ lanciate durante la Settimana Santa, non poi così diverse, in Italia, da certe litanie ripetitive (e per questo minimaliste) della religiosità nostrana, come ad esempio nella ‘tammuriata’ napoletana e nella ‘pizzica’ pugliese che pure rappresentano una sorta di trascendenza in musica, derivata forse da rituali lontani nel tempo e d’origine indoeuropea che ripercorrono, al contrario, il percorso di Cage verso la ‘alea’, quando attorno agli anni ’50 s’interessò alla musica e alla filosofia indiana Zen con cui ridiscutere il concetto di musica, allora considerata come affermazione di vita, nella totale mancanza di scopi e di intenzioni da diventare perciò ‘aleatori’, ovvero si disperdono nel vuoto, nel segno di quel silenzio che infine ‘tutto risana’.
Ma ecco che sulle note del ritrovato silenzio ancestrale Cage escogita, non in modo intenzionale, un metodo (tecnica aleatoria) per organizzare il caso, per controllare l’imprevedibile, recuperando “The Seasons” del 1947, il suo primo pezzo orchestrale nato come musica per un balletto di Cunningham in cui, almeno nell’intenzionalità, tenta di “esprimere le armonie statiche e le antidirezionalità che suggeriscono l’andamento ciclico della natura”, da cui darà seguito a numerose altre sue composizioni multimediali. “Negli ultimi anni, tra il 1987 e il 1992, Cage compone le sue opere più astratte, intitolate semplicemente con dei numeri che rappresentano il numero degli esecutori. “Seventy-Four per orchestra”, del 1992, è composta per i 74 musicisti della American Composers Orchestra. La parte di ogni esecutore è composta di quattordici suoni isolati. Cage indica un lasso di tempo in cui il musicista ha la libertà di decidere quando fare iniziare il suo suono e un lasso di tempo in cui concluderlo. Poiché le due misure temporali si intersecano, il musicista può decidere di fare durare il suono un certo tempo, oppure può decidere di dare una durata nulla a quel suono. Il volume e gli effetti sugli strumenti sono lasciati alla scelta degli esecutori”. (fonte Wikipedia).
Un ulteriore aspetto fa riferimento ai tanti compositori che sulla scia di queste dinamiche abbiano lasciato il loro particolare e talvolta originale segno nella musica contemporanea, soprattutto nell’approfondire e ritualizzare la ricerca. Come ad esempio nell’utilizzo degli ‘overtone’ (ipertoni o armoniche) in cui “le componenti di un suono complesso dotate di una frequenza superiore a quella della fondamentale sono multipli interi della frequenza della fondamentale”. Cosa s’intende per ‘overtone’ è ben spiegato in “Enciclopedia della musica” (Garzanti/Feltrinelli), e comunque riguarda la ricerca del suono puro trasmesso dagli oscillatori di frequenza attraverso le onde sonore. Il canto armonico è usato fin dall’antichità a scopi curativi e meditativi, basti pensare ai Monaci di Gyuto, ma è comunque una forma espressiva ed artistica affascinante, che molti musicisti hanno esplorato con le loro composizioni e improvvisazioni, come ha fatto e fa anche Michael Vetter l’indiscusso musicista tedesco del genere, grande sperimentatore di timbri e tecniche per canto armonico, composizione grafica e di musica vocale sperimentale che ha ispirato grandi compositori come Karlheinz Stockhausen. Interessante è tutto il suo lavoro, sfociato in diverse pubblicazioni e incisioni come “Overtones” del 1982 per vocal e tambura; “Overtones in Old European Cathedrals” del 1985 per voci soliste e cori; “Ancient Voices” del 1992 e lo splendido “Nocturne” del 1993 per voce sola.
Torniamo a parlare di ‘ambient’ con numerosi compositori ‘ispirati’ alla ricerca del ‘suono puro’ come Paul Horn “Inside the Great Pyramid” del 1976 (per flauti e voce) che si fece chiudere all’interno della sala del sarcofago per una notte intera; Paul Giger e il suo “Chartres” del 1989 (per violino solo), registrato all’interno della famosa cripta della cattedrale; Stephen Micus “The music of stones” del 1989 registrato all’interno della cattedrale di Ulm con un’apperecchiatura sofisticata e accompagnamento di particolari strumenti esotici come lo ‘shakuhachi’ (flauto di bamboo giapponese), tin whiste (flauto originario irlandese), 3 chimes (campane tubolari), voce e ‘resonating stone’ (sassi sonori ‘ossidiana’?) o forse le pietre stesse della cattedrale).
Ma a Stephen Micus, musicista tedesco che lavora con gli strumenti musicali tradizionali di tutto il mondo e che si avvale di tecniche particolari come la registrazione multipista che gli permette composizioni molto originali come cori a 22 voci dove il cantante in realtà è soltanto lui, dobbiamo un riconoscimento particolare e il plauso di averci fin qui condotto per mano attraverso un itinerario che porta alla ‘conoscenza in musica’ di atmosfere ‘ambientali’ diverse selezionate dalla sua sofisticata sensibilità e suggestione di fronte a quello che è il creato in ogni sua espressione vitale. Alcuni titoli dei suoi album bene introducono al ‘mistero’ delle sue creazioni, un’alchimia di suoni, voci come soffiate dal vento e come il vento talvolta senza consistenza, sussurrate attraverso toponimi, parole in lingue sconosciute, frasi di poemi ascoltati una volta, narrazioni di leggende, come quella della gazzella in “Behind Eleven Desert” del 1978 che nella sua corsa sa dove andare e va verso un luogo che a noi rimane ignoto. Come solo conosce le spire del vento e muove le sue ali la cicogna in “Wings over Water” del 1982, in cui spingersi per nidificare; allo stesso modo in cui la risacca dell’ “Oceano” del 1986 giunge a lambire la costa e ad esso fa ritorno quasi senza un perché ma che pure conosce ‘in verità’ come la luce che si spalanca nelle tenebre in “Darkness and Light” del 1990; lì dove i fenicotteri rosa in “Towards the wind” del 2002 raggiungono le acque basse dove adire alla loro riproduzione nel giro armonico della ritrovata stagione.
Ma il suo e nostro viaggio non finisce qui, la sua musica può collocarsi nel crocevia fra la musica classica e la World Music in cui risuona l’eco di un incanto poetico di cui sono permeati i suoni, nel restituire ad ogni elemento ciò che lo riguarda, ciò che da sempre gli appartiene; e allora anch’egli non può sottrarsi dall’essere prima ancora che compositore, ascoltatore attento insieme a tutti noi di quella oralità udita sotto la pioggia e attorno al fuoco in cui tutto si esalta e si ravviva, come in “Listen to the rain” del 1983 e in “Desert Poems” del 2001 la cui dedica “For Yuko” s’imprime di delicato amore: "Quando nubi di tristezza s’aprono in me / io posso vedere i tuoi occhi. / Quando gli uccelli che ci circondano sono scomparsi nel cielo / io posso vedere i tuoi occhi. / Quando il fiume si confonde con l'orizzonte / io posso vedere i tuoi occhi." … e in me torna la lietezza d’essere vivo.
Ma se crediamo che non c’è amore senza poesia non ne facciamo mistero e sulla sua scia ci lasciamo coinvolgere volentieri dalla musica delle sfere ricreata per noi dallo strepitoso pianista/organista Keith Jarrett che, proprio in “Sferes” del 1976 raccoglie quattro movimenti ‘improvvisati’ che danno nome alla sua ‘sinfonia per organo’ dal titolo omonimo, registrata utilizzando il ‘Trinity Organ’ di Karl Giuseppe Riepp (1710-1775), organo dell'Abbazia Benedettina Ottobeuren. “Nessun ‘overdubs’ – informa Jarrett – ornamentazioni tecniche furono utilizzate, solamente il suono puro dell'organo nell'abbazia è quello che si ascolta. Molti degli effetti unici, sono stati ottenuti tirando per così dire un po’ le chiuse delle uscite, mentre altre restavano nella posizione di ‘aperto o chiuso’. Gli organi barocchi come questo si avvalgono straordinariamente di questa capacità”.
Tornando a parlare, dopo le divagazioni, di ciò che fa in musica un’esperienza ‘ambient’, torniamo ad occuparcene con David Byrne (statunitense d’origine scozzese), musicista, compositore, produttore discografico, attore, scrittore, vincitore di Oscar con Rvuiki Sakamoto e Con Su per le musiche del film di Bernardo Bertolucci “L’ultimo Imperatore” del 1987, e dei premi Golden Globe (1988) e Grammy (1989) per la sua produzione musicale, nonché fondatore dei Talking Heads. Nel 1981 ocllaborò con Brian Eno all’album “My Life in the Bush of Ghosts” che riscosse i favori della critica e fu tra i prodromi delle produzioni con ‘musica campionata’, all’epoca una nuova tecnica musicale che permetteva l’impostazione di una base musicale preparata (appunto campionata anche detta software culture)) su cui elaborare e/o aggiungere, sovrapporre, intervallare ecc. un tema o altro che avrà un enorme sviluppo successivo, tale che oggi anche la cosiddetta canzone pop è spesso elaborata su una ‘base’ campionata. La sua produzione musicale è vasta quanto varia e spazia oltremodo dal cinema alla coreografia, dal rock alla World Music, ma ciò che più interessa allo scopo di questo articolo/ricerca sono almeno due composizioni: “In Spite of Wishing and Wanting” del 1981 che apriva al genere ‘paesaggio sonoro’ (ambient), e “The Forest” del 1991 che in qualche modo ne rappresenta l’evoluzione e la conclusione. A questo proposito è lo stesso Byrne che ci aiuta a trovare la necessaria conclusione del discorso approntato, quando nella presentazione di “The Forest” del febbraio del 1991 avverte la necessità di inserimento in questo mondo che sta cambiando e che in effetti cambierà, con l’aiuto delle nuove tecnologie che egli dice rappresentano il nuovo mito da amare:
“È stato detto che un mito è un sogno che ci aiuta a trovare il nostro luogo nel mondo. In 'la foresta' ciò diviene il mezzo che da inizio a un processo: scoprire quello che è nella nostra natura e di cosa noi siamo fatti. Sia che generi delle idee o dei pregiudizi; che propagandi ciò che ci riempie o quello che noi pensiamo sia bello o brutto, quello che noi consideriamo Natura e quello che noi pensiamo è Dio. Il processo è stato un po' come una immersione nell'inconsapevolezza dello storico (isterico?), della mente storica europea nella speranza di scoprire come noi ci stiamo evolvendo, da quale genere di provenienza animale (?). La musica ci dice queste cose nella maniera del sogno che noi, in certi casi non capiamo, almeno non con le nostre menti dopo il risveglio. (..) Non è affatto un caso che molte di queste preoccupazioni vennero di nuovo in superficie e discusse estesamente durante la Rivoluzione Industriale in Europa e nord America, quando noi pensavamo che gran parte delle nostre idee con le quali convivevamo, la maggior parte dei concetti e dei sentimenti noi pensavamo fossero ‘moderni’. (..) Che ciò che faceva parte della Natura fosse bello e quello che era delle città fosse brutto, un po’ come per assunto diciamo che Dio è parte della Natura e che l’Uomo non fa parte di quella stessa Natura. (..) Una delle scoperte personali che io ho fatto mentre lavoravo a questo progetto è che noi siamo molto meno ‘moderni' di come noi pensiamo e siamo. Per gran parte noi stiamo vivendo e ispirando un mondo nuovo e mentre pensiamo già è lo sentiamo vecchio. Noi abbiamo bisogno di divenire consapevoli dei nostri pregiudizi e deviazioni prima di poter fare il prossimo passo. (..) Allo stesso modo io stesso vorrei essere capace di simpatizzare con quanti avvertono il futuro nella fabbrica, la bellezza e il potere, le molte possibilità delle macchine che cambieranno il mondo”.
‘Paesaggio sonoro’ traduzione dall'inglese soundscape, si intende, nelle parole del compositore canadese Raymond Murray Schafer che coniò per primo l'espressione, "un qualsiasi campo di studio acustico [...], una composizione musicale, un programma radio o un ambiente" con riferimento innanzitutto all’ambiente acustico naturale, consistente nei suoni delle forze della natura e degli animali, inclusi gli uomini. È il campo di studio del design acustico la cui teorizzazione è stata sviluppata dal World Soundscape Project, un progetto di ricerca condotto negli anni Settanta dal teologo musicale Pierre Schaeffer alla Simon Fraser University di Vancouver (Canada). Progetto al quale Eno e Byrne aderiranno (non so quanto volontariamente) con il loro lavoro di ricerca. Nel frattempo, nel 2006 è uscita una versione rimasterizzata - e con alcune nuove bonus track - del disco prodotto nel 1981 con Brian Eno. Due tracce del nuovo album sono state pubblicate in “Creative Commons”. Per quanto riguarda invece le arti visive, a parte il citato progetto in PowerPoint, Byrne vanta al suo attivo una serie di mostre a partire dalla metà degli anni novanta: installazioni, sculture, dipinti, spesso non firmati. Nel gennaio 2007 il New York Times gli ha dedicato un profilo, che fa riferimento a un’affermazione tratta dal suo blog, nel quale Byrne dichiara «Ero un ragazzo borderline, immagino a causa dell’Asperger». Nel 2011 scrive le musiche per “This Must Be the Place”, film di Paolo Sorrentino durante il quale il musicista si esibisce cantando l'omonimo brano incluso nell'album dei Talking Heads “Speaking in Tongues” del 1983, e recitando alcune brevi parti.
In aggiunta e in conclusione mi limito ad elencare qui di seguito i nomi di artisti che negli anni ‘80/’90 hanno dato in qualche modo impulso creativo al genere musicale cosiddetto ‘elettronico’ misurandosi in qualche occasione con i ‘geni’ della manomissione musicale, sfolgoranti per creatività e intuizione nell’ormai vasto panorama della musica contemporanea, come l’ancor grande Vangelis Papathanassiou, i giapponesi Masanori Takahashi in arte Kitaro e Stomu Jamash’ta, Mike Oldfield, Jean Michel Jarre, Peter Gabriel, Steven Halpern, John Surman, Kip Hanrahan e moltissimi altri in ogni parte del mondo che hanno raggiunta una certa popolarità ancorandosi alla più commerciale pop-music, all’intrattenimento, all’ easy-listening. Con ciò riappropriandosi della tradizione classica per certi aspetti emozionale e/o esuberante, indubbiamente più armoniosa e rilassante con punte di pathos minimalista e contaminazione onirica.
Ne è un chiaro esempio l’opera omnia del compositore Michael Nyman, compositore, pianista, musicologo e librettista inglese, rappresentante del minimalismo musicale, tra i primi a utilizzare questo termine in ‘musical contest’ nel 1969. Nel 1967 Nyman ha iniziato una lunga collaborazione con il regista gallese Peter Greenaway, per il quale ha composto numerose colonne sonore, tra le più recenti “La stanza del figlio” di Nanni Moretti. Tuttavia egli deve la sua popolarità al film “Lezioni di piano” (The Piano, 1993), un film di Jane Campion di cui ha scritto la colonna sonora. Nicola Piovani ha riproposto “Water Dances” di Nyman (tratto dal cortometraggio “Making a Splash” di Peter Greenaway). Tuttavia Nyman è anche conosciuto per i suoi lavori musicali non legati ai film come “Noises, Sounds & Sweet Airs” (1987), per soprano, contralto, tenore ed ensemble strumentale (basato sullo spartito di Nyman per La Princesse de Milan); “Ariel Songs” (1990) per soprano e banda; “MGV” (Musique à Grande Vitesse) (1993) per gruppo; “The Piano Concerto” (1993) basato sullo spartito di ‘Lezioni di piano’, con l’uso di clavicembalo, trombone e sassofono; l'opera “The Man Who Mistook His Wife for a Hat” (1986), basato su un case-study di Oliver Sacks; e diversi quartetti per archi. Nyman ha inoltre scritto un libro nel 1974 sulla musica sperimentale intitolato “Experimental Music: Cage and Beyond”, in cui esplora l'influenza di John Cage sui compositori classici.
(continua)
*
 - Cinema
- Cinema
La scatola dei sogni - cinema, moda, fascino sul set.
'LA SCATOLA DEI SOGNI' (teatro, cinema, fascino moda e curiosità sul set del music-hall). (prima parte)
C’e un passato al quale possiamo tornare non senza una certa ironia sentimentale e perche no, con ‘un pizzico di follia’ che lo riscatti dal peso dei decenni e lo rapporti con la realtà del presente. Un certo qual modo per riappropriarsene? Forse. Certamente uno stratagemma per vincerne la vetustà del tempo. “That’s Entertainment!” - si trovò ad esclamare il regista Marvin Le Roy alla presentazione del film “C’era una volta Hollywood” (1974), un'eccezionale rassegna delle sequenze più significative dei grandi film musicali mai realizzati, nel quale riproponeva spezzoni di altrettanti film di successo dal 1929 al 1958, ormai divenuti classici di un certo cinema, e che testimoniano come “…lo show business hollywoodiano servisse a rendere la gente un po' più felice col fargli credere qualcosa che probabilmente non aveva mai visto e che non avrebbe visto mai”.
Fù così che fra il 1925 e il 1935, sulla scia dei grandi successi di Broadway, l’allora giovane cinema hollywoodiano prese ad interessarsi al Musical, trasformandolo in breve in materiale di più largo consumo, appunto il ‘film musicale’ che, a sua volta, riprendeva gli spettacoli teatrali considerati di intrattenimento detti appunto ‘Music Hall’, da cui il ‘Musical’, che da allora in poi avrebbe ottenuto un incomparabile successo di pubblico e di critica.
Erano quelli gli anni d’oro di “Paramount on Parade” (1930), di “Movietone Follies” (1929/30), della Fox di “Show of the Shows” (1929), della Warner e di “Hollywood Revue” (1929) e della Metro, unicamente prodotti dalle ‘major’ cinematografiche esistenti. Quegli stessi anni che Angus Wilson (*) nel suo esilarante libro "Per chi suona la cloche", successivamente distinse come: “..una stagione romantica e satanica, degradata edulcorata e commercializzata”, e che nell’insieme fornirono quella che andrà sotto il nome di ‘grande illusione’ di tutta un’epoca.
Quel ‘sogno americano’ iniziato negli Anni Venti, così detti ‘roaming twenties, e che in seguito diverrà agli occhi dell’America e del resto del mondo, un’autentica realtà, rivestita di lustrini e paillettes, di musica scatenata e di quella ‘polvere di stelle’ che avrebbe illuminato il firmamento ancora molto tempo a venire. Non conosco allegoria più pertinente di quella che il giovane cinema americano di quegli anni espresse attraverso il ‘Musical’. Senza ombra di dubbio, l’unico e il più grande espediente di tutti i tempi, utilizzato e fermato sulla celluloide e che lo trasformò in vera e propria forma d’arte. Per cui acquisì, per così dire, una originale identità linguistica e sonora posposta all’immagine di se stessa, e che in seguito fu definita ‘l’epoca d’oro del cinema americano’ destinata a un grande successo oceanico.
Le due figure primarie di questa nuova ed eccentrica creatività furono senza alcun dubbio: Florenz Ziegfeld e Busby Berkeley i qual malgrado il cinema fosse ancora alle sue prime esperienze sonore, diedero al cinema quella spettacolarità di cui aveva bisogno per imporsi al grande pubblico. Non solo questo, il pubblico accorse in massa e riversò in questa ‘follia’ del il quotidiano delle sue aspettative di ‘sogno’, cui da sempre (nell’inconscio collettivo) sperava un giorno di poter prendere parte. E con quel ‘sogno’ si andò risvegliando, desiderosa com’era d’essere finalmente sollevata dalle brutture della guerra, della povertà, della fame che avevano oppresso il mondo intero.
Spettò a Florenz Ziegfeld consacrare il grande successo del ‘Musical’ con la creazione delle “Ziegfeld Follies” rappresentate dal 1907 al 1932 in teatro e la cui formula egli aveva ripreso dalle celebri “Follies” che movimentavano le notti parigine. Al fasto grandioso dello spettacolo parigino Ziegfeld affiancò la ricercatezza dei costumi creati per ogni singola esibizione canora e coreografica, con la stessa magia con cui i ‘nuovi’ effetti luminosi, messi a punto in quegli anni nella ‘ville lumiere’, trasformarono i palcoscenici con nuove ‘atmosfere’ e ‘ambientazioni’ sublimi che negli spettacoli venivano evocate. Basti qui ricordare gli spettacoli “42nd Street” (1933) con le canzoni “Fortysecond Street” e "Shuffle Off to Buffalo” e le tante altre di successo che fecero il giro del mondo; come ad esempio: “A pretty girl is like a melody” cantata da Dennis Morgan e “Don’t say goodnight” portata al successo da Dick Powell.
Ma è con Busby Berkly che si arriva alla glorificazione della donna nello show-business e che, detta così in breve, diventa l’oggettività personificata. Oggi, la frase suona decisamente diversa, quasi malevola, ma agli occhi dell’epoca, in cui la donna era considerata poco più che niente, salvo rare eccezione fra le alte sfere della nobiltà decadente, tutto ciò segnò l’avvio verso l’emancipazione femminile, anche grazie al seguito delle prime conquiste ‘femministe’. Si potrebbe dire che la donna dell’epoca adattasse la propria vita privata e mondana, alla moda cinematografica di allora, ricreata ed edulcorata sui set hollywoodiani.
Dallo schermo infatti apprendeva a vestirsi, a pettinarsi, ad atteggiarsi sull’esempio delle dive dell’epoca. Cosi come l’uomo si era già a quel tempo, impossessato del mito di Rodolfo Valentino. Il primo grande ‘mito’ riconosciuto del cinema mondiale. “Hooray for Hollywood” dal film “Hollywood Hotel” (1938), insieme a “That’s Entertainment” possono dirsi i due ‘pezzi forti’ del film “C’era una volta..” che si può dire rinnova il successo di tanti altri motivi tratti da film stupendi. Ne cito solo alcuni: “Wonder Bar” (1934) in cui l’astro nascente di Al Jolson con “About a quarter to nine” attraversò, si disse, ‘come una cometa’ il firmamento hollywoodiano.
I più giovani forse non conoscono il mitico film “Il Cantante di Jazz” (1927), primo Musical cinematografico dove un piccolo uomo con la faccia ‘tinta di nero’ rifaceva il verso ai bluesman che lungo il Mississippi intonavano nenie dal sapore nostalgico e che ‘spezzavano il cuore’. In pochi immagino conoscano o ricordino il pure straordinario Eddie Cantor e i suoi ‘musical-extravaganza’, una sorta di parodia in musica che con “Kid Millions” (1930) e “Roman Scandals” (1933), segnarono tappe importanti nell’avanzata del Musical che qui si vuole raccontare. Di quest’ultimo soprattutto va ricordata una canzone celebre “Mandy”, che oggi definiremmo una ‘evergreen’ che fece piangere generazioni di fan e dato al mondo una ragione in più per celebrare il cinematografo come mezzo espressivo per eccellenza.
Da quel momento chiunque avesse uno ‘spicciolo’ di talento si presentava alle case di produzione cinematografica per ottenere una ‘parte’ anche la più misera e che, seppure gli l’avesse portato all’agognato successo, non era detto gli avrebbe concesso una maggiore felicità ma questa era cosa secondaria, la felicità era lì a portata di mano, bastava prenderla. Fu così che ognuno apprese a cantare e danzare sul filone della scena cinematografica fino a che il mondo intero sembrò come impazzito, preso da una febbre eccessiva per i ritmi d’ogni provenienza, vin quella che fu definita l’ “era della trasformazione del sui passi del ‘Tip-tap’.
Ciò che avvenne al seguito di una schiera di ballerini e ballerine di grande rilevanza e in qualche modo audaci, in pellicole che ne enunciavano l’evoluzione: a cominciare da “Top Hat” (1935) su musiche e canzoni di Irving Berlin, con le coreografie di Hermes Pan, e che segnò il culmine aristocratico con la coppia Fred Astaire e Ginger Roger. Un film dove stile ed eleganza si sposavano col fascino dei movimenti di due ballerini di incredibile versatilità che si ripeterà in altre pellicole realizzate dalla coppia: “Top Hat” con la celeberrima “Cheek to cheek” e ancora “Flying down to Rio” (1933) con “Carioca” un film realizzato da Vincent Youmans con musiche e canzoni di Irving Berlin. Una citazione a parte va fatta per “Smoke gets in your eyes” dal film “Roberta” (1934) un’altra straordinaria canzone che più mi piace ricordare, non tanto per celebrare il film quanto per lasciare spazio alla vostra immaginazione di quanto, in quegli anni, veniva concesso al ‘meraviglioso’, da considerarsi tra i momenti più ‘eccitanti’ in assoluto del cinema musicale.
La scelta non è casuale quanto, invece, mi occorre per introdurre la trama di un altro film il cui successo continua ancora oggi: “Il mago di Oz” (1939), una fiaba colta e insieme raffinata, unica nel suo genere. Il suo autore Frank Baum ne trasse un musical andato in scena a Broadway nel lontano 1902, uno dei più grandi successi che si ricordano del teatro americano dei primi anni del secolo. Successivamente, nel 1939, la Metro Goldwin Mayer ne realizzò un film di altrettanto successo per la regia di Vincent Minnelli, la cui interprete principale era la straordinaria Judy Garland. Vi si racconta la storia di Dorothy, una bambina che viene trasportata da un ciclone dalla sua casa nel Kansas nel mondo fantastico della ‘Citta degli smeraldi’.
Qui, nella ricerca della strada che la riporti a casa, incontra dapprima una Fata buona, quindi uno Spaventapasseri chiacchierone, un saggio e volenteroso Boscaiolo di stagno e un Leone sornione e codardo che d’ora in poi saranno i suoi compagni di viaggio. Insieme devono superare molte avventure attraverso le quali arriveranno a incontrare il grande Mago di Oz che fino allora nessuno ha mai conosciuto, l’unico in grado a ricondurre a casa Dorothy e a dare agli altri quello che essi desiderano da sempre: un cuore pulsante al Boscaiolo di stagno, l’intelligenza allo Spaventapasseri e il coraggio al Leone codardo. La canzone leit-motiv del film “Over the rainbow” nel corso degli anni ha conosciuto centinaia di versioni cantate dai più straordinari artisti della musica leggera. Né va dimenticata la bellissima “If I only had a brain, a hart, the nerve” cantata in coro dagli insoliti personaggi della fiaba.
Judy Garland indubbiamente è stata la stella più luminosa del film musicale, colei che ha dato al Musical momenti di eccezionale vitalità, fino alla sua interpretazione di “È nata una stella” (1954) di George Cukor che la consacrerà per sempre nel firmamento hollywoodiano con la canzoni: “Come Out Wherever You Are”, “Ding Dong the Witch is Dead”, “Munchkinland” ed altre, le cui interpretazioni sono a tutt’oggi gioielli di musicalità canora capaci di trascinare l’ascoltatore in una suggestiva atmosfera di sogno insuperabile. Il Musical dunque come ‘sogno’ o come semplice ‘illusione’? Restano famose alcune parole del film “Wonder Bar”: “Why can’t this go on forever?” (Perche tutto questo non dura in eterno?). Stiamo ancora aspettando la risposta.
Ma torniamo ancora per un momento a “C’era una volta Hollywood” prodotto e diretto da Jack Haley Jr., con Daniel Melnick in qualità di produttore esecutivo e ben 11 celebri ‘divi’ che erano alla MGM nel periodo in cui il ‘motto’ riprendeva quello di tanti altri Studios cinematografici: “Fatelo in grande, fatelo bene e dategli classe”. Numerosi i film presenti in questa pellicola che nell’insieme hanno meritato in tutto 126 candidature all’Academy Award e cumulato ben 38 Oscar. La pellicola raccoglie in sé la scelta di circa cento altri film prodotti rispettando quelle direttive. Straordinari risultano gli interpreti chiamati a intervallare gli spezzoni dei loro stessi film, i quali sono rievocativi di tannt’altri ricordi personali, e che sono in ordine: Fred Astaire, Bing Crosby, Gene Kelly, Peter Lawford, Liza Minnelli, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Mickey Rooney, Frank Sinatra, James Stewart ed Elizabeth Taylor.
E non solo, vi appaiono anche Judy Garland, Deanna Durbin, Leslie Caron, Cyd Charisse, Ann Miller, Esther Williams, Eleanor Powell, Joan Crawford, Jimmy Durante, Lena Horne, June Allison, Carmen Miranda, Tony Martin, Ginger Rogers, Vic Damone, Howard Keel, Van Johnson, Ava Gardner, Clark Gable, Cary Grant, Jean Harlow, Norma Shearer, Robert Montgomery e tanti, tantissimi altri che in fatto di cantare, ballare e recitare non avevano rivali già solo se si considerano le 13 candidature e i tre Oscar che il film ha al suo attivo. Come pure si trovò a dire Jack Haley Jr. scrittore, produttore e regista del film in occasione della ‘prima’: “Ciò che abbiamo messo insieme rappresenta il valore di miliardi di dollari, in quanto vi sono le musiche dei più grandi musicisti del secolo e il lavoro di molti registi, produttori, scenografi e coreografi tutti famosissimi. Ma a parte le statistiche, ciò che è più importante è che si tratta di puro e grande spettacolo.”
Il film si apriva con questa dichiarazione: “Attraverso gli anni, sotto la direzione di Louis B. Mayer ed altri, la Metro Goldwyn Mayer produsse una serie di film musicali il cui successo e merito artistico sono rimasti ineguagliati nella storia del cinema. Vi sono state letteralmente migliaia di persone, artigiani e tecnici che operavano dietro la macchina da presa, oltre agli artisti che affascinavano le folle dallo schermo, che hanno contribuito con il loro talento alla creazione dei grandi ‘Musical’ della MGM. Questo film e dedicato a tutti loro”. Non in ultimo c’è da aggiungere il grande lavoro svolto per la ‘colonna sonora’ composta da Henry Mancini, che lega i brani eseguiti più conosciuti con quella/e degli spezzoni musicali recuperati. I brani scelti inoltre sono stati tutti adattati o ri-adattati con una scelta quanto mai appropriata alla nuova musica appositamente scritta per il film che rende il sonoro omogeneo in ogni sua parte.
Nell’impossibilita di citarli tutti, e perché vi sono stati incorporati spezzoni di ‘corti’ ed altro materiale filmico di opere mai apparse in Italia, fornisco qui di seguito una breve lista dei film MGM presenti in questa straordinaria pellicola: “The merry widow” (1934), “Dames” (1934), “Tentazione bionda” (1935), “San Francisco” (1936), “Nata per danzare” (1936), “Babes in arms” (1939), “Via col vento” (1939), “Musica indiavolata” (1940), “Se mi vuoi sposami” (1941), “Meet me in St. Louis” (1944), “La parata delle stelle”(1944), “Due marinai e una ragazza” (1945), “Cynthia” (1947), “The pirate” (1948), “L’allegra fattoria” (1950), “Show Boat” (1951), “Un Americano a Parigi” (1951), “Cantando sotto la pioggia” (1952), “Spettacolo di varietà” (1953), “Sette spose per sette fratelli” (1954), “Alta Societa” (1956), “Gigi” (1958), che hanno segnato, insieme a tanti altri, alcuni momenti assolutamente ‘magici’ che a rivederli oggi entusiasmano ancora.
Abbandonati gli schemi delle ‘parade’ e delle ‘follies’ ripresi dai grandi successi parigini, la seconda generazione del ‘Musical’ hollywoodiano reinventò se stessa portando in scena l’ormai tramontata Operetta, a cominciare da “Porgy and Bess” (1935) in versione lirica di Georges Gershwin su libretto di DuBose Heyward e testi di Ira Gershwin. La storia si basa sul romanzo dello stesso Heyward “Porgy” e sull’omonimo lavoro tatrale che egli scrisse con la moglie Dorothy, che descrive la vita degli afroamericani nell’immaginaria strada di Catfish Row a Cherleston, nel South Carolina, all’inizio degli anni trenta. Narra la storia di Porgy, un uomo di colore zoppo dei sobborghi ("slum") di Charleston e il suo tentativo di salvare Bess dalle grinfie di Crown, il suo protettore, e Sportin' Life, uno spacciatore senza scrupoli che la maltratta.
Originariamente concepita da Gershwin come una "American folk opera" ("opera popolare Americana") “Porgy and Bess” fu rappresentato la prima volta il 30 settembre del 1935 nel Colonial Theatre di Boston diretto da Alexander Smallens ed il 10 ottobre all'Alvin Theatre di New York per Broadway, ma non fu accettato negli Stati Uniti come opera legittima fino ai tardi anni '70 e '80 e solo ora è considerata parte del repertorio operistico popolare ed è anche regolarmente rappresentata internazionalmente. Nonostante questo successo, l'opera è stata controversa fin dall'inizio, dopo che alcuni critici l'avevano considerata razzista.
Un grande del cinema, il regista Otto Preminger che, nel 1959 ne fece un buon film, tuttavia poco e niente portò alla sceneggiatura strettamente connessa con la trama e alla scena che tuttavia restava legata alla scena teatrale, si trovò a tagliare alcune parti musicali fra le tante che componevano l’Opera originale. Quelle rimaste sono comunque tutte di grande levatura musicale, tra le quali spicca ‘Summertime’ il pezzo che negli anni ha visto innumerevoli interpretazioni eccellenti. Ma non è la sola, sia per l'innovativa sintesi che Gershwin attuò servendosi delle tecniche orchestrali europee; sia per l'utilizzo con il Jazz e la musica Folk.
Lo testimoniano le numerose e contaminate esecuzioni e interpretazioni suggeguitesi nel corso degli anni: ‘My Man's Gone Now’ è contenuta negli album “Porgy and Bess” di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong del 1957 e “Gershwin Live!” di Sarah Vaughan con la Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas del 1982 premiato con il Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Female 1983. ‘Bess, You Is My Woman Now’ è contenuta negli album “Porgy and Bess” realizzato da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong )del 1957, e “Porgy and Bess” di Harry Belafonte e Lena Horne con gli arrangiamenti di Lennie Hayton del 1959. ‘It Ain't Necessarily So’ è stata resa nota anche dall'interpretazione di Sammy Davis Jr. nel film del 1959, e contenuta in “Aretha” (album 1961) di Aretha Franklin, e nell'album “The Magnificent Moodies” del 1965 dei The Moody Blues.
La stessa è inoltre stata cantata dai Bronski Beat nel 1984 sia come singolo che nell'album “The Age of Consent”, da Cher in “The Glory of Gershwin” del 1994; nell'album “Porgy & Bess” di Joe Henderson (con John Scofield, Tommy Flanagan, Dave Holland e Jack DeJohnette) del 1997 cantata da Sting, nell'album “Pointless Nostalgic” del 2002 di Jamie Cullum, in “Brian Wilson Reimagines Gershwin” del 2010 ed in “Let Them Talk (Hugh Laurie)” del 2011.‘I Loves You, Porgy’ è inoltre stata eseguita da Nina Simone nel 1958 sia come singolo che negli album “Little Girl Blue” dello stesso anno e “Nina Simone in Concert” del 1964 e nell'album “Waltz for Debby” del 1961 di Bill Evans (con Scott LaFaro e Paul Motian al Village Vanguard). Davvero poco conosciuta è la vera ‘chicca da amatori’ di “Porgy & Bess” realizzata dalla coppia Ray Charles – Cleo Laine arrangiata e condotta da Frank DeVol nel 1976 negli Studi della RCA Recording di Hollywood in California, in cui i due grandi ‘vocalist’ spesso si scambiano le parti e interpretano duetti da brivido. Il cofanetto di 2Lp edito da London- CrossOver contiene un booklet con foto di Phil Stern, testi di Benny Green e Norman Granz.
Ma torniamo pure al Musical vero e proprio, partendo da “Il Pirata” (1948) sempre di Vincent Minnelli che, in quegli anni prematuri, pur aveva individuato quale sarebbe stato il futuro del Musical a tutto tondo. Dagli elenchi che abbiamo fin qui scandagliati una pellicola su tutte apre gli Anni ‘50: “Un americano a Parigi” (1951) ancora diretto da Vincent Minnelli su musiche dell’ormai celeberrimo George Gershwin con le coreografie dell’allora esordiente Gene Kelly e le straordinarie canzoni “Singing in the rain” e “S’ wonderfull”. Con questo film che il critico Pauline Kall definì “..Il miglior musical di tutti i tempi” l’orizzonte del film musicale spalancò definitivamente le porte alla sua esuberante allegria che la ritrovata gioia di vivere post-war reclamava a gran voce. A seguire troviamo “Anna prendi il fucile” (1950), “Baciami Kate” (1953) e il già citato “Sette spose per sette fratelli” (1954), “Gigi” con i suoi strepitosi e affascinanti interpreti, da Leslie Caron, Maurice Chevalier e Louis Joudan, e le canzoni altrettanto celebri “Gigi”, “Thank even for little girl” scritte da un binomio d’eccezione: Lerner-Loewe.
Dacché Hollywood si dichiara a profitto esclusivo di un pubblico che reclamava di diritto le sue storie a lieto fine, forse un po’ sciocche ma senz’altro meravigliose. Il duo Lerner - Loewe, va ricordato per aver firmato numerosi musical di successo come “Brigadoon” (1955), “Paint your wagon” (1969) e il favoloso, trasbordante successo “My fair Lady” (1964) del quale si parlerà ancora per lungo tempo. C’e però un momento che va sottolineato, se non altro per rimarcare quella ‘magia’ del musical che Vincent Minnelli riuscì a creare negli anni ‘50, legata all’indimenticabile sequenza di ballo di “Dancing in the dark” tratto dal film “Spettacolo di varietà” (1953) i cui straordinari interpreti Fred Astaire e Cyd Charisse danzano avvolti nella penombra della sera sulla musica di uno dei motivi orchestrali più belli che e dato ascoltare e che, per chi ha avuto occasione di vederli danzare, ha dato al cinema una delle sequenze che non si possono facilmente dimenticare.
Tuttavia altre occasioni strepitose sono costantemente offerte dal cinema musicale di quegli anni. Vanno qui ricordati: “Lola-Lola” e “Ich bin die fesche Lola” eseguite da Marlene Dietrich in “L’angelo azzurro” (1930) e la ‘mitica’ “I’m no Angel” (1933) dal film omonimo cantata da Mae West. Successivamente, “Amado mio” e “Put the blame on Mame” ascoltati nel film “Gilda” (1946) affidate al sex-appeal di Rita Haywort, sebbene l’esecuzione canora non fosse la sua, che ha stracciato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Ma ecco che un altro film, per così dire, continua successivamente la splendente tradizione di “C’era una volta …” ed è senz’altro “Hollywood…Hollywood” (1976) che riprende da dove terminava il primo. Come a dire che Hollywood non ha eguali, basta il nome a ricordarcelo. Questa volta presentando sequenze favolose di ‘Musical’ con particolare rilievo a divi non-canori come Greta Garbo, Clark Gable, i Fratelli Marx e numerosi altri che, oltre a presentare un’attrazione, accontentava in egual modo tutti gli spettatori del mondo.
Fred Astaire e Gene Kelly vi appaiono non solo come presentatori delle sequenze sceniche, bensì anche come protagonisti, ballando e cantando in numeri coreografici appositamente ideati e diretti per il film: “Avevamo bisogno di una nuova formula per il film e così abbiamo pensato che la cosa più ovvia da fare era lasciarsi guidare attraverso i ricordi musicali di due grandi che pur senza sperarlo hanno creato per questo film davvero una grossa sorpresa. Abbiamo voluto aggiornare il Musical, abbiamo cercato di farlo con canzoni che avessero nuove parole e quelle scritte da Howard Dietz e Saul Chaplin per “That’s Entertainment” sono davvero insuperabili” –affermarono i due produttori Daniel Melnick e Saul Chaplin alla presentazione del film. Lo stesso Gene Kelly che ne diresse tutte le nuove sequenze, compresa una speciale ripresa in esterni dedicata a Parigi, ebbe a dire a proposito della sua esibizione con Fred Astaire: “Abbiamo sentito la musica e inevitabilmente abbiamo cominciato a ballare”.
‘Inevitabilmente’ certo, quando la musica è quella delle canzoni che hanno fatto il giro del mondo, tutto diventa più facile, come dire che i piedi ballano da soli. Infatti Kelly e Astaire sono riusciti a dare al film una narrazione scintillante quanto le sequenze scelte dai vecchi film. I contributi di Fred Astaire comprendono il balletto “Triplets” dal già citato “Spettacolo di varieta” di Vincent Minnelli, una canzone di Howard Dietz e Arthur Schwarz che in un primo tempo era eseguita da Nanette Fabray e Jack Buchanan insieme ad Astaire in cui il entrambi ballavano in ginocchio sì da sembrare bambini. Un’altra canzone però “Steppin’ Out With My Baby” di Irving Berlin, per la quale fu creata una coreografia quantomeno ‘rivoluzionaria’, in cui al ballo lento di Fred, girato al rallentatore, si contrapponeva un’azione coreutica scatenata, riuscì a ricreare quella ‘magia’ che il Musical spesso reclama. Si tratta di un’altra straordinaria interpretazione di Fred “I love Allo f You”, un pas de deux poetico, coreografato da Hermes Pan, tratta da “Silk Stocking” (1957) di Rouben Mamulian, che sottolineava l’enorme versatilità di Astaire e la sua grande capacità di adattarsi al mutamento delle tecniche cinematografiche.
Sempre in “Hollywood … Hollywood” va ricordato il duo Rogers ed Astaire nel balletto “Bouncin’ The Blues” eseguito dietro le quinte e che ben sottolinea la loro strabiliante abilità nel tip-tap. La stessa carriera di Gene Kelly e qui ben rappresentata da “For Me and My Gal” (1942) e ancora da “Il Pirata” (1947) entrambi di Vincent Minnelli che Gene condivise con Judy Garland, entrambi presenti in questa antologia da urlo. Va detto che Kelly, sempre alla ricerca di nuove tecniche, fu un pioniere nel combinare riprese dal vero con i cartoni animati. Chi non rammenta il divertente balletto col topo Jerry in “Due marinai e una ragazza” (1945), e in “ Trittico d’Amore” (1956), oppure la sua interpretazione nel balletto ‘classico’ incluso in “Simbad The Sailor” (1947) sulla musica di Rimsky Korsakov?
Tutti noi credo, del resto pensando a Kelly è impossibile non associarlo al gioioso tributo che nei suoi film lasciava al piacere per la vita, idealmente personificato da “Good Morning” in “Cantando sotto la pioggia” (1952) con Debbie Reynolds e Donald O’Connor, come pure la sua sfilata sui pattini nei viali della MGM in “E’ sempre bel tempo” (1955) diretto dallo stesso Kelly con Stanley Donen. E i suoi pattini non potevano davvero mancare anche nelle nuove sequenze create e dirette da Kelly per “Hollywood…Hollywood”, dove egli balla con una schiera di bambini francesi sui marciapiedi parigini davanti alla Tour Eiffel in una meravigliosa presentazione di tutti i grandi musical della MGM che hanno visto Parigi come set prescelto.
Alle spalle la Parigi del dopoguerra, divenuta di nuovo la capitale romantica del mondo a fare da sfondo a Gene Kelly che canta “Our Love is Here to Stay” di Gershwin; che balla con Leslie Caron in una scena del già citato “Un americano a Parigi”. Le sequenze di quella Parigi incantata tornano anche in “La Vedova Allegra”(1934) di Ernst Lubitsch con una sala da ballo piena di ballerini che ballano il valzer, mentre Maurice Chevalier canta le canzoni di Franz Lehar “Girls, Girls, Girls” e “I’m going to Maxim’s” nella famigerata sequenza del “Can-Can”(1960) dal rifacimento del film di Curtis Bernhardt con Gwen Verdon come protagonista. L’allegria di quegli anni è quindi assicurata ma contrasta con la melodia di Kern Hammersten musicata per “L’ultima volta che vidi Parigi” (1954) e cantata da Dinah Shore sullo sfondo di fotografie sbiadite della città prima della guerra.
A Hollywood però si lasciano le lacrime dietro le quinte o se preferite dietro lo schermo e molti nuovi volti vi si affacciano increduli in cerca di notorietà. Devono la loro fama di artisti e ancor più come cantanti di successo, personaggi che hanno iniziato la propria carriera prendendo parte a questo o quel Musical, talvolta solo impegnati in piccole parti. È il caso di Bing Crosby con la sua “Temptation” inclusa nel film “Verso Hollywood” (1933). Nonché quella di Frank Sinatra che qui ricordiamo per le sue esecuzioni di “Lady is a tramp”, “Ol’ Man River”, “You’re Sensational” di Cole Porter cantata a una bellissima Grace Kelly. E ovviamente come interprete dei fortunatissimi “High Society” (1956) e “Pal Joey” (1957), dal quale è tratto il brano divenuto poi un successo internazionale.
Il ricco patrimonio di divi non musicali della MGM appare però nella seconda parte di “Hollywood … Hollywood” dedicata alle ‘battute celebri’ tratte da “Ninotschka”, “Dinner at Eight”, “Private Lives”, “Saratoga”. Non va certo dimenticato Louis Armstrong con la sua carica di autentico jazz-man, che fu interprete di “ The five pennies” (1954) al fianco del generoso Danny Kaye, e del successivo “Hallo Dolly” (1969) con Barbra Streisand, altra grande interprete di ‘Musical’ di successo quali “Funny Girl” (1968), “Funny Lady” (1975) da cui la straordinaria “People” e che, come si vedrà, ci trainano già oltre quegli anni che abbiamo definiti ‘d’oro’. In aggiunta alla musica anche l’umorismo ha nel film un suo posto d’onore con i Fratelli Marx che nella esilarante scena del ‘salone’ in “A Night At The Opera” (1935), ci regalano una sequenza esilarante, già perfezionata attraverso mesi di tournee nei circuiti della rivista omonima, prima di essere filmata per il cinema. Sono inoltre presenti anche scene con Abbott e Costello, e Laurel e Hardy con le loro gag più effervescenti. Il film si chiude con la versione cantata di “That’s Entertainment” in cui i vecchi e i nuovi protagonisti del più grande “Spettacolo di Varietà” che sia mai stato visto, sono uniti dalla ‘magia’ del montaggio cinematografico e accompagnati dall’orchestra di Nelson Riddle.
Tuttavia, poiché non mi piace salutare con un brusco addio, come di consueto mi soffermo ancora un po’ per un incontro d’eccezione con un personaggio chiave del moderno musical hollywoodiano, per parlare di una pin-up prestigiosa, Marilyn Monroe, che pur ha legato il suo successo proprio a film musicali che non esito a definire ‘caldi’ per essere improntati sul suo sexappeal, come “Gli uomini preferiscono le bionde” (1953) frizzante ed esplosivo per le canzoni “Diamond are the Girl Best Friend”; “A qualcuno piace caldo” (1959) allegro e travolgente, assecondata da due strepitosi Tony Curtis e Jack Lemmon; “Facciamo l’Amore” (1960) in cui fa coppia con Frankie Vaughan nella canzone “Specialization”, e nell’orchestrale “Strip City” e … Mi fermo qui, anche se c’è molto ancora da raccontare.
La storia del moderno 'film musicale' è ancora tutta da scrivere, per quanto sempre più spesso assistiamo a remake di Musical più o meno famosi, riesumati dai palcoscenici di West End (Londra) e di Broadway (New York) che, trasferiti ‘in esterni’ non senza un certo successo e un certo buon gusto, pur a volte stravolgono l’intento contenutistico dell’ “Entertainment per l’Entertainment’’ che più verosimilmente solo il palcoscenico riesce a dare. Rifacendomi a una frase che ricorre spesso nel mondo teatrale e cinematografico, mi viene esplicito dire: “There’s no business like a show business” (canzone di Irving Berlin e film del 1954) e va detto che lo spettacolo offerto dal Musical è indubbiamente il più grande di tutti. Perché va oltre l’illusione del ‘sogno’ racchiuso in una scatola sonora, anche se trova in essa la sua grande affermazione.
Come Angus Wilson fa dire alla tenera Masie nel suo già citato best-seller: “Chiunque e capace di distruggere le illusioni, l’importante nella vita e saperle conservare”. Ovviamente non e tutto qui, molti altri sono i film di cui mi sarebbe piaciuto parlare ma che per ragioni di ‘lungaggine’ non ho considerato opportuno fare, limitandomi per lo più a quelli che mi sono venuti alla mente. Pertanto mi scuso con tutti coloro che possano sentirsi esclusi da questa ‘compilation’ per il fatto di non avervi trovato il loro preferito. A tutti voi va il mio plauso e il mio ringraziamento per aver contribuito largamente e con stragrande generosità alla felicita di noi tutti. (continua).
*
 - Musica
- Musica
Etnomusica 10 - ’Gitanos’
Tratto da “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” di Giorgio Mancinelli, MEF Firenze Atheneum, premio letterario “L’Autore” per la Saggistica, 2006.
“No hay cante chico ni grande / lo que cuenta es la grandeza / de quien lo vive en sus carnes.”
"Non c'è canto 'chico' né 'grande' / ciò che conta è la grandezza / di chi lo vive nella sua carne."
È questa una ‘letra’ di anonimo gitano, ripreso nel “Cancionero Musical Espanol” di Felipe Pedrel che bene esplica la tematica qui affrontata, sul significato del Cante Flamenco nell’identificazione psicologica con la terra e la musica coltivata in Andalusia. Quella dell’Andalusia, a Sud dell’odierna Spagna, a differenza di altre tipologie, era una musica ricca e vivace, di facile adattamento all’orecchio esperto dei nomadi detti Egiptanos – da cui la contrazione in Gitanos – fin dal loro arrivo nella penisola iberica attorno al 1425. Allorché il re d’Aragona accordò un salvacondotto valido per tre mesi a Don Johan de Egipte Menor, proveniente dall’Egitto, dopo aver costeggiato l’Africa.
Un’altra cronaca del tempo, relativa a Jaén (in Catiglia) riferisce dell’accoglienza fatta dal Cancelliere della città, certo conte Miguel Lucas de Franzo, a Tommaso e Martino conti del Piccolo Egitto e ad un centinaio di loro seguaci portatori di una ‘carta’ che li dichiarava ‘pellegrini penitenti’ e che permetteva loro di attraversare i regni per recarsi ai santuari, assai numerosi, nel Nord della Spagna cattolica. Che fosse lo stesso conte Tommaso del Piccolo Egitto che nel 1435 giunse a Santiago de Compostela e si rifiutò di pagare i diritti imposti dalla dogana di Jaca, esibendo un salvacondotto rilasciato l’8 Maggio 1425 a Saragozza dal re Alfonso V d’Aragona è possibile, ma non dimostrato con certezza.
Ma un’altra cronaca assai più tarda, riferita al 1462, vede i Gitanos, talvolta anche detti griegos per la presenza di vocaboli greci nel loro linguaggio, affermare la loro presenza sul suolo andaluso entrando in conflitto con i re cattolici che inflissero loro un lungo periodo di repressione, accusati di ogni sorta di malefatte a causa delle quali il nomadismo fu in seguito proibito fino alla fine del XVIII secolo. Tuttavia gli studiosi hanno accertato che un numero imprecisato di Gitanos erranti seguitarono a incrociare le loro rotte sul territorio dal Nord al Sud e viceversa in terra di Spagna, molto tempo prima di stabilirvisi in quelli che oggi sono i centri della loro massima sedentarizzazione.
In base al tipo di vita che i Gitanos conducono oggigiorno, studi censori hanno classificato nell’attuale società spagnola due diversi ceppi originali: degli ‘zincali’, di riferimento ai Gitanos nomadi più antichi; e ‘calorrás’ gli attuali nomadi ormai sedentarizzati che vivono dispersi o integrati nei centri cittadini di maggiore intensità e di richiamo turistico. Sempre che una linea divisoria che distingua i girovaghi sempre in cerca di uno spazio dove fermarsi, dai sedentari si renda possibile. Cosa questa che ha dell’improbabile sotto l’aspetto occupazionale, per via delle scarse relazioni fra i ‘gruppi’ presenti sul territorio, poiché ogni singolo ‘ceppo’ di discendenza mantiene fedeltà a un diverso codice di vita ‘gitano’ e spesso di un loro linguaggio’ specifico gitano/andaluso.
Nella fusione ideologica che non permette ormai più una distinzione o diversificazione dall’essere Gitanos o Andaluso in ragione della grande affermazione culturale che in entrambi i casi, essi hanno raggiunto all’interno della società andalusa. L’Andalusia infatti rappresenta da tempo ormai, l’opera compiuta e mai concepita di un popolo che ha cercato durante i millenni, una propria identità etnica. Ed è presumibilmente uno dei punti focali su cui indirizzare le linee convergenti della ricerca qui condotta. I Gitanos hanno fatto dell’Andalusia la terra prescelta o forse predestinata, mettendola al centro del loro sogno ‘mitico’, per cui l’importanza di avere una patria d’origine, dopo secoli di contestazioni, ha rappresentato nel tempo la loro irrefrenabile aspirazione: l’intramontabile visione di una terra vecchissima con vocazione di eterna perfezione”.
Ed è da questa reiterata aspirazione che i Gitanos traggono maggiore ispirazione alla loro ‘geniale’ creatività musicale, i sentimentalismi più accesi, gli imperscrutabili desideri passionali. Se ne rintraccia l’eco in un appassionato passaggio letterario nella “Gitanilla” di Miguel de Cervantes:
“Siamo signori dei campi, delle selve e dei monti, delle fonti e dei fiumi. (..) Per noi l’inclemenza del cielo è il vento, refrigerio la neve, bagno la pioggia, musica il tuono e il lampo; per noi il duro terreno è materasso di morbide piume; il cuoio conciato dei nostri corpi ci serve da armatura che ci difende. Abbiamo quel che desideriamo, dunque ci contentiamo di ciò che abbiamo”.
È qui ripreso il tema del nomadismo e della sopravvivenza con tanto di spiegazione. In effetti la forza interiore dei Gitanos è nella piena identificazione con la terra andalusa, nella quale infine sono giunti e dalla quale non andranno più via, se non per farvi ritorno. Un viaggio che porta in sé il ricordo ancestrale della terra natia perduta, leggendaria, letteraria, poetica che sa di festa, di colori, di musica. Quella dell’Andalusia, a differenza di altre tipologie, è una musica adattabile che i Gitanos hanno assimilata in fretta apportandovi un alto contributo strumentale sia nella danza che nel canto, a formare un’eccezionale mistura di suoni ed espressioni folkloristiche. È infatti possibile affermare che il ‘Cante andaluso’, dapprima flamenco e poi gitano, nasce e si forma su due elementi fonici principali, la terra andalusa con il suo antico entroterra musicale tipico e l’originale versatilità gitana che hanno permesso l’interazione di due culture atipiche, contrassegnate da un comune fondo di anonimato.
Non si conosce quanto tempo ciò abbia richiesto, in ragione del fatto che il ‘Cante flamenco’ continua oggigiorno ad evolversi, a cambiare d’aspetto, senza tuttavia perdere nulla o quasi della sua originalità. Mentre il ‘Cante gitanos’ è tutt’oggi impregnato del suo essere intimistico e sfrenato al tempo stesso, amaro come amara è talvolta la vita ‘vissuta’, espressione di quella passionalità carnale che si porta dentro. Rare testimonianze letterarie trattano della sua evoluzione prima del 1780, anno in cui in una cronaca del tempo è citato un cantante, certo Tio Luis el de la Juliana, riconosciuto interprete di ‘seguiriyas’ (una variante del Cante). Tuttavia la nota è poco attendibile poiché menzionata solo un secolo più tardi da Antonio Machado in “Colecion de Cantes Flamencos” cui si fa riferimento all’affermazione della ‘seguriyas’ gitana nella sua forma definitiva.
Scrive lo storico Oreste Macrì: “Si tratta dunque, di una fenomenologia elementare, primitiva dell’opera d’arte, di un prezioso modello alla portata del nostro tempo o troppo colto o troppo barbaro, nel quale, riguardo alla manifestazione espressiva , rimangono distinti e illibati i tre elementi: della creazione nella realtà del tempo e dello spazio (Andalusia), dell’interpretazione rapsodica (gitana), della voce autentica , specifica, assoluta, del Cante flamenco …”. Ai Gitanos va tuttavia riconosciuta la prerogativa di aver dato origine al ‘baile flamenco’, o almeno ad una forma simile, forse più rozza, eseguita a scopo rituale, riconducibile di una più antica “cultura delle origini”, e non solo. Inoltre, va riconosciuto loro il merito di aver assimilato il segreto profondo del ‘Cante’, la cui comprensione richiede qui un maggiore approfondimento.
Seppure contraddittorio suona il parere dei musicologi sulle origini del ‘Cante flamenco’, in altro campo folcloristi, musicisti e poeti hanno contribuito attraverso il tempo a farne materia di studio nell’ambito della cultura ufficiale, che ha assunto il nome di ‘flamencologia’, una cattedra creata a Jerez nel 1958. Ad onor di cronaca va qui citato il primo concorso abbinato al Festival del ‘Cante andaluso’, tenutosi in Granada nel 1922 sotto la direzione del maestro Manuel De Falla e del poeta Federico Garcia Lorca, con il quale si volle dimostrare che il ‘Cante’ non era semplicemente un’espressione del passato, bensì la manifestazione “tipica y envidiable” del folklore nazionale. Sopra ogni altra cosa Garcia Lorca volle riportare il ‘Cante’ alla forma delle origini, come doveva essere nella sua autentica espressione popolare, “ricco di vitalità e bellezza formale”:
“..mucho mas hondo que el corazòn actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi infinito.”
“..molto più ‘jondo’ del cuore che verosimilmente lo crea e lo canta, perché è quasi infinito.”
Significati del Cante flamenco y hondo o jondo (profondo).
Numerose furono le ipotesi avanzate dagli studiosi per rispondere al quesito che all’epoca si poneva sulla differenza fra il ‘Cante jondo’ considerato il più puro e antico, e il ‘Cante flamenco’ ritenuto non così puro e per questo suddiviso in due gruppi: ‘cante grande y cante chico’. Pareri discordanti attribuivano ora a questo ora a quello l’essere parte integrante del flamenco. Anche in questo caso la soluzione si presentava complessa e difficile. Per Manuel Rios Ruiz, co-fondatore della cattedra di flamencologia:
“Il substrato del Cante è tanto profondo che si confonde con la nativa attitudine andalusa di cantare, ballare e suonare la chitarra; come anche è riferito negli scritti degli autori latini del VI secolo a.C. Si deve inoltre tenere in considerazione l’influenza musicale delle diverse culture del passato presenti in Andalusia: la musica orientale e quella latina, la canzone popolare e quella colta, il canto liturgico sefardita e la melopea araba. Un tale compendio di suoni entrati nei diversi stili dell’attuale flamenco dopo molti secoli di convivenza tra razze distinte tra loro, con il popolo andaluso, del quale il flamenco, in ultima analisi, ha percepito e traslato l’influsso della sua cultura artistica. Questo il risultato di un ampio processo evolutivo al quale va attribuita la partecipazione attiva dei Gitanos, nel reciproco scambio fra la loro sensibilità intuitiva e la ricchezza musicale del folklore andaluso”.
Scrive Hipòlito Rossì: “Non è però corretto denominare con eguale appellativo flamenco la pura arte del ‘Cante’. Come abbiamo avuto modo di intendere le due parole ‘jondo’ e ‘flamenco’ hanno due significati distinti, uno ristretto al ‘cante más puro y antiguo’, l’altro aperto alle influenze esterne, meno arcaico, che possiamo definire in senso più moderno: ‘soggetto aperto alle contaminazioni’.”
Una chiara origine extraeuropea contrassegna però il ‘Cante’, il cui corpus rivela analogie antichissime che vanno riferite ad alcune influenze particolarmente tangibili. Si è giunti a riconoscere in esso alcuni elementi della ‘liturgia mozarabe’ anteriore all’arrivo dei Mori sul suolo ispanico. Secondo Felipe Pedrell: “Il dato orientaleggiante va invece attribuito unilateralmente a reminiscenze bizantine ancora in uso nella chiesa ufficiale in Spagna, dopo la conversione del paese al Cristianesimo.” Tuttavia il vero ‘Cante jondo’ sembra più l’estrapolazione del canto gregoriano proprio della liturgia romana, per la sua caratteristica monodica nell’uso antico che lo accomuna all’intima connivenza con il sacro.
Lo storico Medina Azara annovera un’ulteriore influenza nel ‘Cante’ riferita al fattore ebraico, reminiscenza della prima lamentazione degli israeliti dopo la distruzione del Tempio: “Il canto liturgico era intonato nel giorno della festa, e ‘jondo’ sarebbe la deformazione andalusa dell’espressione ‘jom-hol’”. Non è escluso che lo storico abbia individuato una delle correnti d’influenza tra le più attendibili avvenute sul suolo iberico, poiché la tradizione ebraica rivela un patrimonio musicale conservatosi più che intatto fino ai nostri giorni, al di fuori delle influenze e dal disorientamento dell’esodo. L’attaccamento alle tradizioni ha fatto in modo che l’uso del canto originario più antico venisse trasmesso nella sua forma più ‘pura’ alle generazioni che si sono succedute e si pensa che in qualche modo esso abbia influenzato la cultura mediterranea e successivamente quella europea.
Ciò è rivelato dall’uso del canto che gli Ebrei-sefarditi svilupparono all’interno delle comunità judio-espanoles fino a a qualche tempo fa misconosciuto alla musicologia applicata, che altresì oggi permette una comparazione assai più ravvicinata e attenta. Questo genere di canto, detto anche ‘ladino’ nel gergo degli ebrei spagnoli e dai discendenti dei ‘sefarditi’ che furono costretti a emigrare, si vuole derivi dal canto biblico di Gerusalemme, ed è comunque difficile poter affermare in quale misura sia individuabile nelle spire del flamenco. Entrando ancora più nel vivo della questione, è grandemente accettata l’ipotesi che la ‘seguirya gitana’ derivi dal canto ebraico o, comunque, rifletta una certa similitudine con il rituale ‘Kol-Nidrei’, nel quale le parole formano con la melodia di fondo una sorta di recitativo cantato in cui si rintraccia una comune trascendenza mistica, una particolare connessione tra le sofferenze dei martiri e le subite persecuzioni razziali che, almeno idealmente, uniscono i due popoli, quello ebreo e quello gitano.
Un’ulteriore fonte di indubbia contaminazione musicale è ancora una volta suggerita da F. Garcia Lorca, il quale nella conferenza di studi sul ‘Cante’, tenuta nel 1931, rivelò di essere stato colpito dalla “..similitudine che esiste fra i temi di alcune seguiryas e le poesie arabe dei poeti Serage e Warak, Ibn Ziati, e dei poeti persiani Hafir e Omar Khayyâm”. Con la letteratura dell’antica Persia, o forse con quella più moderna conosciuta al tempo di Lorca, si ravvisa infatti una continuità che ritroveremo in seguito nel Romance tipicamente spagnolo. Ma è forse la tradizione araba ad aver più influito direttamente sulla formazione musicale zingaro-gitana, se non addirittura quella turcomanna. Non a caso il termine ‘taraf’ usato per designare il gruppo di musicisti che oggi formano l’orchestrina che si esibisce nei ‘cafés’ è derivato dalla lingua turca e la Turchia va considerata il punto di arrivo e dipartita dei gruppi zingaro-gitani prima del loro stanziamento nel cuore dell’Europa, terra d’incontro e di trasmissione delle due diverse culture, orientale e occidentale, avvenuta nel periodo della sua occupazione tra il XVI e il XIX secolo.
È finanche immaginabile ipotizzare un orientamento della musica d’Occidente che attraversa l’odierna Turchia fino ai Balcani come a una via possibile di estensione che oltrepassa tutto il Medio Oriente prima di stanziarsi in Europa, in cui sono rintracciabili testimonianze etniche di piccoli gruppi nomadi di origine indiana come: i Ghadjar, gli Halabou, e i Bahlawanat che successivamente spostatisi dalla foce del Gange raggiunsero la Giordania, il Libano, la Siria e l’Iraq. Una escursione nella musica di questi paesi sarebbe necessaria per comprendere appieno la validità di una simile affermazione.
Lo studioso Habib Hassan Touma sottolinea come: “La musica costituisce una parte essenziale della musica del Medio Oriente e del Nord Africa; essa rappresenta uno tra i pochi sistemi tonali indipendenti del nostro tempo, dominata dalla tecnica esecutiva del ‘maqam’: una forma modale che si esprime attraverso l’improvvisazione e caratterizza la musica colta di tutte le culture musicali di quest’area. Il ‘maqam’ è una forma sia vocale che strumentale del mondo arabo, utilizzata sia nella musica religiosa che in quella profana. Il compositore crea la propria melodia, l’adatta a un modello ritmico prestabilito, per lo più non creato da lui, tuttavia non sottoposto ad alcuna regola. Il ritmo caratterizza lo stile dell’esecutore e dipende dalla sua tecnica e dalla sua interpretazione, ma non caratterizza il ‘maqam’ come tale. (..) Il musicista esegue il ‘maqam’ in modo improvvisato su elementi chiaramente distinguibili tanto nelle forme vocali che in quelle strumentali senza partitura, suscitando nell’ascoltatore profano l’impressione che non abbia né principio né fine.”
Di fatto, la musica araba occupa un posto assai rilevante nell’impostazione tipica del ‘Cante grande’, che va sotto il nome di ‘nuba andalusa’. Nella lingua araba classica infatti, espressa con il termine ‘naubah’, troviamo “.. un’importantissima quanto autentica forma erede di una più antica tradizione musicale che fu trasmessa dapprima da Bagdad a Qurtuba, (l’odierna Cordoba) e a Garnata (l’odierna Granada), a partire dal IX secolo e che, in seguito al ritirarsi dei Mori dalla Spagna nei secoli successivi, attorno al XIII, XV, e XVII secolo, giunse in Africa settentrionale”.
Scrive inoltre Habib Hassan Touma, che: “La sua forma musicale consta di un numero di pezzi vocali e strumentali con prevalenza dei primi, che sono tutti basati su una scala ‘maqam’ detta anche ‘tabah’. (..) Fino all’epoca suddetta, questi pezzi o canzoni erano chiamati ‘saut’, nome usato nella tradizione antica. (..) Molto importante è il testo letterario della ‘nuba andalusa’ che negli esempi più datati, consta di più strofe con differenti rime finali, cantate con l’accompagnamento di diverse formule ritmiche ‘wazn’ improntate sulla percussione del tamburo. Per questo tipo di esecuzione, in conformità alle disposizioni di Ziryab che ne è stato il maestro, il cantante deve osservare un determinato ordine nella successione dei canti e del ritmo. (..) I generi della musica colta profana, la forma più nobile e perfetta del ‘maqam’ di origine persiana, prevedono l’uso di tre strumenti, rispettivamente: la cetra a percussione, ‘santur’, il violino a forma di lancia ‘jose’ e il tamburo a coppa ‘tabla’ detto anche ‘dunbak’; ai quali a volte si aggiunge un tamburello a cornice. L’elemento centrale della forma musicale ‘maqam’ è il canto in arabo classico o comunque nella lingua parlata oggi in Iraq, espresso in forma di poema cantato che va sotto il nome di ‘zuhairi’”.
Assolutamente da tenere sempre presente che quelle qui descritte sono in massima parte forme comuni a tutto il mondo arabo: dal sistema tonale alla forma musicale, al procedimento d’improvvisazione alla tecnica compositiva; e ancora la prassi dell’esecuzione, la struttura dei complessi orchestrali, le formule ritmiche, le stesse che sono alla base del ‘Cante flamenco’, il cui “repertorio è formato da pezzi vocali e strumentali appresi nella forma orale dai vecchi maestri”; esattamente come accade nella musica araba dove “..i musicisti, almeno quelli di un tempo, facevano a meno di ogni sorta di materiale didattico scritto come libri e note, perché la lezione di musica si basava sull’apprendimento orale suggerito dalla viva voce del maestro”.
Così, ad esempio, nell’utilizzo di strumenti “si ricorreva alla pratica strumentale dalle caratteristiche stilistiche delle varie zone, dalla maniera di intonare il canto, alla tecnica di pizzicare i liuti; dalla struttura della scala musicale fino alla composizione dei versi, al loro contenuto”. Caratteristiche queste che è possibile ritrovare anche nell’odierna prassi musicale, ancora oggi inseparabilmente collegata alla vita degli arabi quanto a quella dei Gitanos andalusi. Certo non sfuggono ad una attenta lettura delle diverse tematiche affrontate nei testi, le molte somiglianze e le interazioni con il ‘Cante flamenco y gitanos’. Non si può comprendere l’importanza dell’influenza della musica araba in Occidente e, soprattutto nella Spagna moresca, se non si conosce la portata assai rilevante della poesia persiana prima ed araba poi, circolante nelle corti europee sul finire del XIII secolo. Inoltre va considerata l’influenza musicale e strumentale apportata dai primi grandi trattati sulla musica apparsi a Medina prima dell’Anno Mille.
È ai più antichi poemi persiani ed arabi così come alle ‘quartine poetiche’ in uso nel mondo arabe e spesso incluse nel ‘maqam’ che va fatto riferimento per comprendere l’importanza del ‘Cante’ nella sua traduzione letteraria di ‘canto profondo della terra andalusa’. Garcia Lorca quindi aveva ben individuato nella poesia persiana e in quella araba le fonti espressive del ‘Cante jondo’ che hanno dato forma all’improvvisazione e a quella sua caratterizzazione ‘oscura’, così diversa da interprete a interprete; così come la forte individualità impressa nella modulazione della voce. Tuttavia i poeti sopracitati ai quali egli fa riferimento, hanno lasciato componimenti di grande limpidezza stilistica e d’ineguagliabile musicalità creativa. Uno per tutti fu il poeta a lui contemporaneo, l’iraqueno Maarùf ar-Rusafi, del quale leggiamo qui sotto alcune quartine:
“Sino a quando starai a levare i tuoi canti, impotente qual sei a ridestare i dormienti?
Per quanto saldi tu foggi i tuoi carmi. A nulla serve il tuo canto, che il tuo popolo è smarrito lontano”.
“A lungo, sin quasi a perderne la forza, hai alzato una rampogna più tagliente della spada. Essi non si riscossero, a nulla giovò la rampogna. Come fossero fanciulli addormentati. Ignari nel dondolio delle culle”.
“Via, via da me o Baghdàd! Per quanto abbia a dolermi di te
Mi rincresce vederti sull’orlo d’un abisso pauroso.
Si son susseguite su di te le sventure, la dolce vita si è fatta amare.
Perché non generi un figlio in cui splenda la luce?”
Cante Jondo.
Confluiscono e si confondono nel ‘Cante jondo’ gli ideali gitano-andalusi di un’arte panteistica in cui la sacralità si accende di frequente di toni drammatici, tinte violente, segni di perenne conflitto della forza e del potere (tauromachia); dell’identificazione umana con la divinità (debla), della penetrazione di un sentimento (seguiryas), dell’espressiva fierezza (tonà), così come dell’estremo anelito (soleá) e dell’oscura rivelazione (petenera), dove ogni desiderio trova un ultimo afflato con la tangibile coesione della morte. Il ‘Cante jondo’ è dunque il rifugio segreto raramente mistificato dell’anima gitana e costituisce un profondo legame con la figura mitica di quell’ ‘alma mater’ che tutto accoglie in sé e tutto genera. In quanto puro interprete del ‘Cante’ il gitano-andaluso è forse il creatore inimitabile e irripetibile della sua arte, nella quale trasfonde tutto ciò che la natura ha generato in lui. Cosciente che nulla gli appartiene, egli conosce tutto della sua morte futura, per questo può volare anche senza avere le ali che verosimilmente ha inventato per il suo volo.
Come anche è detto: “Egli è dovunque e in nessun luogo, ripete nel dialogo col mercante l’ultima parola del suo interlocutore, può uccidere (se lo vuole) con la sua sola presenza, gente sinistra partecipa al suo funerale, la madre lo riporrà in carta argentata e la luna sarà la sua patria celeste, quasi a significare un ritorno alla forma primigenia”.
Garcia Lorca traspose tutto questo in un unico e suggestivo grido, nel suo ‘Poema del Cante Jondo’:
“..Sobre el tablado oscuro / La Parrala sostiene / una conversaciòn / con la muerte. / La llama / no viene / y la vuelve a llamar / ...”.
“Sopra il tavolaccio scuro / La Parrala sostiene / una conversazione / con la morte. / La chiama / non viene / e torna a chiamarla / …”
Nel ‘Cante andaluso jondo o flamenco’ si fa uso di una sorta di linguaggio emozionale in cui l’interprete esprime i propri sentimenti interiori, l’intimità del suo pensiero, il verbo recondito esteso all’infinito, alla ricerca di possibili assonanze che si riallaccino alla vita. O, forse, a una singola parola d’amore e di rivalità, talvolta riferita a un sogno ricorrente, al ricordo di un cielo perduto dietro una montagna ch’egli trasforma in canto. O anche a un afflato essenzialmente notturno che meglio risuona nell’oscurità e nell’intimità della notte come il gorgheggiare di un usignolo. Ma è sempre un cantare doloroso il suo, impregnato di una malinconia struggente che abbandona al vento, intimo confidente della sua profonda pena d’amore.
Come riporta lo scrittore Oreste Macrì: “Occorrerebbe investigare la prodigiosa libertà della metafora lorchiana che è un linguaggio perfettamente chiuso nel giro della logica gitana. Il segreto di questa libertà topica si deve riferire alla stretta alleanza, alla contemporanea e compresente partecipazione di tutte le persone alle cose del mondo gitano, cioè di tutto il complesso sistema di equivalenze obiettive e di sentimenti intercambiabili. Ciascuna cosa o persona è modulazione totale o affettiva di ciascun altra. La pena è silenzio o solitudine o paese remoto o labirinto o alveo occulto o pianto o calce o oleandro. (..) Ciascun sentimento vibra in modo sostanzialmente identico, giacché è stirato al massimo della sua curva (come la persona nel baile), sul fiume o sulla città, sull’angelo o sulla campagna. Sono indicativi alcuni centri fisici di prima irradiazione delle metafore, come il sortilegio che si vuole derivi dal ‘Cante jondo’ nel ‘corro de la juerga’ , da cui scaturisce il coro umano solidale nel sentimento collettivo individuato dal suo interprete; qui si stabilisce una società sotterranea che articola radi e spenti ‘olé’ di consenso. È il modo degli uomini soli, senza donne, senza bambini, senza fiori, con alle spalle un passato irrevocabile, quello stesso mondo dolorante e perduto che è la parte centrale del Cante che nel ‘tiento clasico’ che egli persegue, trattato con estrema delicatezza”:
“Hasta el alma me duele, seniores. / De tanto querer. / Los tormentos de mis negrs duquelas. / Yo no se los mando / A mis nemigos ...”
“Perfino l’anima mi duole, signori. / Per il tanto amore. / I tormenti delle mie nere pene / Io non li auguro nemmeno / Ai miei nemici …”.
Voler spiegare qui le caratteristiche tecniche e vocali del ‘Cante jondo’, le sue numerose varietà di forma, si presenta arduo in ragione dell’impossibilità di penetrazione dell’indole gitana, del sentimento come del timore atavico che si porta dentro. Gli andalusi medesimi si perdono nel labirinto delle varietà di forme che il ‘Cante’ ha assunto nel tempo. Discordanze in merito pongono ancora oggi gli studiosi uno contro l’altro nel decidere l’appartenenza di questa o quella forma al ‘Cante jondo’ o al ‘Cante flamenco’ come nel voler intentare una seria classifica delle stesse. In effetti c’è una differenza (o forse no) fra le due forme. Tutto è racchiuso in una sottigliezza interpretativa di carattere psicologico a volte di puro campanilismo. I più convengono che il ‘Cante flamenco’ è la derivazione naturale del ‘Cante jondo’ che nel frattempo ha perduta la sua primitiva durezza, e del quale traspare il suo alone mitico che il genio gitano-andaluso ha trasferito nelle forme della ‘seguirya gitana’ e nella ‘soleà’, riconosciuta madre del ‘Cante’.
È possibile classificare il ‘Cante jondo’ in vari modi interpretativi: per la sua riconosciuta antichità, per l’uso espressivo e alquanto aggressivo della voce, per la provenienza territoriale dell’artista e dell’uso degli strumenti tipici, per cui è stato possibile suddividerlo in ‘Cante jondo o grande’ e ‘Cante flamenco o chico’ (piccolo). Fanno parte del ‘Cante grande’: ‘debla’, ‘martinete’, ‘seguirya gitana’, ‘fandango’ d’influenza moresca, ‘carcelera’ tradizionale andalusa e la ‘soleà’ probabilmente di origine ebraica. Appartengono al ‘Cante chico’: ‘liviana’, ‘granadina’ originaria di Granada, ‘taranta’, ‘malaguena’ d’origine moresca, ‘buleria’ e ‘alegria’ gitane, ‘sevillana’ (di Siviglia), ‘fandanguillo’ e ‘petenera’ tipici del substrato arcaico dell’Andalusia. Pretesto per l’uso dell’una o dell’altra forma è il tipo di sentimento provato dall’interprete detto ‘cantaor’ al momento dell’esecuzione e all’emozione che questi vuole trasmettere.
Narra Rafael Manzano: “Incominciamo col bere del vino, la nobile manzanilla, o il denso e odoroso Jerez, preludio indispensabile al cante, preparazione al suo magico rito. Uno degli intervenuti o uno dei cantaores invitati alla festa darà inizio con un cante liviano o piccolo, allegro e bello. Con questo cantare passerà la prima ora. Il vero Cante jondo in verità non farà il suo ingresso se non quando lo faranno i cantaores con la voce roca dal vino e dei versi (delle citazioni). È questo il momento in cui trasalgono le note gravi del Cante: martinetes, seguiryas, solerte, polos. La preparazione necessaria dell’inizio è servita infine all’unico vero momento di autenticità, fortemente drammatico e tormentato come il primo respiro del mondo”.
Più che alle parole, l’originalità di quest’arte è affidata all’interpretazione del singolo ‘cantaor’ o al ‘tocaor de guitarra’ al quale è lasciata l’autorevolezza dell’accompagnamento. Infatti è compito del ‘tocaor’ di suggerire al ‘cantaor’ di eseguire il ‘tercio’ ovvero la sequenza del ‘Cante’, come dire di infondere l’afflato e il palpito della voce alle dure espressività della chitarra, senza le quali il momento ‘profondo’, appunto lo ‘jondo’, non si può ritenere raggiunto. Ma è solo attraverso i ‘testi’ (trascrizioni di canti originali) tratti dalla tradizione andalusa più pura, con le sue gradazioni di dolore e pena messe al servizio dell’espressione ‘alta’ della ‘seguiryas’, che oggi è possibile azzardare un’analisi letteraria dei suoi diversi significati.
E ancor più canta:
“Io dico le mie pene cantando / perché cantare è piangere. / Io dico la mia gioia danzando / perché danzare è allegria.”, recita una ‘sygurias’ gitana.
La ‘seguiryas’ è in prima istanza un canto d’amore e di morte in cui i sentimenti sono rivissuti attraverso lo sguardo arcano d’una Sibilla, personaggio d’origine orientale paragonabile alla sfinge, considerata in Andalusia cauterio al bruciare della passione che prende il cuore, la gola e le labbra di quelli che la cantano. È necessario premunirsi contro il suo fuoco e cantarla nel preciso momento che lo richiede l’andamento appassionato di ciascun interprete, preso nell’affermazione intimistica da un disperato e struggente slancio verso l’ineluttabile, la cui inesorabilità si avverte ora come sgomento, ora con rabbia, comunque sempre con una sorta di patos esistenziale ad alto impatto poetico. Leggiamo qui di seguito un esempio di seguiryas tradotta nella sola forma metrica dei versi, così come a suo tempo l’ha trasmessa il poeta Manuel Machado:
“Pensamiento mio, / adonde te vas? / A pas fatiogas / estoy ya tan echo / que las alegrias se me vuelven penas / dentro de mi pecho. / Yo voy como un ciego / per esos caminos./ Siempre pensando en la penita negra / que llevo con migo./ Toìta la tierra / la andaré cien veces, / y volveré a andarla pasito a pasito, / hasta que la encuentre”.
“Pensamento mio, / dove vai? / A sopportar fatiche / sono già tanto abituato / che le gioie divengono affanni / dentro il mio petto. / Io vado come un cieco / per questi sentieri. / Sempre pensando alla pena oscura / che porto con me. / La terra intera / percorrerò cento volte, / e tornerò a percorrerla passo a passo, / fino ad incontrarla”.
Diversamente la ‘seguiryas’ è una elaborazione gitana della ‘tonà andalusa’. Blas Infante, folklorista e scrittore, afferma che la ‘seguidiya’ (diversa pronuncia) anche detta ‘sevillana’ è un’aria a ballo composta in tre tempi e di un movimento molto animato la cui ampiezza termina in un ritornello cantabile. Ne fa risalire l’origine al XVI secolo richiamando a conferma un passo del “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes:
“Pues qué, cuando se hunillan a componer un género de versos que en Candaya se usaba entonces, a quien ellos llamaban seguidillas?”.
“Può essere, quando si univano a comporre un genere di versi che si usava comporre in Candaya, e che essi la chiamassero seguidillas?”.
Da cui, al tempo attuale, si usa chiamare questo grazioso ballo ‘seguidilla manchega’ riconoscendo di fatto la sua origine nella Mancha, terra adottiva di Don Chisciotte. E comunque trattasi di una ‘seguirya gitana’ così come lo è anche la ‘tonà’, più volte citata, nell’introduzione al ‘tercio’, intercalata da un grido acuto potente, detta ‘tonà grande’ quando l’accento ieratico è cadenzato come per una marcia funebre. Allorché il ‘cantaor’ abbandona l’accompagnamento della chitarra e si esibisce con la sola voce (a cappella), si ha la ‘liviana’. Eccone un esempio:
“Campanita de plata, / reloj de morfil, / como guardando, guardando estaba / de tu boca el sì”.
“Campanella d’argento / orologio di morfil, / come aspettavo, aspettando stavo, / della tua bocca il sì”.
La ‘tonà’ è più un modo di cantare che un genere, o forse entrambe le cose che, come la canzone epica medievale era molto diffusa fra i trovieri e i menestrelli girovaghi per le città che ne facevano uso nel Romance, il cui intercalare del parlato e del canto era costruito sulla base monodica del canto gregoriano richiedente una straordinaria capacità vocale di grande temperamento. La particolare tecnica vocale che il gregoriano richiedeva, a un tempo riaffermata dai Gitanos che la utilizzarono a modo loro, cogliendone la profonda drammaticità impossessandosene e finanche occultandone la forma vocale che la distingue, è infine la vera causa della suddetta difficoltà interpretativa ‘ieratica’ su cui si fonda il ‘Cante iondo’. Di fatto le ‘tonà’ più antiche sono all’origine della ‘débla’, il cui significato ‘déa’ preannuncia una sorta d’invocazione connessa con i canti che presiedono ad una forma arcaica di ritualità, erano un tempo e lo sono tutt’ora trasmesse oralmente da padre in figlio che oggi, a seguito della dispersione di maestri autentici va lentamente scomparendo.
Esempio di débla:
“Yo ya no era quien era / Ni quien yo soy / Ni bia ser / Soy un arbol de tristeza / Pegadito a la parez / Y de mì calbari”.
“Io non ero già chi ero / Né quello che sono / Né quello che sarò / Sono un albero di tristezza / Attaccato alla parete / Questo è il mio calvario”.
Origine della ‘carcelera’ e del ‘martinete’.
All’inizio del XVI secolo, epoca in cui i Gitanos cominciarono ad essere perseguitati dalle autorità spagnole, in molti abbandonarono la vita nomade finendo per sedentarizzarsi nei villaggi di frequentazione, cercando in questo modo di mettersi al riparo mimetizzandosi con la popolazione locale. Ciò permise loro di sfuggire alla feroce repressione in atto che li vide soccombere per molti anni. Alcuni gruppi fecero ritorno alle loro attività primarie della lavorazione del ferro e del rame e trovarono facilmente lavoro presso le fucine, mentre altri nelle miniere metallifere e di carbone. Questi, che erano in uso cantare anche senza accompagnamento musicale, recuperarono dalla tradizione locale di cantare le antiche ‘tonà’ con particolare intonazione della voce, trasmettendo ad esse quella tristezza atavica che si portavano dietro in una forma ancora più intensa e ‘profonda’ del passato.
Nacquero così, nelle fucine, i primi ‘martinete’ ritmati sul battere del martello sull’incudine, una sorta di canti di lavoro in cui si evocava spesso quel ‘dio ctonio’ che li avrebbe riscattati dall’angoscia e dalla miseria delle loro condizioni. Mentre quelli che lavoravano nelle miniere accompagnavano il ritmo del piccone che scavava nella roccia e che l’eco rimandava dal ‘profondo delle caverne’ come un canto di origine religiosa. Il genere, entrato a far parte del ‘Cante jondo’, troverà un suo corrispettivo nelle più tardive ‘slave-songs’ e nelle ‘work-songs’ negro-americane che accompagnavano le fatiche degli schiavi nei campi di cotone. Come appunto è detto in un significativo ‘martinete’:
“Y se no es verdad / Que Dios me mande la muerte / Si me la quiere mandar”.
“Se ciò che dico non è la verità / Che Dio mi mandi la morte / Se si degna di mandarmela”.
E in questo esempio di ‘carcelera’:
Allo stesso modo viene detto in una famosa ‘slave song’:
“Non dire niente / la fuga è a portata di mano / (..) sono così contento di ottenere la mia libertà in tempo..”.
Nell’opinione di Gregorio Paniagua, eccellente musicologo nonché noto direttore d’orchestra spagnolo, il ‘martinete’ è all’origine di altre forme musicali dette anche ‘minera’ e ‘cartagenera’, associate al lavoro della forgia e accompagnate dal solitario suono del martello che dava ad esse una connotazione dura e al tempo stesso trascendentale. Tuttavia la forma cantata del ‘martinete’ in cui non è fatto uso di alcun accompagnamento strumentale, è particolarmente complessa ed evoluta, racchiusa nel continuo ‘profondo’ lamento che vuole esprimere un dolore inarrivabile quanto amaro. Quel medesimo dolore che ha permesso infine alla ‘taranta’, lì dove la chitarra sostituisce il battere del martello, sebbene essa venga spesso associata alla forma del ‘tarantismo’ conosciuto in tutto il bacino del Mediterraneo, di entrare nella sequenza del ‘Cante’.
Esempio di ‘martinete’ senza accompagnamento:
“Fragua, dunque y martillo / rompen los metales; / el juramento que yo a ti te ho hecho / no lo rompe nadie”.
“Fiamma, incudine e martello / rompevano il metallo; / il giuramento che io ho fatto a te / non lo rompe nessuno”.
La ‘soleà’, detta anche ‘soleares’ o ‘solearillas’ nelle sue numerose varianti, è la derivazione certa di ‘soledad’, cioè di quella ‘solitudine’ ritenuta da tutti ‘madre del ‘Cante’. Accoglie in sé forme molto probabilmente più antiche conosciute con altro nome. I primi ‘soleares’ si vuole facciano la loro prima apparizione nel quartiere sivigliano di Triana e successivamente in diversi luoghi della penisola, sul ritmo di un’altra danza, forse più antica, originaria di Cadice: lo ‘jaleo’, anch’essa entrata a far parte del repertorio ‘jondo’. Malgrado una fondamentale regolarità ritmica la ‘soleà’ presenta un andamento musicale sincopato, rafforzato dal suono della chitarra e dal battito delle mani, l’uso delle quali si rende indispensabile quando la ‘soleà’ è danzata. Ciò spiega le numerose citazioni riferite per lo più ai suoi grandi interpreti che l’hanno resa gloriosa ed entrati nella leggenda, come Mercedes la Sarneta, diventata celebre dopo la sua morte avvenuta nel 1910 e ritenuta la più grande interprete che sia mai esistita.
Si dice in una famosa frase a lei dedicata che si canta ancora in suo ricordo:
“Cuando murìo la Sarneta la esquela quedò serrà, porque se llevò la llave del cante per soleà”.
“Quando morì la Sarneta la scuola restò chiusa, perché ella portò con sé la chiave del cante per soleà”.
Cadice, Utrera, Cordova, Jerez, Triana furono i luoghi d’origine di quasi tutti i canti per ‘soleà’ che si conoscono. Va qui ricordato anche Alcalà, le cui ‘soleares’ divennero popolari grazie a Joaquin el de la Paula, tramandate con grande perizia da Manolito el de la Maria, Antonio Mairena e Juan Talega.
Ecco un esempio di ‘soleà’ appresa da Antonio Mairena:
“Aque el mundo te criticque / que eres una mala mujer. / Yo te voy a tener a mi vera / aunque mal pago me des. / Me pesa el haberte hablado / la alegria de mi cara / serrana te las llevado”.
“Sebbene il mondo ti critichi / perché sei una donnaccia. / Io ti terrò alla mia sponda / malgrado mi compensi male. / Mi dispiace averti parlato / l’allegria del mio viso / te la sei portata via”
La ‘petenera’ è una forma del ‘Cante chico’ di difficile datazione, certamente anteriore al XVII secolo, legata a una figura leggendaria, probabilmente nata dalla superstizione. Trattasi di una figura andalusa in cui si fondono substrati arcaici e oscuri riferiti a una favolosa cantante detta la Petenera, abitante di Paterna di Rivera alla quale Garcia Lorca si sarebbe ispirato nel “Grafico della Petenera” e che contribuì a rendere celebre:
“En la casa blanca, muere / la perdiciòn de los hombres. / Cien jacas caracolean. / Sus jinetes estàn muertos..”.
“Nella casa bianca, muore / la perdizione degli uomini. / Cento cavalle galoppano. / I loro cavalieri morti..”.
La leggenda narra che la giovane, sedotta e abbandonata dall’uomo che amava, consideratasi perduta, decise di vendere la propria bellezza e trascinò alla perdizione tutti gli uomini che l’amarono: “..che al solo vederla se ne innamoravano perdutamente e ne erano trascinati nel baratro profondo.”. Sembra che tale fosse la sua bellezza che ovunque ella andasse scatenava gelosie, crimini, suicidi, assassinii, al punto che lei stessa finì con il morire pugnalata da un amante geloso. All’epoca apparve così improbabile che una donna così fosse realmente vissuta che molti rifiutarono di credere che fosse mai esistita. Il testo originale rimane pressoché sconosciuto, tuttavia, nella sua versione narrativa è assai popolare quanto oscuro. Quello qui di seguito trascritto è solo uno delle sue molteplici versioni orali, cantata solo ed esclusivamente in speciali occasioni in ragione del fatto che il ‘cantaor’ che la esegue teme a sua volta di incorrere in un sortilegio o maleficio e pertanto essa non viene mai eseguita in pubblico se non nel caso di una riunione di soli iniziati. Gli stessi Gitanos la temono e usano segnarsi allorché incorrono al solo sentirne il nome.
Generalmente il ‘Cante de la petenera’ si sviluppa in modo lineare, in puro stile ‘jondo’ di una semplicità maestosa e ieratica. Come appare nell’esempio qui di seguito riportato:
“De noche cuando te veo / Llegar con tus pasos lentos / Se me agotan las calabra / Que luego llevo dentro / Dejandome la garganta / Fria, seca y sin aliento. / Te llaman lla petenera / Pa’ martirio de los hombres / Que se matan o se mueren / Que se matan o se mueren / Con solo mentar tu nombre / The llaman la petenera / Pa’ martirio de los hombres. / Quisiera yo renegar / De este mundo por intero / Volver de nuevo a mi gitana / Madre de mi corazòn / Volver de nuevo a mi gitana / Por ver si en un mundo nuevo / Por ver si en un mundo nuevo / Remedio puedo encontrar. / Ay! Que penita me da / Ay! Que penita me da / Dos hombres se estàn matando / Madre mia de mi corazòn / Ay! Que penita me da / Ay! Que penita me da / Dos hombres se estàn matando / Madre mia de mi corazòn”.
“Di notte quando ti vedo / arrivare col tuo passo lento/ si asciugano le parole / che tengo dentro, lasciandomi la gola / fredda, secca e senza più fiato. / Ti chiamano la petenera / per il martirio che dai agli uomini / che si uccidono o muoiono / al solo menzionare il tuo nome / Ti chiamano la petenera / per il martirio degli uomini. / Vorrei rinnegare / questo mondo per intero / ritornare dalla mia gitana / madre del mio cuore / ritornare dalla mia gitana / madre del mio cuore / ritornare dalla mia gitana / per vedere se in un mondo nuovo / posso trovare rimedio. / Ahi! Che pena mi da / Ahi! Che pena mi da. / Due uomini si stanno ammazzando / madre mia del mio cuore. / Ahi! Che pena mi da / Ahi! Che pena mi da. / Due uomini si stanno ammazzando / madre mia del mio cuore”.
La tematica del ‘Cante jondo y flamenco’ si presenta vasta oltre ogni considerazione letteraria, da formare un autentico linguaggio parallelo a quello musicale e per quanto sia di mia conoscenza, unico nel suo genere. Un linguaggio capace di esternare l’intima essenza dei sentimenti di chi si trovi ad interpretarne le parti: l’attaccamento alla vita, la rivalità in amore, il dualismo esistenziale ecc., esattamente come in questa ‘malaguena’, parola intraducibile in senso letterale e che forse è semplicemente il nome riferito alla donna di Malaga, come sembra dall’esempio qui riportato:
“Dime donde ba a llegar / Este querce tuyo y mio. / Dime donde ba a llegar / Tu tratas de aborrecerme / Yo cada dìa te quiero màs. / Que Diòs me mande la muerte”.
“Dimmi dove se ne va / questo amore tuo e mio. / Dimmi dove se ne va / Tu vuoi lasciarmi / Io ogni giorno ti amo di più / Che Dio mi mandi la morte”.
Spesso nel ‘Cante’ propriamente detto, vengono espressi inoltre l’orgoglio, la distinzione di razza, la medesima esigenza di vita, il condizionamento sociale, la repressione, la lotta politica, la libertà, come del resto appare in questo ‘fandango gitano’:
“Por el maldido dinero / Quieren dominarme a mì / Por el maldido dinero / si la muerte a da venir / Pa’ el rico y pa’ el pordiosero / Pa’ que tanto discutir / Seria mi felicidad. / Que yo me volviera loco / De que me a serbido estudiar / Si ahora veo la hipocresia / Que tiene la humanidad. / Los desenganos / Son los que nunca se olvidan / Estos grandes desenganos / Uno me dieron un dia / Y me causò tanto dano / Que hasta morirne yo queria”.
“Per il maledetto denaro / Mi vogliono dominare / Per il maledetto denaro / Se la morte deve venire / Per il ricco e per il mendico / Perché tanto discutere / Sarebbe la mia felicità./ Che io diventassi pazzo / A che mi è servito studiare / Se adesso vedo l’ipocrisia / Della umanità. / Le disillusioni / Sono quelle che mai si dimenticano / Di queste grandi disillusioni / Una me ne dettero un giorno / Che mi causò tanto danno / Che finanche morire io volevo”.
O come è detto in queste due ‘tonà’ di Francisco Moreno Galvan che apprendiamo nell’interpretazione di José Menese:
“Cuando Espana es un lamento / Desesperaciòn y lagrimas / Alientan nocturnos ecos / con sones de pirenaica”.
“Quando la Spagna è un lamento / Disperazione e lacrime / Alimentano echi notturni / con fruscii pirenaici”.
“Espana Plaza Mayor / de tus pueblos y regiones / brotan por tus cuatro esquina / la esperanza en surtidores..”.
“Spagna Piazza Maggiore / del tuo popolo e delle regioni / germogliata per i tuoi quattro cantoni / la speranza dei ribelli..”.
Al fianco dei ‘cantaores’ memorabili entrati nella storia del ‘flamenco’ e dei quali non si conosce l’esatta origine geografica, trovano oggi affermazione interpreti non necessariamente Gitanos che operano nella continuità della tradizione. Notizie incerte rivelano i nomi di Juan el Pelao, maestro nel difficile ‘Cante gitano’ al cui nome risponde un modo particolarmente drammatico di esecuzione vocale; Juan Breva, che diede vita al ‘Cante andaluso’; Dolores la Parrala, ricordata per la sua straordinaria bellezza e il ciclone di passioni che scatenò in vita, amica e discepola del famoso Silverio Franconetti di origine italiana, ricordato per aver condotto il ‘Cante’ in una nuova forma espressiva interiormente sentita e che, Garcia Lorca a sua volta definì ‘sublime’ dedicandogli un celebre “Retrato”. E inoltre, Manuel Gagancho, Pepe Marchena, Don Antonio Chacòn, Manuel Torre, tutti nomi di autentici ‘cantaores gitanos’ di straordinaria sensibilità interpretativa. Vanno qui inoltre ricordati: Pastora Pavòn conosciuta come la ‘Nina de los peines’, sivigliana, alla quale si attribuiva il segreto e la tradizione del ‘Cante vjejo’ oggi quasi dimenticato; Antonio Mairena, a suo tempo ricordato come l’enciclopedia vivente del ‘Cante’ e ritenuto il maestro assoluto dell’ultima generazione di ‘cantaores’, al limite della genialità; Manolo Caracol, forse l’ultimo in ordine di tempo, acclamato ‘cantaor’ che portò il flamenco al riconoscimento internazionale.
Più recentemente, José Menese, gitano, salito alla ribalta del successo per la sua voce ‘terrible y honda’ e considerato l’ultimo rappresentante della nuova generazione della risorta Spagna flamenca. Con lui il ‘Cante’ ha ritrovato l’espressività di un tempo attraverso le vie sotterranee della matrice originaria che sembrava smarrita negli anni del franchismo. Nelle sue tenaci interpretazioni canore Josè Menese trascende la pena individuale e la proietta nella coscienza collettiva, proponendosi come il prosecutore della tradizione secondo la forma più ‘pura’ del ‘Cante’ con la sua voce ferma e senza esitazione alcuna, andando diretto alla sostanza e al contenuto del verso. Sì da farsi egli stesso partecipe del duro lavoro della forgia e del campo che, trasposti al giorno d’oggi, significano lavoro nella fabbrica e nella miniera in cui più si rivela la penosa condizione dell’emarginazione. Come egli stesso ha ammesso in una intervista:
“Todo lo que canto, occurre a mi pueblo, es decir , me rodea a mi mismo.” Di lui ha scritto Manuel Tunon de Lara: “Penso che Josè Menese come a suo tempo Miguel Hernandez, rappresenti la testimonianza solitaria di un sentimento collettivo, quella stessa sognata da Antonio Machado”.
Non in ultimo va qui ricordato Camaròn de la Isla recentemente scomparso. Celebre ‘cantaor gitano’, già leggenda quando era ancora in vita, ritenuto uno dei più grandi di tutti i tempi. Così lo ha salutato la critica che gli ha attribuito il possedere l’arcano principio attivo del ‘fuego’ creatore, colui che “..si erge come un eroe vincitore contro il destriero della morte”. La cui voce aspra s’impone fervida e implacabile come la voce stessa del “sangre azul del flamenco y de la raza gitana”. Un appellativo questo che più d’ogni altro da l’esatta dimensione del suo essere partecipe della leggenda che lo contiene: “Camaron es cielo y el abisso, Camaron es Oriente”. “Quell’Oriente – aggiunge Joaquin Albaicin che – il gitano presente in lui vedeva come punto originario di riferimento, era la sua mitologia, era il tutto”.
La ‘chitarra’ flamenca.
Il vocabolo tradotto dal greco in ‘chitàrae’ attraverso l’arabo orientale di ‘kitara’ si distingue in ‘guitarra morisca de las voces aguda de los puntos arista e latina’ che, con la ‘vihuela de arco e la sinfonia’ è poco adatta alla musica araba, e in ‘guitarra a la espagnola’ diversa sotto tutti gli aspetti a cominciare dalla forma. È lo strumento che si è rivelato insostituibile nell’arte del ‘flamenco’. Il primo conosciuto metodo per chitarra fu scritto da Luis Millàn: ‘Viuela de mano’ o ‘El maestro’ a Valencia. Ma il più popolare diffuso in Europa fu composto nel secolo seguente da Luis Brisento: “Metodo para aprendir a tanir la guitarra a la espanola”, Paris 1626. Mentre l’influsso che ebbe la chitarra sulla musica in generale è riscontrabile nella riforma di Ramos Pareja, il quale sostituì il sistema ‘esacorde’ di Guido D’Arezzo con quello moderno fondato sull’ottava, sembra deducendo la sua teoria proprio dai chitarristi gitani.
Nella seconda conferenza sul ‘Cante Jondo’, Garcia Lorca accennava alla irresistibile costituzione tonale di questo prodigioso strumento e alla virtù del vero chitarrista: “una sagacità alfine di eliminare ciò che è nuovo e accessorio, sì che risalti l’essenziale; un potere magico nel saper disegnare o misurare una seguirija con accento assolutamente millenario. La chitarra commenta ma crea anche, ed ha costituito il Cante Jondo. È opera di approfondimento della oscura musa orientale ebraica e araba antichissima, ma per questo balbettante. La chitarra ha occidentalizzato il Cante”. Le sei corde dell’attuale ‘chitarra flamenca’ sono state poeticamente paragonate a sei anime distinte in un corpo armonioso, tal grande è la loro indipendenza di espressione. La sua tecnica, nell’uso spagnolo o flamenco che sia, adotta il pizzico vero e proprio evitando di fatto lo strimpellamento. L’esecutore addestrato riesce ad estrarre profondo lamenti dalle corde di base, vibrazioni prolungate sulle quali le corde intermediarie singhiozzano, mentre il ‘mi’ da un continuo e brillante fremito e si scoprono nei suoi ritmi gli accenti ‘sbagliati’ i capricci sorprendenti.
La vera patria riconosciuta della chitarra è in quel Sud esaltato dell’Andalusia dove fiorì la sua anima orientale. È lì che essa trova la profondità, il colore delle sue passioni e la successione proibita delle note. Era dunque inevitabile che la chitarra si unisse per comunanza al ‘Cante flamenco’, poiché a quel tempo era lo strumento più in voga in Spagna, usata nei concerti classici come strumento solista e d’accompagnamento, mentre il ‘flamenco’ si andava formando dalla musica folkloristica e diventava l’anima stessa della Spagna gitana. Suonare la ‘chitarra flamenca’ richiede un adeguato talento musicale da parte dell’esecutore, una severa dedizione, vero senso del ritmo e dell’armonia, creatività e conoscenza profonda dell’arte flamenca; saper essere abili nell’inserirsi nel contesto ‘flamenco’, interpretarne il variare del ritmo. A cui necessita infine la capacità di catturare lo spirito intimo, il variare delle emozioni, le sue esplosioni di gioia, l’intensità melanconica e la compromessa audacia. Il ‘tocaor de guitarra’ al pari di un asceta sgrava il suo intimo dal peso dell’esistenza per presentarsi puro al cospetto di quel fantasma divino e diafano che si pone di fronte a lui, per un ennesimo atto al raggiungimento dell’assoluto ‘incontestabile’.
Così Antonio Machado esprime l’immagine della profonda drammaticità che la chitarra comunica:
“… Y en la guitarra, resonante y tremula, la brusca mano, al golpear, fingia el reposar de un ataud en tierra”.
“... e nella chitarra, risuonante e tremula, la brusca mano, al battere, fingeva il riposare di una bara in terra”.
La chitarra costituisce un’arte unica nell’attuale cultura della Spagna. Il crescente e solido interesse per lo strumento valorizza l’arte flamenca e ne sostiene la continuità all’interno della traduzione andalusa. C’è chi afferma l’inevitabile separazione della chitarra dal ‘flamenco’ per imporsi come genere distinto dal folklore che si consuma all’interno delle ‘cuevas’ gitane o dei ‘tablao’ andalusi, per sopravvivere distaccata in forma solista. Per quanto, malgrado la crisi in cui è caduta tutta la cultura orale a causa della venuta meno dei presupposti che l’avevano generata, il panorama musicale flamenco mostra un volto giovane, rinnovato dall’acuirsi dell’interesse per questo strumento e non solo.
Paco Pena, certamente il più celebrato e raffinato chitarrista spagnolo di musica classica, operatosi per la conservazione della musica ‘flamenca’ nella sua forma più autentica, seguendo in questo le tracce di grandi musicisti come i Montoya e Sabicas. Nato nel 1942 a Cordoba, uno dei grandi centri di musica flamenca ha ottenuto consensi dalla critica internazionale come chitarra solista. “Noi – ha rilasciato in una intervista parlando a nome del gruppo che lo accompagnava in tournée – abbiamo appreso dai nostri padri quello che essi avevano appreso a loro volta dai loro, ma abbiamo assimilato e trattiamo la musica in un m,odo che è il nostro, così come hanno fatto loro”, a conferma di una forma d’arte pur sempre ‘viva’ ed in continuo sviluppo che lascia spazio all’interpretazione personale degli artisti.
Nell’impossibilità di riscrivere un intero capitolo della musica spagnola, mi limito qui ad accennare a quegli esecutori, in parte gitani puri, in parte andalusi, che hanno dato maggiore impulso alla divulgazione della chitarra flamenca nel mondo: Ramon Montoya, chitarra mitica del ‘flamenco’ formatosi sulla tradizione classica: si deve a lui l’uso tipico del ‘picando’ (pizzicato) e la particolare tecnica del ‘rasgueado’, una sorta di arpeggio in cui le dita passano veloci sulle corde in successione rapida creando uno straordinario effetto ritmico, ed entrato a far parte della tecnica flamenca.
Alla stessa famiglia appartiene Carlos Montoya riconosciuto come il massimo chitarrista gitano, maestro incontestato nell’arte dell’improvvisazione, la cui tecnica è rimasta pressoché ineguagliata. Formatosi con i migliori interpreti da quali apprese l’inconfondibile mutare di tono e i ritmi più complicati, egli ha saputo esprimere, con tensione drammatica e intenso calore, il mistero e la poesia delle notti andaluse.
Augustin Castellon, più conosciuto come ‘el nino’ Sabicas, trovò la sua affermazione all’età di otto anni in un concerto pubblico tenutosi nella sua città natale. Le cronache lo definirono un prodigio che s’impose con l’ardore del ‘flamenco’ medesimo. Più tardi il suo nome si legò al più puro stile tradizionale, segnando punti di elevato virtuosismo. Trasferitosi poi in Sud America legò il suo nome e la sua arte al fianco della celebre danzatrice gitana Carmen Amaya, con la quale interpretò anche alcuni film di successo. Tornato a stabilirsi definitivamente in Spagna, Sabicas è riconosciuto come uno degli ultimi maestri contemporanei dello stile flamenco più puro.
Manitas de Plata, ovvero Riccardo Ballardo, nato in Francia all’interno di un accampamento gitano, iniziò a suonare la chitarra molto presto fino al raggiungimento di uno stile personalissimo che gli ha permesso di conquistarsi l’appellativo di ‘leggenda vivente’ fra i chitarristi non solo d’ispirazione flamenca, bensì classica e jazz. Ha instaurato una vera e propria tradizione accogliendo al suo fianco dapprima suo fratello Polito Ballardo anch’egli chitarrista di talento; il figlio Manero cantante di ‘fandango’; un nipote Ricardo e un cugino José Reyes cantanti, trascinando così l’intero suo ‘nucleo famigliare’ in un’unica e irrepetibile esperienza di successo. Tale da portarlo a conoscere Pablo Picasso che passò con lui un periodo ad Arles. Salvator Dalì per fargli omaggio della sua arte volle decorare la sua chitarra. Jeanne Moreau si recò presso la sua tribù e danzò per una notte intera al suono della sua musica. John Steinbeck disse di lui: “è un grande e selvaggio artista”. Per tutto il tempo fino alla sua morte egli è vissuto a Montpellier in Francia, lontano dai riflettori delle ribalte in continua lotta con i grandi impresari che da ogni parte del mondo hanno sempre tentato di sedurlo.
Sulla scia trainante di questi grandi appena citati si sono affermate in seguito eccellenti figure di chitarristi i cui nomi non sono certo sfuggiti ai cultori di questo strumento: oltre a Miguel Borrul e Manolo de Huelva, vanno qui ricordati Manuel Diaz Cano, Paco de Lucia, Juan Martin, Ottmar Liebert e, non in ultimo, lo zingaro José Sopo, alcuni dei quali per le loro qualità esecutive hanno rappresentato la punta più avanzata del virtuosismo chitarristico, a un livello tale da far dire a un critico affermato:
“Come se l’Andalusia tutta, da Siviglia a Jerez, avesse improvvisamente tirato un respiro di rinnovata freschezza.”
E questo accadeva in tempi piuttosto recenti, certamente prima della scomparsa di Paco de Lucia, da me ricordato in un articolo su questo stesso sito. Le sue rivisitazioni di pezzi classici e le interpretazioni con cui ha accompagnato il rinnovamento dell’arte flamenca hanno aperto le porte alla new-age. Le sue apparizioni al fianco di artisti jazz di chiara fama hanno permesso il confronto comparativo tra due mondi che sembravano distanti e incompatibile che, invece, hanno mostrato di conoscersi a fondo, permettendo a entrambi di affermarsi come parti singole di un unico discorso musicale in un abbraccio che ai più sembrava stratosferico.
La danza gitana e il baile flamenco.
Delle danze più arcaiche che il popolo nomade dei Gitanos era in uso improvvisare davanti al fuoco nelle notti di luna piena, come quelle propriamente rituali d’origine mitologica, oggi non si hanno notizie certe o quantomeno attendibili. Chiunque abbia avuto modo di vedere un gruppo danzare può rendersi conto che quei passi scaltri e quei gesti ieratici non appartengono a un linguaggio coreografico bensì sono l’espressione tipica dell’improvvisazione, tali da rispondere al riproporsi di una tradizione che non è mai venuta meno, che rispondono a una creatività sempre nuova e inaspettata, mai sconsiderata, che definirei piuttosto impulsiva nella loro arcana fruibilità. Riguardo allo stile si può facilmente dire che la ‘danza gitana’ come il ‘baile flamenco’ abbiano derivato la loro forma attuale partendo da concezioni diverse pur non del tutto dissimili. Diversi appaiono infatti i modi di esecuzione rilevati in un gruppo ‘gitano’ da un altro ‘flamenco’, variabile di zona in zona che sia il Sud o un’altra regione della Spagna; così come diversi sono gli esecutori ‘bailadores’ che improvvisano indipendentemente in uno stile o l’altro, una ‘zambra’ eseguita in una ‘cueva andalusa’ o di eseguire un ‘flamenco’ sul ‘tablao’ di un baraccamento gitano.
Influenze di altre danze risultano circoscritte all’interno del corpus fondante sia del ‘flamenco’ che della ‘danza gitana’ entrambe relegate a una forma espressiva per una certo verso ieratica, dall’altra tipicamente sensuale. In entrambi i casi legate all’interiorità del ‘gesto’ o a tutta una serie di ‘passi’, (aspetto esteriore della danza), come anche di un atteggiamento amoroso e passionale (che rispecchi invece l’aspetto interiore della stessa). Per questo è necessario scrutare nell’abilità e nel rigore di chi danza e di chi interpreta la danza. È così che nella costante ricerca delle culture individuate si possono riscontrare influenze etniche diverse: indiane, ebraiche, egiziane ed arabe confluite nel ‘baile flamenco’come nella ‘danza gitana, tali da renderle ancora più suggestive agli occhi di chi l’osserva. Oltre alla ‘zambra mora’ dove non mancano testimonianze dell’uso delle nacchere, troviamo la ‘moresca’, il ‘bolero’, la ‘malaguena’, la ‘sevilliana’ tutte estrapolazioni della ‘zambra’ medesima di cui si rintracciano poche e superficiali alterazioni nel ‘flamenco’ma che, in qualche modo riprendono lontane danze rituali importate dalla lontana India (accertata terra d’origine dei Gitanos), sebbene lontana ormai da ogni contestuale riferimento per la perdita del significato rituale originale.
Il ‘baile flamenco’ propriamente detto si presenta come una sequenza composita di temi espressi con costante ed eccessivo straniamento, capace di una trasposizione che in qualche modo vuole essere manifestazione fisica dell’emozione appassionata e furtiva dell’emozione intimistica, espressa nella tremenda liturgia della danza. Manuel Barrios scrive: “Con il sudore che le scende per tutto il corpo, nel mentre ripete una, mille volte un passo; una mille volte trasfigura nel tremore del gesto che l’accompagna; come tenuto da un fantasma nell’esercizio della grazia e del dolore, con lo sguardo al suolo, con la bocca contratta in un sorriso sdegnoso, arcano”. Sì che viene da chiedersi perché di tutto questo, la cui risposta è racchiusa nel ‘duende’. Quel ‘duende’ che Garcia Lorca ha pienamente espresso nella conferenza “Teorya y fuego del duende” come principio spirituale e demoniaco dell’estetica gitana, che supera ogni esteriorità folkloristica ed imprime un’estrema purezza alla rappresentazione “..in cui le forme si fondono in un anelito superante le loro espressioni visibili”.
Tesi questa, confermata anche dall’erudito spagnolo Garcia Blanco, il quale afferma “..essere raccolte nel grido posto alla fine di ogni esecuzione; quel ‘olé’ proveniente dall’ebraico ‘jolech’, participio del verbo ‘jalah’ che significa ‘ascendere’ in un grido di entusiasmo, quasi faustico. Allo stesso modo l’uso delle ‘castanuelas’ o ‘nacchere’ o ‘crotali’ nella danza come nel ‘baile’ è altrettanto antico. La sua origine è indubbiamente mediterranea col nome ‘crusmata’ in origine formato da due valve di conchiglie, la cui testimonianza deriva da alcuni dipinti egiziani e greci, che fanno risalire lo strumento a Diana cacciatrice, che si vuole: “tenesse nelle mani nacchere dorate”. Per quanto il loro uso nella ‘danza flamenca’ sia piuttosto recente, dovuto forse all’ingresso del ‘baile flamenco’ come ballo d’intrattenimento nei Café Chantant, una danzatrice di ‘flamenco puro’ non fa uso delle ‘castanuelas’, bensì di ‘pitos’, schiocchi delle dita. Più tardi, non si sa bene quando ciò sia avvenuto, l’uso del battito dei tacchi sul tavolato assume nel contesto del ‘baile’ maggiore importanza per il fatto che in modo diverso avvicina l’uomo ‘bailador’ alla donna ‘bailadora’ in un comune e costante vibrare che, all’unisono con il battito delle mani, raggiunge la dimensione mediatica del ‘pulsare’ del sangue della passione nelle vene, dando maggiore impeto al fuoco del ‘duende’, necessario per raggiungere l’ ‘azione’ fortemente drammatica che in esso si rappresenta.
La maggiore difficoltà per entrambi i danzatori sta nel conservare l’attitudine eretta del busto che dev’essere leggermente arcuato senza esagerazione, e nel tenere le braccia sollevate a disegnare una curva pura, ben delineata e sostenuta dal gesto ‘plastico ed elegante’. Ciò che consente ai danzatori di flamenco ad esaltarsi tramite la scansione del ‘tempo’ e ‘controtempo’ eseguiti sul battito dei piedi e delle mani, creando a loro volta una forma di linguaggio (non scritto) delle diverse parti del corpo all’interno di una difficile simbologia interpretativa di ritmi che si scontrano e s’incendiano. Apparentemente l’aggiunta del volteggiare delle mani durante la danza non sembra essere rappresentativo di alcun linguaggio particolare ma piuttosto un’espressione estetica e coreografica in aggiunta alla danza. Il momento focale del ‘flamenco’è raggiunto quando tra il battito delle mani degli accompagnatori, i tacchi dei ballerini e la chitarra, si fondono in un tutt’uno con l’instaurarsi la compenetrazione coreutica della tensione, ciò che imprime al ‘flamenco’ un’istintiva rispondenza di tutto l’insieme.
Fra le più celebri danzatrici di levatura artistica ormai definita ‘classica’ del ‘baile flamenco’ vanno qui menzionate: la Macarona, la Malena, la Argentinita, Matilde Coral e, in tempi più a noi vicini Luisa Maravilla, Rosa Duran, Lola Flores e Lucieno Tena che hanno contribuito a preservare l’arte del ‘flamenco’ dalle contaminazioni. Indubbiamente Carmen Amaya, che già al suo tempo non era ritenuta la più ‘pura’ in assoluto, ma certamente la più conosciuta a livello internazionale ha dato una svolta a questa tipica arte spagnola. Una cronaca a lei riferita narra dello spettacolo che ancora in giovane età offriva al pubblico che teneramente l’appellava ‘la piccola Carmelilla’. La sua origine gitana creò attorno alla sua figura il mito di ‘regina degli Zingari’ con il quale i critici di allora la comparavano ai più grandi artisti che la Spagna avesse mai generato. La sua prima apparizione teatrale fu causa di una rivolta popolare che i reporter del tempo definirono:
“Una tempesta, un turbine, la più eccitante danzatrice mai vista prima”. Disse di lei il grande Luisillo nella doppia veste di ballerino e coreografo: “Nessuno davvero l’ha mai eguagliata, come interprete di flamenco è stata veramente unica, spontanea, emotiva, umanissima”.
Fra i ‘bailadores’ più famosi il ricordo va ai grandi Antonio Bilbao, Rafael Cordoba, Antonio Gades, comunemente riconosciuti come ‘ballerini classici’ che hanno danzato anche il ‘flamenco’. E gli altri: el Guito, Mario Amaya, Rafael el Negro, tutti gitani puri, tranne il pur grande Luisillo che riempì le cronache del suo tempo per la strepitose coreografie improntate proprio sul ‘baile flamenco’, ricordato a sua volta per essere stato un ‘simbolo’ della danza spagnola. Più noto col suo nome d’arte Luisillo, era nato in Messico da padre Zingaro-Gitano e da madre messicana. Disse di se: “Io sono zingaro solo per metà, ho iniziato a danzare all’età di tredici anni con la grande maestra Carmen Amaya. Nel 1960 ho costituito il primo Teatro Danza Spagnola. Quando danzo seguo la mia ispirazione. Nel flamenco ciò che più conta è la spontaneità. Ogni esecuzione è una nuova libera creazione in cui l’artista esprime la propria personalità”. Tenace e insieme sensibilissimo interprete dalla spontanea coloritura folkloristica, Luisillo era in grado di raggiungere la pura essenza della danza seguendo la sola scansione ritmica, incisiva e potente, dei suoi passi, lasciando ulteriore spazio a modulazioni e variazioni sempre perfettamente ricondotte al motivo fondamentale di una rigorosa stilizzazione.
Certamente Antonio Gades, ballerino che a sua volta è salito alla ribalta internazionale, ha saputo infondere al ‘flamenco’ una sua personalissima interpretazione coreografica davvero originale improntando la sua danza su elementi della tradizione popolare con la disciplina accademica più evoluta che ha riscattato il ‘flamenco’ dalla sua cornice folkloristica. Coadiuvato da un corpo di ballo eccezionale in cui spiccava la personalità notevole di Cristina Hoyos, sua abituale partner, Gades si è lanciato in numerose tournée in giro per il mondo negli anni ‘70/’80 acclamato dalla stampa e dal pubblico che gli decretò un successo incomparabile. Restano famose le sue apparizioni alla Scala di Milano e all’Opera di Roma, soprattutto per le coreografie ispirate alla letteratura e e alla drammaturgia spagnola di Lope de Vega e Garcia Lorca: “Bodas de Sangre”, “Fuego”, e quelle dedicate a Bizet “Carmen”, e a Ravel “Bolero”, anche riprese in versione cinematografica dal regista Carlos Saura. Il ‘teatrodanza’ di Gades, che non trascurò le avanguardie del ‘900, puntava sulla purezza originaria del ‘flamenco’ che non trascurò di inserire all’interno delle sue coreografia più complesse, seppure lontana dai virtuosismi e dalle decorazioni posticce. A lui, in occasione di un suo spettacolo all’Opera di Roma, il poeta spagnolo Rafael Alberti dedicò una lirica accorata nella quale si sente il riconoscere del ‘duende’:
“Antonio Gades te digo: / Io que yo, / te lo dirìa mejor Federico. / Que tienes pena en tu baile, / que los fuegos que levantan / tus brazos son amarillos. / Eso yo , me lo sé yo, / te lo dirìa mejor / Federico. / Que el aire baja a tus pies / y el corazon se sube / a la garganta hecho anicos. / Eso yo, lo pienso yo, / te lo diria mejor / Federico. / Que te adelgazas, que tiemblas / que te doblas, que re rompes / y exaltas como un cuchillo. / Eso yo, bien lo sé yo, / te lo dirìa mejor / Federico. / Pero él ya no està. Por eso, / Antonio Gades, le digo: / lo quel yo, / esto que te he dicho yo, / lo hubiera dicho mejor / Federico.”
“Antonio Gades, ti dico: / Io ciò che meglio direbbe Federico. / che hai pena nella tua danza, / che il fuoco che sollevano / le tue braccia è una febbre. / Questo è quanto io sento, / te lodirebbe ancor meglio / Federico. / Che l’aria balla sotto i tuoi piedi / e il cuore s’innalza / sale alla gola come anice. / Questo è ciò che io penso / te lo direbbe meglio / Federico. / Ciò che ti smagrisce, / che yi tempra, / che ti spezza, / e che ti esalta come un coltello. / Questo io, lo so ben io, / te lo direbbe meglio, / Federico. / Però egli non c’è. / Per questo / Antonio Gades, ti dico: / ciò che io, / ciò che io ti dico, / te lo avrebbe detto ancor meglio, / Federico.”
Misa flamenca.
La celebrazione della Messa cristiana nell’interpretazione flamenca costituisce un’isola di particolare interesse etnico e musicologico all’interno della tradizione dei Gitanos di Andalusia. Si è spesso detto delle possibili influenze indiane, ebree, arabe e bizantine che avrebbero concorso alla formazione del ‘flamenco’ nel suo insieme. Volutamente in questa ricerca si è parlato invece poco della profonda trasformazione apportata dalla religione cristiana al tempo dei Re cattolici avvenuta durante il XV secolo, allorquando questa esercitò il suo pieno potere con l’instaurazione del Tribunale Ecclesiastico, più conosciuto come la Santa Inquisizione, che doveva sopravvedere alle molte ‘usurpazioni’ della disciplina liturgica, dei costumi e della moralità voluta dalla Chiesa. È evidente che una tale disciplina, per quanto potesse essere accettata da tutti, doveva attecchire sul territorio. Ciò che avvenne a lungo termine, non senza però trovare sul suo cammino alcuni ostacoli di carattere laico. Non poco si deve a quei a quei padri missionari che giunti nei primi secoli della cristianizzazione della Spagna, incoraggiarono le popolazioni autoctone, compresi i nomadi zingari e zingaro-gitanos, a misurarsi con i canti cristiani durante le funzioni liturgiche imposte loro.
Molti furono tra questi gruppi minoritari che subirono o che tentarono di sottrarsi al terrore dell’Inquisizione con la fuga o nascondendosi nelle ‘cuevas’, grotte fra le montagne. Fra questi gli ebrei-sefarditi, mentre altri, come i Gitanos si convertirono al cattolicesimo ormai imperante. Ma fu durante il Medioevo, allorché migliaia di maestranze giunsero in pellegrinaggio da tutta Europa per lavorare alla costruzione dei grandi santuari di Montserrat, di Barcellona e di Santiago de Compostela, che ebbe inizio quella che doveva diventare la grande tradizione liturgica della cattolica Spagna. All’epoca, la religiosità consolidata sul territorio affondava le sue radici nella liturgia ‘mozarabica’ sopravvissuta all’invasione araba e mai del tutto sostituita fin dal XI secolo quando fu destituita dalla liturgia romana. Successivamente ai primi canti sacri improntati sul gregoriano, entrati in uso durante le grandi festività stabilite dalla Chiesa Cattolica Romana, nacqueo i primi ‘villancicos’ cantati per la Natività di Nostro Signore, ricreati sulle popolari ‘canciones de cuna’ (ninne nanne popolari); inoltre alle lamentazioni funebri legate alla celebrazione della Settimana Santa che si celebrava un po’ ovunque in tutta la Spagna con grande solennità cui partecipavano le masse con tanto di devozione e partecipazione più o meno sentita.
Siviglia in quanto considerata epicentro della tradizione araba e moresca nonché gitana e quindi miscredente, si adeguò lentamente e straordinariamente produsse un’alta espressione liturgica, forse la più alta in assoluto con l’espressione della ‘saeta’, un canto religioso fortemente espressivo che in seguito venne accolto nel corpus del ‘Cante grande’, e che possiamo definire una ‘specificazione ‘ dell’animo profondo del ‘Cante jondo’. A sua volta elaborata nelle scuole di Jerez e di Siviglia sulle salmodie corali dei fedeli cattolici nelle processioni liturgiche. Le più antiche e forse le più belle ‘saetas’ rimangono quelle lanciate, anzi scagliate appunto come una saetta, o anche come frecce in onore della Vergine Maria o al Cristo durante il sostare della processione, quando all’interrompersi della banda musicale che l’accompagna, si crea un spazio liturgico espressamente dedicato al ‘Cante’. L’ambiente è dunque quello trecentesco del Medioevo che troverà il suo completamento alla fine del Cinquecento, ‘tempo’ in cui le celebrazioni per la Settimana Santa conobbero il loro apice nelle rappresentazioni della ‘Passione’. Quello qui sotto riportato è un passo ripreso da una ‘cronaca’ più recente che ben ricrea l’ambientazione e lo svolgersi di una processione:
“Nella mattina degli ultimi giorni stazionano nella Cattedrale (di Siviglia), varie Confraternite e Congregazioni recanti in solenne processione i rispettivi e meravigliosi ‘pasos’. Le Confraternite presenti sono in tutto 49 con complessivi 91 ‘pasos’, distribuite nei 6 giorni che compongono la Settimana Santa. I confratelli indossano ampie cappe e alti cappucci a punta con rispettivo stemma (di appartenenza) sulle spalle e sul petto. Impugnano lunghi ceri o pertiche con lo stesso stemma in cime. I gruppi statuari, montati su enormi palchi sorretti a spalla dai fedeli e stupendamente addobbati, rappresentano le vicende dell’agonia e della morte di Cristo, come è narrata nei Vangeli. L’accompagna la Vergine Maria lussuosamente vestita come persona viva, stringente nelle mani il fazzoletto o la corona, il petto trafitto da una o più spade. Il Venerdì mattina è il turno della Cofradia de los Gitanos con due ‘pasos’ entrati nella tradizione popolare.
‘Pasos’ che Antonio Machado ha incluso in una sua raccolta poetica:
“Oh la saeta, el cantar / al Cristo de los gitanos, / siempre con sangre en las manos, / siempre por desenclavar! / Cantar de la tierra mia, / que echa flores / al Jesùs de la agonia, / y es la fe de mis mayores! / Oh, no eres tù mi cantar! / No puedo cantar, nì quiero / a ese Jesùs del madero, / sino al que anduvo en el mar!”
“Oh la saeta, il cantare / al Cristo dei gitani, / sempre con il sangue nelle mani, / sempre per dischiodare! / Il cantare del popolo andaluso, / che tutte le primavere / va chiedendo scale / per salire alla croce! / Cantare della terra mia, che lancia fiori ( al Gesù dell’agonia, / ed è la fede dei miei padri! / Oh, non eri tu il mio cantare! / Non posso cantare, né lo voglio / a questo Gesù sulla croce / se non a quello che camminò sul mare.”
Manuel Martinez Torner tuttavia non la include nel genere ‘flamenco’ e la considera a parte come di un genere decisamente religioso per la sua caratteristica spirituale tipicamente occidentale. In pieno accordo con quanto riferisce padre Diego da Valencina che fa risalire la ‘saeta’ alla ‘lauda’ francescana, si tratta qui di un autentico ‘grido’ pari a una frecciata che si leva improvviso e quindi inaspettato sopra la processione ad invocare il mistero che la liturgia contiene:
“Vienes de los remotos paises de la pena.”
“Viene dal remoti paesi della pena.”
Recita con accorato pianto chi la lancia, riportando alla mente il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, per quanto non manchino attribuzioni a più antichi riti pagani. Su questo stesso terreno fortemente impregnato di religiosità si è formata nei primi anni ’60 l’idea di una “Misa flamenca” moderna in stile ‘flamenco’ che rispondesse alle esigenze del popolo andaluso. La sua celebrazione, in quanto avvenimento rituale che esprime un ‘mistero’ ha riscaldato gli animi dei Gitanos che infine ne hanno cristianizzato il senso in una performance di intensa drammaticità. La ‘Misa’ trasposta nell’uso interpretativo del ‘flamenco’, in quanto: “..evocazione di un atto storico unico e manifestazione di un fatto che permane nell’eternità al di là dell’umana capacità di comprendere e rappresentare”; trova la sua originalità nell’utilizzo di elementi d’ispirazione gregoriana e reminiscenze della più antica polifonia spagnola, connessi con temi gitano-andalusi, trascritti per l’occasione da solisti impegnati alla chitarra e cori misti. Ma è stato infine il ricorso fatto alla ‘saeta’ che nel momento più alto dell’ ‘eucarestia’ l’ha accesa di interiorità carnale, quasi da ricondurla alla trascendenza pagano-naturalista (e umana) delle origini.
Scrive Antonio Mairena co-autore della ‘Misa flamenca’ in quell’occasione: “Non è stato facile adattare la Messa in spagnolo alla metrica fisica del canto flamenco. non v’è espressione drammatica più graffiante della seguiriya; non c’è alcun cantico che eguagli la serenità della malagueña; né alcuna spiritualità potrà mai essere comparata a quella della soleà. In questo lavoro di trasposizione della prosa in versi, noi abbiamo cercato di rispettare alla lettera le parole sacre. Il rimanente è venuto da solo e molto è dovuto all’esperienza e alla tradizione del Cante.”
Non è un caso che all’interno della ‘Misa’ ritroviamo alcuni dei canti che hanno dato forma al corpus del ‘Cante gitano-andaluso’. Ma è ancora e soprattutto la struttura austera e ieratica del ‘Cante jondo’ a sovrastare l’intera partitura della ‘Misa’ pur rispettando l’ordine della sequenza ufficiale: Introito, Gloria, Kirye, Credo, Sanctus, Agnus Dei. In quanto frutto di un’autentica espressione artistico-musicale la ‘Misa flamenca’ trova la sua affermazione nell’ambito della moderna religiosa spagnola la cui salda continuità l’ha accolta nella tradizione, in quanto sintesi di una perfetta fusione del fatto religioso con la tensione drammatica espressiva del ‘Cante’. Esattamente così come l’hanno vissuta i suoi esecutori in prima persona e tutti coloro che assisterono al suo rito, il 29 Giugno 1968 nella Chiesa del Barrio ‘A’ del poligono di San Paolo a Siviglia:
“La piazzetta di Santa Ana era il cuore del flamenco di Triana. Giungeva fin lì il suono metallico del martello sopra l’incudine, e si univa al rintocco della campana che chiamava al tempio. Un gitano, Manuel Cagancho, creò al ritmo di questo suono un canto per seguiryas che ora figura nella Misa Flamenca. Nella preghiera e supplica del Kirye, l’eco profondo della malaguena imprime la sua andatura con reminescenze del canto gregoriano. Il Gloria, cantico di esaltazione e allegria per la presenza di Dio sulla terra, si fa solenne e rispettoso sull’eco del romance gitano. L’andatura grave nel lamento della petenera serve a introdurre il Credo, mentre per il Sanctus è usata la soleà; l’accordo della chitarra introduce la tonà, la debla e il martinete che si fanno preghiera. L’unione sublime del Padre Nostro con il sangue e la carne del Figlio di Dio medesimo nell’atto solenne dell’Agnus Dei è invece affidato alla seguirya gitana nello stile più puro del Cante jondo: ..se ha puesto de rodillas y vibra y reza canta y llora”.
L’eco profondo della malaguena tradizionale è qui trasposta nella forma del Kyrie sulla reminiscenza del canto gregoriano:
“Dime donde ba allegar. / Este querce tuyo y mio. / Dime donde ba allegar. (..) / Yo cada dia te quiero mas. / Que Dios me mande la muerte”.
“Dimmi dove ci porterà. / Questo amore tuo e mio. / Dimmi dove ci porterà. (..) / Mentre io t’amo ogni giorno di più. / Spero che Dio mi mandi la morte.”
Un tema, questo della morte, che ritorna spesso nella letteratura e nella canzone ispirata dei Gitanos, ma qui siamo di fronte a un fatto musicale che esula dalla semplice operazione colta sul folklore che possiamo facilmente abbinare all’impatto della tradizione spagnola come espressione singolare dei Gitanos che ha fatto del ‘flamenco’ e in particolare della ‘Misa’ un momento trainante e accomunante che si è poi imposto sulle diverse culture presenti sul territorio in quanto punto ideale delle diverse culture indiana, ebraica, araba e bizantina ma soprattutto cristiana, qui confluite come per un ‘encuentro’ ormai avvenuto con il popolo gitano-andaluso e il resto del mondo.
Bibliografia di consultazione:
Preciado Domenico, ‘Folklore Espanol’, Studium, Madrid 1969.
Pedrell Felipe, ‘Cancionero Musical Popular Espanol’, Boileau, Barcellona 1958.
De Cervantes Miguel, ‘Don Chisciotte’, Mondadori, Milno 1974.
Machado Antonio, ‘Poesias Completas’, Espasa-Calpe, madrid 1979.
Macrì Oreste, ‘Canti gitani e andalusi di F. Garcia Lorca’, Guanda, Parma 1957.
Rios Ruìz Manuel, ‘Introduction al Cante flamenco’, Istmo, Madrid ..
Hipòlito Rossì, ‘Teoria del Cante Flamenco’, in Preciado D., ‘Folklore Espanol’, Studium, Madrid 1969.
Hazara Medina, in Preciado D., ‘Folklore Espanol’, Studium, Madrid 1969.
Garcia Lorca Federico, ‘Obras Completas’, Agular, Madrid 1955
Touma Habib Assan, ‘La musica degli arabi’, Sansoni, Firenze 1982.
Maarùf ar-Rusafi, ‘La letteratura araba’, Sansoni, Firenze 1982.
Manzano Rafael, ‘Cante Jondo’, Barna, Barcelona ..
Machado Manuel, ‘Antologia’, Espasa Calpe, madrid 1979.
Paniagua Gregorio, ‘Musique Arabo-andalouse’, Harmonia Mundi (LP).
Mairena Antonio, ‘Misa Flamenca’, Polydor (LP).
Alberti Rafael, ‘Antonio Gades una poesia’, in ‘Poesie, Roma 1969.
Torner Martinez Manuel, in Navarro Isidoro Moreno, ‘La Seimana Santa de Sevilla’, Servicio de Publicationes del Ayuntamiento de Sevilla, 1982.
*
 - Educazione
- Educazione
’L’EDUCAZIONE (IM)POSSIBILE’ di Vittorino Andreoli
‘L’EDUCAZIONE (IM)POSSIBILE’ - Vittorino Andreoli - Saggi Rizzoli 2014
Ovvero ‘come orientarsi in una società senza padri’.
Il sottotitolo è significativo di un avanzamento sociale che ha raggiunto il limite massimo divergente generazionale che l’autore di questo saggio evidenzia con forza, posponendolo alla ‘caduta’ del ruolo pedagogico della famiglia, analogamente a quello della scuola. Luoghi un tempo cosiddetti ‘di riferimento’, in cui altresì si annida ‘il disagio’ psicologico e culturale dell’attuale società che, relativamente al suo sembrare ‘beneficiaria’ di una qualche eredità formativa, dimostra il suo totale ‘fallimento educativo’ e il radicarsi del profondo ‘malessere’ che coinvolge quanti ne fanno parte: “..genitori e no”.
“L’aumento delle figure di riferimento – necessario per molte ragioni, nella nostra società – crea un disaccordo educativo che è la vera causa dell’inquietudine e della disobbedienza..” riscontrabile soprattutto nel binomio padri/figli e più spesso vecchi/giovani entrambi impegnati nello medesimo ruolo generazionale a condividere gli stessi spazi e le stesse precarietà legate alla sopravvivenza. Ciò che da luogo a quello che in passato era vissuto come un inevitabile conflitto antropologico legato alla ‘continuità’ della stirpe, per cui a un certo punto ‘il re doveva morire’ e che, trasferito nella società odierna è l’equivalente di ‘andare in pensione’, ritirarsi dalla vita pubblica e comunitaria, più volgarmente detta ‘rottamazione’, per cui non poteva e non può esserci all’interno d’una discendenza o di gruppo sociale, più d’uno a comandare.
Così all’interno della famiglia, dove la figura materna assicurava la formazione pedagogica e la trasformazione dei ‘giovani’ in ‘uomini’ da immettere nella società, seguendo una tradizione di valori (etici, morali, civili ecc) che erano alla base dell’educazione possibile, in quanto struttura portante della famiglia equo - sostenibile che s’andava costruendo. Sotto quest’aspetto la donna svolgeva un ruolo importante, tutt’altro che secondario, insegnando ai rispettivi figli l’importanza della progenie, l’assumersi la responsabilità di un affettivo processo di crescita dei propri figli, nonché d’essere capaci a loro volta di diventare padri e madri.
“I primi tentativi di ricevere aiuto affettivo si fanno con il padre, con la madre e con i fratelli – ci informa l’autore, adducendo che il legame profondo che tiene legato insieme un rapporto affettivo è ‘l’amore’, indispensabile nel processo di crescita di ogni individuo – “..infatti è compito di un buon genitore (..) dedicarsi a scoprire il piccolo patrimonio di eccezionalità e meraviglia presente nella genesi di ciascuno di noi”. Compito “..che indubbiamente deve continuare nelle aule scolastiche”, per fronteggiare non solo le ‘battaglie’ intrinseche alla crescita e allo sviluppo psicofisico con il tener conto delle memorie private e delle aspettative che si affacciano nell’individuo alle prese con la conoscenza e con il suo sviluppo culturale.
Ma se prima un punto d’unione era spesso trovato tra quanti s’accalcavano alla porta del giovane candidato a diventare ‘uomo’ (familiari, educatori, tutor ecc.), oggi le molte figure di riferimento – benché ritenute necessarie dall’autore – finiscono per essere troppe e nessuna davvero predominante. Avviene così quelli che erano i paradigmi dello sviluppo educativo sembrano pressoché dissolversi nella metafora della ‘modernità liquida’ coniata da Zigmunt Bauman, entrata nel linguaggio comune per descrivere la modernità decontestualizzata nella quale viviamo. Detto ciò, pur nel “L’incostanza e la contraddittorietà educativa, quando educare significava tutto e il contrario di tutto”, lo psicologo Andreoli passa a “Il contesto educativo del tempo presente” e al “Futuro dell’educazione”.
Con ciò toccando tematiche scottanti come la ‘bellezza’, il ‘sesso’, il ‘comportamento ambientale’, la ‘biologia’ della mente umana, la voglia di ‘successo’, il passare inesorabile del ‘tempo’, mettendo un punto fermo sulla ‘fragilità’ distinguendo, nel contesto culturale - filosofico a cui la mente umana pur fa riferimento, in ogni sua forma di ‘credo’, in religione come in politica, a conferma del proprio status sociale ed economico. Nonostante non è a quello ‘status’ che si riferisce Andreoli nel suo libro, bensì al disagio psicologico apparso già in fase adolescenziale che ha preso il sopravvento e si è instaurato nella conduzione ‘mascherata’ della quotidianità a livello autoreferenziale e individualista, dal quale dipendono molte delle ribellioni sistematiche e talvolta improvvise cui assistiamo. Senza tuttavia trovare la capacità di ‘orientarci’ all’interno del macrocosmo globalizzato che ci gira attorno.
Un caso? Il capitolo in risposta a questa domanda, relegato alla fine del libro, si avvale di un esempio noto, già elaborato da Andreoli nel suo “La norma e la scelta” del 1984 (Mondadori). Libro in cui l’autore riafferma un suo convincimento: “..riferendomi al tema dell’educazione, intesa nel suo legame con il contesto sociale, il caso si presenta come un disturbo, un imprevisto, come se qualche cosa si frapponesse a un corso preciso e programmato”, dell’evoluzione sociale e umana – aggiungo io che scrivo – che segna un arretramento accertato, successivo all’evento della globalizzazione, perché incapace di accogliere (mancanza di entropia) tutte le istanze metamorfiche di una secolarizzazione che continua a rimanere distinta all’interno delle tradizioni, degli archetipi fondanti l’inconscio collettivo, della diversità cognitiva delle etnie che abitano la terra.
Acciò il ‘caso’ (contraddittorio) ha sostituito il ‘tempo’ (compatibile), conseguente all’evoluzione della propria esperienza/certezza conoscitiva che sarebbe dovuta sfociare in ciò che ha nome ‘futuro’ e che al contrario, se abbandonato al ‘caso’ diventa ambiguo, discorde e quantomeno incerto. “Del resto il caso caratterizza anche gli eventi sociali e non solo quelli che dipendono dall’uomo, ma persino quelli legati alla natura, che può sconvolgere una società con una catastrofe come un’alluvione o un terremoto” – scrive ancora Andreoli – consapevole che con la fine del ‘tempo’ si perde la considerazione della fine, in cui anche la ‘morte esistenziale’ è ormai dimenticata.
Trattasi di una vera e propria spogliazione biologica che non ha più niente a che vedere con l’affermazione dell’io o addirittura del noi poiché altri si occuperanno delle pratiche, un tempo rituali, che accompagnano la cessazione delle funzioni cerebrali specifica di una condizione permanente irreversibile. Quasi una rispettosa ‘ambiguità’ in cui la precedente condizione di ‘vita’ (relativa), era considerata un ‘sistema’ di riferimento per la famiglia quanto per la comunità civile e religiosa di appartenenza. Da un punto di vista spazio-temporale, oggi le nuove generazioni fanno appello piuttosto a una condizione di ‘infinito’ per cui “..la morte non esisterebbe in quanto fine di tutto poiché l’universo non perde comunque le proprie funzioni”, indi perciò ne risulta confermata la sua condizione di ‘relativa’.
Pertanto “può sembrare un ossimoro, dopo aver posto l’Io, la singolarità, al centro del processo di apprendimento in quanto misura del mondo (di tutte le cose), parlare di Noi e della necessità di giungere a un’unità fatta da molti Io”. Quasi a conferma d’una mediocrità accettabile e accettata ormai da tutti, quanti percorrono la strada in discesa e si astengono nella ‘non scelta’ d’un proprio camminare in avanti, quasi abbiano davvero ‘paura’ della strada in salita.
Ma quale colpa possiamo addebitare loro se i migliori fra gli studiosi non fanno che dipingere di nero il futuro che li/ci aspetta? Fromm come Nietzsche, Andreoli come Bauman, Odiffredi come Galimberti, Rella come Rodotà, ognuno a suo modo, descrive questa vita come una ‘vita di scarto’, senza futuro e che forse, se non corriamo ai ripari (e dobbiamo farlo in fretta), ‘non possiamo più permetterci’ (Bauman). Il ‘caso’ dunque sembra essere la misura del ‘tempo’ che ci è stato concesso. Come “..un personaggio imprevisto che entra in scena all’improvviso per scombinare la sequenza di una storia (..) che non tiene conto dell’imprevisto/imprevedibile sostanza di cui è fatto l’uomo”: di quella forza innaturata che lo sostiene nella sopravvivenza.
“Quanti poeti ce lo hanno raccomandato nei loro versi. (..) Del resto sempre si parla del ‘destino’ che certo non ha una scadenza precisa nel suo manifestarsi e (..) il ‘caso’ pone su due binari diversi il procedere dell’esistenza, tanto da poter separare chi viaggia senza meta da chi invece ha un itinerario con fermate e incontri casuali, (..) e si finisce per perdersi, perché attribuendo all’ignoto ciò che capita (per caso), l’accaduto può assumere qualsiasi senso”.
Ma c’è un altro aspetto. C’è sempre il rovescio d’ogni medaglia, rappresentato dal tentativo umano (filosofico) di ingabbiare il ‘caso’ di razionalizzarlo, di renderlo prevedibile … dipende solo da noi! “Potrei continuare, ma sono certo che i miei interrogativi alla fine riportano tutti alla fragilità, e quindi ad un’unica domanda: non abbiamo forse dimenticato (troppo in fretta) di essere fragili, che la nostra condizione umana è fatta anche della fragilità che abbiamo voluto nascondere inseguendo forza e successo?”.
Mi fermo qui, in ragione di un andare oltre e molto più lontano di quanto è contenuto in questo saggio che pure si lascia leggere come un qualsiasi libro d’avventura e che tutti dovrebbero far proprio in quanto vademecum d’una realtà educazionale della società attuale, che consiglio a quanti: genitori, pedagoghi, insegnanti, esercitano la materia di precettori di vita cui non possiamo né dobbiamo rinunciare, ne vale la continuità della nostra specie: “Mi auguro che si delinei un (nuovo) umanesimo della fragilità che da qui, e solo da qui, rinasca una politica, rinascano i bisogni esistenziali dell’uomo e della convivenza tra gli uomini. (..) Ho iniziato a scrivere queste pagine per dare un senso all’educazione, per salvare questa parola dall’oblio e dalla banalità (incredulità, mancanza di fede ecc.). E ho sognato che l’educazione, che oggi mi appare impossibile, possa diventare possibile.”
Vittorino Andreoli è uno dei maggiori psichiatri italiani, riconosciuto a livello mondiale. Le sue ultime opere saggistiche uscite per l’Editore Rizzoli sono: “La fatica di crescere” (2009); “Le nostre paure” (“010); “Il denaro in testa” (2011); “L’uomo di superficie” (2012) e “I segreti della mente” (2013) e moltissimi altri su argomenti specifici.
*
 - Psicologia
- Psicologia
‘Bla, bla, bla’, (.. in cerca di meccanismi di fuga.)
‘Bla, bla, bla’, (.. in cerca di meccanismi di fuga.)
I can see the whole room...and there’s nobody in it!, e quando ho provato a cercare me stesso, non ho trovato nessuno. Secondo l’ironia del banale di cui mi accingo a scrivere, preludere a una specifica affermazione può essere un modo, uno dei tanti, per eludere la realtà e dare libero sfogo all’immaginazione che, nel modo più assoluto, non vuol dire annaspare nel vuoto per cercare quello che non c’è. Bensì indagare nello spazio che improvviso s’apre tutt’intorno, in cui il ‘tutto’ si rifrange e si moltiplica come in un caleidoscopio in cui forme e colori aspettano che la luce li sorprenda e li magnifichi per incominciare a scomporsi e ricomporsi tra loro, per accingersi per così dire a ‘vivere’, nella pur vana realtà che li accoglie. Un po’ come le note musicali libere di ‘danzare’ nel cosmico insieme dei suoni che non è ancora consonanza, accordo, sintonia, nell’attesa di un divenire che le fissi sul pentagramma e che le trasformi in ‘melodia’. O forse, come le immagini di un fumetto che il guizzo grafico di un disegnatore fa ‘animare’ nello spazio solo apparentemente vuoto della pagina in bianco e che, per chissà quale magica ragione, prendono a esistere pur nella leggerezza dello spazio che è loro concesso, così come nella dissolvenza dell’immaginario, o come fanno i sogni nella realtà del presente e dell’addivenire.
Non da meno è l’agglomerato delle parole, la diversità degli accenti e delle inflessioni che compongono gli altrettanti fono-simboli imitativi dei nostri gesti casuali, entrati nel nostro comune parlare, per cui sbam! diventa sinonimo di una porta che sbatte, brrr! di un inarrestabile brivido di freddo, gulp! di oh che mi succede, etciù! di uno sternuto, roarrr! d’una sgommata d’auto, bratatata! di una raffica di mitraglia, whaam! d’una esplosione. Per non dire delle pause, delle soste, delle sospensioni, degli intervalli vincolati alle parole, ai pur brevi o lunghi silenzi, anche detti “vuoti” o “bianchi” che, con i “neri”, sono parte compositiva integrante di una qualunque immagine fumettistica. Spazi tuttavia colmi di significati onde i “bianchi” stanno a rappresentare ad esempio ‘pause diurne’, ‘pieno giorno’, oppure ‘mancanza di memoria’, ‘svenimento’; mentre i “neri” sono l’essenza stessa del ‘buio’ e di tutto quanto in esso può accadere e che chiedono di essere interpretati come spazi “in ombra”, quando non addirittura come “tenebra” o anche “morte”, a seconda dei casi. Pochi sono coloro capaci di osservare nell’ombra, quasi nulli quelli che lo sanno fare nel buio totale, soprattutto se per ‘osservare’ s’intende ‘vedere alla luce dei ricordi’, ‘nel buio dei sogni’, o magari ‘nei meandri della psiche’. Allora guardare l’intero spazio della stanza e non trovarvi nessuno risponde più a un’incertezza che alla realtà, una ‘defiance’ piuttosto che un mancamento psichico. Certo, in quel frangente di tempo poteva non esserci nessuno, per così dire ‘in corpo’, ma quanto rimane di una precedente presenza non è facile ponderare.
Pensiamo all’olfatto capace di catturare l’odore, il profumo, l’aria che si consuma al solo respirare, il suo rarefarsi a seconda delle emozioni, dell’acidità del sudore della pelle, del respirare sessualità, animalità, piacevolezza, o anche paura, spavento, sgomento, angoscia. Pensiamo all’ombra, che per un istante ha oscurato la luce di un angolo, il ridosso di una parete, o di un’impronta bagnata di pioggia che ha calpestato una mattonella del pavimento, il marmo del gradino di una scala, la soglia di un vano di un appartamento, di quella stanza dove non abbiamo trovato nessuno. Pensiamo alla polvere che si deposita ovunque e che è sottratta da un qualsiasi oggetto che occupa quel certo spazio, che ne rivela, sebbene indefinitamente, la forma, quella superficie verosimilmente vuota che pure ha la dimensione della sua grandezza, della capienza di un qualcosa che ignoriamo, e che era lì, per un periodo che non siamo in grado di misurare. O forse sì, ma la cui durata non ci dice nulla della sua struttura, delle fattezze estetiche dell’oggetto, quasi che la polvere abbia colmato il vuoto del nostro ‘immaginare’ senza ormai distanza e senza ‘durata’ di tempo, l’intervallo tra il suo essere e il suo divenire.
Tutto è sempre stato qui, presente nel presente, veritiero nell’irrealtà dell’inattendibile, dell’improbabile, dell’incredibile che la mente, profanatrice di labirinti, continua a mettere in relazione coi sogni, coi dubbi, con le fenditure del tempo, per trasferirli in possibili scenari ‘altri’ come nuove situazioni, circostanze, condizioni, e anche come trame, soggetti, fondali, altri paesaggi e nuove visuali. In un certo senso, in quegli interstizi della psiche umana che solo l’immaginario riesce a penetrare, e che trovano posto nell’arcano, nell’occulto, nel paranormale, nell’addivenire soggettivo e trascendentale della natura ‘umana’ dell’individuo. In quanto atto di liberalità all’inizio della ragione, ogni mutamento dell’ordine costituito è una forma di rivoluzione che altera lo status quo dell’armonia naturale propria dell’individuo che, prima ancora di doversi riconoscere dentro il presente, il passato o il futuro della sua natura indifferenziata, stabilisce il proprio legame con l’infinito, egli ‘è’ o io ‘sono’. Quello stesso infinito contenitore del ‘tutto’ cui l’individuo attinge nella sua costante ricerca dell’ordine cosmico, della catarsi rigenerativa, della propria germinazione conoscitiva, all’interno di una natura che pure non comprende appieno.
Dacché lo scaturire incessante delle fantasie, degli squilibri sessuali, degli incubi notturni, del flusso ricorrente dei sogni, delle angosce e delle paure che oscurano la psiche umana. Indi per cui le barriere edificate a sostegno di quella integrità costituita (società, religione, democrazia, affetti) cui la ‘ragione’ pure tiene legata l’individualità cosciente di poter scegliere e che, tuttavia, non sceglie, che di per sé esclude la disobbedienza come atto liberatorio dai meccani(ci)smi temporanei di fuga. Tuttavia, l’armonia costituita dal ‘tutto’ non permette la sua disintegrazione. Per quanto l'individuo faccia per assecondare ‘moto proprio’ la spogliazione del suolo terrestre, le guerre fratricide, le esplosioni nucleari, ecc., mettendo in atto lo svuotamento sistematico degli elementi costitutivi della natura cosmica (acqua, aria, terra, fuoco), la natura fisica (umana, animale e vegetale); quella simbolico - esoterica (visibile e invisibile), e quella spirituale (culto, religione, fede), riproponendo ogni volta le ragioni/scusanti della sua ‘caduta’ ancestrale, quasi egli non abbia mai smesso di cadere.
Acciò imparare a ‘volare’ può essere una forma di sollevamento dalla propria fisicità congiunta al terreno e, al tempo stesso di straniamento dalla materia terrestre. Mentre ‘volare alto’ è significativo della volontà di superare se stessi nella conoscenza dell’ ‘altissimo’ e del ‘profondo’ della psiche; se non addirittura, di entrare nello spazio invisibile della non-materia, e avere accesso alla realtà astratta dello spirito. Il rischio è comunque quello di “..entrare nella stanza e non trovare nessuno” perché l’irrazionalità umana, basata sulla ‘indegnità’ che l’individuo si porta dentro, concede solo una funzione di tipo immaginativo, cioè creativa di ‘immagini’ in quanto simboli, rappresentazioni, metafore, tropi, allegorie, cornici, scenografie che finiscono per essere innumerevoli ‘vuoti’ che vanno riempiti di altrettanti significati, modelli, pensieri, concetti e interrogativi a cui prima o poi bisogna rispondere. Contrariamente invece, certi ‘pieni’ pre-costituiti danno forma oggi a una parte ‘incoercibile’ della natura umana, rappresentata da impulso distruttivo, che va dalla brama di potere, alla tendenza violenta, all’intolleranza e al razzismo; dal desiderio di gloria, al godimento del piacere sessuale; dal sadismo al masochismo, alla paura della sessualità, dando forma così a un agglomerato di altrettante aspirazioni e rispettive angosce, significative di empi impulsi individuali, del mancato rapporto con gli altri, con il mondo esterno e, il bisogno di evitare la disintegrazione mentale, nonché la sempre crescente solitudine.
“Sentirsi completamente soli e isolati conduce alla disintegrazione mentale proprio come l’inedia fisica conduce alla morte. (..) Questo essere in rapporto con gli altri non si identifica con il solo contatto fisico. Un individuo può essere solo in senso fisico e tuttavia può essere in rapporto con idee, valori o almeno modelli sociali che gli danno un sentimento di comunione e di ‘appartenenza’. D’altro canto può vivere in mezzo alla gente, e tuttavia essere sopraffatto da un totale sentimento di isolamento, il cui risultato, se supera un certo limite, è lo stato di follia rappresentato da disturbi schizofrenici. (..) Il genere di relazione con il mondo può essere nobile o meschino, ma anche l’essere in rapporto con il modello più basso è immensamente preferibile all’essere soli. (..) Possiamo chiamare solitudine morale questa mancanza di rapporto con i valori, simboli, modelli, e affermare che il rapporto spirituale col mondo può assumere molte forme. (..) La religione e il nazionalismo, come tutte le consuetudini e le fedi, per quanto assurde e degradanti possano essere, purché colleghino l’individuo agli altri sono rifugi, (uno dei meccanismi di fuga), per proteggersi da quello che l’uomo paventa di più, il suo isolamento”. Così, Erich Fromm in “Fuga dalla libertà” – Edizioni La Comunità 1978.
Tuttavia non sono poi così convinto che il ‘relazionarsi con gli altri’ offra un modello di soluzione ai problemi qui sollevati, perché gli ‘altri’ hanno maturato già di per sé ulteriori meccanismi di fuga per contrastare l’effetto ‘High Wind’ dal quale spesso si lasciano trascinare, solertemente e dolentemente, a causa di un disaccordo educativo che li spinge all’ozio, come di un cane che per passatempo si morda la coda. Ecco che allora lo spioncino o l’oblò (non fa differenza) da cui osserviamo si rivela un caleidoscopio puntato nel vuoto che, secondo l’ironia del banale di cui sto scrivendo, null’altro può che ripetere l’immagine riflessa di ciò che è dato vedere: “I can see the whole room...and there’s nobody in it! Dove, quandanche provassi a cercare me stesso, non troverei nessuno”.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etno 12 ’Musica Celtica’ parte II
‘L’eco celtica nella musica contemporanea’.
Che i Celti esistano ancora, o almeno esista una ‘differenza celtica’ nell’area della loro massima espansione che va dalla Bretagna alla Cornovaglia, dall’Irlanda al Galles alla Scozia, fino alle Ebridi è provato dall’adattamento al territorio che questo popolo, conosciuto come “il popolo che venne dal buio” ha maturato nei secoli, addensandosi nelle cupe foreste che ricoprivano gran parte del continente: dalle vaste pianure nebbiose attraversate da grandi fiumi, alle brumose e fredde coste settentrionali. Un popolo di cui scrissero Platone, Strabone e Diodoro Siculo, raccogliendo notizie e stupori che già allora circolavano nel mondo ellenizzato: “..del loro furore guerresco e della loro infantile passione per gli ornamenti, i monili e le vesti sgargianti; (..) nonché dell’esistenza di poeti lirici detti ‘bardi’ che solevano cantare panegirici e satire; e di filosofi e teologi cosiddetti ‘druidi’ che tutt’oggi continuano ad accendere passioni. (..) Ne descrissero i lunghi banchetti su pelli di cane o di lupo distesi accanto ai camini nelle capanne; e nelle campagne vicino ai fuochi, dove ardevano grandi fuochi sotto ai calderoni o sfrigolavano sugli spiedi grossi pezzi di porco tra cui sarebbe stata scelta, la ‘porzione’ per l’Eroe’, per onorare il più valoroso tra i convitati. (G. Herm in bibliografia)
Indubbiamente più interessante è per noi quanto riferito nel “De bello gallico”, in cui Giulio Cesare annovera l’estendersi dei regni dei Celti dai Carpazi alle Isole Britanniche e oltre; fin dove ancora oggi, innumerevoli luoghi mantengono i nomi originari di derivazione celtica e gaelica. A conferma che lo ‘spirito celtico’ sopravvive, generazione dopo generazione, nella memoria e nell’uso dell’antica convivialità, così come nelle tradizioni ‘orali’ che ne hanno permessa la conservazione e la trasmissione: come la lingua e le lunghe narrazioni, la musica e gli strumenti tipici che ancora oggi continuano ad accendere passioni.
Una ‘letteratura’ che contrassegna il retaggio di commistioni arcaiche e del cristianesimo medievale, in cui la fantasia fiabesca dei Celti “..si compiacque allora di seguire per fosche boscaglie e acquitrini, in rudi castelli e a festosi conviti”, le più antiche leggende gallesi del ‘Mabinogion’, le favolose imprese di ‘Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda’ e la saga irlandese di ‘Cu-Chulainn’; così come la poesia epica e trovadorica, il calore dei canti popolari e le danze scatenate che hanno conservato un fascino vivissimo che risuona ancora di antico vigore.
“The Celts” by Enya
Hi-ri, Hi-ro, Hi-ri.
Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ho ra.
Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ha ra.
Hi-ri, Hi-ra, Hi-ri.
Saol na saol,
Tus go deireadh.
Ta muid beo
Go deo.
Saol na saol,
Tus go deireadh.
Ta muid beo
Go deo.
Hi-ri, Hi-ra, Hi-ri,
Hoireann is O, ho hi, ra ha, ra ha ra.
Hi-ri, Hi-ro, Hi-ri.
“Per sempre / Iniziando dalla fine / Noi siamo vivi / Per sempre”: dicono i versi di questa canzone in lingua gaelica interpretata da Enya che ha il grande merito di aver contribuito a riportare in auge la musica celtica, seppure servendosi dei mezzi di comunicazione di massa e delle nuove tecnologie a disposizione, e nella forma musicale certamente più commissionata, quasi ibrida, se non che ancora capace di suggestionare l’ascoltatore avvolgendolo di quello ‘spirito celtico’ misterioso che sembra provenire dal lontano passato, mentre si tratta invece del ‘respiro musicale del nostro presente’. Questa, se può rendere l’idea, è la forza intrinseca di questa musica che ci permette oggi di comprendere dove la ‘differenza celtica’ si annida; cioè nel suo costante fare riferimento a una concezione del mondo costruita ad immagine e specchio del destino dell’uomo e sulla sua determinazione nel realizzarlo: “I Celti non hanno mai creduto nella materia, bensì nelle differenti manifestazioni e concretizzazioni di forze astratte, spirituali, considerando il mondo una delle tante manifestazioni del Cosmo”. (Jean Markale in biblio)
Tutto questo accade certamente qualche tempo fa in Irlanda (territorio celtico elettivo) e dintorni, mentre tuttora sussistono, leggende più antiche e nobili che tramandano l’esistenza di terre inafferrabili e incontaminate, esistite “al di là dei luoghi dove tramonta il sole”. Oltre a quella ‘Lyonesse’, che la fantasia dei marinai e dei poeti ha chiamato con nomi diversi: ‘Mag Mell’ (pianura del piacere), ‘Tir Nam Beo’ (terra della vita) e ‘Tir Nam Nog’ (terra dell’eterna giovinezza), sono conosciute ‘Avalon’ e ‘Lethosow’, ‘Cu Curlain’ e altre di mitica memoria. Terre queste scelte a dimora dagli dèi dei Celti che dominano il fato, abitate da una schiera di strane creature, quali Elfi, Fate, Folletti, Spiriti dell’acqua e della vegetazione come esseri magici dai nomi bizzarri e dal carattere burlesco. Tuttavia la tradizione orale parla anche di crude storie quotidiane, di malattie e sofferenze, di guerre e sopraffazioni straniere, di carestie e fame che per secoli, così lunghi da sembrare eterni, hanno dilaniato queste terre, soprattutto l’Irlanda fino ai giorni nostri.
All’Irlanda rimanda infatti l’immagine onirica di una comunità agricola suddivisa in una miriade di principati relativamente indipendenti, in cui la cultura orale risente della disseminazione in tante piccole ‘isole narrative’ in cui spesso accade che le stesse leggende siano la reinterpretazione di altre più antiche, narrate in modo diverso e verosimilmente accresciute dalla creatività di questa o quella fazione popolare, ora in Scozia come in Bretagna, ora nel Galles che in Cornovaglia. Sì da doverle conoscere tutte per poter raccapezzarci e rintracciarne il ‘corpus’ originario di questa o di quella saga e, comunque, perdersi in mille rivoli narrativi come dentro una selva. Tuttavia non essendo questo il tema della ricerca qui avviata, per lo più di genere etno-musicologica, (ed è improbabile ci riesca), mi sono affidato ad alcune figure ‘mitiche’ che ‘ab illo tempore’ e più di altre hanno rappresentato specifiche attività culturali, all’interno della miriade d’informazioni raccolte in libri diversi, citati in ‘bibliografia di consultazione’.
Tutte le informazioni del caso riconducono ad un'unica realtà oggettiva che sposta l’interesse scaturito dalla leggenda a quelle che sono le scoperte archeologiche di riferimento a quella ‘Lyonesse’ da cui ha preso il via la ricerca sulla musica celtica cui i mitici ‘bardi’, tra nuovi compositori, musicisti, esecutori vocali ecc., hanno dedicato il loro lavoro e la loro creatività. La necessità di ancoraggio ad un evento ‘mitico’ si inserisce in quella che è poi all’occorrenza l’esigenza culturale/spirituale dell’essere umano all’interno di ogni popolazione, onde lasciarsi travolgere dal soprannaturale quale fonte di ispirazione e trascendenza. Soprattutto in presenza di qualcosa, oggettivamente esistente, che ne riveli la fondatezza, sulla quale edifica la propria ragione di esistere e possibilmente innestarvi le proprie radici. Quale occasione migliore quindi di rinverdire le tradizioni popolari e risvegliare gli animi su una ‘leggenda’ popolare come quella di Lyonesse?
L’occasione ci è offerta dall’archeologia subacquea e dalla scoperta, nelle profondità della Baia di Douarnenez, di alcuni resti attribuibili alla città sommersa di ‘Ker-Is’. Benché non esistano prove di un’alluvione di vaste dimensioni avvenuta in quei tempi in area celtica, può darsi che maree eccezionalmente alte, come quelle del 1953 nella costa orientale inglese, abbiano provocato un disastro locale. È possibile che, quando i monaci dell’Abbazia di Mont Saint-Michel, in Bretagna, fondarono in Cornovaglia la casa figlia di St Michael’s Mount, abbiano portato con sé la storia dell’inondazione. I discendenti dimenticarono il luogo esatto della catastrofe e lo collocarono dove esistevano le possibili prove della sua esistenza. Riguardo all’epoca dell’accadimento, si è scelta quella più verosimilmente vicina alla tradizione eroica dei Celti e, conseguentemente, quella epica di Re Artù ,ei quali si narravano gesta strabilianti.
“Il monopolio delle attività intellettuali era affidato principalmente al ‘druido’, consigliere del re, mago, sacerdote e spesso letterato e giurista, oltre che ai ‘filid’ poeti aristocratici, membri della classe sacerdotale e depositari dei cicli epici che costituiscono la memoria della razza celtica. Alla base di questa gerarchia intellettuale erano i ‘bardi’, poeti-cantori di estrazione popolare che sostituirono a poco a poco l’astro in declino dei ‘druidi’ e diventarono figure esemplari della vita irlandese, incarnazione vivente di una cultura orale arcaica e contadina. L’opera capillare dei bardi e dei monaci cristiani servì ben presto a trasformare l’ “isola verde” in una roccaforte della cultura (evangelizzata), dove studiosi in esilio provenienti da tutta Europa poterono trovare rifugio, e dove fu creata, intorno al 1300, una delle civiltà culturali e spirituali più fiorenti. (..) I monasteri, veri centri propulsori del sapere, patrimonio di tradizioni e di tecniche specifiche, miniando i Libri Sacri, riscoprivano l’avviluppata, rabescata e un po’ ebbra tradizione decorativa di un arte raffinata imperniata sulla riproduzione di manoscritti antichi, mentre ancora nel medioevo “i monaci irlandesi raggiungevano il continente e rischiavano di conferire una definitiva patina celtica al cristianesimo europeo” (P.Joannon in biblio).
A tal proposito - scrive Serafino Riva (in biblio) - “Non c’è nulla che eguagli la capacità di evasione dal reale nella loro arte quanto la loro forte presa nella realtà quando decidono di rimanervi aggrappati”. Questa, che potrebbe sembrare una contraddizioni in termini, di fatto, rappresenta l’ostinata volontà popolare celtica di mantenere una propria distinta individualità: “Tutta la spiritualità celtica è racchiusa in questa singolare convivenza di elementi assolutamente fantastici e crudamente realistici, e tutta la cultura celtica trae alimento da questa convivenza tra la trasfigurazione letteraria del quotidiano e l’immaginazione impregnata di realtà. Immaginazione e realtà sono i termini di una cultura nella quale i linguaggi specifici dell’arte e della vita, entrano in contatto senza creare fratture o dualismi”. (ibid.)
Del resto, se è vero che la cultura conserva il sapore dei luoghi fisici dove è stata prodotta, la cultura musicale e poetica irlandese non poteva che sapere di terra. In realtà luoghi specifici deputati alla cultura non sono mai esistiti in Irlanda, la poesia e l’estro musicali nascevano nel grande locale destinato alla cottura del pane, nelle aie e sui campi dove le canzoni scandivano il ritmo del lavoro e il tempo dello spirito.
Se vogliamo, è questa la conferma della fatale parabola che ha salvato lo ‘spirito celtico’ dallo schiacciamento della storia che in certo qual modo vede negare ogni valore ai vinti. Se i Celti sopravvivono ancora oggi è perché il loro ‘spirito’, la loro ‘cultura’ rimangono ad impregnare l’area che essi hanno dominato e, le cui tracce, sono riconoscibili in ogni manifestazione del loro pensiero, così come nei riti, nelle superstizioni e nella creativa fantasia delle loro favole e saghe, nelle ballate e nella musica che accompagnava e accompagna in ogni ‘pub’ che si rispetti, le loro sere e e le manifestazioni più autentiche dell’intrattenimento.
“Ciò che ci stimola a guardarci d’attorno, indicandoci i modi per riconoscerci fra di noi, nell’Occidente che fu celtico, la persistenza della nostra civiltà”, è una frase entrata di forza a far parte del credo celtico, a testimonianza non un semplice indirizzo culturale che bensì ha condizionato in modo costante, seppure discontinuo, l’insieme della civiltà occidentale e continua a farlo allo stesso modo che in passato, nella nostra civiltà contemporanea, industrializzata e tecnologizzata, orientata verso il futuro. Ed è qui, nell’ormai nota leggenda celtica riferita a ‘Ker Ys’ e alla buona strega Dahut, di cui ho narrato nel capitolo precedente, che pure si cela una determinata realtà attorno alla “terra perduta dove oggi si stende solo il burrascoso mare” di Lyonesse (Lethosow, Avalon ecc.), che vanno ricercate le origini del ‘revival’ che anni fa ha interessato la musica celtica.
In quanto fenomeno articolato e complesso che, partendo dall’Irlanda attraverso il la Bretagna e il Galles, su fino all’England e alla Scozia, ha interessato i pubblici di tutto il mondo con una vitalità che ha pochi precedenti nella storia della musica popolare, riconduce a leggende in parte dimenticate che pure narrano di altre storie, ed altre, tantissime ancora. Ma significherebbe qui capovolgere il nostro intento di ricerca di un contesto musicale di cui è profondamente impregnato il ‘sentimento celtico’, simbolicamente legato al mito pseudo - cristiano della resurrezione.
“Celtic Legend” by Alan Stivell
O Lyonesse, be stronger now
The Winds of Change have come for thee
To wander hence but still return
From darkest waters of the Sea
O Lyonesse
Although the waves have come for thee
You will return to wander hence
With tears of salt to fill the Sea
The Sea. The Sea
The waters came from the darkness (waters)
The waters came from the darkness (waters)
Through endless days that turn to night
O Lyonesse, I'll wait for thee
Though I may be asleep in dust
My spirit lives beneath the Sea
The Sea. The Sea
The waters came from the darkness (waters)
The waters came from the darkness (waters)
The Sea. The Sea
O Lyonesse, devi essere più forte ora / I venti del cambiamento sono venuti per te / A vagare da qui, e ancora tornare / Da più buie acque del tuo Mare.
O Lyonesse, / Anche se le onde sono venutieper te / Si tornerà a vagare da qui / Con le lacrime di sale per riempire il mare.
Il Mare. Il Mare
Le acque provenivano dalle tenebre (acque) / Le acque provenivano dalle tenebre (acque)
Attraverso interminabili giorni che volgono a notte.
O Lyonesse, aspetterò per te / Anche se dovessi addormentarmi nella polvere / Il mio spirito vivrà sotto il tuo mare
Il Mare. Il Mare
Le acque provenivano dalle tenebre (acque) / Le acque provenivano dalle tenebre (acque)
Il Mare. Il Mare.
“Se le religioni astrali per mezzo delle stelle e forse con il loro aiuto si aspettano una vita ultraterrena, i popoli delle steppe sperano di vedere dietro le nuvole un cielo splendente e infine un ritorno nel grembo della Grande Madre. (..) Il fatto che le ‘matres’ celtiche sempre appaiono in triplice aspetto, dimostra la loro forza. Non sono realmente tre, ma una sola; è sempre l’unica e sola Grande Madre (Morigan). Quasi tutte le religioni la chiamano così o in maniera simile, in ogni caso sempre con un’espressione che indica forza, (..) amministra sia la morte che la vita, anche per questo porta in grembo ceste di frutta, talvolta cornucopie, simbolo di fertilità e rinascenza”. (M. Riemschneider op.cit.). È così, che quasi per incanto, si rende possibile recuperare alla fantasia, le molte melodie ascritte ad alcune leggende come quella che abbiamo appreso di ‘Ker Ys’ e della ‘dama del lago’, di Dahut e Tristano e tante altre, narrate o meglio musicate e cantate dagli odierni ‘bardi’ della canzone celtica.
Ballate e canzoni intrise talvolta di un sapore aspro e incisivo che emerge dalla folta produzione letteraria dei crudi poemi guerreschi e dalle antichissime saghe, attestate alla prima produzione letteraria irlandese del ‘Craobh Ruadh’ (ramo rosso) e del ciclo detto di ‘Ulster’. A queste rudi produzioni si affiancano senza salti di livello capolavori di raffinata fantasia, come le numerose leggende su ‘Tir Na Nog’, la mitica terra della giovinezza le cui immortali delizie costituivano, al di là dal paradisiaco, una tentazione per gli uomini d’Irlanda. Per una cultura dell’‘utopia’ quale momento migliore per andare alla ricerca di un modo nuovo d’intendere una diversa immagine del passato? – mi chiedo. Forse, è proprio in ciò la risposta. Riscoprirne i contenuti, pur sull’onda dei tanti ‘revival’ che si susseguono al passo con le mode, nell’arte come in letteratura e in musica, significa rendere giustizia alla varietà delle scaturigini “da cui l’Europa ha succhiato il suo latte”.
Come altre volte mi è capitato di affermare parlando degli usi e costumi di alcuni popoli nomadi, a maggior ragione confermo che le testimonianze etniche riferibili ai Celti sono parte integrante della cultura europea. L’influenza celtica sull’architettura romanica (e non solo) è quanto di più evidente è possibile rinvenire nel cuore dell’Europa tutta, lì dove religione, civiltà, società, un tempo hanno rappresentato una medesima identità culturale. “Per restituire a questo popolo la collocazione che esso merita nella storia della civiltà occidentale, occorre indagare a fondo nelle tradizioni più lontane, sia antiche che medievali, senza perdere di vista la grande importanza dei miti fondamentali. Confrontando il mito e la storia, con l’ausilio anche degli strumenti messi a disposizione dall’analisi psicoanalitica, si giunge via via a riportare alla luce l’autentico aspetto di quell’élite guerriera e intellettuale che, prima dei Romani, seppe imporsi ai vari popoli occidentali e influì profondamente, nel Medioevo, sulle grandi scelte – religiose, filosofiche, morali, artistiche – dell’Occidente” – scrive ancora Jean Markale (op.cit.), straordinario studioso di ‘cose celtiche’.
Alan Stivell, di cui si tornerà a parlare, come un antico bardo medievale ci propone qui un’altra sua composizione in gaelico: “Ar Gelted Kozh” (I primi Celti) di cui esiste anche una traduzione in inglese comunque di difficile trasposizione in lingua italiana. Ciò mi permette di ribadire il fatto che ogni testo, sia esso cantato o recitato, ha un valore etico ed estetico a sé, quando è recepito nella lingua che lo ha concepito, vuoi per la musicalità intrinseca alla lingua, vuoi per la concettualità propria del pensiero del popolo che lo ha espresso.
“Ar Gelted Kozh” (Les Anciens Celtes) by Alan Stivell
Tril mil bloaz zo sur'walc'h, n'oa ket ur baradoz 'wid 'r Gelted kozh
Met tud aman oa 'heseo Demokrasiezh, araog an dud 'barzh Bro-Gres
'Wel barzh 'r'vro sen 'oa kentoc'h ur c'hlas o c'hoari 'n dra-se
Met tri mil bloaz 'zo dija, n'oa roue 'bet war hon douar
'Merc'hed oa par d'ar baotred, hag an douar 'oa d'an oll
Daou mil a pemp kant bloaz 'zo, Kultur ar Gelted kozh oa o fewa?
War lod brasa? an Europa, lorc'h 'bet hon eus o lar an dra-se
Met rheid eo gout 'oa ar Romaned tud gouez'n o c'hichen
War 'n dachenn filozofel, arzhel a' sokiel.
Hag 'wid 'lodenn diouzh 'skianto? ha diouzh an tekniko?
Skupet eo bet bed kozh ar Gelted ga' hin' ar Romaned
Kre?woc'h oa he, ya'hat, 'wid rhe?k ur stad a rhein un niverenn da bep den
'Brezel etre ar Gelted hag ar Romaned
'Zo bet ur brezel 'tre ar Stad o doue ha' gevredigezh tud
'Tre 'r bed karrezeg ha kaled leun a karrezed vihan
Hag ur bed ronn ha dourel leun a droellenno? hunvre ha follentez
Kollet eo bet ar brezel-se, 'wid ar mare.
(versione inglese)
Life was no paradise three thlousand years ago for the Celts of old
But before they spoke in Greece of democracy we had tried it out in practice,
Not just for those in the slave-owning class but for all men.
Three thousand years ago we bowed the knee to no king,
Women stood equal to their brothers and the land belonged to all.
Five hundred years went by, bloomed bright the free-sown flower of our culture
Across the boundaries of Europe, this no idle boast in our mouths :
When Romans ranged on the seven hills with packs of wolves
The Celts were known as philosophers, their arts and society
Blossomed around our ancient lore of science and craft.
Sweeping across the ancient Celtic world came the Romans,
Building their State on our bones, numbering each man as slaveowner or slave.
Not merely Roman and Celt were locked in struggle :
It was a battle of ideas between the supremacy of the State and the liberty of the individual,
On the one side a square cube of cube-shaped thoughts
Imprisoning a liquid world full of spiralling dreams and fantasy,
Which now has begun once more to break free.
Alan Stivell è indubbiamente colui che più di altri ha dato vita a questo fantastico revival, virtuoso a sua volta dell’arpa celtica (nome gaelico ‘cruit’), che di ‘uilleann pipe’ (cormanusa), dei quali fa uso in quasi tutte le sue composizioni con ingegno e maestria assoluta. Spesso questo recupero ‘nostalgico’ della tradizione e della lingua gaelica pecca di enfasi o di strumentalizzazione, ed anche a volte di un intellettualismo non certo populista, pur rimanendo uno dei più fertili e positivi metodi (romantici) dell’intera rinascenza letteraria irlandese ed europea cui abbiamo assistito: “La fantasia poetica – scrivono gli autori di ‘Musica Celtica’ (in biblo) da cui attingo la notifica – si focalizza come non mai intorno agli argomenti della vita sociale e nella storia irlandese: libertà, emigrazione, evoluzioni o involuzioni politiche, questi sono i temi della cultura sociale ottocentesca (ballata, musica strumentale ecc.); i toni vanno dall’asprezza delle canzoni che incitano alla rivolta, ad accenti d’ingenua speranza, come in questa ballata in voga a Dublino nei primi anni del secolo e che suona come una filastrocca infantile, citata da P. Joannon (op.cit.):
And will Ireland then be free?
Says the Shan Van Vocht:
Will Ireland then be free?
Say the Shan Van Vocht
Yes! Ireland shall be free,
from the centre to the sea;
Then hurrah for Liberty!
Says the Shan Van Vocht.
E l’Irlanda sarà poi libera?
Dice lo Shan Van Vocht:
L’Irlanda lo sarà poi?
Dice Shan Van Vocht
Sì! l’Irlandainfine sarà libera,
Dal centro al mare;
Allora hurrà per la Libertà!
Dice Shan Van Vocht.
D’altro canto le ballate possono assumere toni malinconici come questa bellissima canzone dedicata all'amore lontano.
“Lagan Love” tradizionale by Caroline Lavelle
Where Lagan streams sing lullabies
Through clouds of lilies fair
The half-light gleam is in his eyes
The night is on his hair
Like a love-sick lenashee
He has my heart to call
No life have I
No liberty
For his love is lord of all
And often when the late birdsong
Has lulled all the world to sleep
I will steal into my lover's arms
Our secrets there to keep
And on the cricket's singing stone
He'll make a drywood fire
And tell me then, sweet undertones
The song of my heart's desire.
Dove i ruscelli di Lagan cantano ninnananne / Attraverso nubi di gigli / Nel barlume acceso dei suoi occhi / E con la notte nei capelli / Come un usignolo ammalato d’amore / Lui userà il mio cuore per chiamare / Nessuna vita ho io / Nessuna libertà / Per il suo amore egli è signore di tutti / E spesso sul tardi quando con la sua canzone / Avrà cullato tutto il mondo per dormire / Io starò tra le braccia del mio innamorato / Tratterrò i nostri segreti / E sulla pietra dove solitamente il grillo canta / Lui farà un fuoco di legna secca / E mi canterà , con toni bassi dolci / La canzone che desidera il mio cuore.
È appurato che la lingua rimane uno degli strumenti più preziosi che un popolo ha a disposizione per conservare se stesso, e per l’Irlanda questo è doppiamente vero perché, se con la sua ‘rinascenza culturale’ da un lato ha avviato il recupero del proprio passato. È tuttavia proprio dell’aver conservata la sua lingua e la sua musica che ha potuto riappropriarsi di quello ‘spirito celtico’ che la distingue; per l’aver lasciata inalterata la grande varietà di sfumature fonetiche, toni e colori della musicalità, intrinseche del gaelico, ritenuta dai filologi (linguisti, lessicologi, glottologi) una delle lingue indoeuropee più antiche e complesse, talvolta avvicinata al sanscrito. Come si è constatato dalla lettura dei canti proposti, quella gaelica è una lingua estremamente complessa, ma d’altra parte proprio all’enorme quantità delle sue declinazioni e alla subordinazione della parola alla frase, essa deve una potenzialità poetica infinitamente superiore a quella di una lingua indeclinabile e invariabile come può essere l’inglese.
“In realtà a nessun irlandese verrebbe in mente di considerare il gaelico una lingua morta, da studio filologico, come per noi possono essere il greco antico o il latino. La cadenza stagionale ed impenetrabile, della vita contadina e la pratica costante della trasmissione orale della cultura hanno mantenuto vivo l’idioma gaelico sottraendolo all’inevitabile usura del tempo, seppure arricchendolo di sempre nuovi elementi; è per questo che oggi non è in fondo difficile rimuovere la patina del ‘disuso’ e restituire il gaelico ad una pratica pubblica e quotidiana che con lingue da museo, risulterebbe impossibile” (in ‘Musica Celtica’ op.cit.). I musicisti stessi dicono di trovare difficoltà a dare una definizione esatta di ciò che cantano in gaelico anche se esistono elementi di base molto importanti che riguardano una certa ‘melodia’ che essi seguono ad orecchio, quel certo ‘ritmo’ che suggerisce lo strumento, così come l’uso ripetitivo della frase, la struttura di un pezzo, messo in relazione al giro armonico e con lo ‘stile’ che pur varia di regione in regione e che li aiuta in questo senso.
I brani più recenti che si rifanno alla tradizione vengono accettati in quanto, come tali, devono risultare conformi alle caratteristiche sopra descritte che di diritto entrano a far parte del rinnovarsi della tradizione orale, permettendo in seguito di poter subire continui mutamenti, come del resto è capitato a quelli più antichi. I casi sono infiniti che quasi è impossibile fare degli esempi. Tant’è che molti ‘brani’ strumentali o cantati ripresi dalla tradizione sono oggi di dominio pubblico e ogni gruppo li interpreta a suo modo, con le variazioni che più gli aggradano, secondo le proprie capacità e volontà di interpreti, siano essi d’appartenenza al rock che al jazz, ed anche alle nuove tendenze strumentali analogiche o elettroniche. In ogni caso non va dimenticato che nel folklore vivo che si crea ogni sera nei pub, gli irlandesi suppliscono a questa apparente uniformità dei singoli pezzi con l’inventare sempre nuovi modi di accostarli l’uno all’altro, con salti armonici imprevedibili (talvolta virtuosistici), che finiscono per diventare una delle immagini più stupefacenti di una certa ‘creatività popolare’ che solo il ‘gruppo’ può realizzare, quando è in sintonia ovviamente, e lo è in ogni caso, quasi sempre.
Si è già parlato di strumentisti importanti nella trazione viva come l’‘arpa celtica’ (cruit), della ‘uilleann pipe’ (cornamusa), del violino, lo strumento ad arco per eccellenza usato d’accompagnamento alle danze che rappresentano di per sé un momento diversivo della tradizione celtica dal canto e dal fare musica insieme. L’occasione permette qui di introdurre solo alcuni dei gruppi e singoli interpreti che negli anni di maggior enfasi creativa hanno dato lustro alla ‘rinascenza’ della musica celtica con la riscoperta di antiche arie come romanze e ballate; nonché di canzoni ‘Carols’ e danze ‘Morris dance’ entrate a far parte del patrimonio musicale nazionale, che va oltre l’eco enfatica del revival. Inizio con l’introdurre una band storica di eccezionale bravura riconosciuta a livello mondiale, The Chieftains: un gruppo folk irlandese che deve il suo nome alla traduzione gaelica di Taoiseach, che significa Capo Clan, e in verità come band lo è stata a tutti gli effetti.
The Chieftains,
Paddy Moloney ‘uilleann piper’ che ha già suonato in diversi gruppi ed è alla ricerca di un nuovo approccio alla musica tradizionale irlandese che lo porti a suonare "una musica che non sia mai stata ascoltata", forma il gruppo The Chieftains nel 1963 insieme ad alcuni amici con cui già suonava nei Ceoltoiri Cualann di Seàn Ó Riada: ne fanno parte il violinista Martin Fay, il suonatore di tin whistles Seàn Potts, il flautista Mìcheàl Tubridy, e al bodhran David Fallon. Sempre in quell’anno pubblicano il loro primo disco omonimo; la copertina, come nei tre album successivi è disegnata da Edward Delaney. Paddy Moloney il leader del gruppo, è il principale compositore e arrangiatore dei brani in cui compaiono composizioni di grande levatura strumentale come ‘Turlough O'Carolan’, ‘Tristan and Isolde’, ‘Millenium Celtic Suite’, ‘He moved through the Fair’ ed altri. Negli anni successivi alcuni dei suoi componenti originari lasciarono il gruppo, sostituiti da nuovi ferventi esecutori che entrarono nella formazione, come il violinista Seàan Keane, l’arpista Derek Bell, il virtuoso flautista Matt Molloy, insieme al noto flautista classico James Galway che li ha affiancati in alcuni concerti e in occasione di registrazioni discografiche.
Nel 1970 il gruppo apre un concerto dei Fairport Convention al National Stadium di Dublino e, per la prima volta compaiono parti cantate, con la voce dell’allora diciassettenne Dolores Keane. Nel 1974 esce Chieftains 4, che presenta un tributo a Seàn Ó Riada (personaggio storico della musica irlandese) con il brano ‘Mneá na heÉreann’ una loro pietra miliare. Nel 1975 pubblicano Chieftains 5, disco che comporta alcune novità nell'uso di alcuni strumenti come il tiompan e l'approccio a musiche bretoni. È infatti l'anno della svolta, The Chieftains diventano un gruppo professionista, e il loro successo cresce grazie anche al contributo della colonna sonora del film ‘Barry Lyndon’ di Stanley Kubrick che vincerà un Oscar. Nel 1979 l'evento più importante dell'anno è la visita di papa Giovanni Paolo II in Irlanda, The Chieftains sono chiamati a suonare davanti a più di un milione di persone: suonano ‘Carolan's Welcome’ prima dell'arrivo del Papa e altri brani durante la messa. Nel 1983 aprono il concerto dei Rolling Stone allo Slane Castle di Dublino, suonano inoltre al Capitol Building a Washington e sulla Grande Muraglia cinese. Dello stesso anno è la colonna sonora del film canadese ‘The Grey Fox’ che viene premiata con un Genie. Nel 1986 sempre per il regista Philip Borsos incidono la colonna sonora del film ‘Ballad of the Irish Horse’, un documentario della National Geographic.
Nel 1987 pubblicano ‘Celtic Wedding’, un concept album che vuole ricreare le atmosfere e le musiche di un matrimonio bretone del XIV secolo: è il primo album che va alla ricerca delle radici della musica celtica nel mondo. Dello stesso anno è ‘In Ireland’, insieme al noto flautista classico James Galway. Nel 1990, dopo la caduta del muro di Berlino, The Chieftains partecipano al concerto di The Wall di Roger Waters, insieme ad altri ospiti come Sinead O'Connor, Van Morrison, Bryan Adams, Marianne Faithfull. Registrano inoltre la colonna sonora per il remake de ‘L'isola del tesoro’ con Charlton Heston e Oliver Reed. Nel 1991 escono ‘Over the Sea to the Skye’ tratto da alcuni concerti registrati a Brisbane con il flautista James Galway, ‘The Bells of Dublin’ e la raccolta di colonne sonore ‘Reel Music: the Film Scores’. Nel 1992 pubblicano ‘Another Country’ che esplora le connessioni tra la musica tradizionale irlandese e quella americana: folk, country e bluegras; e ‘An Irish Evening’, un live all'Opera House di Belfast con Roger Daltrey e Nanci Griffith, che vicerà un Grammy come miglior album folk.
Il 1993 è l’anno di ‘Celtic Harp’ con la Belfast Harp Orchestra, vincitore di un Grammy. Nel 1994 il gruppo partecipa al concerto per il venticinquesimo anniversario degli Who. Nel 1995 collaborano alla colonna sonora del film ‘Braveheart - Cuore impavido’ di Mel Gibson e pubblicano ‘The Long Black Veil’, uno dei loro maggiori successi, con guest stars come i Rolling Stones, Van Morrison, Marianne Faithfull, Mark Knopfler, Sinead O'Connor, Tom Jones, Sting e Ry Cooder. Nel 1996 esce ‘Santiago’, omaggio alla musica galiziana, album che vincerà un Grammy l'anno successivo. Nel 1999 pubblicano ‘Tears of Stone’ che immortala le migliori collaborazioni tra The Chieftans e voci femminili della portata di Joni Mitchell, Loreena McKennitt, Sinéad O'Connor. Nel 2000 esce ‘Water from the Well’, un ritorno ai brani tradizionali irlandesi che un critico ha definito: "un viaggio in lungo e in largo per l'isola d'Irlanda". Fino al 2002 i membri sono: Paddy Moloney (uilleann pipes, tin whistle, fisarmonica, bodhrán); Matt Molloy (flauto, tin whistle); Kevin Conneff (bodhrán, voce); Seán Keane (fiddle, tin whistle); Martin Fay (fiddle, bones & spoons); Derek Bell (arpa celtica, tastiere, oboe).
La ragione di questa singolare e pur breve biografia permette qui di individuare e raccogliere molti fra singoli interpreti e gruppi che con la loro personalità artistica, la loro esperienza e creatività hanno contribuito alla ‘rinascita’ musicale celtica e che, come si è detto, mescola esperienze inglesi, scozzesi e gallesi, nonché irlandesi di cui i Chieftains sono stati fautori indiscutibili e insuperati. Ma già altri si affacciano tra le righe appena lette ed hanno nomi altisonanti, alcuni dei quali non hanno neppure bisogno di una presentazione che sarebbe comunque riduttiva delle loro lunghe carriere fatte di ricerca, intenti, ripensamenti, successi e umane cadute, la cui storia comunque rimane straordinaria, è scritta ormai negli annali della musica o recuperabile nelle sue linee essenziali sul web. L’importanza di questa ricerca va però letta come indicativa per far conoscere i nomi da digitare sui motori di ricerca, i brani da ascoltare e/o visionare su Youtube, accrescere e intrattenere un ‘dialogo aperto’ con la musica, con quelli che sono stati i protagonisti di un’epoca d’oro della riscoperta, del revival, di quelle che in fondo sono le radici di tanta nostra conoscenza.
Alan Chochevelou Stivell,
figura mitica, a lui si deve tutto o quasi, di quanto avviene dell’apoteosi della musica celtica negli anni successivi. Come un antico ‘bardo’ Stivell è stato il portatore mondiale della tradizione della sua terra, la Bretagna, e del folklore celtico più in generale. Suona molti strumenti in modo virtuoso e spesso strabiliante, tra i quali arpa celtica, bag-pipe, flauto irlandese, bombarda. Facendo inoltre un uso del canto nella forma popolare medievale. Un’ampia apertura strumentale che permette a Stivell di creare accostamenti di forme arcaiche a canti medievali e ad altre decisamente moderne. Un modo di avvicinare la musica di ieri alla tecnologia di oggi in modo da ottenere un progressivo rapporto sonoro che rende la sua musica qualcosa di unica e irripetibile.
Durante l’intervista a me rilasciata in occasione del ‘Festival della musica celtica’ tenutosi a Roma nel 1980 a Villa Torlonia, si è così espresso: «Dopo aver contribuito ad accrescere l’interesse per la musica celtica, è mia volontà, senza andare troppo oltre quel tipo di musica, dirigere l’attenzione e di spingere un certo tipo di ricerca sulla musica bretone. Ma non soltanto sulla musica, quanto alla situazione storica passata e presente della mia terra d’origine.» E così è stato. Subito dopo, coerente con quanto detto, Stivell si è fatto promotore del movimento di solidarietà che vide irlandesi e bretoni insieme schierati a difesa della loro cultura autoctona, nel ricercare quelle che erano le radici etniche e musicologiche della sua musica, pur nel rispetto della tradizione popolare. È nella musica tradizionale che il ricercatore Stivell trova infatti negli anni successivi il suo pieno riscontro artistico.
Tuttavia la sua ‘Arte’ soprattutto, rimane legata al suono dello strumento che lo ha fatto conoscere fuori dei confini nazionali, l’arpa celtica cui egli ha dedicato la sua professionalità incontrastata con lo spirito del ricercatore di suoni e assonanze che quasi ‘celestiali’, tanto è riuscito a emettere dal suo strumento. Suoni che ancora oggi riempiono l’atmosfera di echi misteriosi e di suggestiva bellezza. Dopo alcuni album fortemente impregnati di ‘spirito celtico’ bretone e gallese: “Chemins de Terre” (1973); “E Langonnet” (1974), “Trema’n inis” (1976); “Journee a la Maison” (1978) e è con “Renaissance of the celtic arp” (1972) riproposto negli anni successivi e dedicato interamente a questo strumento, che include brani della tradizione irlandese e scozzese, che il successo di Stivell esplode in tutto il mondo in modo strabiliante: ‘YS’, ‘Marv Pontkalleg’, ‘Gaeltacht’ dedicato a Sean O’Riada, ‘Eliz Iza’ e alcuni estratti dal manoscritto per arpa ‘Penllyn’, che compongono l’album sono quanto di più rappresentativo esiste nella sua produzione. Il disco ottenne il Grand Prix International de l’Academie Charles Cros.
Successivamente sono apparsi “Synphonie Celtique” (1979), “The Mist of Avalon” (1991); “Brian Boru” (1995); “Terre de vivants” (1981); “Légende” (1983); “Explore” (2006); “Emerald” (2009). Un numero infinito di esecutori lo hanno accompagnato nelle sue avventurose sfide che Stivell ha lanciato alla musica con sue composizioni, arrangiamenti e svolte e scoperte musicali in giro per il mondo. Tanto da riempire le pagine di un’intera enciclopedia che arriva fino ai giorni nostri con rinnovato interesse del pubblico europeo e internazionale. L'anno 2002 segna il cinquantesimo anniversario di carriera di Alan Stivell. Per l'occasione, esce il nuovo album “Au-delà des mots” ("Oltre le parole"), un disco interamente strumentale dove il musicista suona sei tipi differenti di arpa. Il 15 marzo 2003, Alan Stivell chiude da par suo la seconda “Nuit Celtique” allo Stade de France di Parigi-St.Denis: lo ascoltano 68.000 persone. Suona due pezzi classici come ‘Tri Martolod’ ("Tre marinai") e il finale della ‘Symphonie Celtique’.
Tra gli esecutori che con lui hanno collaborato per molti anni, è certamente da celebrare, si tratta di Dan Ar Braz, all'anagrafe Daniel Le Bras, un cantautore e chitarrista francese, di origine e cultura bretone. La sua carriera ha inizio verso la fine degli anni sessanta collaborando prima con Alan Stivell e poi intraprendendo la carriera solista. Agli inizi degli anni novanta fonda l'Héritage des Celtes con il quale parteciperà all'Eurovision Song Contest 1996 rappresentando la Francia con una canzone in bretone, "Diwanit bugale". Nel panorama della musica celtica, e bretone in particolare, la sua esperienza è una di quelle, assai innovative, che maggiormente si caratterizzano per influenze rock accostate ad una forte base tradizionale, come in questa specifica ballata:
“Tour An Arvor” (La Tour D’Armor) by Alan Stivell
Piw ac'hanoc'h-c'hwi a welas - mordud,
E beg an tour, e ribl an traezh
E beg an tour e kastell Arvor
Daoulinet eo 'n itron Azenor
Eskob kêr-Is eured a lidas
Ha pemzeg teiz krenn a badas
Pemzeg teiz bannuwezh ha koroll
An delennourien en o roll
Ne oa ket eizh mis echu - me'gred
D'he lez-vab a so bet lavaret :
"Daw 'vez ganeoc'h c'hwi paotr a Vreizh
Diwall al loar demeus ar bleiz ?"
Ma e-leal am c'helennet
Bremaïk e vo hi bac 'het
E-barzh an tour krenn a vo lakaet
Hag a-benn tri dewezh e vo devet
(versione francese)
Qui d'entre vous a vu - gens de mer,
En haut de la tour, au bord de la plage
En haut de la tour au château d'Armor
Madame Azenor est agenouillée ?
L'évêque d'Ys célébra les noces
Et elles durèrent quinze jours pleins
Quinze jours de festtin et de danse,
Les harpeurs à la leur poste
Huit mois ne s'étaient pas écoulés - je crois
A son beau-fils, elle dit :
"Aimeriez-vous fils de Bretagne
Défendre la lune du loup ?" (être mis à la porte)
Si votre conseil est loyal
On va l'emprisonner sur l'heure
Dans la tour ronde on la mettra
Et dans trois jours elle sera brûlée.
Van Morrison,
George Ivan Morrison, cantante e paroliere nordirlandese, nonché musicista straordinario che suona diversi strumenti tra i quali chitarra, armonica a bocca, tastiere, sassofono e occasionalmente anche la batteria, la cui storia sarebbe qui da ripercorrere allo stesso modo di quanti lo hanno preceduto nello stretto legame con la musica tradizionale del suo paese d'origine (Sen O’Riada, un compositore e forse la figura più influente nel revival della musica tradizionale irlandese durante gli anni sessanta, attraverso la sua partecipazione in Ceoltóirí Chualann, composizioni, scritture e trasmissioni su temi celtici; padre ispiratore di tutti gli artisti irlandesi che a lui si rifanno). In essai, dopo gli esordi rock blues nel 1964 fonda i Them, del quale diviene subito leader. La band raccoglie numerosi successi, il maggiore dei quali è ‘Gloria’, che sarebbe divenuto uno degli standard del rock e che verrà incisa da numerosi altri artisti, avviandosi così a una ricca carriera solista in costante equilibrio tra la passione giovanile per il (celtic rock), e per la musica nera (blues rock, folk rock, soul bianco, fusion), che imprime alla sua musica una forte vena sperimentale che spesso lo porta a sconfinare in territori del jazz. A rendere unico il suo stile contribuiscono senz'altro la sua incredibile voce e i testi estremamente ricercati e poetici. L'album generato da quelle sessioni è Blowin' Your Mind!. Morrison ammise successivamente che non era soddisfatto del risultato, dicendo in un'intervista del 1969 a Rolling Stone che «It came out wrong and they released it without my consent» ("È venuto male e lo hanno pubblicato senza il mio consenso"). Registrazioni di quel periodo furono riedite occasionalmente dalla Bang e anche sotto forma di bootleg, sotto vari nomi. Le registrazioni complete furono messe insieme nel 1991 come Bang masters. Includono una versione alternativa di Brown-eyed Girl, così come una prima versione di Beside You e di Madame George, canzoni che compaiono con lievi variazioni di accordi, di arrangiamento e di parole nel secondo album di Morrison. Negli anni settanta Morrison si trasferisce in California dove pubblica ‘Moondance’, del quale cura anche la produzione. L'album raggiunge la 29ª posizione della classifica curata da Billboard. Lo stile di questo album è in netto contrasto con quello di Astral Weeks: se questo era un album intriso di sofferenza ed infinita dolcezza, ‘Moondance’ è invece ottimistico ed allegro, ricco di riferimenti alla black music e più vicino allo spirito degli esordi giovanili. La title track, sebbene mai pubblicata negli Stati Uniti come singolo, diviene un grande successo radiofonico. Anche Into the mystic (molto evocativa) e Caravan divengono molto popolari nel corso degli anni. La prima facciata verrà poi definita da Rolling Stone come il miglior lato A nella storia dei 33 giri.
Dopo un breve distacco dalla musica, inizia a esibirsi nei club e riguadagna la sua abilità istrionica, sebbene con un pubblico più ridotto. Forma poi un gruppo, The Caledonia Soul Orchestra, e con esso si avventura in un tour americano di tre mesi, riportato dall'album doppio It's Too Late to Stop Now, ampiamente riconosciuto dalla critica come uno dei migliori dischi dal vivo della storia del rock. Nel 1973, Morrison scioglie la Caledonia Soul Orchestra e divorzia dalla modella Janet Planet, che era sua moglie da sette anni e con la quale ha avuto una figlia. Realizza poi l'album introspettivo e triste Veedon Fleece (1974). Per quanto quest'album riceva poca attenzione al tempo della sua pubblicazione, la sua importanza è cresciuta attraverso gli anni ed è ora considerato uno dei migliori lavori di Morrison. La canzone You Don't Pull No Punches, but You Don't Push the River evidenzia il lato ipnotico e criptico di Morrison, con i suoi riferimenti al poeta visionario William Blake e al Sacro Graal.
Nel 1976, Morrison suona al concerto d'addio della Band, nel Giorno del Ringraziamento. È la prima esibizione dal vivo dopo un periodo di silenzio e Morrison considera più e più volte l'eventualità di saltare l'esibizione fino all'ultimo secondo, ma alla fine l'esibizione ha un successo travolgente. Suona due canzoni, una delle quali è Caravan (da Moondance). Il concerto viene filmato da Martin Scorsese che ne ricava un celebre film (L'ultimo valzer, del 1978). Nel 1977, Morrison scrive A Period of Transition, in collaborazione con Dr. John (anche lui presente in The Last Waltz). Dell'anno seguente è Wavelenght, che rappresenta una nuova rinascita commerciale. La canzone Kingdom Hall tratta dell'esperienza di Morrison con i testimoni di Geova e indica le tendenze religiose che diverranno evidenti nell'album successivo, Into the Music, del 1979. Dave Marsh descrive quest'album (in The Rolling Stone Album Guide - 2nd edition) come «un ciclo erotico/religioso di canzoni che culmina nella migliore musica che Morrison abbia creato fin dai tempi di Astral weeks».
Nel 1984 Van Morrison ritorna alla magica ispirazione astrale con il disco più convincente dai tempi di Into The Music , No Guru, No Method, No Teacher in cui spiccano musicisti presenti in “Moondance” come il pianista Jef Labes. Pezzo portante dell' album la straordinaria ed evocativa In The Garden dove il testo diventa un manifesto filosofico e spirituale dell' autore ma già da Got To Go Back , il pezzo di apertura, si capisce lo spessore di un disco che mostra Morrison nella sua piena maturità espressiva ed artistica. Poetic Champions Compose del 1987, molto apprezzato negli Stati Uniti, si sposta verso composizioni più accessibili e romantiche. Un unicum della sua produzione è rappresentato dall'album realizzato in collaborazione con i Chieftains. “Irish Heartbeat” racchiude brani della tradizione irlandese interpretati in brevi e spontanee session che catturano alla perfezione il mélange precario tra le ruvide e suggestive tessiture acustiche dei Chieftains e il cantato soulful di Morrison alle prese con alcune delle sue migliori interpretazioni di sempre (‘Raglan Road’, ‘She Moved Through the Fair’, ‘My Lagan Love’). L'album avrà grandissima influenza sui giovani musicisti interessati alla musica tradizionale o roots.
Con il nuovo contratto alla Polydor, Morrison conosce la definitiva rinascita commerciale a partire da “Avalon Sunset”, contenente almeno due classici come il duetto con Cliff Richards ‘Wherever God Shines His Light’ e la celeberrima ballata Have I Told You Lately. Viene in tal modo ufficialmente sancito il suo status di evergreen. Nel 1990, Morrison partecipa, insieme a molti altri artisti, allo spettacolo The Wall, organizzato da Roger Waters a Berlino, dove canta ‘Comfortably Numb’ con Roger Waters, Levon Helm, Garth Hudson e Rick Danko. Il 10 febbraio 2009 esce “Astral Weeks Live at Hollywood Bowl”, il risultato è una straordinaria performance e una nostalgica rivisitazione del capolavoro assoluto di Van Morrison. Dopo tre anni di silenzio, nel 2012 esce “Born To Sing: No Plan B”, un album per la prestigiosa label Blue Note, registrato dal vivo in studio. L' album riscuote grandi consensi, soprattutto per le qualità compositive e per gli arrangiamenti.
L'influenza di Morrison sulla totalità dei cantautori rock è davvero notevole e può essere paragonata, per vastità, a quella di Bob Dylan. Inoltre, può essere riconosciuta facilmente nella musica di molti artisti quali gli U2 (soprattutto The Unforgettable Fire), Bruce Springsteen (Spirit in the Night, Backstreets), Bob Seger, Rod Stewart, Patti Smith (responsabile di una versione poetica-proto-punk di ‘Gloria’), Graham Parker, Thin Lizzy, Dexys Midnight Runners e molti altri.[15] Tra questi Bob Seger, che in un'intervista a Creem ha affermato: «I know Springsteen was very much affected by Van Morrison, and so was I» ("è chiaro che Springsteen è stato molto influenzato da Van Morrison e la stessa cosa è accaduta a me").
Numerosi sono i Grammy Awards e i riconoscimenti:
Nel 1993 Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame; 1996 Best Pop Collaboration with Vocals, ‘Have I told you lately’ (con i Chieftains); 1998 Best Pop Collaboration with Vocals, ‘Don't look back’ (con John Lee Hooker); 1999 Grammy Hall of Fame Award per “Astral weeks”; 1999 Grammy Hall of Fame Award per “Moondance”; nel 2003 risulta ancora una volta inserito nella Songwriters Hall of Fame. La rivista Rolling Stone lo inserisce al quarantaduesimo posto nella sua lista dei 100 più grandi artisti di sempre e al ventiquattresimo in quella dei migliori cantanti nel mondo. Inoltre, due suoi album ‘Astral Weeks’ e ‘Moondance’ compaiono costantemente nei top ten delle critics lists e nella lista dei 500 migliori album di sempre. Non ho altro da aggiungere perché Morrison è stato ed è tuttora un grande ‘mito’ al quale da allora guardano e si rifanno tutti gli artisti e le band che dopo di lui si susseguono al mondo.
Dubliners,
Vale qui citare questo storico gruppo che ha scaldato i cuori di milioni di frequentatori di pub con le loro ballate ‘caserecce’ strumentalmente valide e le voci che diremmo ‘abbirrazzate’ della migliore tradizione irlandese, formato da Ronnie Drew voce, chitarra; Luke Kelly voce, Banjo; Ciaran Bourke voce, chitarra, tin whistle, armonica; Barney McKenna Irish Tenor Banjo, mandolino, fisarmonica, voce; John Sheahan violino, mandolino, tin whistle; Bobby Lynch voce, chitarra; Jim McCann voce, chitarra; Sean Cannon voce, chitarra; Eamonn Campbell chitarra, mandolino; Paddy Reilly voce, chitarra; Patsy Watchorn voce, Banjo, bodhrán. Numerosi sono gli album pubblicati, tra i quali vale la pena citarne alcuni: “The Dubliners with Luke Kelly” (1964); “Finnegan Wakes” (1966); “At Home with The Dubliners” (1969); “30 Years A-Greying” (reassembling 1992); “40 Years” (half reassembling 2002); “A Time to Remember” (2009).
Clannad,
altro gruppo che ha fatto molto parlare di sé, originari della cittadina di Gweedore nel Donegal, il nome è la contrazione di an Clann as Dobhar, sono inizialmente i tre fratelli Brennan (due fratelli e una sorella) - Ciáran, Pól, Máire (Moya Brennan) - e i due fratelli Duggan - Noel e Padraig - loro zii. Una quarta sorella, Eithne Brennan, meglio nota come Enya, si unisce al gruppo nel 1979. Esordiscono con un repertorio folk col quale si fanno conoscere nella madrepatria; nei primi anni ottanta vengono notati dalla BBC che commissiona loro una colonna sonora per una serie di telefilm incentrata sul personaggio di Robin Hood. La loro canzone "Theme From Harry's Game" li fa conoscere oltre i confini irlandesi. Giungono alla popolarità internazionale grazie al brano ‘In a Lifetime’, interpretato insieme a Bono, voce degli U2, e pubblicato nel 1985 nel loro album “Macalla” ("eco", in irlandese). Da allora il loro repertorio si sposta verso il pop ed il country, non senza la realizzazione di altre colonne sonore per film, film d'animazione e documentari. Sempre di loro ricordiamo ‘I Will Find You’ presente nella colonna sonora del film “L'ultimo dei Mohicani” del 1992.
Sinéad O’Connor,
nata a Dublino da famiglia numerosa (suo fratello, Joseph O'Connor è uno scrittore di successo), è stata una tra le voci più affascinanti degli anni ottanta e novanta, artista dalla spiccata personalità, che deve la sua fama sia alla musica ma anche al suo essere anticonformista; è ricordata per il suo look fuori dal comune (spesso aveva i capelli rasati a zero) e le sue opinioni controverse. All'età di 14 anni si unisce al gruppo irlandese In Tua Nua col quale debutta come autrice nel brano ‘Take my hand’ che diventa un successo nel 1984 e in seguito collabora con il gruppo dei Ton Ton Macoute. Nel 1985 Sinéad si trasferisce a Londra per lavorare al suo primo album. “The Lion and the Cobra” scritto e prodotto dalla stessa Sinéad viene pubblicato nel 1987 ed è un immediato successo di pubblico e critica, nell'album appare anche una giovane Enya che nel brano ‘Never get old’ recita in gaelico alcuni passi della Bibbia. Sull'onda del successo del disco Sinéad intraprende un tour attraverso l'Europa e gli Stati Uniti. Il concerto tenuto al Dominion Theatre di Londra nel giugno 1988 viene ripreso dal regista John Maybury e l'anno seguente viene pubblicato col titolo “The Value of Ignorance”.
Il 1989 vede inoltre il debutto di Sinéad come attrice nel film “Hush-A-Bye-Baby”. In campo musicale il suo successo maggiore rimane legato al singolo ‘Nothing Compares 2U’, del 1990, e incluso nell'album “I Do Not Want What I Haven't Got”. Il brano è una struggente ballata romantica e raggiunse i vertici delle classifiche mondiali. Prince, nel 1985, l'aveva composta e affidata ai Family che la inclusero nel loro unico disco, rivelatosi un totale insuccesso. La O'Connor, dopo cinque anni, spinta dal suo manager, reinterpreta a suo modo il brano, altrimenti destinato a rimanere sconosciuto. Lo stesso album ottenne un ragguardevole successo, trainato anche dai singoli successivi ‘The Emperor's New Clothes’ e ‘Three Babies’. Sulla scia della popolarità, troverà posto nelle classifiche anche il terzo album, “Am I Not Your Girl?”, composto da una serie di omaggi a celebri standard jazz che abbracciano circa sessant'anni di storia della canzone, con un solo inedito, ‘Success has made a failure of our home’, di cui ha scritto il testo. Tra il 1990 e il 1991 ha una relazione con il cantante Anthony Kiedis, membro del gruppo Red Hot Chili Peppers, il quale le dedica la canzone ‘I Could Have Lied’ (contenuto nell'album “Blood Sugar Sex Magik”).
Enya,
Eithne Patricia Ní Bhraonáin, corrisponde all'inglese Enya O' Brennan, ovvero Figlia di Brennan, cantante e musicista irlandese che, lasciato il gruppo dei Clannad pubblica il suo primo album solista col nome di Enya. Ripercorrere qui la carriera musicale di Enya fatta di date, riconoscimenti e premi internazionali, è pressoché impossibile, dietro alla sua figura musicale, ruota in realtà un trio composto dalla cantante stessa, che compone le musiche, suona e canta, Nicky Ryan, produttore e arrangiatore, e Roma Ryan, che scrive i testi in diverse lingue. Nel corso della sua carriera, Enya ha venduto più di 75 milioni di album e risulta essere la cantante solista irlandese ad aver riscosso più successo nel mondo, riconosciuto come il fenomeno musicale più importante del suo paese dopo gli U2. Tra i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti spiccano quattro Grammy Awards, sei World Music Awards, due lauree honoris causa e una nomination al Premio Oscar. Il suo ‘stile’ molto particolare e alquanto originale, al punto che può essere definito ‘unico’, rivela una grande compositrice di temi musicali come non si era mai vista prima. Ciò anche a causa delle numerose sperimentazioni sulla voce cosiddetta Multivocals, che individua nel timbro lieve ma allo stesso tempo potente di Enya il mezzo più adatto per creare “i grandi muri sonori corali“ che l'hanno portata al successo in tutto il mondo.
L'altra grande innovazione da riconoscere ad Enya e al suo team tecnico sono senz'altro gli arrangiamenti: tutti gli strumenti da lei suonati, con una maestria tale che le permette di fondere in maniera unica la musica tradizionale irlandese con la musica classica e addirittura con la musica pop, rara nel suo genere. Alcune canzoni di Enya sono cantate interamente in irlandese o latino anche se l'inglese è spesso mescolato altre volte come in un’unica lingua sonora. Roma Ryan ha scritto i testi in gallese, irlandese, latino, spagnolo, e anche nelle lingue create da J.R.R. Tolkien per “Il Signore degli Anelli”, per il cui film Enya ha composto tre brani ispirati al libro: ‘Lothlórien’ (strumentale), ‘May It Be’ (cantata in inglese ed in Quenya) e ‘Aníron’ (in Sindarin), canzone che ha ottenuto una nomination all'Oscar nel 2002. Pur avendo partecipato a numerosi spettacoli dal vivo e in televisione, ad alcuni eventi e cerimonie (la più recente apparizione è stata ad un tributo alla famiglia Brennan a Letterkenny) e sebbene non abbia mai effettuato un concerto, Enya ha espresso il desiderio di effettuarlo un giorno, e considera l'eventualità come un'importante sfida nella propria carriera.
Battlefield Band,
è un gruppo di musica tradizionale scozzese fondato a Glasgow nel 1969, i cui membri sono: Alan Reid - tastiere/chitarra/voce (anche l'unico membro fondatore ancora presente); Alasdair White - violino, flauto, banjo, bouzouki, Highland e small pipes, bodhran; Mike Katz - Highland pipes, small pipes, vari flauti, basso; Sean O'Donnell – voce, chitarra, sostituì il fondatore irlandese Pat Kilbride alla voce e alla chitarra nel luglio del 2005. Molti dei membri, in particolare John McCusker, hanno intrapreso distinte carriere soliste. La band è famosa per le sue combinazioni di cornamuse con altri strumenti, e i suoi mix di musiche e motivi tradizionali con nuovo materiale. L' attuale marchio musicale della band fu sviluppato quando a Brian McNeill e Alan Reid si unì Jenny Clark (voce, chitarra, liuto, appalachian dulcimer e flauto) e Duncan McGillivray (cornamuse e flauto). Stand Easy, l' album che registrarono nel 1979, è ancora considerato uno dei migliori del gruppo. La successiva formazione includeva Dougie Pincock (cornamuse) e Jim e Sylvia Barnes, Alan Reid (voce e tastiera elettrica) e Brian McNeill (fiddle). Ogni formazione a partire dall'album “Stand Easy” ha avuto almeno un suonatore di cornamusa. Un aspetto inusuale per la formazione strumentale per un gruppo tradizionale include la presenza di tastiere elettriche e l' assenza di percussioni.
Ogni loro album mischia canzoni e motivi scozzesi con composizioni moderne (spesso originali). I motivi variano dalle bevute, all'amicizia e ai tempi difficili della storia, alla geografia e alla politica. L'album del 2006, “The Road of Tears”, affronta esplicitamente il tema dello spostamento. Molte canzoni affrontano l'immigrazione, sia volontaria che forzata. L' album “Dookin' “ del 2007, ha un'atmosfera più leggera, dopo il tono cupo del primo questo include un insieme di parti vocali , con le parti principali divise tra Alan Reid e Sean O'Donnell, e altre strumentali. Una discografia corposa dove non mancano momenti di eccezionale ‘forza’ compositiva e strumentale, dai toni accesi come del resto è tutta la musica scozzese: “Farewell to Nova Scotia” (album) (1976) (or Scottish Folk); “Battlefield Band” (1977); “Home is Where the Van Is” (1980); “The Story So Far” (1982); “Anthem for the Common Man” (1984); “Home Ground” - Live From Scotland (1989); “Farewell to Nova Scotia” (1996) (=Scottish Folk reissue on CD); “Live Celtic Folk Music” (1998); “Best of Battlefield 1976 – 2003”.
Fairport Convention,
altro gruppo folk rock inglese, fondato da Simon Nicol chitarrista, Richard Thompson chitarra solista, Ashley ‘Tyger’ Hutchings bassista e frontman, e Shaun Frater alla batteria. Iniziano come gruppo di cover di rock della West Coast ma presto sviluppano un loro stile che mescola il rock con la musica tradizionale folk inglese, contendendosi il titolo di più grande folk rock band inglese insieme con i Pentangle. Dopo numerosi cambi di formazione si sciolgono nel 1979 per riformarsi per un concerto nel 1985, da allora continuano a suonare e pubblicare dischi. In parte il continuo successo che ancora oggi hanno i Fairport Convention è dovuto all'annuale festival di Cropredy, nell'Oxfordshire, ora rinominato Fairport's Cropredy Convention e che riunisce ogni anno dal 1974 almeno 20.000 fan. Il gruppo suona per la prima volta dal vivo in una chiesa nel Nord di Londra nel 1967, da cui il nome del gruppo Fairport Convention (Convention in inglese vuol dire riunione, incontro) e che a partire da quel momento suonerà per 40 anni. Tuttavia questa prima formazione suona solo nel primo concerto, poi il giovane Martin Lamble, presente in quell'occasione come spettatore, prende il posto del batterista.
È solo il primo cambio di formazione di una lunga serie che caratterizzerà la storia dei Fairport Convention. Il grande momento della band sono indubbiamente gli anni Settanta, quando la band sostituisce Hutchings con Dave Pegg e decide di fare a meno della voce femminile. Il gruppo pubblica “Full House” e il live “Live at the L.A. Troubadour”, subito dopo anche Richard Thompson abbandona il progetto: Simon Nicol è l'ultimo membro fondatore della band quando nel 1971 escono i due LP “Babbacombe Lee” e “Angel Delight”, i primi due album dei Fairport Convention. Dopo numerosi cambiamenti sopravvenuti e incredibili ritorni, la band incide “Rosie” e, nell'anno successivo, “Nine” con Il violinista Ric Sanders. Nel 1974 anche Sandy Denny torna nei Fairport Convention, partecipando al primo disco live Fairport Convention Live e scrivendo quasi per intero il disco “Rising for the Moon”. Questa sarà la formazione più duratura, undici anni, dei Fairport Convention fino al 1998 Mattacks lascia il posto a Gerry Conway. Una discografia copiosa di contenuti e complessa in ragione dei molti cambiamenti e ritorni, tuttavia straordinaria, dalla quale ho scelto a caso alcuni titoli: “Fairport Convention” (1968); “Unhalfbricking” (1969); “Angel Delight” (1971); “Babbacombe Lee” (1971); “Rising for the Moon” (1975); “The Bonny Bunch of Roses” (1977); “Old New Borrowed Blue” (1996); “Who Knows Where the Time Goes” (1997); “Fairport Convention XXXV “ (2001); “Over the Next Hill” (2004).
Lyonesse,
è un gruppo di folklore anglo-celtico che, oltre a ripercorrere le origini del folk in Francia a partire dal canto e dalla ghironda, si spinse in seguito nella composizione di brani strumentali facendo leva sul folklore bretone e le leggende apprese in Cornovaglia. Il nome Lyonesse riprende l’ormai nota leggenda inglese narrata all’inizio: secondo cui tra le coste della Cornovaglia e le isole Scilly sarebbe esistita una terra emersa su cui si trovava il regno di Lyonesse, civilissimo e splendido. Al gruppo si devono infatti alcuni brani bellissimi, come ‘Waltz for Ker Is’; ‘Tristan de Lyonesse’, ‘Cantique’, ‘Tristan en Bretagne’ dedicati a quella prima esperienza di ricerca. Formatosi col nome di Lyonesse nel 1973 attorno alla cantante Mireille Benhaim, vocals, dulcimer, André Thomas (bombarde, bagpipe, bodhran; Trévor Crozier, vocals, harmonica, Gérard Lavigne, electric guitar, bass; Job Philippe, celtic harp, bombarde, bag pipe; Pietro Bianchi, keyboards, piano, fiddle, percussion, violin, vocals; Eoin O'Duignan, uillean pipes, tin whistle; Bernard Sever, keyboards, organ, piano; Lili Ben, vocals, violin, dulcimer, percussion; Armel Sorveyron, bombarde, bagpipe, tin whistle, bodhran.
Ad essi si aggiunse l’inglese Trevor Crozier che conosceva il repertorio britannico con cui il gruppo amava confrontarsi. Il loro primo concerto pubblico fu proprio del Novembre del 1973, sul palco salirono anche il fratello di Mireille Ben e Gabriel Yacoub con i Malicorne, anche questi ultimi alla loro prima uscita. Le difficoltà erano notevoli perché sia Lyonesse che Malicorne suonavano con strumenti elettrici e in quel periodo, un periodo di recupero della musica tradizionale, il fatto non era sempre ben visto. Ma Gérard Lavigne che pure suonava con loro era al di sopra di ogni contestazione, suonava con identica maestria basso e chitarra elettrica e proseguì nel suo intento a viaggiare in Inghilterra suonando in alcuni festival, Oxford e Cambridge per esempio, e stringendo amicizia con molti artisti britannici. Il repertorio inizialmente era misto: c’era chi faceva ricerche in Bretagna, come Job, e chi nel Berry, come Mireille. Insieme a Trevor Crozier e Pietro Bianchi svizzero.
L’incontro tra questi musicisti si deve dunque alle affinità musicali e alle circostanze che hanno dato loro la possibilità di suonare assieme. Un anno dopo: era l’anno della registrazione a Milano del primo disco del gruppo “Lyonesse” (1974), davvero molto innovativo e ancora oggi si può ascoltare la sua freschezza, quasi che il tempo non sia passato. Nel 1975 pubblicano un secondo album “Cantique” molto diverso rispetto dal precedente: il disco nasceva dalla collaborazione con diversi musicisti, ognuno dei quali proponeva brani del proprio repertorio che il gruppo avrebbe rielaborato. Tra queste collaborazioni spicca quella con Eoin O’ Duignan del gruppo Wild Geese, valentissimo suonatore di Uillean pipes. Nel 1976 il terzo album “Tristan de Lyonesse”. Tra il 1978 e il 1981, per quattro anni, il gruppo divenne direttore artistico del Festival Internazionale di Musica Popolare di Bra (Piemonte). A ogni gruppo partecipante sarebbe stato chiesto di fare un canto di “questua” delle uova, da qui il nome Cant’è j’euv”.
L’idea iniziale era quella di un’iniziativa per la gente del luogo non molto pubblicizzata all’esterno. Fu dunque una sorpresa, il primo anno, vedere mille persone a Bra, la notte della questua, senza neppure molta pubblicità. Alcuni addirittura provenivano da Palermo, altri perfino dall’Iran. Gli inglesi per l’occasione celebrarono, coi fiori nei capelli, nel teatro di strada, la festa di St-Gorge e altri rituali di fertilità antichissimi tratti dalla tradizione popolare anglo sassone, come l'"Obby Oss" (hobby horse) della Cornovaglia. È del 1979 un loro “Live in Milan” dove meglio si può ascoltare quale fosse l’impatto che essi intessevano col pubblico. Gli anni 80 segnarono il passo per il folk revival che sembrava avere perso quella carica di novità che aveva nel decennio precedente. I Lyonesse tuttavia continuarono a suonare in pubblico ma senza un progetto preciso, suonavano così, dove capitava. Mireille maturò una convinzione: pensò che fosse opportuno fermarsi almeno tre giorni nel luogo del concerto, non per riposarsi ma per passare più tempo con la gente, a contatto con le culture.
In occasione di queste esperienze erano stati anche ritrovati molti strumenti (organetti e violini soprattutto) e nacque così l’idea di creare una scuola di musica affinché i giovani ritornassero a suonare, recuperassero le loro radici musicali e riscoprissero il canto e la danza. Nel 1989 venne fondata la Scuola di Musica Popolare con l’ACP (Ass. Cultura Popolare) della Valle Verzasca dove Mireille insegnava la danza popolare francese. La scuola non ebbe vita lunga: dopo circa tre anni a una difficoltà di gestione della scuola si aggiunse la crisi dell’unione tra Pietro e Mireille. Tuttavia la carriera musicale di Pietro Bianchi e Mireille Ben non termina qui. Mireille ha partecipato a diversi progetti come Bandalpina, Magam, MusicAlpina e il Mireille Ben Ensemble. Con questo gruppo ha registrato il primo CD “Lazùr” nel 1998 e ne ha in preparazione un secondo che vedrà la luce nella primavera del 2006 col titolo “Miniatures” distribuito da Ethnosuoni. Questo nuovo lavoro è basato sulle ricerche di Mireille ma anche su alcune composizioni originali, tra le quali un valzer composto proprio da Gabriele Coltri. Del gruppo fanno oggi parte anche la violinista ticinese Claudia Klinzing, Oliviero Biella alla chitarra, Alfredo Savoldelli, un contrabbassista proveniente dal jazz, e Gianbattista Piantoni alla batteria.
Pietro Bianchi invece continua le sue trasmissioni musicali per la radio svizzera italiana (con il quale io stesso ho lavorato presso la RSI nella serie di trasmissioni radiofoniche dal titolo “Itinerari folkloristici”) e svolge ricerche, anche insieme a Roberto Maggini, sulle tradizioni popolari del Ticino: è da queste ricerche che è nato il CD “Cantà pai sass”. Sebbene oggi i dischi dei Lyonesse sono diventati una rarità per collezionisti, ciò rischia di confinare nella memoria di pochi appassionati il notevole contributo che questo gruppo ha dato al folk revival. Certamente, corrono tempi in cui le “reunions” vanno di gran moda e il nuovo live dei Planxty nel 2004 ha scatenato entusiasmi. Anche gli appassionati dei Malicorne battono sul chiodo, attraverso le pagine internet di Gabriel Yacoub, per poter rivedere il gruppo riunito. Ma va detto anche che è sempre poco edificante, se è solo per ricercare un passato che non c’è più, rivedere una band calcare il palcoscenico. A meno che, naturalmente, non vi sia qualcosa di nuovo da raccontare.
Steeleye Span,
è un gruppo folk-rock inglese formatosi nel 1970, il cui nome è tratto da una ballata del Lincolnshire dal titolo ‘Harkstow Grange’ propostp da Tim Hart alla formazione della band, quando il bassista Asheley Hutching abbandona i Fairport Convention e fonda il proprio gruppo di folk revival con alla testa lo stesso Tim Hart e la moglie vocalist Maddy Prior, allora un duo affermato che suonava nel folk club di Londra. “Hark! The Village Wait” (1970). Dopo un periodo di cambiamenti e di sostituzioni all’interno del gruppo e ben altri due album pubblicati “Please to See the King” (1971) e “Ten Man Mop o Mr. Reservoir Butler Rides Again” (1972), avviene la svolta dal folk puro al rock. Nel 1972 pubblicano il quarto Album “Below the Salt”, in cui brani tradizionali e medievali che vengono riletti con arrangiamenti rock. Fa parte di questo album la bellissima ‘Gaudete’ che diverrà un successo internazionale e che porterà gli Steeleye Span a suonare al Top of the Pops per la prima volta. Commoner's Crown è del 1975, e contiene, tra gli altri, la ballata epica Long Lankin, il lungo strumentale Bach Goes to Limerick e New York Girls in cui Peter Sellers suona l'ukulele.
Nell'ottobre del 1975 gli Steeleye Span pubblicano "All Around My Hat", il loro album di maggior successo commerciale, il quale raggiunge il n. 7 delle charts inglesi, mentre l'omonimo singolo raggiunge il quinto posto. Nonostante il successo, o forse proprio per questo, il gruppo viene aspramente criticato dai puristi del folk per il sound, che ormai comprende robuste iniezioni di rock, a volte addirittura hard. Nel 1995 tutti i membri passati e presenti del gruppo si ritrovano a suonare insieme per il concerto del 25º anniversario della band, unico assente Terry Woods. Maddy Prior inizia ad avere problemi alla voce e Gay Woods torna nella band, che torna nuovamente ad avere due voci femminili. Dopo sette anni, nel 1996 viene inciso un nuovo album, Time. Nel 1997 Maddy Prior abbandona definitivamente il gruppo, ma gli Steeleye Span continuano con una vena produttiva che non avevano da anni pubblicando “Horkstow Grange” (1998) e “Bedlam Born” (2000). Ma senza Maddy, la popolarità degli Steeleye Span tende a svanire, Horkstow Grange è troppo folk, mentre Bedlam Born è troppo rock. Ci sono anche dei disaccordi nella band tra Woods e Johnson riguardo ai brani da eseguire dal vivo, la prima favorisce i brani più vecchi, il secondo quelli del nuovo repertorio.
Malicorne,
gruppo musicale francese di musica folk, attivo negli anni settanta ed ottanta si caratterizza per l'impiego contemporaneo di strumenti folk (ghironda, nyckelharpa, dulcimer) ed elettroacustici (chitarra elettrica) o comunque moderni (batteria). Fondato da Gabriel Yacoub e Marie Sauvet conosciuta anche come Marie Yacoub o Marie de Malicorne: i due inizialmente pubblicarono “Pierre de Grenoble” (1973). Ad essi si aggiunsero poi Hughes de Courson e Laurent Vercambre. Gabriel Yacoub faceva parte del gruppo di Alan Stivell ma, secondo le sue asserzioni, preferì cantare canzoni tradizionali del patrimonio francofono piuttosto che di quello bretone e gaelico, e quindi lasciò quel gruppo per fondare i Malicorne. L'influenza del gruppo nel mondo folk degli anni settanta in Francia, insieme a gruppi più tradizionali come La Bamboche e il gruppo di Alan Stivell, fu importante. Gli arrangiamenti sono complessi e ricercati, nella ricerca di una sintesi tra sonorità antiche e moderne. Spiccano le voci di Gabriel e Marie Yacoub: i loro canti a cappella sono riuniti nel disco “Vox” (1996). Una discografia essenziale è quanto rivela i loro gusti artistici in fatto di musica tradizionale. Vanni ricordati soprattutto per alcuni album che hanno ottenuto una certa rilevanza di successo: “Malicorne” Uno (1974) e Due (1975); “Almanach” (1976); “Le Bestiaire” (1979) “Concert exceptionnel aux Francofolies de La Rochelle” (concerto del 15 luglio 2010 a La Rochelle; 1 CD e 1 DVD) del 2011. Inoltre ovviamente a “Vox” (1996) e a “Marie de Malicorne” (canzoni interpretate da Marie Sauvet-Yacoub) (2005) .
Caroline Lavelle,
cantautrice e violoncellista inglese cominciò a suonare in un gruppo di Musica neo-barocca, chiamato Humoresque dopo aver studiato al prestigioso Royal College of Music di Keningston (Londra), Successivamente incontrò Frankie Gavin, membro della band irlandese De Dannan, che la invitò a suonare col gruppo; Caroline rimase nella band fino ai primi anni novanta, al fianco di Mary Black e Dolores Keane. Nel 1992 ha contribuito al brano ‘Home Of The Wale’ dei Massive Attack e partecipò come violoncellista all'album ‘Us’ di Peter Gabriel. Il produttore William Orbit apprezzò il suo stile e la contattò per produrre il suo album di debutto, “Spirit”, la cui uscita è datata 1995. La sua versione della canzone ‘Moorlough Shore’ venne usata come sigla per l'acclamata fiction “EZ Streets” di Paul Haggis. Nello stesso anno partecipò come cantante e violoncellista nella canzone’ Come To Me’ di Vangelis, proveniente dal suo album “Voices” e cominciò il suo rapporto di collaborazione come violoncellista con l'artista canadese Loreena McKennitt. Nel 1997 contribuì come violoncellista all'album “The Bends” dei Radiohead.
Nel 2001 pubblicò il suo nuovo album “Brilliant Midnight”, del quale uscì un anno dopo anche una versione extra con 3 tracce inedite, tra le quali spicca ‘Home of the Wale’, il brano registrato 9 anni prima con i Massive Attack e utilizzato nella colonna sonora del film “The Eye” - Lo sguardo, di Ewan McGregor e Ashley Judd. Sempre nel 2001 la sua canzone Anxiety, contenuta nell'album “Brilliant Midnight”, fu usata come colonna sonora del film “Radio Killer” di John Dahl. Si nota sempre nel 2001 la collaborazione come violoncellista con il gruppo Alternative Rock inglese Muse, per l'album Origin of Symmetry. L'ultimo album uscito, “A Distant Bell”, è datato 2004.
Attualmente Caroline vive nel sud dell'Inghilterra e sta lavorando al suo quarto album. Contemporaneamente sta partecipando al Ancient Muse Tour di Loreena McKennitt, con la quale ha proseguito il rapporto di collaborazione cominciato nel 1995, partecipando agli album “A Winter Garden” e “Books Of Secrets” e a numerosi concerti. Ha finora contribuito a produzioni di album di numerosi artisti e ad altre collaborazioni importanti con Hector Zazou, come cantante oltre che violoncellista, e con la band irlandese The Chieftains. Breve e concisa la sua discografia vede solo quattro album “Spirit” (1995), “Brilliant Midnight” (2001), “Brilliant Midnight 2.0” (2002), “A Distant Bell” (2004)
“Moorlough Shore” by Caroline Lavelle
I have waited long for you to come back home
to hear you call my name again
in my heart's deep soul you've not changed at all
and the years have passed you by
your sweet lips that lingered on my skin
i can feel their heat again
and your eyes that thrilled with passion's fire
they watch my every whim
some say my love, sweet love was lost
while crossing the raging main
or perhaps he has gone with some other girl
I might never see his face again
but if my irish love is lost he's the one I do adore
and for seven long years i'll wait for him
on the banks of the moorlough shore
he said farewell to castles grand
farewell to the foggy hills
where the linen waves like bleaching silk
and the falling stream runs still
near there we spent our joyful days but alas they are all gone
for cruelty has banished him
far away from the Moorlough shore
Ho aspettato a lungo per voi di tornare a casa
per sentire si chiama di nuovo il mio nome
nel profondo l'anima di mio cuore che non sei cambiato per niente
e gli anni sono passati da voi
le tue labbra dolci che indugiavano sulla mia pelle
Sento di nuovo il loro calore
e gli occhi che entusiasti con il fuoco della passione
guardano ogni mio capriccio
alcuni dicono che il mio amore, dolce amore è stato perso
mentre attraversava la infuria principale
o forse è andato con un'altra ragazza
Potrei mai più rivisto il suo volto
ma se il mio amore irlandese si perde è lui io adoro
e per sette lunghi anni ti aspetto per lui
sulle sponde della riva Moorlough
ha detto addio ai castelli grande
addio alle colline nebbiose
dove le onde di lino come sbiancante seta
e il torrente che cade corre ancora
vicino ci abbiamo trascorso i nostri giorni felici ma ahimè sono andati tutti
per crudeltà lo ha bandito
lontano dalla riva di Moorlough.
Bagad Kadaudal De La Rennes,
è un insieme tradizionale di musica bretone di base a Vern-su-Seicher, che prende il nome dal vecchio ‘bagadoù’ campionato nazionale creato nel mezzo degli anni 1950, di cui è stata parecchie volte Campione della Bretagna in 1a categoria, in tutto 5 titoli dal 1967 al 1969. Etimologicamente Kadoudal significa ‘il guerriero che torna al combattimento’ e letteralmente ‘il guerriero cieco’. Il nome Kadoudal ha segnato la storia della Bretagna con Joseph e Giorgio Cadoudal. Formatosi nel 1975, il gruppo contava allora una decina di musicisti composto da bombarde, ‘binious’ piccole cornamuse, e ‘casse claires’ percussioni, per il sostegno ritmico. Il loro repertorio, di assidua ricerca sul territorio, era volto alla continuità del patrimonio artistico tradizionale bandistico per le parate ma che, in occasione delle festività, si spingeva anche alla musica folk e pop. Il bagad si evolve dal 1991 promuovendo la cultura bretone in Germania, Spagna, Irlanda,orno vaglia e ovviamente, le isole Ebridi, andando ad occupare di fatto, un ruolo di primo piano che pone l’ensemble all’avanguardia del movimento di rinascita della tradizione popolare di tutta l’area e che avrebbe in seguito contagiato la cultura europea fino alle più rissose avventure del rock: da Jethro Tull a Jon Lord, a Mike Oldfiend, oltre, quindi del semplice ‘revival’.
Al di là quindi del semplice ‘ritorno alle origini’ l’ensemble Bagad tenta di svelare i valori intrinseci di questa musica genuina, far conoscere i suoni originali, le assonanze sconosciute, al tempo stesso ravvivandola, tralasciando quanto di essa può avere la sola funzione di reperto e restituirla alla primaria ispirazione campestre e contadina con rinnovata creatività, con motivi ‘a-ballo’ e canti tradizionali. Per impossessarsi del ballo non come futile esibizione, bensì di intima comunicazione con la comunità, mezzo per perpetuare in modo ‘vivo’ insieme al patrimonio musicale, le antiche usanze, i costumi e le azioni del quotidiano. Fin dalla sua creazione, almeno fino al 2012 la Bagad assicura la formazione musicale dei suoi musicisti nella sua scuola affiliata alla confederazione dei Cerchi Celtici War 'l leur.
È pressoché impossibile spiegare a parole l’incredibile prestigio con cui i componenti della Bagad usano i loro strumenti, ogni aria è suonata nel modo preciso in cui qualsiasi strumentista vorrebbe sentirla suonare. Anche per questo la Bagad de Rennes rappresenta qualcosa di più che l’ensemble di semplici virtuosi per assurgere alla qualità di autentici detentori della cultura musicale bretone, capace tuttavia di rinnovarsi in modo creativo pur restando ancorata ai suoi principi fondamentali. La discografia comprende la ‘conoscenza’ della musica tradizionale della Bretagna e della musica ‘celtica’ più in generale: “Ensemble de musique et danse (33T Barclay-Bel Air : Le bagad Kadoudal sonne pour Herri Léon, Le cercle celtique de Rennes (33T Barclay-Bel Air) (1965) ; « Bombardes et binious de Bretagne Vol. 1/2/3/4» (Collection Arion 1970 / 1976 / 1980 / 1982 / 1994 (CD); inoltre a «Xème Festival International des Cornemuses de Brest», avec Kevrenn de Rennes, Bagad Kemper, Bagad Lann-Bihoué, Pipe Band d'Écosse (33T Mouez Breiz) e «Le meilleur des musiques celtiques : Bretagne, Irlande, Écosse ». avec Jean-François Quemener, Les Sœurs Goadec, Scottish Bagpipes, The Blacksmiths, Ailoach (CD Arion).
Mi fermo qui, perché anche volendo non potrei mai elencare tutti quanti sono i ‘protagonisti’ del folklore celtico/irlandese che ogni sera si esibiscono ‘moto proprio’ nei ‘pub’ che numerosi affollano le strade delle regioni che più spesso ho nominate, e che rientrano nella folta schiera degli anonimi che, non perché di una mancata visibilità di successo, vuol dire che non siano più o meno virtuosi di questo o quello strumento, o cantino in modo imperfetto le ballate e le canzoni tradizionali, anzi semmai è spesso vero il contrario. Del resto noi tutti, in veste di lettori, uditori, ascoltatori di musica, arrivati a un certo punto, sentiamo di essere stati spinti a volare, come in un volo di uccello, in un vortice astrale che lo ‘spirito celtico’ riporta alle verdi distese, alle scogliere e fino al mare di questi luoghi incantati, alla presenza di antiche deità agricole e pastorali, ctonie e marine che in quanto narrate, abbiamo altresì visitate. Accompagnati da tanti esecutori, strumenti, canti e danze che, solo a pensare che esistono e hanno dato luogo a una siffatta ‘renaissance’ hanno già dello straordinario. Fino a quando l’arrivo della primavera o il calare del sole a mezz’agosto, le festività annuali dell’inverno, tutto questo forse ritroverà come in passato il suo significato, tutto il ‘senso’ che avremo voluto dare a questa nostra esistenza.
Note:
Molto del testo qui utilizzato è ripreso dalla trasmissione radiofonica “Folk Concerto” andato in onda su RAI 3 a cura di Giorgio Mancinelli per la regia di Pierluigi Tabasso.
Altri testi sono apparsi su ‘Audio Review’, ‘Musica & Dischi’, mentre l’intervista rilasciata da Alan Stivell all’autore in occasione del Festival della Musica Celtica tenutosi a Roma nel 1980 a Villa Torlonia, è apparsa sull’ ‘Avanti!’ del 25 Ottobre 1980.
Bibliografia essenziale di riferimento:
Catalogo Mostra “I Celti” – Venezia Palazzo Grassi – Bompiani 1991
Jean Markale, “I Celti” – Rusconi 1980
Gerhard Herm, “Il mistero dei Celti” – Garzanti 1975
Margarete Riemschneider, “La religione dei Celti” – Società Editrice Il Falco
Pierre Joannon, ‘Histoire de l’Irlande’ – Edition Plom Paris 1973)
Serafino Riva, ‘La tradizione celtica e la moderna letteratura irlandese’- Religio 1937
AA.VV. “Musica Celtica” – Savelli Editore 1980
Altra Discografia:
Collana ‘Fotografie sonore raccolte e registrate da Gérard Kremer’:
Dir ha tan, “Canti Celtici della Bretagna” vol. 1 -2 Lp ARION Farn 1053/4
Vari Interpreti, “Ballata Irlandese” – Lp ARION Farn 1008
Denise Mégevand, “L’arpa celtica delle isole Ebridi” – Lp ARION Farn 1070
The Edinburgh Military Tatoo, “La cornamusa scozzese” – Lp ARION Farn 1032
Bagad Kadoudal de La Kevrenn De Rennes, “ Bombarde e binious della Bretagna” – Vol. 1 | 2 Lp Arion Farn 1038/1069
AA.VV. "L'Isola dei canti" - Meridiani Musicali - Editoriale Domus 2001
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etno 12 ’Musica Celtica’ parte I
‘Ker Ys’ : una leggenda celtica della Cornovaglia.
Narra una nota leggenda celtica della scomparsa di ‘Lyonesse’, un tratto di terra che un tempo collegava la Cornovaglia alla Bretagna e le numerose terre che, secondo la tradizione, compongono oggi le isole Scilly. La tradizione medievale descrive un’antica terra situata oltre Land's End, la punta sudoccidentale d'Inghilterra. Chiunque, in una giornata limpida, spazi con lo sguardo verso le Isole Scilly, non avrà difficoltà a immaginare che fra queste e il continente sorgesse, in un remoto passato, un fiorente paese. Si trattava, citando il poeta inglese Lord Alfred Tennyson, della “terra perduta di Lyonesse (Lethosow) dove oggi si stende solo il burrascoso mare”. In questo luogo che sembra esistito veramente, alcuni ricercatori hanno rinvenuto sott’acqua un anello di massi di grandi dimensioni che fa pensare a una possente costruzione, forse un monumento preistorico o un castello medioevale.
Il primo accenno scritto a una terra scomparsa al largo della costa della Cornovaglia è contenuto nell'Itinerario di Guglielmo di Worcester, del XV secolo. Egli parla di “boschi, campi e numerose chiese parrocchiali, attualmente tutti sprofondati, tra il Monte e le Isole Scilly”. Ma, a questo paese sommerso, egli non assegna alcun nome, anche se alcuni studiosi collegano a questa leggenda, tramandata inoltre in famose ballate e fiabe celtiche, il ricordo di una città mitica il cui nome ‘Ys’ (pronunciato anche ‘Is’ o ‘Ker-Ys’ in bretone) è quello di una città mitica edificata sulla riva del mare nella baia di Douarnenez in Bretagna, da Gradlon re di Cornovaglia per la bellissima figlia Dahut, “la buona strega”, in grado di realizzare con l’aiuto delle ‘fate del mare’ spettacolari città dalle mura di cristallo.
Si vuole che l'isola governata da Gradlon si trovasse sotto il livello del mare e per questo motivo attorno alla città il re aveva fatto costruire un sistema di dighe che la proteggevano dai flussi dell'oceano, e come gesto d'amore nei confronti della figlia le aveva dato le chiavi che le permettevano di aprire le dighe a suo piacimento. Ma, poiché Dahut osò sfidare le leggi patriarcali rendendosi sovrana e conducendo una vita dissoluta con un giovane straniero giunto sull’isola, fu condannata dalla legge divina e da quella degli uomini a perire insieme a lui: “E il mare, ovunque dilagando, devastò completamente il territorio di Lyonesse, e molte altre vaste zone”.
Un’altra versione della stessa leggenda narra che il giovane straniero fosse quel Tristan de Lyonesse (legato alla saga arturiana) dietro il quale pare si nascondesse il demonio e che, innamorato di Dahut, una volta impossessatosi delle chiavi delle dighe della città, le aprì, permettendo all'Oceano di sommergere l'isola con tutte le sue cose. Solo re Gradlon in sella a un bianco destriero che precedeva le onde riuscì a salvarsi, raggiungendo la costa e portando con sé Dahut, ma durante il tragitto Iddio gli ordinò di gettare in mare la figlia perché posseduta dal demonio, ed egli così fece. Si vuole che proprio Dahut, per adattarsi alle acque dell'Oceano, si trasformò in una splendida sirena che con il suo dolce e ossessivo canto, riusciva a incantare i marinai. In seguito i pescatori del luogo che nelle notti di luna piena passavano vicini alla spiaggia dove un tempo sorgeva il castello di Ys vedevano una morverc'h (a mermaid), una bellissima sirena che pettinava i suoi lunghi capelli dorati cantando alle onde che avvolgevano i suoi piedi questa ballata:
“The Breton legend of Ker-Ys” (The Fortress of the Deep)”
Ocean, beautiful one of blue, embrace me, roll me on the sand
I am thine, lovely Ocean blue
Born upon amidst thy waves and foam was I;
As a child I played with thee
Ocean, magnificent Ocean, blue
Ocean, beautiful one of blue, embrace me, roll me on the sand
I am thine, lovely Ocean blue
Ocean, arbiter of boats and men, give me thy wrecks
Gold-trimmed, jewel-bedecked treasure fleets
Bring handsome sailors to my gaze,
To use and then return to thee
Ocean, beautiful one of blue, embrace me, roll me on the sand
I am thine, lovely Ocean blue.
Oceano, bellissimo blu che mi abbraccia, che mi rotola sulla sabbia
Io sono tua, e tu il bell’Oceano blu
Nata tra le tue onde di schiuma son io;
Come un bambino che giocai con te
Oceano, magnifico Oceano blu
Oceano, bellissimo blu che mi abbraccia, che mi rotola sulla sabbia
Io sono tua, e tu il bell’Oceano blu
Oceano, arbitro di barche ed uomini che mi porti i doni dei tuoi naufragi
Flotte di tesori d’oro, e di gioielli-adornate
Tu che porti i bei marinai al mio sguardo fisso,
Ch’io possa usare e poi ritornare a te
Oceano, bellissimo blu che mi abbraccia, che mi rotola sulla sabbia
Io sono tua, e tu il bell’Oceano blu.
Nel ciclo arturiano, ‘Lyonesse’ è il nome della terra d'origine dell'eroe Tristano, nipote di re Marco e amante della moglie di questi, Isotta. Poiché Marco era sovrano della Cornovaglia, Carew e un altro autore ritennero che la "terra perduta" locale e Lyonesse fossero un solo e unico luogo. I medievalisti non accettano questa ipotesi e sono dell'opinione che ‘Lyonesse’ sia la forma corrotta di un nome più antico assegnato al paese di Tristano, “Loenois”, attualmente Lothian, in Scozia. Tale collocazione concorda con il fatto che il nome Tristano apparteneva a un principe dei Pitti delle Terre Spezzate presenti sul territorio già nelI' VIII secolo. In un’altra leggenda si dice anche che nelle notti quiete le campane di ‘Ker Ys’ possono essere sentite suonare dolcemente ancora nel vento: come in questa antica canzone qui trascritta in gaelico:
Gweles-te morverc'h, pesketour
O kriban en bleo melen aour
Dre an heol splann, e ribl an dour?
Gwelous a ris ar morverc'h venn,
M'hle c'hlevis 0 kannan zoken
Klemvanus tonn ha kanaouenn.
(traduzione ‘poetica’ in italiano)
Didst tu che vedi nel mare, o pescatore
lei che pettinò le sue chiome d’oro
come il sole che risplende dall'orlo dell'acqua?
Io la vidi nel mare pallida
Io ricordo d’aver udito la sua canzone
nell'aria, l'angoscia del suo lamento.
Una leggenda ascritta a ‘la dame du lac’ vuole che Dahut “la buona strega” viva ancora nel suo meraviglioso castello (di cristallo) in fondo al mare aspettando il momento adatto per tornare alla luce e, quando questo avverrà, Ys sarà la più bella città mai esistita al mondo: “che non teme pari”. L'antiquario Richard Carew, nativo della Cornovaglia, fu il primo a identificare il regno svanito nel mare con l’Avalon della leggenda di Artù. L'opinione è riportata in Britannia di William Camden e nello Studio della Cornovaglia (1602), dello stesso Carew: "quando Lyonesse fu sommersa dalle acque, solo un uomo di nome Trevelyan riuscì a fuggire su un cavallo bianco". Da quel giorno sullo stemma della famiglia che porta il suo nome fu rappresentato un cavallo bianco che emerge dalle onde.
Che si parli della terra scomparsa di ‘Lyonesse’ o della magnifica città di ‘Ys’ non lo sappiamo ancora, di certo quel tratto di terra fu un tempo occupata dai Celti, un popolo dalle origini ancora sconosciute, probabilmente giunto in Bretagna attraverso il Reno o la Moldava, stabilitosi dapprima nella Gallia Cisalpina e Transalpina, là dove il nome di Galizia ricorda i Galati o i Galli; per poi giungere in Inghilterra e in Irlanda fino alle Isole Ebridi. Una crescita demografica attiva e la necessità di nuovi spazi abitativi, li spinsero a maturare uno spirito bellicoso che, unito alla notevole capacità nel forgiare i metalli, probabilmente li portò a sciamare verso il Mediterraneo e il Mar Nero, fino in Asia Minore. Un elemento basilare accomuna oggi tutti questi territori così diversi tra loro, rintracciati nelle lingue neo-latine, questo è il ‘gaelico’, una lingua che pure rientra nella grande famiglia cosiddetta ‘indo-europea’.
Gli odierni filologi pensano sia comparsa primaria tra i Balcani e il Mar Nero, poi dispersa per ragioni che sono tuttora sconosciute, formatasi su un ceppo linguistico primitivo, così come arcaica risulta essere la loro struttura sociale, diversificatasi gradualmente nel tempo, dando forma ad altri ceppi distinti, di cui, il più antico, è sicuramente attribuibile ai Pitti, un gruppo celtico che in illo tempore occupò la Scozia. Si tratta del “Popolo Dipinto” o Pitti come sono chiamati comunemente i membri di questa razza, di cui sono rintracciabili incisioni su steli di pietra, entrate a far parte del patrimonio archeologico celtico tuttora allo studio. I Pitti, in effetti, al tempo dell'arrivo dell'uomo nelle Terre Spezzate facevano parte del popolo degli Adusti, giunto dall’estremo sud e stabilitosi dapprima negli odierni territori di Meridia e poi spintosi verso nord fino ad incontrare gli Elfi.
L’incontro con un popolo così arcano e potente affascinò parte degli antichi Adusti e li spinse ad una sorta di venerazione nei loro confronti. Alcuni Adusti vedevano negli Elfi degli Dei in terra, la testimonianza diretta dell’esistenza di un mondo magico e spirituale che permea quello reale: “…ecco, Amici, ecco perché i nostri Padri amarono il popolo che negli occhi ha il colore del Cielo. Essi posseggono la forza e l’onestà delle fiere, odono i sussurri degli alberi e la loro voce ha la potenza del Vento. Sono semplici, rifuggono la civiltà, e come fanciulli che ascoltano le storie degli anziani per dimenticarle non appena il sonno giunge a chiudere i loro occhi, i Pitti rimangono per sempre giovani…” (cif. Vedi Terre Spezzate in wikispaces.com). Sembra vivino ancora oggi tra le gelide nevi di Altabrina, nella profondità delle selve di Neenuvar e in una piccola comunità nei fitti boschi di Corona del Re vive un popolo, di piccola corporatura ma di grande coraggio, misterioso ed alieno agli occhi degli Uomini.
Le saghe legate alla tradizione orale ascritte all’antica religione celtica rivelano in primo luogo la venerazione delle ‘forze della natura’ trasformate in divinità dei monti, delle foreste, dei fiumi e del cielo, oltre a combinazioni mostruose di animali ed esseri viventi, inclusi quelli vegetali, che davano luogo a tutto un mondo metafisico straordinariamente variegato. Nella mitologia celtica infatti, fanno la loro apparizione divinità con tre facce, dei con le corna di cervo e un serpente ‘favoloso’ con la testa di montone, liocorni ed altri animali fantastici la cui nascita mitica è spesso raccontata in varie forme e talvolta interpretata allegoricamente e misticamente. Dello stesso parere sembra essere Marcel Proust che nelle prime pagine della “Recherche: Dalla parte di Swann”, fa dire al narratore, lui meme: “Trovo del tutto ragionevole la credenza celtica secondo la quale le anime di coloro che abbiamo perduto sono imprigionate in qualche essere inferiore, un animale, un oggetto inanimato, perdute davvero per noi fino al giorno, che per molti non arriva mai, nel quale ci troviamo a passare accanto all’albero o a entrare in posseso dell’oggetto che ne costituisce la prigione. Allora esse sussultano, ci chiamano, e non appena le abbiamo riconosciute, l’incantesimo si spezza. Liberate da noi, hanno vinto la morte, e tornano a vivere con noi”.
Non mancano in queste leggende inoltre agli ‘spiriti’ spaventati e agnostici dell’orrore, le ‘fate’ anche dette ‘madri’, le cui capacità di trasformazione messe in relazione con la più arcaica credenza della reincarnazione di cui narrano alcuni poemi orali attribuiti al poeta di lingua gallese Taliesin (534 - 599) attivo nel basso medioevo, del quale sono sopravvissuti alcuni manoscritti che probabilmente riportavano tradizioni conosciute molto tempo prima, e trascritte nel ‘Libro di Taliessin’:
Sono cambiato più volte
fui salmone azzurro, poi cane
poi cervo e capriolo di montagna.
Fui martello nella fucina.
Per un anno e mezzo fui gallo
. . .
Ancora oggi si ritrovano tracce di questa credenza arcana del folklore celtico e nelle fiabe inglesi di spettri e di magie, e sempre risalta la convinzione profonda riferita all’immortalità dell’anima che trasmigra dall’agonizzante per volare nelle regioni eteree sotto l’aspetto di un uccello o di altro animale mitico dotato di ali, che ritroviamo nei molteplici reperti archeologici (ori e bronzi) di ottima fattura, tra cui si denotano affascinanti figurazioni stilizzate di figure umane (per lo più guerrieri) che rivelano una raffinatezza di esecuzione e un disegno estetico relativo a mondi immaginari, orientati a testimoniare una certa trasfigurazione della realtà. Così come in molte miniature e incisioni in oro, nei manoscritti irlandesi e britannici, nei reperti ornati delle croci celtiche e nelle steli scolpite nella pietra, e sulle lapidi tombali.
La biografia di Taliessin è quantomeno oscura e di difficile ricostruzione, oltre a ciò che è contenuto nelle sue stesse opere, sappiamo infatti molto poco riguardo alla sua vita. Molte sono le presenze del suo nome nella letteratura popolare. La tradizione, le cui fonti scritte si attestano al XVI secolo, vuole che Taliessin fosse un ‘bardo’ nelle corti di almeno tre re britannici della zona del Galles. Secondo la leggenda egli fu nominato "Capo Bardo di Britannia" ed era perciò responsabile di giudicare le competizioni di poesia tra tutti i bardi della Britannia. Il suo nome si trova come Taliessin nella raccolta ‘Idilli del re’ (Idylls of the King) del già citato Lord Alfred Tennyson e in alcune opere posteriori. Taliessin, il cui nome significa "fronte raggiante", era il figlio adottivo di Elphin che più tardi divenne re del Ceredigion, dove si vuole si trovi la sua tomba, in cima a una collina. Della quale si dice, che se un viandante riposi nelle sue vicinanze il giorno dopo si risveglierebbe o poeta o completamente pazzo. Il villaggio di Tre-Taliesin, situato ai piedi della collina sepolcrale, prese questo nome, in onore del bardo, solo nel XIX secolo.
«Su tali opere Robert Graves ha basato molto dei suoi studi sui ‘miti’ e della sua teoria storiografica. Nel romanzo fantasy "Le nebbie di Avalon" di Marion Zimmer Bradley, il bardo Taliesin viene identificato con Mago Merlino. Taliesin è anche un personaggio chiave nel romanzo fantasy mitologico “Agenzia Senzatempo: Viaggio irreale nella Britannia di Merlino e Artù”, di Dario Giansanti e Claudia Maschio (2010). Taliessin è presente inoltre fra i personaggi secondari nella saga “Il romanzo di Escalibur” di Bernard Cornwell. Inoltre Taliesin ha fatto fugaci apparizioni in alcuni numeri del fumetto italiano “Dampyr” con un ruolo non ancora del tutto chiarito: vari indizi fanno pensare che possa essere stato l'unico dampyr attivo nel passato. Anche se di rilevanza secondaria, Taliesin è uno dei personaggi della pentalogia fantastica de “Le Cronache di Prydain” di Lloyd Alexander.» (cit. wikipedya.com).
Questa ricerca prende avvio da qui, dove la leggenda si interrompe per introdurre un altro itinerario, non meno interessante, improntato sulla musica cosiddetta ‘celtica’ che raccoglie molte tradizioni di temperamento musicale: gaelica, bretone, irlandese, inglese, scozzese, tra le quali si è spesso creata una certa mescolanza attiva, operosa e dinamica. Mescolanza che ha dato luogo a una sorta di ‘rinascimento’ musicale che dal suo interno si è promulgata all’esterno, regalandoci moltissime ‘arie’ e ‘brani’ (musica strumentale e canzoni) che sono oggi di riferimento per tutta la musica nostrana, dalla ballata, alla contraddanze; dall’uso degli strumenti tipici (viella, crotta, ghironda francese ecc.) riscoperti per l’occasione, all’utilizzo degli stessi nell’orchestra e nei molteplici gruppi folk-rock e pop di formazione inglese o irlandese.
Prima fra tutti l’arpa celtica, uno strumento a corde pizzicate tese su di un insolito telaio triangolare, solitamente di legno, diverso da quelle consegnate alla storia, note nell’antico Egitto e in Assiria in quantità di fogge e con un numero variabile di corde. Presente fin dal VI secolo presso i Celti che la portavano con sé nel loro avanzamento bellico nei paesi nordici, trasformata nella tipica forma avente il lato parallelo al corpo del musicista a forma di arco teso, l’arpa divenne fonte di una diffusione musicale vastissima a tutti i ceti sociali fin dall’era pre-cristiana a tutto il medioevo, animata soprattutto dai Bardi che sostituirono l’arcaica ‘crotta’, con uno strumento a loro più consono e di più facile trasporto, l’arpa celtica, appunto.
In Irlanda, alla versione celtica è stata affiancata la versione irlandese, mentre in Bretagna essa continua la sua incontrastata esistenza. Un tempo strumento per eccellenza di una ristrettissima élite di trovieri di corte dell’aristocrazia gaelica, l’arpa veniva suonata in modo tradizionale, almeno nel folk irlandese: il ‘sean nòs’, termine gaelico che si potrebbe tradurre con ‘stile antico’ e senza l’intervento di altri strumenti storici come le ‘uillean pipes’. Specificamente come intermezzo strumentale del canto e mai da accompagnamento ad esso, lasciando spazio agli elementi vocali della poesia medievale dei ‘bardi’. Ne è un prezioso esempio la canzone del trovatore provenzale Rigaut de Berbezilh: (cit. H. I. Marrou).
Tot atressi com la clatatz del dia
Apodera totas altra clartatz,
Apodera , Domna, vostra beutatz
E la valors el pretz e lh cortezia,
Al meu semblant, totas celas del mon.
Proprio come lo splendore del giorno
Supera tutti gli altri splendori,
Signora, la vostra bellezza,
E il valore, il pregio e la cortesia,
Supera, a mio avviso, tutte le altre del mondo.
In quanto strumento mitologico e druidico in senso stretto, l' 'arpa celtica' pur mantenendo un ruolo centrale nel panorama musicale di queste specifiche regioni, rimane lo strumento che ha mantenuto un carattere magico e dunque ancestrale per eccellenza, che si è mantenuta più o meno identica dalle sue origini, custodita con orgoglio e fierezza in queste popolazioni le cui antiche origini culturali e linguistiche i Celti conservarono gelosamente all’interno delle proprie tradizioni musicali, anche dopo che, con l’incalzare degli eventi storici, persero il loro predominio espansivo in Europa, assimilandosi ai Britanni in fuga dalle terre conquistate dai Sassoni. Con ciò le popolazioni d’origine celtica mantennero quelli che erano i loro caratteri originari, ancora oggi rintracciabili in letteratura, nelle epopee cavalleresche medioevali, e nelle canzoni ‘dell’amor cortese’, nell’uso trovadorico che dalla Provenza si estese per tutto il Medioevo e invase il Nord Europa delle Corti.
Quello stesso ‘amor cortese’ che la figura del Bardo spesso legava ad eventi epici o personaggi storici, e che continua a imperversare, mistificato in ‘passione d’amore’ ancora oggi nel pop e nel rock anche se con intenti assai diversi. “Gente pittoresca i Bardi e i trovieri in genere, di sospettabile moralità – rileva Antonio Viscardi (in biblio) – ma certamente interessante per il repertorio di canti, di novelle e più ancora di fatti e avvenimenti visti e riportati nella tradizione orale. Non v’è alcun dubbio che l’arrivo di uno di costoro in un isolato maniero medievale, chiuso e impenetrabile alla vita esterna, doveva costituire un qualche avvenimento di estremo interesse”. Allo stesso modo Costanzo Di Girolamo (in biblio)– li qualifica in quanto “rappresentanti, in qualche modo dell’invenzione della lirica moderna. Ma questa tradizione capitale per la civiltà letteraria occidentale resta ancora curiosamente remota a noi per ragioni varie e complesse: quanto comunemente si scrive o si è scritto sui trovatori sembra destinato a ricadere, inevitabilmente, negli opposti generi critici dello ‘specialismo’ più esasperato da un lato e della mera divulgazione dall’altro”.
Di straordinaria bellezza compositiva e grande intensità la poesia e il canto all’uso dei Bardi, in quanto possedeva forme complesse e sofisticate quanto quelle della musica strumentale. Nelle sue forme più alte ed ’esoteriche’ l’estrema difficoltà di eseguire oggi una tale ‘concezione’ d’intrattenimento che è quasi inaccessibile oggi sia agli interpreti che agli utenti ma che pure è una delle sue caratteristiche più rilevanti, che rende l’agglomerato musicale cosiddetto ‘celtico’ straordinariamente fruibile. Non è un caso che almeno due generazioni si sono sottoposte alla costante presenza sulla scena musicale di gruppi e composti strumentali (dall’antico medievale al moderno pop) che hanno segnato gli anni della ‘rivoluzione’ (e riscoperta) del folklore europeo e celtico in particolare.
Un’altra caratteristica, alquanto comune, è quella dell’anonimato di tanta musica o riconducibile (per assonanza) alla tradizione etnica o al folklore popolare. Ciò è riconducibile al rivestire da parte dell’esecutore, un ruolo del tutto secondario rispetto alla musica e alla qualità della performance che prevede, in abbondanza, ornamenti e variazioni sul tema, tipico dell’improvvisazione e del virtuosismo, nonché dall’efficacia e dall’immaginazione esecutiva. E in questo senso, particolarissimo ma estremamente significativo, si comprende come non esistano steccati di sorta fra ‘traditional’ e ‘jazz’, ‘etno’ e ‘tribal’, ‘folk’ e ‘pop’ nella contaminazione costante della cultura musicale contemporanea.
Molti sono gli esecutori di strumenti tipici inglesi e irlandesi nonché bretoni saliti alla fama internazionale, che rimando alla cospicua discografia in fondo all’articolo.
Le ‘uillean pipes’ irlandesi fanno parte della vasta famiglia delle cornamuse di origine contadina; si dice che siano arrivate in Irlanda agli inizi del XVIII secolo e che siano state plasmate nella forma attuale verso il 1890. Hanno un temperamento alquanto nevrile (nevrotico) e sono estremamente difficili da domare, tanto che per loro è stato creato un proverbio: ‘tre volte sette è il tempo giusto per le ‘uillean pipes’: sette anni di esecuzione”. La loro popolarità si estende dalla Bretagna (binious), all’Inghilterra (horn-pipe), nonché alla Scozia dove, col nome di ‘bag-pipe’ è diventata lo strumento tipico per eccellenza. Si dice che riesca a suscitare sentimenti contrastanti, per cui certe persone la amano ed altre letteralmente la detestano. Tuttavia, con piccole differenze particolari, è presente in molte regioni dell’Europa centrale dove è in uso nelle zone montuose e collinari durante le festività religiose, come pure nei matrimoni e solo raramente nei funerali.
Il ‘bodhràn’ e uno strumento a percussione riportato in auge dal grande innovatore Sean O’Riada agli inizi degli anni Sessanta; si tratta di un tamburo a cornice di foggia circolare, generalmente fatto di pelle di capra, che la leggenda tradizionalmente associa ai ‘wren boys’, cioè a ragazzi , solitamente mascherati, che suonavano e, ancor oggi suonano, per le strade durante il Wren’s Day datato al 26 Dicembre, il giorno detto ‘dello scricciolo’, animale totem dei Druidi. Tra i flauti in legno, generalmente a-becco e molto semplici nella loro tipologia, troviamo la ‘bombarda’ simile a una trombetta dal suono caratteristico, per lo più usata in combinazione con la cornamusa, alla quale si propone come una sorta di controcanto di tipo confidenziale. I ‘tin whistle’ invece, appartengono ali ‘zufoli’, , e sono di metallo e forniscono accenti acuti e striduli e raramente assurgono al rango di strumenti solisti.
Altri strumenti sono l’’accordion’ e la ‘concertina’, entrambi appartenenti alla grande famiglia delle fisarmoniche, sempre più utilizzate nel fare musica quotidiana come ad esempio nell’accompagnare e intonare canzoni a ballo. Ecco infine il ‘fiddle’ il violino folk, molto popolare e suonato in ogni parte, soprattutto in Irlanda. Nel suo caso i puristi individuano due stili essenziali, entrambi associati ad altrettante regioni irlandesi: il primo è il cosiddetto ‘Donegal style’, molto melodico e lineare; il secondo detto ‘Sligo style’, assai più elaborato e scintillante. Entrambi eccellenti, in ogni caso, per esaltare le linee melodiche della ‘dance music’ più tradizionale e coinvolgente. A proposito della musica-a-ballo (dance music) da non confondere con la disco music, sarà forse interessante sapere che un’indagine condotta nel 1985 ha stimato in almeno seimila i temi del patrimonio tradizionale irlandese, con l’aggiunta di centinaia e centinaia di variazioni. E che la loro stragrande maggioranza è composta da ‘jigs’ e ‘reels’, le figurazioni più classiche della musica da ballo irlandese, mentre tutto il resto è è appannaggio delle logiche differenze dovute agli stili regionali, alle modalità di apprendimento, al background culturale o al semplice gusto soggettivo. Come ad esempio nelle ‘hornpipes’ e le ‘highlands’ dove nelle figurazioni l’afflato scozzese è più che evidente.
Tuttavia il ballo rappresenta un momento di aggregazione, inteso come forma del comunicare e perpetuare le antiche tradizioni, per trasmettere il culto delle deità agrarie celtiche e solstiziali di stampo druidico. Si conoscono solo alcune delle danze più antiche, tra le quali spicca: Bro Gwened (paese di Vannes), rappresentato da due danze principali: ‘An Dro’ e ‘Laridé’ a tempo variabile. Più nota è la ‘Gavotte de montagnes’ costruita su tre temi: a una prima aria di danza, segue un tempo lento o di riposo, per concludersi con un’aria più vivace; diversa a seconda del paese dove viene eseguita. Nella più austera regione del Bro Leon che si estende da Morlaix all’estrema punta della Bretagna, si danza la ‘Dance Leon’ a sottolineare la sua tipicità, ma di cui si conoscono appena alcuni passi su cui la danza si basava in origine. Indubbiamente più famosa la ‘Gavotta’ è in uso in ogni contrada dalla Bretagna all’Irlanda, alle Ebridi. Notevole in questa danza è l’uso della strumentazione, espressione della collettività in cui molti dei partecipanti si accompagnano come possono con tamburelli e altri sonagli.
L’amore per la terra natia , i sentimenti antichi, la certezza che le rocce e le montagne e i fiumi, sono abitati da spiriti e folletti, da fate e gnomi che non sono semplici spettri, ma autentici esseri in tre dimensioni, sono in questi paesi gli ingredienti fondamentali di una qualunque ballata che talvolta s’accompagna alla danza. Sarà forse per questo che a proposito dell’Irlanda è stato coniato il nickname di ‘isola dei canti’ e anche ‘l’isola di smeraldo’ per l’intensità dei colori del suo mare, lo splendore del dei suoi cieli, il senso di solitudine che attanaglia, il canto del vento, delle nuvole che corrono velocissime, che sembrano fuggire al suono di una ‘giga’ (‘jigs’ e ‘reels’) o il canto delle sirene che invece vorrebbero trattenerle.
La storia relativa al suono di quasi tutti i popoli è imperniata sul dualismo musica popolare - musica colta. Stranamente la musica riguardante questi paesi tendono a sfuggire a questa legge. Di fatto nella realtà arcaica celtica esisteva una precisa situazione musicale imperniata sul principio delle caste, successivamente, con l’estendersi del nazionalismo, le forme gentilizie più austere del culto, imperniate sulla tradizione antica, vennero assimilate alla forma della ballata trovadorica e più tardi a quella di transizione popolare. Cioè allentarono un poco la pesantezza del rito cortigiano e assunsero un uso più consono alla quotidianità, lentamente dalla realtà tristemente racchiusa del castello feudale, e si adeguò all’esterno delle piccole città urbanizzate.
Tant’è vero che con la sua dinamica intrinseca, i suoi imprevedibili salti di registro, la particolare intonazione della voce del ‘singing’ melodico permise di liberare lo ‘spirito’ del canto nella lingua madre delle singole aree di contaminazione come nelle Gaeltacht, le aree di resistenza gaelica, dove si canta appunto in questa lingua; e, differentemente, nella lingua inglese, basato sulla tradizionale forma della ‘ballad’, con la sua prodigiosa capacità di assorbire anche le più arcaiche influenze irlandesi, in modo da creare una sorta di fascinoso ibrido fra ‘stile’ irlandese e ‘radici’ inglesi. Tutto questo ha anche molto a che vedere con l’eterna migrazione irlandese in ogni angolo del mondo; con la perdita della memoria e dei legami da parte di quanti sono partiti, e con l’oblio delle tradizioni più antiche di cui immancabilmente si perdono le radici.
“Io faccio parte di una minoranza culturale che cerca di avvicinarsi alle proprie radici, con molta fatica” – spiegava alcuni anni fa Alan Stivell mettendo così in evidenza le sue intenzioni di artista e di intellettuale, ed è in questa semplicità e in questa chiarezza d’intenti che vanno ricercate le origini del revival della musica celtica, un fenomeno articolato e complesso che, partendo dalla Bretagna, dall’Irlanda e dalla Scozia ha interessato i pubblici di tutto il mondo. Non a caso i concerti, i festival, le occasioni per fare musica insieme, si sono moltiplicati con una vitalità che ha pochi precedenti nella storia della musica popolare. Queste le coordinate di questo rapido viaggio attraverso la musica celtica, a cui farà seguito una seconda parte imperniata su ‘l’eco della musica celtica nella musica contemporanea’ con i Chieftains, Dubliners, Stivell, Clannad, Fairport Convention, Lyonesse, Malicorne, Battlefield Band, Enya, Caroline Lavelle ed altri, moltissimi altri a testimonianza di una ‘differenza celtica’ che continua ad accendere passioni.
Note:
Molto del testo qui utilizzato è ripreso dalla trasmissione radiofonica “Folk Concerto” andato in onda su RAI 3 a cura di Giorgio Mancinelli per la regia di Pierluigi Tabasso.
E in “Itinerari Folkloristici” con Pietro Bianchi (Lyonesse) andato in onda su RSI Radio della Svizzera Italiana.
Bibliografia di riferimento:
“The New Oxford History of Music” a cura di Gerald Abraham – Oxfod University Press / His Master’s Voice – 1960
Catalogo Mostra “I Celti” – Venezia Palazzo Grassi – Bompiani 1991
“I Celti”, Jean Markale,– Rusconi 1980
“Il mistero dei Celti”, Gerhard Herm – Garzanti 1975
“La religione dei Celti”, Margarete Riemschneider – Società Editrice Il Falco
“La poesia dell’antica Provenza” a cura di G. E. Sansone – Biblioteca della Fenice – Guanda 1984
“I Trovatori”, H. I. Marrou – Jaca Book 1983
“I Trovatori”, Costanzo Di Girolamo – Bollati Boringhieri 1989
“Musica Celtica”, AA.VV., Savelli Editore 1980
“Scritture e scrittori dei sec. VII -X”, A. Viscardi – G. Vidosi – Einaudi 1977
“Antiche storie e fiabe irlandesi”, a cura di Melita Cataldi – Einaudi 1985
“Fiabe popolari inglesi”, Katharine Briggs – Einaudi 1984
“Fiabe irlandesi”, W. B. Yeats – Einaudi 1981
“Fiabe inglesi di spettri e magie”, a cura di Lorenzo Carrara – Arcana 1991
“Fiabe celtiche”, a cura di L. Carrara – Arcana 1993
“Elfi e streghe di Scozia”, a cura di L. Carrara – Arcana 1989
“Leggende della Bretagna misteriosa”, a cura di Gwenc’hlan Le Scouezec – Arcana 1986
“Fate e spiriti d’Irlanda”, a cura di Henry Glassie - Arcana 1987
*
 - Fede
- Fede
’PAPA FRANCESCO : Il libro della gioia’ (2)
Papa Francesco: Il Libro della Gioia (seconda parte)
(continua)
Tuttavia l’invito alla preghiera di Papa Francesco, non è cosa da poco, in quanto ‘pregare’ risponde a una necessità di fede che Egli si trova a ridistribuire ai credenti in forma di amore per l’umanità, di fratellanza benevola, di solidarietà amicale, affinché ognuno trovi e/o ritrovi nella preghiera comunitaria la forza per tirare avanti, la linfa vitale necessaria nella serenità, la ‘gioia’ nell’uguaglianza e il giusto rigore nella tolleranza e nella libertà religiosa, come teoria di sopravvivenza in questa nostra età. Riferendo le parole dell’apostolo Paolo infatti Egli ripropone alla comunità uno dei precetti della massima importanza nel cammino di crescita: “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti” (1 Ts 3,12), che riguarda di fatto la libertà religiosa e l’uguaglianza, in quanto parte integrante dell’istituzione giuridica del ‘diritto’. Ciò malgrado – scrive Marco Ventura in ‘Il dibattito delle idee’ (La Lettura/Corriere della Sera 08 Sett.2013 ) – “ragioni apparentemente contraddittorie siano alla base di seri problemi di sopravvivenza di forti maggioranze confessionali, (..) per cui si domanda agli Stati una politica attiva di riconoscimento della diversità religiosa e non religiosa come ‘parte integrante’ del diritto di partecipare alla vita sociale”.
Un’ ‘esortazione’ ad uscire ad abbracciare gli altri che vuole sottolineare con forza la ‘missione’ primaria della Chiesa nell’evangelizzazione, fin troppo spesso presa dalla tentazione dell’efficientismo negletto, e che invita ad essere protagonisti nel cambiamento. Una Chiesa coraggiosa, quindi, che sprona i credenti cristiani a guardare ai mali del mondo come a sfide per crescere, e non farsene alibi per il disimpegno. Con ciò Papa Francesco ci chiede di avere ‘uno sguardo contemplativo’ a significare che “..il mandato missionario del Signore comprende l’appello alla crescita della fede e (..) allo stesso tempo, dar luogo a un cammino di formazione e di maturazione”. (160.) “Non sarebbe corretto interpretare questo appello alla crescita esclusivamente o prioritariamente come formazione dottrinale. Si tratta di osservare quello che il Signore ci ha indicato, come risposta al suo amore, dove risalta, insieme a tutte le virtù, quel comandamento nuovo che è il primo, il più grande, quello che meglio ci identifica come discepoli (160): “Questo è il mio comandamento affinché vi amiate gli uni con gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). (161.)
Così la ‘preghiera’ rivolta da Papa Francesco assume carattere morale e moralizzatrice che invita a crescere nel Vangelo, perché è rivolta a un bene desiderabile, quindi possibile. È propositiva perché contiene “..una proposta di vita, di maturità, di realizzazione, di fecondità” (168.), alla cui luce si può comprendere il nostro essere e divenire custodi del bene e della bellezza, qui nella sua accezione serenità nell’armonia e di prosperità nella pace. “Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana” (169.). Un capitolo in particolare affronta qui diverse tematiche di rilevanza sociale affidate all’insegnamento della Chiesa, sebbene già nella premessa non si escluda la possibilità di divenire ‘oggetto di discussione’, perché, è detto, i grandi principi sociali non rimangano mere indicazioni generali che non interpellano nessuno” (182.). “Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo (noi plurale maiestatis) questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. (..) La Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia” (Benedetto XVI ‘Deus caritas est’). (183.)
Eccoci al dunque, la Chiesa sente l’obbligo di una ‘giustizia sociale’ che sia ‘giusta’; che si preoccupi della costruzione di un mondo migliore, sempre vicina ai poveri e agli abbandonati dalla società. “Di questo si tratta – dice Papa Francesco – perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, orienta un’azione trasformatrice, e in questo senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore” (186.). Dacché l’inclusione sociale certamente non nuova, dei poveri all’interno del messaggio cristiano; quel “grido altissimo” che Papa Francesco recupera dal suo omonimo Francesco d’Assisi, attualizzandolo “nella Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore per l’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze” (188.) Ciò implica sia la cooperazione nel risolvere le cause strutturali della povertà e promuovere lo sviluppo integrale dei poveri; sia recuperando i gesti più semplici del quotidiano, della solidarietà e della giustizia sociale, per far fronte alle miserie che i poveri si trovano ad affrontare.
La solidarietà quindi, come reazione spontanea da pare di chi ne riconosce la funzione sociale: “A volte si tratta di ascoltare il ‘grido’ di interi popoli, dei popoli più poveri della terra – e portare loro quella pace in cui tutti noi agogniamo – perché la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli”. (..) Abbiamo bisogno di crescere in uina solidarietà che “deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere artefici del loro destino”, così come “ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi” (190.). L’imperativo di ascoltare il ‘grido’ dei poveri si fa carne in Papa Francesco ed egli dice (spera) sia così anche per noi quando ci commoviamo nell’intimo nostro essere di fronte all’altrui dolore; mentre ci ricorda con le parole del Vangelo: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7) attribuendo a questa frase un autentico valore salvifico. È questo un messaggio così chiaro che non possiamo esimerci dal valorizzarlo con qualche intervento estraneo al ‘libro’ in questione col fare riferimento alla ‘empatia’, la specifica capacità di partecipazione emozionale nel rapporto con e/o verso gli altri. Quell’attitudine a rendersi completamente disponibili verso gli altri, caratterizzata da uno sforzo di comprensione intellettuale dell’altro, superando la forma affettiva (simpatia, antipatia), e ogni giudizio morale, mettendo da parte le nostre preoccupazioni e i nostri pensieri personali, pronti ad offrire, al bisogno, la nostra piena attenzione e quella solidarietà che è richiesta.
Ma c’è qualcosa in più che si rileva dalle frasi di Papa Francesco che va oltre il significato del merito etico-morale, ed è ciò che più affonda nel cuore (umano, non umano) quel processo di comunicazione non violenta, peculiare di una richiesta di ‘pace’, di ‘gioia’ che si rinnova nel dare (Mauss). Veniamo quindi alle parole della ‘esortazione apostolica’ che abbiamo fin qui lette, e sono tante, ognuna delle quali contiene una profonda riflessione escatologica (sul destino ultimo dell’essere) di un sapere (conoscenza) che ha un suo peso, quando è rivolto a tutti noi, restituitoci come un ‘dono’ ricevuto per grazia di Dio. Un argomento che non possiamo tacere e che ha molto appassionato Alberto Melucci (*) definito ‘il sociologo dell’ascolto’ aperto ai temi della pace, delle mobilitazioni giovanili, dei movimenti delle donne, delle questioni ecologiche, delle forme di solidarietà e del lavoro psicoterapeutico. Il quale, in anticipo sui tempi, ha esplorato il mutamento culturale dell’ ‘identità’, in funzione della domanda di cambiamento proveniente dalla sfera lavorativa in generale. E che, inoltre, ha affrontato i temi dell’esperienza individuale e dell’azione collettiva studiandone la loro ricaduta sulla vita quotidiana e sulle relazioni di gruppo, riconfermando la validità dell’interazione scientifica tra le diverse discipline, e apportando innovativi contributi alla ricerca sociologica:
“Sono convinto - scrive Melucci - che il mondo contemporaneo abbia bisogno di una sociologia dell’ascolto. Non una conoscenza fredda, che si ferma al livello delle facoltà razionali, ma una conoscenza che considera gli altri dei soggetti. Non una conoscenza che crea una distanza, una separazione fra osservatore e osservato, bensì una conoscenza capace di ascoltare, che riesce a riconoscere i bisogni, le domande e gli interrogativi di chi osserva, ma anche capace, allo stesso tempo, di mettersi davvero in contatto, con gli altri. Gli altri che non sono solo degli oggetti, ma sono dei soggetti, delle persone come noi, che hanno spesso i nostri stessi interrogativi, si pongono le stesse domande e hanno le stesse debolezze, e le stesse paure”.
Non sembra anche a voi che Papa Francesco risponda con ‘coraggio’ personalmente e direttamente a tutte queste esigenze? Io penso di sì. Ma che cos’è il ‘coraggio’ se non un atteggiamento positivo con cui si affronta una situazione di pericolo o con cui si tende a uno scopo dal raggiungimento difficoltoso e incerto? “Come stato emotivo opposto alla paura – scrive Umberto Galimberti (*) – il coraggio è considerato una delle principali virtù umane fin dai tempi di Aristotele che lo distinse dalla temerarietà, ritenendolo il giusto mezzo fra questa e la paura. A differenza della temerarietà, infatti, il coraggio tiene conto delle condizioni di realizzabilità dello scopo o di superamento del pericolo. (..) Per questo il cuore (inteso come sede) è l’espressione metaforica del sentimento, una parola dove ancora risuona la platonica ‘tymoidés’ che non è languore né la malcelata malinconia, né sconsolato abbandono”.
Il sentimento è forza e non dobbiamo averne paura, scrive ancora Papa Francesco: “la forza di essere se stessi al di là di tutte le convenienze, di tutti i calcoli, di tutte le opportunità”. Al dunque sembra dirci ancora Papa Francesco è una questione di ‘fiducia’, sembra che non possiamo fare a meno di fidarci di qualcuno e allora perché non di Dio? Non è forse da cercare qui una delle ragioni più importante della Catechesi e della Evangelizzazione?, mi chiedo io. Se è vero che non ci fidiamo più di nessuno per via di comportamenti inaffidabili (politica, democrazia, società) che hanno reso la fiducia troppo rischiosa (declino culturale, perdita di valori, sviluppo ecc.), non vedo cos’altro rimane in cui poter e/o dover credere se non in noi stessi e alla nostra atavica che ci riconduce, seppure con qualche incognita individualistica, a quella spiritualità innata in ciascuno che ci eleva al mondo superiore? E seppure volessimo proprio non fidarci di nessuno di fatto le cose non cambiano, perché ci piaccia o non ci piaccia, non possiamo prescindere dal ricorrere alla ‘fiducia’ quale unico mezzo di scambio e di convenzionalità che ancora ci rende partecipi della società in cui viviamo. Non viene forse chiamato ‘libero’ chi, possedendo la pienezza della ragione e della volontà (libero arbitrio), è capace di volgere se stesso e gestire le proprie ideologie (leggi utopie) che, in ogni caso, rispondono a leggi supreme, dettate dalla platonica ‘tymoidés’, da quel ‘coraggio’ che si rivela nel sentimento e che ci da ‘forza’, che è esso stesso forza di cui parla Papa Francesco.
Ma dobbiamo riflettere su un’altra parola, in questo caso suggerita da Mons. Semeraro e che abbiamo incontrato in apertura: la “prossimità” che, nel nostro contesto vuol dire ‘vicinanza’, usata allo scopo di creare quella relazione fiduciaria che ci fa sentire ‘uguali pur nelle nostre differenze’, gli uni e gli altri non accomunati da un rapporto di contrapposizione, come spesso accade, ma di solidale alleanza contro l’inquietudine che genera la solitudine; la ‘differenza’ che crea sconcerto e che per questo il Papa fa appello alla ‘solidarietà’ come mezzo di comprensione e di scambio; quell’andare incontro agli altri, anche ai più reietti, abbandonati dalla società. Il riferimento alle borgate disastrate delle grandi metropoli, alle favelas presenti anche nella sua giustamente amata Argentina è specifico. Non in ultimo egli fa appello alla ‘prevenzione’ piuttosto che alla repressione dei soggetti emarginati, quanto a interventi di clima ‘fiduciario’, a quella ‘prossimità’ che allenta le tensioni e consente di passare da una cultura di controllo a una cultura di aiuto e tutela che agevola un diverso modo di vivere, di uguaglianza e fratellanza insieme.
“Discutere di uguaglianza o di disuguaglianza può sembrare in prima battuta una discussione ovvia, scontata e persino sterile – scrive Maurizio Ferraris (*) in apertura del volume ‘Le domande della Filosofia’ dedicato proprio a questa tematica –. Chi non è d’accordo che uno dei valori supremi della nostra civiltà sia quello dell’uguaglianza?” – si chiede, per poi concludere che è un valore e un diritto assoluto che va riconosciuto e tutelato sopra ogni altra cosa, ma che è anche uno dei compiti che la filosofia politica moderna e contemporanea ha cercato di assolvere, in quanto diritti che tutti gli esseri (umani) hanno in quanto umani, diritti che sono uguali per tutti (diritto alla vita, alla proprietà, alla libertà, ecc.) e che sono a fondamento dell’uguaglianza. In quanto, in ogni caso, siamo tutti uguali “perché tutti – in qualsiasi condizione ci troviamo – abbiamo gli stessi diritti” (ibid.). Devo ammettere che davvero finora non me ne ero accorto poiché le disuguaglianze (tra gli uni e gli altri) per cui riuscire a garantire il ‘riconoscimento’ (teoria del) mi hanno sempre fatto sentire uno zombie in cerca di una ‘giustizia’ (universale e formale) che decidesse in modo imparziale sul mio destino. Ma così non è.
“Il contratto sociale che dovrebbe essere ‘paritario’, stabilito da individui tutti uguali, spinti tutti dalla stessa necessità: uscire dal disordine dello stato di natura che non garantisce la sicurezza, la pace e la tutela dei beni e costruire un ordine politico che stabilisca tutto ciò che in natura manca” (ib.); nella realtà non ha funzionato perché non ha in natura un ‘giudice’ al di sopra delle parti così imparziale da rendere l’uguaglianza indiscutibilmente paritaria. L’argomentazione è filosofica anche se con Alexis de Tocqueville (*) è divenuta di tipo politico-sociale e quindi di autonomia democratica culturale e civile che ci parla di giustizia, di libertà e di pace. Che siano tutti temi riferiti alla ‘utopia’? di cui non avrei voluto parlare ma che Papa Francesco, parlando con ottimismo del ‘futuro’ promosso dalla religione della ‘nuova chiesa’, sembra aver depennato dal suo vocabolario, sostituita da un numero straripante di altre parole di cui sembrava avessimo perduta la consapevolezza, come ‘tolleranza’, ‘speranza’, ‘perseveranza’, ‘lealtà’, ‘pentimento’, ‘povertà’, ‘ambizione’, ‘famiglia’, ‘fede’ e, non in ultima la ‘pace’, e senza lasciarsi irretire dal passaggio storico del futuro come minaccia di isolamento, al futuro come promessa della costruzione di legami affettivi e di solidarietà.
La ‘perseveranza’ – ci dice A. C. Grayling (*), racchiude in sé altre ‘virtù’ di cui si è accennato: il coraggio e la speranza, cruciale per la sua capacità peculiare di ottimismo e capace di infondere un tratto positivo al carattere umano, oltre ad altre caratteristiche presenti nell’individuo, come la determinazione, l’ambizione, la ‘forza’ e la decisione, il cui opposto è la rinuncia, l’abbandono fine a se stesso. Nel ramo della filosofia denominato ‘epistemologia’ (teoria della conoscenza), la ‘fede’ è definita una credenza vera e dimostrata, in quanto descrive una relazione fra uno stato della mente e un fatto: “Il contenuto dello stato della mente è un giudizio formulato in modo responsabile; il fatto è (per esempio) una particolare configurazione della realtà che – quando il giudizio è vero – è proprio ciò che lo rende tale (..) venendosi a trovare in modo completo ed esclusivo nel territorio della mente, e non si basa su nessun elemento della realtà” (* A. C. Grayling).
Un concetto questo certamente discutibile, in seguito utilizzato dall’autore in senso contrastante con i principi della Chiesa, per cui la ‘fede’ sta all’origine della religione cristiana (di Cristo) e il ‘verbo’ (la parola) è di per sé strumento di conversione. Da cui prende l’avvio uno dei criteri fondamentali dell’evangelizzazione: l’uguaglianza di quanti si riconoscono nel ‘popolo di Dio’ e, in senso lato, degli esseri umani tutti, di esortazione alla ‘giustizia divina’. “Questa verità – sollecita Papa Francesco – è ancora oggi fondamentale nella dottrina della Chiesa per combattere l’individualismo edonista. (..) la riflessione dovrebbe avvalorare il suo significato esortativo e aiutare a farla propria con coraggio e fervore. Gli apparati concettuali esistono per favorire il contatto con la realtà che si vuole spiegare e no per allontanarci da essa. Questo vale soprattutto per le esortazioni bibliche che invitano con tanta determinazione all’amore fraterno, al servizio umile e generoso, alla giustizia, alla misericordia verso il povero (e verso gli altri). (..) Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino luminoso di vita e di sapienza. Perché ‘ai difensori dell’ortodossia’ si rivolge a volte il rimprovero di passività, d’indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia intollerabili e verso i regimi politici che le mantengono” (194.) (cit. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Libertatis Nuntius del 1984).
“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è (e non vuole essere) un eccesso di attivismo ma, prima di tutto, un’attenzione rivolta verso l’altro ‘considerandolo come un’unica cosa con se stesso. (..) Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente” – spiega Papa Francesco citando ancora una volta San Tommaso d’Aquino (Summa Theologica), aggiungendo che l’amore autentico ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze mettendo in luce quello che è stato il messaggio tommaseo sull’amore e il suo modo di vivere la fede.”(199.) Un dare e un avere reciproco, quindi, che è alla base dell’uguaglianza e della lealtà, entrambi fattori di quella ‘equità’ e ‘giustizia’ più spesso sollecitata e solo apparentemente conflittuali.
Ciò malgrado – scrive Umberto Galimberti (*) “le norme giuridiche si scontrino spesso nel cielo delle idee e, ancor più spesso cozzino tra loro nell’ambito ristretto e profondo delle singole soggettività, per cui il giudice si trova molto spesso in mezzo alla guerra dei delatori e alla guerra delle soggettività, in un conflitto di doveri che chiedono un oltrepassamento della legge (e quindi della giustizia) in nome dell’equità”. Ammettere che la ‘giustizia’ fatta dagli uomini sia anche giusta, o sempre giusta, è ammettere una falsità di cui sono piene le fosse, per questo – ci rammenta U. Galimberti – Aristotele introdusse il concetto di ‘phrónesis’: “quella forma di prudenza e saggezza legata all’applicazione della norma (legge), là dove la situazione si rivela decisamente più complessa della semplicità con cui la norma universale è formulata”. Mi sembra che dovremmo recuperare il senso e forse la saggezza rivelatrice dei ‘diritti fondamentali dell’uomo’, e ri-ciclando Kant, di quella ‘equità’ che vede la legge fatta per gli uomini e non gli uomini fatti per la legge. Cosicché sulla scia di Papa Francesco anche noi possiamo ammettere che la ‘giustizia divina’ è superiore a quella umana già solo per il fatto che riconosce nell’applicazione della ‘legge’ una forma di ‘equità’ sociale distribuendo in modo ‘egualitario’ principi e fini che concernono la vita (quanto la morte).
“La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla ‘fede’, «ogni violazione della dignità personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa a Lui» - scriveva Giovanni Paolo II, nell’Esort. Ap. ‘Christifideles laici’. (1988). Per un certo verso si è parlato molto del bene comune e sociale tralasciando quella ‘gioia’ che fin da principio ci conduce per mano e che è alla base di questa ricerca, la cui finalizzazione deve comunque condurci a una riflessione sulla ‘pace’, altrimenti perché parlare di giustizia quando non può esserci giustizia senza la pace.: “Sarebbe parimenti una falsa pace quella che servisse come scusa per giustificare un’organizzazione sociale che metta a tacere i più poveri o tranquillizzi quelli che godono dei maggiori benefici. Le rivendicazioni sociali che hanno a che fare con la distribuzione delle entrate, l’inclusione sociale dei poveri e i diritti umani, non possono essere soffocate con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice. (218.) La pace «non si riduce ad un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze (in campo). Bensì si costruisce giorno per giorno, nel proseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini» - scrive Paolo VI nella Enciclica ‘Populorum Progressio’(1967), e che Papa Francesco porta a conclusione lanciando un anatema: “In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza” (219.), insieme ovviamente, a una benedizione affinché non debba essere così.
Da non sottovalutare le frasi seguenti che hanno il sapore di un ammonimento: “Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza (la sete di potere) provoca la volontà di possedere tutto e il limite (la fine impietosa) è la parete che ci si pone davanti. Il ‘tempo’, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto”, da cui emerge “un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: (in quanto) il tempo è superiore allo spazio”. (222.) Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. (..) significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di ‘iniziare processi più che di possedere spazi’. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta dio privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti senza ansietà, con convinzioni chiare e tenaci” (223.224.).
Papa Francesco ci ricorda che: “L’annuncio di ‘pace’ non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello Spirito (e nello Spirito), armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi (..) in cui la realtà è più importante dell’idea. (..) ciò che coinvolge è la realtà illuminata del ragionamento”, (..) onde per cui è possibile affermare che la realtà è superiore all’idea. Superare questa dicotomia non è facile e richiede un qualche approfondimento concettuale –filosofico che sposta il criterio dell’incarnazione della parola (il Verbo) sul piano della riflessione teologica pura: “Il criterio di realtà, di una Parola già incarnata e che sempre cerca di incarnarsi”. (233.) «In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio» - afferma l’apostolo Giovanni (1 Gv4,2) qui citato da Papa Francesco, e che tuttavia non convince se non preso come dogma. Postulato questo che ci porta, da un lato, a valorizzare la ricca tradizione bi millenaria della Chiesa, senza pretendere di elaborare un pensiero disgiunto dal Vangelo. Dall’altro lato, ci spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare opere di carità e misericordia e/o di ‘giustizia’ e ‘pace’ di cui la Parola è feconda.
La giustizia dunque come apertura necessaria al ‘dialogo sociale’ in quanto contributo alla ‘pace’, dove “il tutto è superiore alla parte”. Affermazione questa non senza un qualche coinvolgimento scientifico che apre al ‘dialogo tra la fede, la ragione e le scienze’, solitamente ostiche nel favorire una ‘pace’ che suoni come riscatto ancestrale, lì dove si è detto la pace va conquistata. “La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile progresso delle scienze. Al contrario, si rallegra e perfino gode riconoscendo l’enorme potenziale che Dio ha dato alla mente umana. Allorché il progresso delle scienze, mantenendosi con rigore accademico nel campo loro specifico, rende evidente una determinata conclusione che la ragione non può negare (ma nemmeno spiegare), allora la fede non la contraddice” (243.) Tuttavia noi sappiamo che non è stato sempre così, la storia ci insegna qualcosa che va decisamente all’opposto di tale affermazione; che contrasta con la scienza dei ‘matematici impertinenti’ e dei ‘filosofi dell’ultima ora’ “che vanno oltre l’oggetto formale della loro disciplina e si sbilanciano con affermazioni o conclusioni che eccedono il campo propriamente scientifico. In tal caso non è la ragione ciò che si propone, ma una determinata ideologia, che chiude la strada ad un dialogo autentico, pacifico e fruttuoso” (243.). È allora che la ‘Chiesa’ fa appello al dogma referenziale per definire espressamente una verità di fede per cui: “La credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani superassero le loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza dalla cattolicità a lei propria in quei figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena comunione» (244.), (Conc. Ecum. Vat. II)”.
È questo un aspetto della ‘fede’ che non è possibile affrontare nel breve spazio che abbiamo di fronte se non nel vedere un riferimento preciso ad altre tematiche politico-ecumeniche importanti in ordine alle diverse ‘comunioni religiose’ e all’apertura auspicata dal Concilio Vaticano II sul futuro dell’umanità. Con ciò – dice Papa Francesco – “A partire da alcuni temi sociali, (..) ho cercato ancora una volta di esplicitare l’ineludibile dimensione sociale dell’annuncio del Vangelo, per incoraggiare tutti i cristiani a manifestarla sempre nelle loro parole, atteggiamenti e azioni. (258.). (..) In quest’ultimo capitolo non offrirò una sintesi della spiritualità cristiana, né svilupperò grandi temi come la preghiera, l’adorazione eucaristica o la celebrazione della fede, sui quali disponiamo già preziosi testi magisteriali e celebri scritti di grandi autori. (..) Semplicemente propongo alcune riflessioni circa lo spirito della nuova evangelizzazione (260.)”. Per poi inoltrarsi nelle motivazioni per un rinnovato impulso missionario che fa seguito alla Lettera apostolica di Giovanni Paolo II (Novo Millennio ineunte del 2001): “Nello stesso tempo si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione”.
È con quanto segue, infatti, che Papa Francesco favorisce l’incontro in pienezza con Dio, e ci indica il realizzarsi che l’amore per il prossimo e la carità verso i più deboli e i poveri del mondo si traduce nella forza spirituale che ci permette di amare gli altri, facendo proprio il messaggio evangelico: «fino al punto che chi non ama il fratello cammina nelle tenebre» (1 Gv 2,11); «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non conosciuto Dio» (1 Gv 4,8). E portando come esempio le bellissime parole riportate nel “Deus caritas est” di Benedetto XVI, 2005): “Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio” (272.). Ma Papa Francesco non si ferma qui, va avanti come un fiume in piena, ora inveendo, ora militando: “Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare”. (..) Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. (..) Ogni essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita la sua vita. (274.) La sua resurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile” (276.). Quasi a voler affermare una massima di C. G. Jung (*) entrata nell’uso comune che recita: “Ogni vita non vissuta rappresenta un potere distruttore e irresistibile che opera in modo silenzioso e spietato”, per cui andare incontro alla fine è sperare in un nuovo splendente inizio.
E davvero ostinato ci sembra il fervore che anima Papa Francesco, che quasi stupisce e ci meraviglia, e che ci riserverà ancora chissà quante altre sorprese. La sua forza sta nell’intercedere con autentica vitalità nella sua missione evangelizzatrice, e che si esprime nel suo costante rivolgersi alla ‘preghiera’, com’egli spesso dice citando San Paolo: «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia (..) perché vi porto nel cuore» (Fil 1,47). Ancor più Papa Francesco chiede ai fedeli di pregare per lui, affinché la preghiera lo sostenga nel cammino di fede che ogni giorno si trova a dover indicare alla platea sempre più sterminata che l’accoglie, e con la quale condivide ormai ogni attimo della sua missione: “Così scopriamo che intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri, è un inganno” (282.); per cui la ‘pace’, quella ‘pace sociale’ che tante volte qui abbiamo intersecata, possa estendersi a tutta la collettività cristiana (e non solo) al fine di permettere la realizzazione di quella ‘giustizia divina’ che tutti ci accomuna.
Con questa ‘esortazione evangelica’ Papa Francesco ha rincorso con quella ‘gioia’ che abbiamo preso a inseguire fin dall’inizio di questa ricerca e lo ha fatto senza affanno, con la semplicità e la bonarietà che gli è più consona e che sembra auspicare ogni giorno un nuovo incontro che certamente ci sarà, prima o poi, quando l’incommensurabile amore di Dio poserà lo sguardo su di Lui e su ciascuno di noi, per il quale egli instancabilmente prega. Mi piace qui concludere con la frase idiomatica dell’inizio: Che egli sia l’uomo della futura ‘gioia’ ?
Note: I numeri che seguono i brani virgolettati “” (esempio 124.) fanno riferimento ai passi del libro: “Evangeli Gaudium”.
Papa Francesco “Evangeli Gaudium” Esortazione Apostolica, introduzione di Mons. Marcello Semeraro. Libreria Editrice Vaticana. Edizioni San Paolo 2013.
Francesco “La gioia di ogni giorno” Libreria Editrice Vaticana. Edizioni San Paolo 2014. www.libreriaeditricevaticana.com Nelle edizioni Mondadori: “Il cielo e la terra” (con Abraham Skorka) “Non fatevi rubare la speranza” “Non abbiate paura di sognare cose grandi” www.librimondadori.it
*
 - Fede
- Fede
’PAPA FRANCESCO : Il libro della gioia’.
PAPA FRANCESCO : ‘Il Libro della Gioia’.
Nell’affrontare un libro di teologia c’è sempre l’incertezza di non essere legittimato alla sua comprensione e probabilmente non obiettivo nel formulare un giudizio d’insieme che non provenga da una rettitudine religiosa e da una necessaria onestà intellettuale. Per quanto ciò non manchi del tutto, in entrambi i casi, nel mio personale curriculum, mi sono posto il problema di come far fronte alle molteplici ‘proposte’ che Evangelii Gaudium, stilato a più mani sotto la supervisione di Papa Francesco, suggerisce o, per meglio dire, ‘raccomanda’ al Popolo di Dio, ancorché si rivolga, in primis, al Popolo della Chiesa in forma di ‘esortazione apostolica’ che si pone sulla scia del vademecum comportamentale e morale di un vivere secondo l’insegnamento del Vangelo “..in accordo con il grande progetto d’amore del Padre” (114.). Indubitabilmente il proposito centrale del richiamo è rivolto a ritrovare quella serenità e quella ‘gioia’ che la certezza della salvezza in Dio ab illo tempore accende di speranza e restituisce vigore al cammino della vita attraverso la Chiesa che, nella concezione di Papa Francesco : “dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati .. con grande rispetto e amore” (114.).
L’amore, e quindi la ‘gioia’ che questo sentimento comporta, è il ‘fulcro’ dell’Introduzione cui approda Mons. Marcello Semeraro nel metterci a conoscenza dell’intenzione principale espressa nell’incipit, cioè nell’indicare quello che sarà il ‘punto dominante’ dell’insegnamento spirituale papale di riferimento, che da qui in poi mi propongo di esaminare. Come ho preannunciato le ‘proposte’ sono molteplici e affrontano aspetti teologici importanti, ma non solo. Uno su tutti, di cui bisogna tener conto, è certamente di tipo socio-antropologico, per il riferimento oggettivo alla natura umana, alla compagine sociale dei popoli, alla commistione dei credi religiosi, alle diversità di genere. Un altro riflette sui perché la Chiesa oggi senta fermo il dovere di doversi ‘modernizzare’ e, in qualche modo, riscattarsi da secoli di oscurantismo, aprendosi e ‘uscendo’ allo scoperto nel nome di Dio: “Usciamo, usciamo – incita Papa Francesco durante un incontro coi fedeli – ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca, per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata .. perché vuota”.
Parole queste, “che fanno ardere i cuori”, e che sanno di sfida quando sono dette con ardore, assecondate da ripetute azioni che si vanno accumulando e che tutti noi conosciamo per averle sentite dalla viva voce di Papa Francesco durante i suoi frequenti ‘incontri pubblici’, il cui colloquiare apertamente ben lascia intendere quale sia la ‘missione’ del suo pontificato. Parole che nuovamente – perché dimenticate dai posteri – il Papa esplicita senza annunci eclatanti, con quella semplicità bonaria che, a suo tempo, già Francesco d’Assisi indicava come strada maestra da conseguire affinché la Chiesa affermasse il suo magistero, non rivestendo i panni del potere ma assumendo il ruolo di ‘povera fra i poveri’ nell’insegnamento di Cristo: “Un modo di esprimersi che – riporta Mons. Semeraro – è assai vicino al ‘linguaggio di prossimità’ in quanto innestato nel racconto acceso dalla vita, con una concinnitas (qui usata secondo l’accezione di armonia) che spesso l’avvicina ai detti sapienziali, che sono brevi perché affilati e concreti, e per questo in grado di raggiungere l’interiorità”. Questo dunque il ‘fulcro’, o meglio uno dei ‘punti dominanti’ di questa esortazione: ‘interiorità = armonia’ e viceversa, che Papa Francesco ha inteso evidenziare con questo ‘libro alla gioia’: “..un modello per il linguaggio della nuova evangelizzazione”; altro tema quest’ultimo di una lunga conversazione già intrapresa dai papi che l’hanno preceduto – soprattutto da Paolo VI che in “Evangelii nuntiandi” (1975) riconosceva nella ‘parola’ del Vangelo il ‘messaggio che esercita il culto della verità”.
La suddivisione in tematiche del libro è già enunciata nella Introduzione di Mons. Semeraro, lì dove egli evidenzia almeno due assunti specifici: “la gioia che si rinnova e si comunica” e “la confortante gioia di evangelizzare”. Dacché il rimando a due possibili filoni di lettura interno e/o esterno alla Chiesa e al suo ruolo nella società; da intendersi comunque rivolti a tutto il ‘Popolo di Dio’, seppure visti da due punti di osservazione diversi e, quindi, da divergenti interessi socio-educativi e moralistico-culturali: accettabilissimo il primo, discutibilissimo il secondo, per quanto entrambi rientrino in ciò che va distinto come ‘vitalità religiosa’ ed ‘economia politica della chiesa’, in fatto di secolarizzazione per un verso e globalizzazione per l’altro. Ma se dal lato prettamente spirituale-culturale la sfida si fa tenace, la mediazione con l’ambiente intellettuale demarca una sfiducia a dir poco drammatica, e questo perché i ‘no’ della Chiesa al superamento di una stasi secolare, superano di gran lunga i ‘si’ di un ammodernamento che potremmo dire iniziato con il Concilio Vaticano II indetto da Giovanni XXIII (1962), e solo in parte applicato dai suoi successori, Paolo VI che lo portò a compimento, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e che, ancora oggi, stentiamo a conoscerne i risvolti.
Indubbiamente una debacle della Chiesa, a suo tempo denunciata da Joseph Ratzinger nella conferenza sulla ‘Situazione attuale della fede e della teologia’ (83.), che ne riscontrava le cause nel: “..grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità”. Una possibile risposta a una domanda che in realtà non è esplicitata ma che è nella mente di quanti si chiedono: quali sono le motivazioni di una tale défiance spirituale oltre che culturale, sociale, costituzionale? Che la Chiesa abbia perso quel contatto e/o riscontro con la realtà è possibile, anche se non si spiega come ciò sia potuto accadere. E già altre domande premono all’uscio della mente e vanno tutte in direzione di una gestione ‘discutibile’ del programma pastorale, alle ‘sfide’ rappresentate dalle culture urbane più emancipate, alle ‘difficoltà’ che incontra la catechesi di rispondere all’ansia odierna di avere risposte adeguate, “ .. al senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati” (85.)
Le risposte straordinariamente sono tutte qui, in questo libro ‘aperto’ che invita al dialogo, alla partecipazione virtuosa basata sulla ‘parola’ intrisa di umiltà, perché semplice e allo stesso tempo arguta, perché non illusoria, di Papa Francesco: “Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo” … alla verità della fede. Come è scritto nella lettera ai Romani “La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (San Paolo Rm 10,17). Onde parlare di ‘fede’ oggi implica – come auspicato – cercare “..un modello per il linguaggio della nuova evangelizzazione”, quindi dialogare, tornare a parlare di bene, della bellezza, di pace, di identità cristiana in seno a quell’abbraccio sacramentale che ci rende ‘uguali pur nella diversità’, onesti e responsabili dei doni che abbiamo ricevuti, in primis quello della vita. Questo è in fondo quello che si chiede e che riveste importanza pastorale: la personificazione della ‘parola’ del pastore chiamato alla guida del gregge cristiano o, se vogliamo, del predicatore di fronte all’assemblea che lo ascolta nell’omelia impartita durante la Messa, di ascoltare parole di ‘testimonianza’ negli ‘incontri’ catechistici: “La gente ha sete di autenticità, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscono e che sia a loro familiare, come se vedessero l’invisibile” (Paolo VI Evangelii nuntiandi ”1975).
L'invito alla gioia’ è la risposta: “Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che scontinuiamo sempre nella crescita, che viviamo il desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo, e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa indispensabile è che il predicatore (come anche il fedele) abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amore ha sempre l’ultima parola (..) per chi si sofferma ad ascoltare la sua ‘parola’ con sincera apertura, che lascia che si tocchi la sua vita, che lo metta in discussione, che lo esorti, che lo smuova, (..) davanti a tanta bellezza. (151.) Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua ‘parola’ e per lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo ‘lectio divina’. Consiste nella lettura della Parola di Dio all’interno di un momento di preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci.” (152.). E aggiunge: “Accade che a volte Dio esiga da noi una decisione troppo grande, che non siamo ancora in condizione di prendere. Questo porta molte persone a perdere la ‘gioia’ dell’incontro con la ‘parola’, ma questo può voler dire (..) che Egli ci invita a fare un passo in più, ma non esige una risposta completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a crescere, e che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo a ottenere.” (153.)
Eccoci messi di fronte a una testimonianza di fede inequivocabile, necessaria per rispondere a una preoccupazione reale di un sentirsi ‘tradito’ se non addirittura ‘abbandonato’ non riferibile ad atteggiamento opportunistico o di meditato rancore quanto piuttosto è profondamente religioso, che spesso rivolge il cristiano praticante rivolgendosi a Dio che, per questo non gli è ignoto, bensì a quel Dio al quale egli rivolge la sua fede e la sua stima, e al quale si appella con la preghiera, e talvolta anche con l’imprecazione, il grido di minaccia, il litigio, l’inimicizia, in segno del mancato approfondimento del kerygma (dal greco: predica, annuncio, messaggio) che si aspetta da chi è preposto all’insegnamento evangelico e che spesso non arriva. “Si tratta di saper leggere negli accadimenti il messaggio, di Dio (..) di collegare il messaggio del testo biblico con una situazione umana, con qualcosa che essi vivono con un’esperienza che ha bisogno della luce della ‘parola’” (156.). Ciò che si cerca di scoprire “è ciò che il signore ha da dire in questa circostanza.” e che, pertanto, si richiede al predicatore un esercizio di ‘discernimento evangelico’ che riconosca, e porti ad esempio – alla luce dello Spirito – quell’appello che Dio fa risuonare nella stessa situazione storica: “anche in essa e attraverso di essa Dio chiama il credente” (Paolo VI Evangelii nuntiandi ”1975).
Siamo qui in ambito della teologia integrale alla quale non si cercano più risposte, la ‘fede’ non prevede risposte a “domande che nessuno si pone”. Tuttavia continuiamo a farcene e non tanto perché cerchiamo risposte quanto, di portare avanti il ‘colloquio’ intrapreso con Papa Francesco. Ed è ancora Mons. Semeraro a rispondere, riferendo che trattasi di un “colloquiare personale, molto intimo, sino al suggerimento di una preghiera. Questa sottolineatura è un evidente punto di contatto con il magistero di Benedetto XVI (..) e punto fondamentale della spiritualità ignaziana: rendere possibile alla libertà di ogni battezzato un reale incontro con Cristo e una libera adesione a lui nello Spirito”. Il riferimento a Sant’Ignazio di Loyola fondatore dell’ordine dei Gesuiti rende qui testimonianza dell’educazione religiosa ricevuta da Jorge Mario Bergoglio, ragione per la quale l’oggi Papa Francesco predica la sua missione di povertà: “La mia gente è povera e io sono uno di loro” nel raccomandare a quanti, vescovi, diaconi, consacrati e laici intendono modulare la propria fede sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, ed “Evangeli gaudium” invita tutti a riprendere in mano i Comandamenti e i Libri Sacri per una svolta catechistica della Chiesa affinché ritrovi la ‘gioia’ nell’evangelizzazione e sia in grado di indicare il cammino dei fedeli nei prossimi anni a venire.
Un altro riferimento assume nel libro importanza fondamentale, quello a San Tommaso d’Aquino, domenicano, considerato uno dei principali pilastri teologici e filosofici della Chiesa cattolica, e al suo insegnamento morale che trova nelle virtù e negli atti che da esse procedono “la fede che si rende operosa per mezzo della carità.” (37). Il messaggio raccolto da Papa Francesco è tutto compreso “nell’opera d’amore e di misericordia, con la quale si soccorre la miseria altrui”, manifestazione più perfetta della grazia interiore dello Spirito che egli trae dalla “Summa Theologiae” propria dell’insegnamento tommaseo: “Per analoghe ragioni, abbiamo bisogno di ascoltarci gli uni gli altri e completarci nella nostra recezione parziale della realtà e del Vangelo” (rif.41.). Il messaggio non si arresta qui, travalica i tempi e finisce in queste pagine col risvegliare l’attenzione sul fatto che tutto sommato “i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio sono pochissimi”; e che – citando sant’Agostino – “i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione, per non appesantire la vita dei fedeli, e trasformare la religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera.”(43.) Messaggio che Papa Francesco restituisce all’attualità con la seguente considerazione: “Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al momento di pensare una riforma della Chiesa e della sua predicazione che permetta realmente di giungere a tutti”.
Da cui l’importanza interna ed esterna alla Chiesa di applicare quanto in queste pagine è riportato con sapienziale veemenza sull’imputabilità e la responsabilità di azioni che possono sì essere sminuite da diversi fattori sociali ma che si rendono inaccettabili quando vengono attribuite all’ignoranza, all’inavvertenza, al timore vacui e dagli effetti smodati di una società assoggettata a ideologie politiche avventate, al consumismo sfrenato che rincorre economie di potere, e che lascia da parte i diritti fondamentali costituiti sul modello ‘sociale’ e ‘spirituale’ delle genti e delle nazioni. “Pertanto – e qui cita Giovanni Paolo II ‘Familiaris consortio’ (1981) – senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno”, basandosi su almeno una legge laica di sicura presa sociale, quel ‘diritto di avere diritti’ secondo cui è permesso a tutti indistintamente, di trascorrere i propri giorni senza dover fronteggiare difficoltà insormontabili anche sul piano teologico spirituale, come quelle approntate dal “Catechismo della Chiesa Cattolica”. “A tutti – dice conciso Papa Francesco – deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute”.
In realtà noi tutti viviamo in una società tecnologizzata dell’informazione che però ci satura indiscriminatamente di dati a dir poco superficiali sulla questione morale, quando non del tutto mancanti a causa dell’utilizzo indiscriminato che facciamo della rete nell'immettervi dati approssimativi che rispecchiano le scelte soggettive di noi singoli operatori, preferendo l’apparenza alla sostanza tra quelle possibili in una società in cui regna l’incertezza del domani. Né possiamo affermare esserci un solo modo ‘morale’ di vivere e che quello testamentario della Chiesa sia quello più giusto. Necessita un 'atto' di fede. Tantomeno che l’esigenza di razionalità come criterio per discernere la qualità metodologica di un comportamento corrisponda a una presa di coscienza formativa che ha come oggetto la ‘responsabilità morale’ attinente alla dignità della persona. Secondo quanto si chiede Michael Gazzaniga (*) una domanda domina oggi la nostra vita: “Siamo macchine, quindi sistemi del tutto deterministici, o siamo liberi di scegliere come vogliamo?” All’occorrenza Roger Scruton (*) ci ricorda che: “Le persone sono vincolate da leggi morali che articolano l’idea di comunità di esseri razionali che vivono nel mutuo rispetto, si assumono le responsabilità delle loro decisioni e possiedono diritti e doveri secondo il tacito presupposto che ogni singolo individuo è riconosciuto come membro insostituibile e autosufficiente dell’ordine morale e i suoi diritti, doveri e responsabilità, sono cose che possiede in quanto persona” e che pertanto il nostro 'libero arbitrio' (volenti o nolenti), è costantemente soggetto arestrizioni e condizionamenti.
Per quanto relativa la ‘razionalità’ pone qui un ulteriore quesito: “i valori morali sono relativi o assoluti? – si chiede il filosofo Maurizio Ferraris (*) – La risposta di gran lunga più ragionevole è indubbiamente che sono relativi (..) ma è altrettanto ovvio che il relativismo ha dei limiti. (..) Se molti sono i modi ragionevoli in cui gli esseri umani possono organizzare la loro vita, resta che ce ne sono alcuni che sono sicuramente inaccettabili”. Problematica che la sociologa Daniela Verducci (*) individua in quel segmento mancante' da ricercare “..nell’attualità dell’esperienza umana la traccia di quel ‘segmento mancante’ che ha nome ‘ontologia’ (necessaria) ai fini del ripristino del contatto coscienziale con quel rivolo di energia vitale che, configurandosi in attività di produzione socio-culturale-intellettualistica, conduce alla realizzazione di scopi e intenzioni”. Per cui il fattore ontologico ‘morale’ è un prerequisito indispensabile non solo alla comprensione meno superficiale dei fenomeni sociali (divergenze, differenziazioni, ecc.), ma anche alla individuazione di strategie di cambiamento.
Lo stesso che Vito Mancuso (*), teologo e docente, pone qui un’ulteriore domanda in un certo senso provocatoria che appare nel titolo del suo libro “Obbedienza e libertà” (?), nel quale affronta la questione morale del “tragico paradosso” oggi presente nella coscienza cristiana. Un tema questo che pur nella luce del delicato rapporto con il potere ecclesiastico, mette in atto una riflessione umana tra ‘anima’ e ‘coscienza’, tra eternità e morale cristiana come conseguenza del suo raggiungimento: “Districarsi in questa situazione c’è infatti la possibilità di incorrere in un tragico paradosso in cui si dibatte la coscienza cattolica: l’istituzione per merito della quale ancora oggi nel mondo continua a risuonare il messaggio di liberazione di Gesù è governata nel suo vertice da una logica che rispecchia proprio quel potere contro cui Gesù lottò fino a esserne ucciso. Questa è la condizione paradossale e a volte tragica dell’essere oggi, e non solo oggi, un cattolico” (ib.). Si sente qui la forza scatenante di un voluto attacco alle istituzioni gerarchiche della Chiesa in nome di quella ‘moralità’ che già Benedetto XVI ed ora lo stesso Papa Francesco combattono divulgando una’educazione evangelica che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori, di cui la ‘moralità’ individuale è certamente la preoccupazione primaria richiesta: “In ripetute occasioni essa ha servito come mediatrice per favorire la soluzione di problemi che riguardano la pace, la concordia, l’ambiente, la difesa della vita, i diritti umani e civili.”(64.).
Una risposta adeguata, affrontata in altro campo da quello prettamente religioso, ci viene da uno storico tedesco Karol Kerényi (*) che in “Rapporto con il Divino” indica un atteggiamento ‘etico-morale’ peculiare nel rapporto (dal tedesco umgang) dell’essere umano in senso non discriminatorio. In quanto – egli dice – “si intrattiene o si coltiva un rapporto che possieda una qualche prerogativa di concretezza tale da costituire la forma più personale di relazione. La concretezza e la personalità indicano – infatti – il confine inferiore e quello superiore nella relazione ‘soggetto-oggetto’ paritaria a quella ‘io-tu’ e che costituisce la forma della più personale relazione uomo-Dio”. E che, lo storico affronta “con attenzione rispettosa, senza la quale non esiste un rapporto corretto. (..) Questo ‘avere conoscenza della correttezza’ del rapporto è indispensabile, quale che sia il suo segno – il segno della concretezza o della personalità”. Una tale peculiarità non si esprime se non nella concezione di intercursus (interscambiabilità) fra soggetto e oggetto “la cui distinzione non riguarda il rapporto in sé e per sé, bensì la sua originarietà, (..) propria del rapporto ‘mediato’ che definiamo religione e il rapporto ‘non mediato’ instaurato con il divino”. (ibidem).
La ‘gioia’ del Vangelo si traduce in questo modo in maggiori possibilità di comunicazione, di incontro e di solidarietà tra tutti. “Se potessimo seguire questa strada, sarebbe davvero una cosa tanto buona, risanatrice e liberatrice, quanto generatrice di speranza. Uscire anziché chiudersi in se stessi per unirsi agli altri fa bene all’anima, significa rifiutare l’amaro veleno dell’immanenza, di ogni scelta egoistica che facciamo.” (87.) Uno sguardo particolare è riservato in questo libro alla donna, dove Papa Francesco ribadisce il ruolo della donna nella società di oggi: “La Chiesa riconosce l’indispensabile attenzione che la donna pone al servizio degli altri e che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. (..) Nel condividere responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, nell’accompagnamento di persone, nei contatti con le famiglie o di gruppi, offrendo nuovi rapporti di riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa così come nelle strutture sociali in cui si deve garantire una maggiore presenza delle donne.” (103.)
C’è anche per una parola di conforto da distribuire ai ‘diversi’, alle ‘diversità’ di razza e provenienza: “La Chiesa ‘in uscita’ è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del ‘figliuol prodigo’, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà”. (46.) Ma ricorda anche che “La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia (..), per cui essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre” (114.) Lamenta Papa Francesco l’avvicendarsi di svariate forme culturali che convivono di fatto nei centri urbani con maggiore intensità di popolazione e in essi si incrementano facilmente il traffico di droga e di persone, l’abuso e lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, mentre convivono varie forme di corruzione e di criminalità, e che, al tempo stesso, creano forti contraddizioni e provocano sofferenze laceranti.
Niente di più vero se, come egli scrive: “La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. (..) In molte parti del mondo, le città sono scenari di proteste di massa dove migliaia di abitanti reclamano libertà, partecipazione, giustizia e rivendicazioni che, se non adeguatamente interpretate, non si potranno mettere a tacere con la forza”. (74.) “Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari paesi risorgono conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”, (Gv 13,35) (99.) Anche se: “..di fatto l’individualismo postmoderno e la globalizzazione favoriscono uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e snatura i vincoli familiari.” (67.)
Pertanto l’azione pastorale per l’inculturazione della fede “esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. (..) D’altra parte assistiamo alla nascita di molte forme di associazione per la difesa dei diritti e per il raggiungimento di nobili obiettivi, in cui la Chiesa manifesta la sua partecipazione a fianco dei cittadini che vogliono/ ‘chiedono’ di farsi costruttori del progresso sociale e culturale” (67.), nonché spirituale in seno alla comunità di appartenenza. “Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane. Gli ambienti rurali, a causa dell’influsso dei mezzi di comunicazioni di massa, non sono estranei a queste trasformazioni culturali che operano anche mutamenti significativi nei loro modi di vivere, (..) nel linguaggio, nei simboli, messaggi e paradigmi che offrono orientamenti di vita, talvolta in contrasto con l’insegnamento evangelico.” (73.).
Anche per questo la preparazione alla predicazione richiede applicazione, studio, dedica, pazienza, amore. Scrive Papa Francesco citando Paolo VI del ‘Evangeli nuntiandi’ (146.), qui più volte ripreso : “Il primo passo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, è prestare tutta l’attenzione al testo biblico, che dev’essere il fondamento della predicazione. Quando uno si sofferma a cercare di comprendere qual è il messaggio di un testo, esercita il ‘culto della verità’. È l’umiltà del cuore che riconosce che la ‘parola’ ci trascende sempre, che non siamo ‘né padroni’, né arbitri, ma i depositari, gli araldi, i servitori’. Bisogna mettere da parte qualsiasi preoccupazione che ci assilla per entrare in un altro ambito di serena attenzione, perché qui si tratta di amare Dio. Dio che ha voluto parlare. A partire da tale amore ci si può trattenere per tutto il tempo necessario, con l’atteggiamento del discepolo: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (1 Sam 3,9). Con ciò Papa Francesco rincorre in questa ricerca quella ‘gioia’ che abbiamo preso a inseguire fin dall’inizio e lo fa senza affanno, con la semplicità e la bonarietà che gli è più consona e che sembra auspicare ogni giorno un nuovo incontro che certamente ci sarà, prima o poi, quando l’incommensurabile amore di Dio poserà lo sguardo su di Lui o su oguno di noi, per il quale egli instancabilmente prega.
(Continua).
Papa Francesco “Evangeli Gaudium” Esortazione Apostolica, introduzione di Mons. Marcello Semeraro è edito per i titoli della Libreria Editrice Vaticana. Edizioni San Paolo 2013. www.libreriaeditricevaticana.com
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnom. 11: ’Brasile tra mito e magia’
Quaderni di Etnomusicologia 11: 'Brasile tra mito e magia'(parte prima)
“O Paìs do Carnaval” – Rio de Janeiro
«Evoè, Carnaval!» - esclama il ricco piantatore di ritorno dall’Europa perso a contemplare il mistero delle acque fra l’azzurro intenso del cielo e il verde del mare, mentre la nave entrando in porto, nella opulenta Rio, ostenta i colori verde-giallo nazionali. Scriveva Jorge Amado negli anni 30’ in quello che va ricordato come il suo primo, insuperato romanzo biografico, pubblicato in Italia appena nel 1984 quando già il suo autore era all’apice del successo. In seguito ne scriverà altri, molti altri, tutti di grandissima presa sul pubblico e di successo, dovuto anche al fatto che da alcuni di essi sono stati tratti films di successo come “Dona Flor e i suoi due mariti”.
Un’apertura decisamente insolita per i ‘Quaderni..’ di cui riprendo qui la pubblicazione dopo la sosta estiva. Pur tuttavia necessaria per introdurre un tema, quello del ‘carnevale’ che mi sta particolarmente a cuore, in ragione di aver vissuto «o’ vivo» alcuni Carnevali importanti, come appunto quello di Rio, che qui descrivo; quello di Bahia; quello di Bali e di Ceylon (che si rifanno ad alcune festività locali); quello della ‘Diablada’ in Perù, e alcuni dei molti altri che si festeggiavano nel passato e ancora si festeggiano in Italia. Insolita non poi tanto perché lo scopo è comunque quello di volgere l’attenzione alla musica che solitamente in essi si consuma. Davvero un ‘mare’ sonoro, di ondate di suoni, di ritmi, di canti, di danze che da sempre accompagnano la straordinaria ‘follia’ del Carnevale.
E allora che c’è di meglio di iniziare proprio da qui, dal paese che ormai si distingue come ‘O Paìs do Carnaval’: Rio de Janeiro: “..una città incendiata per tre giorni e tre notti, come un vulcano incandescente che si riversa per le strade, dove migliaia di persone manifestano la loro gioia di vivere”. Dalle ‘favelas’, le tristemente famose bidonville che sorgono e prosperano come funghi al margine della metropoli; al trionfo del ‘samba’ che ha il potere di coagulare bianchi e neri, gente carioca e creola, conquistatori e conquistati, all’interno della festa ‘d’amore e di sangue’ che dimentica le miserie e gli affanni nell’orgia carnevalesca, in cui ‘vive’ il proprio istante d’eternità.
«È il paese con il più grande avvenire del mondo intero!» - aggiunge il giovane speranzoso. «Lei ha appena dato l’esatta definizione del Brasile, il Paese Verde per antonomasia, proiettato nel futuro. Entro cent’anni il Brasile sarà il primo paese del mondo. Oggi..».
È questa una terra dove, almeno per un breve periodo dell’anno, la parola ‘carnevale’ recupera il suo originario significato etimologico di esaltazione della carne e una sfrenata gioia di vivere in una sorta di ‘bolgia’ gigantesca dove infine si contano i decessi a centinaia. È questo il risvolto tragico della festa, come se tutto l’odio, il rancore, il parossismo, il delirio, la ribellione dei diseredati e degli oppressi, si condensino in un immane cruento sacrificio. Sono tre giorni e tre notti vissuti al culmine della gioia e dell’orrore in cui l’intera città, anzi l’intero paese si riversa per le strade di Rio, bruciato dal fuoco di una ‘follia’ selvaggia e imprevedibile. Si conta che quando si avvicinano i giorni del Carnevale, almeno un milione di persone provenienti da tutto il Brasile si riversano a Rio. In molti hanno lasciato il proprio posto di lavoro che forse non ritroveranno; altri non fanno più ritorno ai rispettivi paesi d’origine, fermandosi nella metropoli già affollatissima, unendosi al fitto campionario della popolazione emarginata, diseredata, affamata, in cerca di una propria identità.
«Peccato che non sia mai andato oltre.. – esclama l’onnipresente e danaroso possidente – Oggi (in Brasile) dominano le religioni feticiste. A nord, la religione è un miscuglio di feticismo, spiritismo e cattolicesimo. Ma se lei pensa che tale religione sia quella che predomina in Brasile, si sbaglia. Esiste di essa una deformazione africana: la Macumba (insieme di riti animisti afro-brasiliani, in onore degli orixà, spiriti delle acque e delle foreste, originari di Bahia), a nord tiene il posto della Chiesa che, a sud, è sostituita da gruppi spiritisti».
Ed è davvero così, la questione religiosa in Brasile si riduce a una questione di ‘paura’. Una paura ancestrale che giunge di lontano, allorché intere popolazioni ridotte in schiavitù, furono estirpate dalle loro terre d’Africa e trasferite nelle lontane americhe a bordo delle navi ‘negriere’, così si chiamavano, con i loro idoli e loro antiche tradizioni. “Macumba” e i riti di “Umbanda” in Brasile, il Voo-doo ad Haiti, le ‘Santerias” a Cuba ecc. non sono che il trasferimento di quei culti aviti provenienti dal cuore del continente africano, le cui pratiche devozionali ‘oscure’, così dette di ‘iniziazione’ e altro, erano a volte violente e mettevano a dura prova i giovani che vi venivano sottoposti. Oltre alla ‘paura’ diffusa che migliaia di individui si trovarono ad affrontare fin dall’inizio del viaggio sotto la sferza negriera, e dopo, quando furono costretti a lavorare sotto la minaccia delle armi da fuoco. Paura che si intravedeva ovunque ma che non si mostrava mai chiaramente e li perseguitava senza una ragione, perché indistinta, fluttuante, disancorata dall’oscuro, perché occulto, mondo dei loro idoli e delle loro ataviche certezze. Paura sempre e ovunque che essi racchiudevano nell’incertezza del buio, che aveva inizio fin dal calar del sole e che avvolgeva il ‘mondo’ nell’oscurità imperscrutabile, serra di tutte le paure, di fronte all’immediata minaccia per la loro vita.
Ma la ‘paura della morte' si può vincere - si dice - andandogli incontro con spavalderia, aspettando il momento opportuno con convinzione e coraggio, affrontandola sullo stesso piano del ‘soprannaturale’ che mette in campo, venendo a conoscenza di che cosa essa nasconde di terribile e inevitabile, nell’ostinata sensazione che ci condanna a trascorrere notti senza sonno, avvelenando i giorni della nostra vita che avremmo dovuto godere in salute e in piena libertà. Questo gli ‘schiavi’ lo sapevano da sempre, faceva parte della loro conoscenza atavica contrapporre un antidoto al veleno mortale, con l’attuare la ‘catarsi’, inventando riti di ‘purificazione’, di ‘rigenerazione’ e, non in ultimo, di ‘liberazione’ da tutti i lacci ‘orrifici’ e ‘demoniaci’ che li tenevano prigionieri, facendosi essi stessi démoni.
Scrive Zygmunt Bauman (*) “Gli uomini condividono tale esperienza con gli animali. Gli etologi hanno descritto con abbondanza di dettagli il ricco repertorio di reazioni degli animali di fronte a un’immediata minaccia per la loro vita: reazioni che – come per gli uomini – oscillano tra fuga e aggressione”. Ed ecco che gli ‘uomini’ creano i loro riti miticizzando quelli che sono i comportamenti animali e farli propri, indossando le loro pelli e piume, onorando le loro capacità ferali, impossessarsi delle loro potenzialità aggressive di difesa e di attacco, cannibalizzando, in un certo senso, il ‘potere’ intrinseco alla loro natura. C’è dell’orrore in tutto questo ma c’è anche il riconoscimento di sì tanta bellezza assoggettata all’esistente, che immagina strade alternative alla stessa vita.
Provate anche voi a immaginare la notte squarciata dall’esplodere di un vulcano, con le migliaia di scintille incandescenti che illuminano la scena, lo snodarsi di un fiume umano brulicante di lava e avrete appena una minima ‘idea’ di ciò che il Carnevale brasiliano rappresenta: “un ponte ininterrotto tra passato e presente”, tra culture diverse e diversificanti, colori smaglianti e luci sfavillanti, costumi che assomigliano ad uccelli fantastici, una fantasia di maschere voluttuose e orribili, di corpi ‘nudi’ che danzano rapiti dalla frenesia del ritmo e della sessualità più sfrenata. Uno spettacolo per gli occhi colmi di voluttuose immagini che stimolano all’irragionevolezza, che pretendono di abbandonarsi agli istinti corporei e si appellano alla pur mutevole assennatezza umana, di lasciarsi coinvolgere nell’indistinto e indistinguibile volere della carne.
Tutto questo amalgamarsi di ‘immagini’ che – credetemi – non ho qui voluto caricare di maggiore enfasi, neanche un poco, ha un suo comune denominatore, la musica accattivante e inebriante del ‘samba’, la più popolare danza del Brasile, capace del massimo coinvolgimento. Come scriveva Vinicius de Moraes (vedi articolo su questo stesso sito): “Il samba se è bianco di pelle in poesia / è nero nell’anima e nel cuore”; riconoscendo ad esso la capacità di convogliare suoni e ritmi ‘tipicamente’ brasiliani. È l’apoteosi del ‘samba’ e delle ‘favelas’ che, (anche grazie all’aiuto economico di misteriosi finanziatori), molto tempo prima del Carnevale danno inizio ai preparativi. Ogni favela infatti ha la sua Accademia o Scuola di Danza che non si limita soltanto ai numeri di ballo, ma prepara il proprio ‘spettacolo’ danzante, solitamente a tema, crea i costumi adatti, solitamente fantasmagorici, realizzati dalle donne ‘meniniñas’ della favela d’appartenenza.
Per settimane intere i danzatori/trici si esercitano nel ‘samba’ sulla musica prescelta che solitamente contiene una canzone, o più d’una, che farà poi il giro dell’intero continente, passando di bocca in bocca, fino a scavalcare l’Oceano e invadere l’Europa e gli States, grandi estimatori della musica brasiliana. Arredatori e costumisti coadiuvati da una folta ed entusiastica mano d’opera realizzano idee bizzarre e stravaganti che le ragazze ‘creole’ e ‘carioca’, mostreranno sui loro corpi voluttuosi come una seconda pelle immaginifica. Vengono costruiti i carri allegorici dedicati a fatti e personaggi della vita pubblica brasiliana e internazionale che sfileranno poi lungo la grande via della città addobbata per l’occasione.
Non mancano le allegorie religiose dalle forti tinte paganeggianti. La la migliore che si ricordi è quella della Escola Mocidade Independiente di Padre Miguel, intitolata “A festa ‘do divino”, un corteo profano-carnevalesco di eccezionale forza evocativa.La scelta dei colori dei carri, detta la ‘tonalità’ a tutto il blocco sfilante di questa o quella ‘Escola do Samba’ conseguendo un effetto d’insieme di perfetto contrasto tra i gruppi. È così che il rosa si sposa col verde, il bianco da maggiore risalto alla pelle ‘nera’ dei danzatori/trici. Piume e paillettes, broccati e gioielli sottolineano la prepotente bellezza delle ‘creole’. Musicisti, cantanti, bande musicali, i nomi più cari e noti al pubblico brasiliano, fanno a gara per presentare il motivo o la canzone che durante i tre giorni verrà poi dichiarata ‘a furor di popolo’, la canzone ‘Regina del Carnevale’, se ne ricordano un numero infinito quali, ad esempio: “O nosso amor” (Tom Jobim), “A banda” (Cico Buarque de Hollanda), “Nao tegno lagrimas” (Milton de Oliveira), e le epiche “Macunaima” (Marco Moran), “Barracao” (Elizeth Cardoso e Jacob do Bandolin), “Brigitte Bardot” (…), “Manha de Carnaval” (Edu Lobo), e tantissime altre.
Sono questi solo alcuni titoli presi ad esempio, rappresentati di quanto accade durante i tre lunghissimi giorni del Carnevale di Rio, allorché ogni favela scende in città per presentare il suo ‘samba-enredo’ sorta di insieme figurato e vivente. Molte sono le ‘Academie’ ed Escola do Samba’ di larga fama presenti nello stato di Guanabara, che da il nome di ‘carioca’ agli abitanti di Rio de Janeiro e al carnevale stesso, detto infatti ‘Carnevale Carioca’. Tra le più qualificate figurano senz’altro Mangueira, Sangueiro, Portela, Imperio Enredos, Em cima da hora, Mocidade Indipendiente, Villa Isabel, Beja Flor, Imperiatrix e molte altre. Anche se all’attuale alcune di esse possono essere cambiate di nome o scomparse, il loro numero effettivo supera di gran lunga la cifra ufficiale che ne enumera trenta.
“Sono un figlio delle favelas, in esse mi sono formato ed ho conosciuto la realtà della vita, fra la gente. Tra quella gente che fa i preparativi per il Carnevale. Li ho tutti nella mente: trenta carnevali. A Carnevale, nel mio paese, non è soltanto un fatto folkloristico, è prima di tutto un episodio umano e sociale, è una festa d’amore e di sangue” – ha dichiarato Ney Matogrosso, affermato cantante brasiliano, durante l’intervista rilasciatami alcuni anni or sono.
Dopo la grande sfilata delle Scuole, segue una lunga, interminabile, maratona cui il popolo ‘tutto’ partecipa alla baldoria collettiva. Non c’è brasiliano che non vi prenda parte con uguale impegno, occupando la città per tutto il tempo della durata del Carnevale: chiudono le Banche, il Parlamento, i Giornali, restano quasi deserte finanche le Caserme militari (per le numerose licenze), sì che ‘è impensabile in quei giorni perfino organizzare un colpo di stato’. Ovviamente dal 1985, data di questo lungo articolo (qui ripreso in gran parte) apparso in ‘Super Sound’ (rivista musicale di successo), qualcosa è certamente cambiato. Quello che non è cambiato è invece il ‘Samba’.
“Non c’è samba senza carnevale, non c’è carnevale senza samba”, questa frase fatta è la chiave per meglio comprendere che cos’è il ‘Samba’ nella sua etimologia e di che cosa si compone. Sinonimo di ‘danza’ è parola considerata alquanto magica e misteriosa nella sua essenza musicale. Incrocio fra modi ritmici africani e moduli della cultura melodica portoghese, le popolari ‘rodas’ che hanno portato ad uno speciale equilibrio tra ‘samba’ e ‘saudade’, come di ‘due facce di uno stesso volto’ che si affrontano in una ‘rinata’ quanto originale espressione musicale ricca di contrasti: ‘negra’ nei ritmi, ‘creola’ per la sua formale noncuranza del ‘saudade’. Altra parola intraducibile che si avvicina al comune senso di ‘nostalgia’ e ‘rimpianto’.
Il Samba propriamente detto da il nome alla danza brasiliana per eccellenza, che viene posta fra il ‘turundu’ autoctono, dalle forti tonalità drammatiche, e il ‘fandango’, una rielaborazione del ‘tango’ argentino. Molto diffusa è anche un’altra danza detta ‘tempo di marcia’ dal tono gioioso, utilizzata soprattutto durante le sfilate del Carnevale, che prende nomi diversi secondo l’uso che se ne fa: ‘Caporeira’, ‘Marchina’, ‘Xaxado’ e ‘Baiao’. ‘Maxixe’ è invece una danza propriamente folkloristica dal colore paesano, tipica delle provincie di Rio e Sao Paulo; mentre il ‘Rasguado’ dal ‘tempo’ più disteso presenta notazioni tipiche dell’Argentina. Il ‘saudade’ brasiliano è ben rappresentato dal ‘Frevo’, ‘Choro’ e ‘Maracatù’.‘Samba’ vuol dire anche poesia, racconto, lamento, tristezza, sentimento espresso in versi in quasi tutte le canzoni, vecchie e nuove, nella loro pur semplice compiutezza. In brasiliano dire: ‘Piangere di gioia’ è come dire ‘samba’. L’incontro di due note musicali in ‘Samba de duas notas’ (Luiz Bonfa) è ‘samba’, come lo è ‘Samba de bençao’ (Moraes – Powell), utilizzato come sinonimo di allegria di colori, speranza e felicità. “Samba è vita! Fare un samba non è una barzelletta. Il samba è preghiera se lo vuoi. Samba è tristezza fatta danza, la tristezza che ha sempre la speranza di non essere triste prima o poi” – ha scritto Vinicius de Moraes in una sua canzone di successo.
Accanto ai ritmi e alle danze, uguale importanza assumono quelli che sono gli strumenti tipici della musica brasiliana che, nelle nuove formazioni, convivono con quelli più evoluti della moderna tecnologia. Infatti, a fianco del sassofono-contralto o baritono e delle chitarre elettriche, dei vibrafoni e dei sintetizzatori, troviamo la ‘sanfona’ una piccola fisarmonica diatonica; il tradizionale ‘flauto’ nelle versioni amerindo piccolo e basso; il ‘berimbao’ d’importazione africana composto da un arco di legno sottile lungo il quale corre una sola corda metallica, fissata a una zucca che fa da cassa di risonanza armonica. Accanto a questi prosperano una folta famiglia di chitarre: il ‘cavaquinho’ o chitarra piccola a quattro corde; la ‘violao’ ovvero la chitarra classica; la ‘viola’ paesana a dieci corde; la ‘chitarra portoghese’ denominata ‘a-laù-dé, molto simile al liuto. Quasi senza numero, gli strumenti a percussione vanno dai semplici ‘legni’ a ogni sorta di ‘atabaques’, taburi e taburelli d’ogni forma e dimensione dai nomi fantasiosi: ‘surdo’, ‘caixa’, ‘cuica’, ‘tamborin’, ‘pandeiro’. Altri ancora, di fattura artigianale povera, sono l’ ‘afuché’ corrispondente alla noce del cocco avvolta da una collana di conchiglie; il ‘choralho’ tubo metallico chiuso alle estremità contenente semi e piccole pietruzze; il ‘reco-reco’ segmento di bambù tagliuzzato che si gratta con la bacchetta; l’ ‘agogò’ insieme di campanelle fissate su di un manico; l’ ‘apito’ fischietto che il capo della Escola usa per comandare i danzatori, e altri ancora.
In passato, a ognuno di questi strumenti, era attribuito un valore magico, talvolta religioso, connesso con l’uso dell’accompagnamento vocale che diventava ‘corale’ nei canti pastorali, marinari, sacri e sentimentali. Successivamente, con il riproporsi del ‘tropicalismo’ e della ‘musica nova’ si è raggiunto il drammatico e l’intellettualismo in musica, per lo più espresso nel 1935 con due film “Alò alò Brasil” e “Alò, alò Carnaval” di Ademar Gonzaga interpretati da Carmen Miranda protagonista e cantante di successo che la fecero conoscere in tutto il mondo e con lei il favoloso ritmo del ‘samba’. Successivamente, nel 1950, sarà “O’ Cangaceiro” di Lima Barreto, con le musiche originali tipicamente brasiliane di Gabriel Migliori, e “Macunaima” di Joachim Pedro De Andrade, che il folklore brasiliano uscirà definitivamente dai limiti nazionalistici; seguiti da “Orfeo Negro” del 1959, diretto da Marcel Camus su un progetto di Vinicius de Moraes con le musiche di Bonfa e le stupende canzoni di Joim, Bonfa e lo stesso De Moraes.
Non vanno dimenticati però due straordinari ‘cartoon’ diretti allora da Walt Disney: “Saludos Amigos” (1942) del quale faceva parte lo strepitoso “Aquerela do Brasil” di Ary Barroso e Miguel de Olivera; e “Los tres Caballeros” (1944) con il divertente “Os quindinis de yaya”, che contribuirono in modo stravolgente al successo e consacrarono la musica brasiliana a livello internazionale. Da ultimi vanno qui segnalati due film: “Dona Flor e i suoi due mariti” (1976) diretto da Cidiclea Miranda appunto tratto dal romanzo di Jorge Amado e le musiche di Cico Buarque de Hollanda e la hit internazionale “O que serà”. E “Central do Brasil” un film brasiliano del 1998 diretto da Walter Salles, nominato all'Oscar al miglior film straniero.
Scrive ancora Jorge Amado:
«Più in là un senatore, un fazendeiro, un vescovo, un diplomatico la moglie del senatore chiacchierano nella buona pace borghese di chi possiede il regno della terra e la certezza di potersi comprare quello del cielo.»
«Sì - dice il fazendeiro – per il raccolto non c’è male. Ma i prezzi...»
«Via, colonnello, la vuol dare a bere a me? … Anche al prezzo attuale, il caffè continua a dare guadagni da capogiro … È la ricchezza di Sao Paulo, e del Brasile.»
«Anche perché il Brasile è São Paulo”» intervenne la moglie del senatore, bairista in modo irritante.
Era il diplomatico a parlare. Primo Segretario dell’Ambasciata a Parigi, non aveva ancora reso alla Patria il suo primo servigio di rilievo. Era nativo di Bahia, e nel sangue e nei capelli crespi portava traccia delle libertà che i suoi antenati portoghesi si erano presi con le sue bisavole africane.
«..ma ne esistono altri, di grandi Stati. Guardi Bahia per esempio. Vede, Eccellenza, Bahia produce di tutto … dal cacao al tabacco, ai fagioli. E uomini, signora mia, uomini di genio … Rui Barbosa era baiano …»
«Non dica di no, signora. Ancor oggi esistono a Bahia persone di grande talento.»
“Has estado en Baia?”
E noi, prossimamente, ci condurremo a Bahia per scoprire quello che il Carnevale brasiliano ancora ci riserva in ambito musicale dopo i movimenti evolutivi che dall’afro-samba e della ‘bossa nova’, fino al jazz-samba che ben si attagliano al moderno Brasile.
Nota: I brani narrativi "virgolettati" sono tratti da Jorge Amado “Il paese del Carnevale” – Garzanti 1984.
*
 - Mitologia
- Mitologia
SFINX - In nome della sfinge.
Shesep Ankw, (antico nome 'ieratico' della sfinge) il volto del dio vivente.
Quale “immagine del dio vivente” la Sfinge simboleggiava un tempo la potenza del Faraone che proteggeva il bene e scacciava il male, messa a guardia del tempio di Osireion (oggi in fase di recupero), probabilmente voluta da Khafre o Khefren (Chepren IV dinastia) e risalente al periodo detto dell’Antico Regno. Da nessuna delle fonti si rileva però, che il volto della Sfinge riprodurrebbe il volto del faraone che l’ha commissionata, poiché ci troviamo di fronte alla totale mancanza di testi che ne confermano l’attribuzione.
Idillio (dell’apparente bellezza).
“Da tutte le cose Uno … e da Uno tutte le cose” recita un frammento di antico papiro, arguendo sulla metafisica dell’ordinamento del mondo in costante tensione e apparente conflitto, per cui: “tutto ciò che esiste muta, e il mutare è al tempo stesso contesa, che va oltre l’umana comprensione, quando, davanti all’armonia sì grande del creato, essa s’affissa e non se ne fa ragione”.
Quando, nel rimare l’umano ch’è in sé, chi vive in mezzo a sì eclatante bellezza, tosto si bea nella molteplicità che fa dell’immagine una “verità” assoluta, al passo col tutto, che concesso gli è far conoscenza d’ogni cosa della terra, dell’aria, dell’infinito astratto, poiché il soggetto ultimo dell’uomo è l’uomo stesso, così come il fine dell’armonia del creato, è in altro modo un Sé medesimo che si scinde nei molti.
Non v’era dunque idillio che non potesse accadere, né che l’incomprensione dei molti si discostasse dall’Uno, né viceversa, che la volontà dell’Uno non ricadesse sui molti, su tutti coloro che per una coincidenza tensionale degli opposti, fossero giunti a chiedersi di conoscere se stessi, nel corpo e nello spirito che gli erano propri, così come delle cose e dell’armonia che sono del mondo.
Così come non v’era limite che non potesse superare, che oltrepassare dell’aldilà la soglia non gli era concesso, “senza prima aver sollevato ciò ch’era inferiore a lui, e abbassato ciò che lo sovrastava”; che d’ogni misura era possibile venire a capo, che all’enigma del creato corrisponde un logos certo, che della profondità dell’anima si fa ragione, fino a raggiungere l’armonia cosmica, illimitata, sconfinata, e tuttavia manifesta.
La Sfinge dunque, come immagine statica nel mutamento, assisa tra la notte e il giorno, tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, soglia e frontiera lungo la quale transita il perituro e l’imperituro, in cui l’Uno si manifesta nella pluralità molteplice, affermazione dell’illimitatezza, dell’armonia nascosta che regola tutte le cose: il movimento degli astri, le fasi della luna che ne fa rifulgere lo sguardo.
Quand’anche la sua vista fosse spenta, il suo sguardo pur rimira nella notte la luce infinitamente lontana che oltre la curva declina all’estremo margine dell’universo, nell’attesa costante del riaccendersi del giorno. E la sua bocca, quand’anche fosse muta, deturpata nell’estremo anelito, pur dice, e il suo dire è logos eterno, è verbo, causa e sostanza che lega l’Uno alla molteplicità delle cose, e tutte le genera nel loro mutare.
Simbolo e mistero dell’enigma che da sempre opprime l’anima umana, la cui misura è nella “misura delle cose”, a cui tutto appartiene: il pensiero dei singoli come l’utopia dei molti, i costrutti e gli amplessi, le argomentazioni e le strutturazioni, così come le costruzioni ardite, le città ideali solidificate entro emisferi di cristallo, verticalizzazioni inimmaginabili che s’impongono come misura di tutte le cose.
In ciò che tutto riassume in modo inequivocabile, il buono e il male, la bellezza e la bruttezza del mondo, il sogno e la veglia, la vita e la morte, in un non-luogo fuori della realtà, all’origine d’una mitologia sommersa che risorta dalle sabbie del tempo, entra nella leggenda, come sulla superficie di una tela o meglio, d’una scultura rubata alla pietra, partecipe della costruzione del mondo, che si erge a difesa di un feudo di sale.
A Ghiza, dove il vento del deserto risveglia il sonno dei dormienti, talvolta si leva il suono d’una melodia, o forse un canto, ora flebile, ora sostenuto, compagno della veglia e del sonno, che ha permesso di chiamare soglia quella che invece è una frontiera posta tra la notte e il giorno, tra l’oscurità e la luce, nel cui spazio interstiziale l’uomo è colui che sta in bilico tra la vita e la morte, tra la fine relativa e la rinascita apparente.
È qui, che nell’assoluto enigma dell’esistenza, la Sfinge leva il suo sguardo altero. Il deserto è là, e invita al mistico sentire l’imperscrutabile bellezza del creato, il cui silenzio rallenta i ritmi melodiosi della vita. Quando la vita oltrepassa la sua naturale durata e s’avvia verso l’assoluto, in cui tutto è partecipazione, tormento, passione, dolore, sofferenza, coinvolgimento d’amore, in grado di sedurre l’animo del più sensibile amante.
Idillio (dell’amore assoluto).
Il Sole era ormai prossimo all’orizzonte quando i due segreti amanti sigillarono abbracciati i lacci scarlatti dei loro pari destini, rivestendoli di una luce morbida e velata, a voler dare una sembianza di conciliazione che attenuava, pur nella lacera e irriducibile tensione dei corpi, il compimento del loro atto d’amore in un unico afflato, che le sabbie del tempo avrebbero reso supremo.
Lui, Leone fiero sotto la folta criniera di fuoco, guardava altero davanti a sé quell’orizzonte lontano, conquistato dalla passione che avvampa, che arde, che brucia, prima di abbandonarsi al tutto. Lei, Leonessa superba e franca, pronta a immolarsi nell’amplesso e diventare con Lui tutt’uno, immagine d’una stessa immagine, androgina e virginea, umana e antropomorfa, s’accovacciava al suo fianco, rapita da una passione che un’idea luminosa e splendente trasfondeva in un lucore arcano e febbrile.
Li sorprese il crepuscolo, che più non era luce e ancor non era buio, ove altre realtà si nascondevano: l’amore e l’orrore, il bagliore e la notte, la vita e la morte, che mute giacevano sopite nel cuore della Terra e nella dissolvenza dell’Aria, che aspettavano d’essere svelate. E come per un’istanza lineare e obliqua, beffarda e terribile, assecondando l’atto del concepimento avito, al tempo stesso, la Terra, “madre di tutte le cose”, li nascose al bagliore del guardo divino.
Allorquando, voltisi a guardare là dove il profondo buio ancora non era, appresero sorpresi d’affrancare il volere supremo di abbandonare il passato, e lasciare che il tempo irrompesse nel mito che sarebbe stato. Non già come ricordo, bensì come anelito estremo, per allontanarsi colà, ove si estendevano le regioni della lunga notte dell’oblio, fin dove l’avesse raggiunti la corretta forma in cui apparire.
“Noi siamo l’ultimo bagliore del tramonto e la prima luce del mattino”, disse superba Lei, e tuttavia muta, che nel pronunciare l’oracolo avrebbe disvelato la profetica aspettativa che sospingeva entrambi a entrare a far parte della bellezza che avrebbero incarnato. Ancorché la sabbia del tempo avesse discoperto, fra l’assoluto e il nulla, l’immagine suscitata da quell’idillio, frutto del loro amore appassionato.
Quella stessa bellezza che imponendosi all’evidenza, ometteva l’ambiguità d’una felicità pur raggiungibile, con una sorta di paradossale equivalenza tra innocenza e male, espiazione del castigo e del dolore, condizione essenziale per la rinascenza dell’androgino che i corpi dei due amanti, in uno solo uniti, avrebbero rappresentato.
Ma la densità dell’ineffabile, che non era della parola, prese luogo in Lui, illuminato ad aprirsi, a mostrare, nella vertigine insidiosa del lucore, sotto lo strato indicibile della sua esperienza terrena, lo strato nascosto dell’altro che avrebbe incarnato, al margine tra la spiritualità e la sensualità, in quel labirinto posto al limite del possibile, in cui tutto infine si perde, prima di assurgere alla soglia dell’eternità, alla struggente bellezza del creato.
Il mito era già lì, presente, immerso nell’abbaglio del Sole del Mattino, “il primo mattino del mondo”, nato da un enigma irrisolto e irrisolvibile dell’esperienza divina, silenzioso eppure vivo, scolpito nella consistenza della pietra. Un’entità dal volto umano e il corpo leonino che si dispiegava in un demoniaco sorriso appena trattenuto, nella bellezza del divino che il tempo non avrebbe mai più cancellato, testimone luminoso di un segreto oscuro che avrebbe attraversato i secoli a venire.
L’Ora era ormai prossima al tramonto, “l’ora più bella”, quando la maestosa Sfinge, levatasi dalle sabbie che la tenevano sommersa, muta parlò dagli antri segreti della pietra d’una verità sommessa e piana, immota eppure in movimento, resa luminosa dalla superiore chiarezza del sapere che l’anima e l’intelletto contemplava: “poi ché del ver m’è tolto, (del nulla) assai m’appago”, avrebbe detto il poeta (millenni dopo) di fronte all’infinita notte che lo sovrastava.
Idillio (della pace interiore).
È qui, che nell’assoluto mistero del deserto, levasi impercettibile il respiro sommesso delle dune, come un suono melodioso che varia nel tono, ora più acuto, ora più basso, quasi di flauto o di strumento a corda; o forse di canto, una remota nenia che i sottili granelli di sabbia sgrovigliano, e che fa vibrare le dune di un tremito sottile, interiore, coinvolgente, capace di sedurre l’animo del più sensibile amante.
Come un sussulto del cuore profondo del mondo, o forse un affanno, che risuona di granello in granello, da una duna all’altra, da un deserto all’altro, il cui flusso sonoro investe l’intero corpo astrale e si conduce nello spazio cosmico, dove finanche l’eternità non ha più senso, poiché nel concerto dell’immenso risuona d’organo ogni singola voce, il pianto, il riso, il canto, ogni battito del cuore, ogni singolo respiro.
È qui, che il calpestio dei Cavalli del Sole, che lo sbattere dell’Ala del Falco, agitano il Leone che si cela nell’amante focoso, al cui fianco la Leonessa dall’ambito cuore, giace sommessa col generoso petto sulla calda sabbia del tempo, nell’attesa d’essere fecondata e che, nel tempo dell’aspettazione, apprende del profondo respiro che le sussurra accanto, acciò che il corpo disciolto dell’amante continui a rifluire in lei.
È come un getto che la sabbia improvvisa accoglie, e che si effonde nella guelta d’acqua purissima, che rende fertile ciò che prima era soltanto seccura; che alla tamerice dona la certezza del rigoglio, alla palma il nutrimento vitale, al sicomoro la gloria di un aldilà sempre fecondo, la cui ombra, che pur si distende sui muri del tempio, riveste di sacro nel canto e nella preghiera levata agli dei che sovente si manifestano tra le sue fronde.
Qui, nel complesso sincretismo della concezione osiriaca, che il ba, il destino oltremondano dei due amanti, s’avvale della certezza, dopo la morte, di continuare a vivere fino al loro risorgere a nuova vita, in un unico corpo, che insieme racchiude e conserva la natura e l’identità di entrambi. Ancorché paghi, guardano alla molteplicità che si rivolge all’Uno, affinché il Tutto sia spinto alla vera bellezza che rende visibile il segreto.
Tanto più nettamente si delinea la dualità dell’Uno, tanto più appare chiaro che nella bellezza svelata può darsi solo il sublime. Acciò che nella coscienza della sopravvivenza individuale, né l’uno né l’altro, preservati nello spirito, desiderano tornare a essere ciò che sono stati, ora che la forza e la regalità del maschio, così come la generosità e l’individualità della femmina, vivono uniti nel corpo accogliente della nuova creatura, la Sfinge dal volto austero, certi oramai “dell’eterno anelito dell’umano sentire”, che non troverà mai fine.
È qui, che più d’ogni altra personificazione, emerge colossale il segreto della sua origine divina, la cui immagine e orientamento la elevano a guardiana del Sole, astro di vita, di luce che scaccia le tenebre. Genio oculare di tutte le rinascite, il cui persistere nel mito sprigiona dallo sguardo avito del suo volto umano, nella manifestazione ierofanica che rifulge dal meraviglioso arco dei suoi occhi.
Simbolo univoco di grande mestizia pur nella sua maestosità, la Sfinge è l’incarnazione vivente di un dio aureolato di fiamme (nemes), che risplende come Hou-de-Horem-Kou, l’Horo (il dio dalla testa di falco) e Râ-Hrakhte (l’occhio che vigila sull’Orizzonte), la cui autorità si riflette nello scettro del potere solare, supporto divino di quello stesso “io”, di cui anche il faraone poteva dirsi figlio.
È questo il luogo, sulle rive del Nilo, che la possente Sfinge, poggia sulla sabbia i suoi crudeli artigli, affondandoli sul corpo massiccio della roccia nella quale si modella a immagine e somiglianza del divino, dal quale sono usciti tutti gli esseri “viventi”, immaginari e immaginifici, oltre che i munifici faraoni che fecero grande l’Egitto, coloro i quali s’apprestarono a significare la preponderanza dello spirito sulla natura umana.
Uno spirito ambiguo e tuttavia luminoso, capace di insufflare tutt’intorno, nelle specie viventi, anime di vita e principi intellegibili, in cui si ravvisa l’accoppiamento sconvolgente dell’animalità sacra e del pensiero divino, il cui limo rigeneratore, elemento primordiale che influisce sull’opera della perfezione, trova nel corpo fertile del proprio essere mascolino/femminino, il suo sfogo e il suo godimento.
È quì, infine, dove la divina Sekhmet mostra i suoi seni rigonfi, provocatori del suo petto, simbolo di ringiovanimento e di rinascita, nel ricordo che si compie “in suo nome” l’immane lotta per la vita, la selezione dei più forti, la fatalità che condiziona le sorti; madre e nutrice la cui interiorità risplende dei sogni e delle incertezze di quell’Eterno che a lei si è ispirato fin dall’origine del tempo.
Se mai gli uomini costruiranno un tempio all’universale bellezza del creato, il suo modello non potrà che essere lei, la maestosa Sfinge, nella sua duplicità maschile, in cui si avverte la forza e l’audacia contenute nel Leone che veglia sulla rinascita del Sole (Horo, Râ); e l’eterno femminino della Leonessa (Sekhmet, Nut) la dea infernale e celeste, oscura e solare, che leva lo spirito di luce e di eterna verità sulla grande anima del mondo.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Cantico di Natale 4 - ’Anno Domini’
(mito e leggenda di una tradizione sempre viva)
(Testo originale della trasmissione omonima radiofonica scritto per “Studio A” della Radio Vaticana. Da “ANNO DOMINI”: Usanze e costumi di una tradizione – di Giorgio Mancinelli - Grafica e Arte Bergamo. Copyright 1989).
V
La festa del Natale è ancora nell’aria e raccoglie unanimi consensi fra le genti dell’Europa tutta e gran parte del mondo. Il suo significato è comunitario, dovuto principalmente all’espandersi fra le genti, di condizioni di vita similari, ed al cumulo di medesime esperienze artistico – culturali - religiose, determinatesi all’interno del processo di assimilazione delle forme ‘espressive’ e ‘suggestive’ popolari che ne hanno permesso infine la secolarizzazione.
L’intensa e ricca costumanza fiorita intorno a questa festa, indubbiamente più gioiosa della cristianità, si può sfogliare, usanza per usanza, e leggere negli antichi riti agresti sopravvissuti in moltissimi aspetti e varianti ampiamente riconoscibili che, ritroviamo in quelli che oggi formano la tradizione di molti popoli dell’Europa: Noëls, Weihnachtslieder, Carols, Koledy, Villancicos, sono altrettanti ‘canti’ natalizi che qualche volta c’è capitato di ascoltare durante il periodo festivo. Suggestive, quanto ispirate, le canzoni riferite al Natale appartengono di fatto a quei popoli, ognuno nella propria lingua, che partecipano uniti nel giubilo del canto, che dobbiamo alle tradizioni di ogni singola nazione.
I canti davanti al Presepe, le luci fluttuanti delle candele accese, le decorazioni floreali, i dolci tipici, i doni, gli stessi preparativi per la festa, sono parti insostituibili del rituale che trasforma il Natale nella festa, ed anche come spettacolo di costume che, pospone alla celebrazione liturgica, l’invito a ritrovarsi, in senso corale, nel canto comunitario che si leva con partecipazione cristiana. Riuniti per l’occasione della festa, anche noi abbiamo levato un ‘canto’ all’abete, simbolo della felicità duratura, così come anticamente e ancora oggi vanno facendo le genti dello Schwarzwald: chi non ricorda quel “O Tannenbaum”:
“O abete, come sono verdi le tue fronde
Nel gelido inverno il tuo
Verde abito m’insegna che la speranza
E la costanza, danno
Coraggio e forza in ogni tempo...”.
L’uso di preferire l’abete a tutti gli altri alberi ha origine espiatoria ed è legato ad un tempo arcaico in cui le tribù germaniche della Foresta Nera, festeggiavano il Solstizio d’Inverno agitando i rami verdi dell’albero, in una danza rituale in cerchio che stava a simboleggiare la nascita del primo sole ancestrale.
Il “Grande Libro della Natura” affida ad ogni pianta una precisa funzione deducibile dalla conoscenza; così un fiore, un’erba o un albero, hanno assunto nel tempo significati allegorici che l’essere umano ha tradotto in un ampio vocabolario simbolico, nel quale, ad ogni singola pianta, vengono riconosciute proprietà intrinseche al profumo, alla forma delle foglie, al fatto di essere più o meno sempreverdi e altre.
L’ ‘agrifoglio’ è, ad esempio, il più gradito, se bene sia anche il più austero. Insieme al ‘vischio’ spartisce il fatto di essere tipicamente augurale per l’anno che deve arrivare. Simbolo di difesa, si vuole che le sue foglie, dotate di aculei, scaccino gli spiriti maligni.
L’ ‘alloro’ è invece simbolo di regalità ed anche allegorico della poesia; mentre il ‘biancospino’, il ‘caprifoglio’, l’ ‘edera’, il ‘ginepro’, il ‘pungitopo, il ‘rosmarino’ e alcuni tipi di ‘rosa selvatica’, sono considerate piante tipicamente natalizie per il fatto che, essendo sempreverdi, si spartiscono l’onore d’essere di buon auspicio della continuità della vita. Usate per lo più nella preparazione di semplici ghirlande e festoni, per via dei loro fiori che gemmano in inverno e non appassiscono, si vuole servano a stabilire una sorta di continuità, un sotterraneo contatto tra gli uomini e lo spirito della natura.
Ma è al ‘ceppo’ di quercia che forse dobbiamo una delle più antiche tradizioni italiane, tipica delle regioni del settentrione ma che ritroviamo anche in Svizzera, in Belgio, così come in Bosnia ecc. :
“Era detto ‘ceppo’ il grosso tronco d’albero tagliato e messo a bruciare il giorno della ‘vigilia’ di Natale e che di solito si faceva durare fino a Capodanno e, in alcuni casi, se l’inverno era molto rigido, anche fino all’Epifania. Il nonno, lo spegneva durante le ore tiepide del giorno: «...per farlo durare più a lungo» - diceva. E non perdeva occasione di rammentare, a noi bambini di casa che stavamo ad ascoltarlo, il significato di quelle che egli diceva essere la più antica tradizione della nostra regione. Era così che abbinava la durata di dodici giorni del ‘ceppo’ ai dodici mesi dell’anno, cioè al giro che la terra compie attorno al sole, da cui gli auspici e gli influssi benefici per tutta la famiglia.
Inoltre, era anche solito rammentare la potenza purificatrice del fuoco, la cui cenere egli in parte conservava, considerandola detentrice di arcane virtù alchemiche. La tradizione voleva che si tagliasse il ‘ceppo’ qualche tempo prima dell’Avvento. Poi, nel giorno stabilito dal Calendario lunare, veniva deposto su uno speciale alare di ferro, battuto e acceso tra la gioia di tutti quanti. Noi fanciulli venivamo bendati e fatti girare intorno al ‘ceppo’; si doveva picchiare con le apposite molle il ciocco ardente e recitare una filastrocca augurale: l’Ave Maria del Ceppo, alla quale si attribuiva la virtù di farci arrivare ogni sorta di doni.
“Ave Maria del Ceppo
Angelo benedetto
L’angelo mi rispose
Portami tante cose”.
Il rituale qui sopra descritto si completava proprio la notte della Natività del Bambino di Bethleem, allorché, il nonno per primo, versava un bicchiere di buon vino sul ciocco acceso nel focolare; dopodiché ad ognuno della famiglia, era permesso di gettare nel fuoco le briciole del pane consumato, bucce di mele e di mandarino. Allora il fuoco crepitava e la fiamma avvolgeva il ‘ceppo’ per intero. La luce improvvisa della fiamma illuminava tutt’attorno, le facce perplesse di noi fanciulli, le rughe espressive dei vecchi, della mamma e del papà, che ci osservavano crescere con amore.
Animava, per così dire, il piccolo Presepe nell’angolo in ombra della stanza, dove la ‘favola’ diventava per un momento realtà. Il fatto ‘meraviglioso’ della nascita del Bambino, suggellava la saggezza antica di tutto un popolo che in quella Notte di Natale si raccoglieva nelle proprie case a suggello di una tradizione agreste di fecondità e di buon raccolto, che restituiva al fuoco il significato ancestrale di espiazione e di rinascita”.
Voglio qui ricordare un grande poeta italiano del novecento, Giuseppe Ungaretti, al quale devo l’aver ritrovato in questi anni il ‘senso’ intrinseco del Natale, delle cose buone che mi legano alla famiglia, ai bei ricordi sempre vivi, alle fantasticherie giovanili, alla quiete e la pace ritrovata, magari aspettando che arrivino i Magi o, forse, la Befana:
“Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo di strade
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi così
come una
cosa
posata
in un
angolo
e dimenticata
Qui
non si sente
altro
che il caldo buono
Sto
con le quattro
capriole
di fumo
del focolare”.
VI
Con l’Epifania di Nostro Signore si conclude il ciclo delle festività legate alla Natività. Il Natale e l’Epifania sono infatti interscambiabili, perché storicamente, calendarmente, liturgicamente dicendo, fissavano un tempo, e in qualche modo ancora oggi, la medesima festa solstiziale, che abbraccia quindi i giorni e le notti incluse dal 24 dicembre al 6 di gennaio del nostro Calendario attuale.
È qui utile sapere che il calendario riferito al Natale, fa parte di un ‘ciclo’ di dodici giorni, le cui date d’inizio variano sostanzialmente, sebbene siano scandite dalle ‘calende’ che vanno: dal 13 novembre al 4 dicembre; dal 25 dicembre al 5 gennaio; dal 1 al 21 gennaio; in rapporto con le credenze arcaiche di trarre buoni presagi per il futuro. Recita un vecchio detto popolare ancora in uso:
“Le Calende della festa del Sol
le mostra al mondo quel che
Crist’vol”.
La fantasia popolare ha avuto, indubbiamente, parte preponderante nel costituirsi dell’alone ‘meraviglioso’ che circonda la festa del Natale e ovviamente l’Epifania che la Chiesa celebra nel giorno calendariale del 6 gennaio, con la quale si commemora la visita che i Magi federo, passati tredici giorni dalla nascita del Bambino a Bethleem, e con la quale si stabilisce la continuità del racconto evangelico che riafferma la contemporaneità della realtà storica e la tradizione popolare dell’evento miracoloso. A questo proposito, propongo qui un testo letterario che Roberto Vecchioni ha trasformato in un Canto di Natale, intitolato “Dalle Stelle Alle Stalle” (Canzone di natale in prosa):
“È notte, un'ombra sorvola furtiva la vecchia fattoria. Qui le cose non vanno molto bene, mormora tra sé e sé, inventerò un giorno per metterle a posto e sarà un gran bel giorno per tutti, lo chiamerò NATALE. Se pensi che è difficile un anno da formica, sapessi a far la volpe, rubare è una fatica! E a noi farfalle allora? Dicono che siamo leggere, un fiore dopo l'altro, è proprio un bel mestiere! E a un topo? Mai che capiti una giornata al mare! E a chi interessa un'orsa che piange per amore o una cicala povera col vizio di giocare o un grillo senza musica e case discografiche? Ma noi balliamo, e poi balliamo e poi balliamo ancora. La stella che ci illumina in fondo è quasi nuova e l'anno nuovo è nuovo per una volta sola. Le chiocciole da tempo ormai si affittano la casa. Se le galline mancano, i lupi vanno in chiesa. I coniglietti aumentano tanto da far spavento e i millepiedi scappano, insomma qui è un tormento! Ma alla formica toccherà il seme nella neve, al topo niente trappole, alla farfalla il fiore, al grillo la sua musica, alla cicala i dollari, ai coniglietti "pillole", e all'orso un grande amore. E noi cantiamo, e poi balliamo e poi balliamo ancora. La stella è tanto bella che sembra quasi finta e l'anno nuovo è nuovo, la notte adesso canta. Ma noi balliamo, e poi balliamo e poi balliamo ancora. La stella che ci illumina in fondo è quasi nuova e l'anno nuovo è nuovo per una volta ancora”.
Il testo, scandito sulla musica di quel “O Tannenbaum”, (in italiano ‘O albero’) che molti di noi hanno cantato sui banchi di scuola, è di per se molto interessante dal punto di vista dell’inventiva e della creatività di un autore che ha dato ampia dimostrazione di possedere una certa dote di fantasia che s’avvicina molto al ‘meraviglioso’ che ho voluto fin qui narrare e che, va nella esattamente nella direzione popolare dei ‘vangeli apocrifi’ che si rinnova, a distanza di duemila anni, nel proporsi e riproporsi nel segno della natura. O meglio, calcando le orme dell’arcano e del magico, sulla scia del ‘verosimile’ interpretativo, talvolta ancor più bello ed entusiasmante del ‘vero’, come solo Roberto Vecchioni ha saputo dare alla canzone italiana.
Più che in ogni altra memoria, l’avventuroso quanto misterico cammino dei Magi, trova nella “Legenda Aurea” del XII sec., di Jacopo da Varagine (1228-1298), e nella successiva “Historia Trium Regum” del XIV sec., di Giovanni da Hildesheim (1310/20-1375), quella immediatezza di linguaggio tipica del racconto popolare, umanamente accettabile, capace di affascinare e stupire dopo quasi un millennio. Il cui significato, trascende il confutabile della storia, per avvicendarsi nell’inconfutabile della narrazione fantastica e che, tiene ‘la vicenda’ come sospesa al filo incantato della ‘favola’ bella.
Il ‘ciclo’ delle leggende riferite all’arrivo dei Magi a Bethleem è indubbiamente tra le cose ‘meravigliose’ riservate dalla tradizione all’evento del Santo Natale. L’arrivo dei Magi va quindi legato ai doni che questi portano al Bambino dall’Oriente: l’oro, l’incenso e la mirra, entrambi simboli della missione ‘divina’ del Signore fin dalla sua nascita. La fantasia popolare, che nulla lascia di intrapreso, ha trasferito l’atto del portare i doni al Bambino di Bethleem, come un gesto d’amore che si ripete ancora oggi, portando in questo giorno calendariale i doni ai bambini, ripetendo così un ‘atto’ divenuto catartico nella storia, delle vicissitudine (leggi colpe) a cui si legano i genitori nel metterli al mondo.
La parte laica, cercando fra i personaggi della realtà cui attribuire questa incombenza, si fa riferimento alla figura del ‘buon padre’, talvolta riconosciuto in uno dei Magi, che torna dal suo viaggio; e dalla Befana nel personaggio della vecchia o la nonna, appartenente in origine al mondo delle fate della più antica tradizione Europea. Comune a molte genti, la figura del Buon Padre, detto Babbo Natale in Italia, domina oggigiorno la scena natalizia: in Gran Bretagna, ad esempio, ha assunto il nome di Father Christmas, in Francia di Pere Noël, Sinter Klaas in Olanda, Santa Klaus in Germania, Samicklhaus in Svizzera.
Bonario e sorridente, soccorritore dei bisognosi, vescovo o santo, è più semplicemente un buon nonno allegro, dallo sguardo cordiale. La sua figura di vecchio si presenta con una folta barba bianca che ne nasconde l’età. Piuttosto lo si direbbe il ritratto dell’antica saggezza contadina, se bene il suo vestire adorno, il suo arrivare a cavallo o trainato da una muta di renne, ce ne diano una raffigurazione elegante e ricercata. Una certa iconografia lo vede con un enorme sacco in spalla dalla capacità inesauribile dove sarebbero contenuti i doni che egli distribuisce con relativa prodigalità un po’ a tutti, soprattutto ai bambini.
Ne riporto qui il testo originale che nel tempo è stato cantato dai più grandi nomi del panorama musicale mondiale, da Bing Crosby, Frank Sinatra a Elvis Presley, da Bruce Springsteen a Michael Boublè e tantissimi altri. Ha dell’incredibile il fatto che moltissimi artisti e gruppi rock, a un certo momento della loro carriera abbiano sentito la necessità di misurarsi con una canzone natalizia e mi piace pensare che non sia stata sempre una operazione prettamente economica.
“Santa Claus is coming to Town” (J. Fred Coots, Henry Gillespie, 1934) è oggigiorno considerata forse la più conosciuta canzone natalizia entrata nella tradizione anglosassone:
“You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list,
And checking it twice;
Gonna find out Who's naughty and nice.
Santa Claus is coming to town
He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!
O! You better watch out!
You better not cry.
Better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town”.
Faresti meglio a guardar fuori / Faresti meglio a non piangere / Faresti meglio a non fare il broncio / Adesso ti dico perché / Babbo Natale sta arrivando in città / Sta facendo un elenco / E la controlla due volte; / Troverà che è bravo e chi è birichino / Babbo Natale sta arrivando in città / Lui vede quando dormi / Lui sa quando sei sveglio / Lui sa se siete stati buoni o cattivi / Allora fai il brano / Oh! Faresti meglio a guardar fuori / Faresti meglio a non piangere / Faresti meglio a non fare il broncio / Adesso ti dico perché / Babbo Natale sta arrivando in città / Babbo Natale sta arrivando in città.
Originariamente erano queste giocose giaculatorie e, in seguito, liriche e ispirate canzoni popolari, dedicate alla festa ed entrate a far parte delle festività natalizie, un po’ come lo sono le luminarie, gli addobbi, i biglietti augurali, le candele colorate, i cibi appositamente confezionati e i pacchetti regalo a conferma della trasformazione di una festa dalle origini umili e contadine in ‘fatto’ esclusivamente speculativo e commerciale. All’origine, infatti, rientrava nei ‘gesti di costume’ e prendeva esempio dall’usanza romana delle ‘strenne’, cioè dai rami d’alloro in segno di regalità, e di ulivo in segno di pace che la gente si scambiava come augurio di prosperità e di abbondanza, durante le calende del mese di gennaio.
Quella che segue è invece una canzone relativamente moderna che non ha bisogno di presentazione: “Do they know It’s Christmas?” di Bob Geldof, ed è stata qualche anno fa, uno dei maggiori successi discografici; forse l’unica, fra le numerose che di tanto in tanto entrano nell’orbita della canzone natalizia, ad affrontare il tema scottante della fame nel mondo:
“It's Christmas time; there's no need to be afraid
At Christmas time, we let in light and we banish shade
And in our world of plenty we can spread a smile of joy
Throw your arms around the world at Christmas time
But say a prayer to pray for the other ones
At Christmas time
It's hard, but when you're having fun
There's a world outside your window
And it's a world of dread and fear
Where the only water flowing is the bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring there
Are the clanging chimes of doom
Well tonight thank God it's them instead of you
And there won't be snow in Africa this Christmas time
The greatest gift they'll get this year is life
Oh, where nothing ever grows, no rain or rivers flow
Do they know it's Christmas time at all?
Here's to you, raise a glass for ev'ryone
Here's to them, underneath that burning sun
Do they know it's Christmas time at all?
Feed the world
Feed the world
Let them know it's Christmas time again
Feed the world
Let them know it's Christmas time again”.
E' Natale
Non c'è bisogno di aver paura
A Natale
Lasciamo passare la luce e aboliamo le zone d'ombra
E nel nostro mondo di abbondanza
Possiamo diffondere un sorriso di gioia
Butta le braccia intorno al mondo
A Natale
Ma dì una preghiera
Prega per gli altri
A Natale è difficile
Ma quando ti stai divertendo
C'è un mondo fuori dalla finestra
Ed è un mondo di terrore e paura
Quando l'unica acqua che scorre
È la puntura amara delle lacrime
E le campane natalizie che suonano là
E’ lo scampanellio del loro tragico destino
Beh stanotte grazie a Dio tocca a loro e non a te
E quest'anno in Africa non ci sarà neve a Natale
Il miglior regalo che riceveranno quest'anno è la vita
Dove niente cresce
Non scorrono né pioggia né fiumi
Hanno una minima idea del fatto che sia Natale?
Un brindisi a te, alza un bicchiere per tutti
Un brindisi a loro stare sotto il sole cocente
Hanno una minima idea del fatto che sia Natale?
Sfama il mondo
Fa loro sapere che è ancora Natale.
Lo scambio dei doni avveniva e avviene tutt’ora in segno di amicizia e quindi di fratellanza, quale simbolo augurale e significativo nei rapporti conviviali, di unione, di lieta dipendenza, come segno di affabilità e di felicità raggiunte; ed anche di stretta intimità che da sempre caratterizza il ‘tempo della festa’. Tempo in cui si esprime il ‘senso’ del quotidiano vivere comunitario, e del ‘meraviglioso’ reciproco scambio augurale di ‘pace’ e rinnovata ‘speranza’.
Alla ‘pace’ è dedicata un’altra canzone scritta da L.Lopez /G.Ullu / C.Vistarini e portata al successo da Riccardo Fogli:
“Pace”
“Pace a voi
uomini, fabbriche di favole
chi non ha amato non lo sa
che luce fa una stella
in notti come questa qua;
io vorrei prendere
tutti i sogni in vendita,
credere nel tempo che verrà
a mezzanotte il mondo
un po' di pace troverà.
Girotondo di bambini
pace porterà
une mano nella mano
che ci guiderà.
Suonano musiche di tanto tempo fa
la notte di Natale un po' d'amore porterà;
cercami, chi non ha amato non lo sa
che luce fa una stella
in notti come questa qua;
anche noi credere nel tempo che verrà
a mezzanotte il mondo
un po' di pace troverà.
Anche noi credere nel tempo che verrà
la notte di Natale un po' d'amore porterà”.
Termina qui il nostro excursus nella ‘Musica per una festa’ che ho voluto regalare a tutti voi ‘Poeti’ de larecherche.it per questo Natale, nella speranza che il messaggio, solo apparentemente banale, d’un pur semplice cantare, può fare molto per alleggerire il peso in un momento di recessione come quello che conosciamo, che le difficoltà non esistono per si sa cantarle o interpretarle con un verso, la ‘poesia’ non porta gli allori ma indubbiamente può far molto per alleviare la pena di questa esistenza straordinaria che ha del ‘meraviglioso’ solo per il fatto che c’è. Auguri!
Giorgio Mancinelli
*
 - Letteratura
- Letteratura
Etnomusica 11 - ’Lo Spirito del Viaggio’
ETNOMUSICA 11: ‘LO SPIRITO DEL VIAGGIO’
“Molti viaggeranno, e la conoscenza ne sarà accresciuta” – scriveva il Profeta Daniele (circa 610 a.C.), mettendo in risalto alcune verità della ragione che valgono per ognuno di noi come per uno sdoppiamento della propria personalità, quel “dentro di me, fuori di me” che ci permette di confrontarci con ciò che ci sta attorno, e che ci procura quel ‘brivido di bellezza’ che a volte ci fa trasalire e che è all’origine dell’entusiasmo che releghiamo al ‘vivere insieme’. Quell’emozione momentanea e quindi passeggera che da un senso ai molti perché della vita, congiuntamente al nostro sistema neurobiologico, soggettivo, relazionale e culturale, che carica di importanti significati l’idea che abbiamo del ‘viaggio’. Aspetti questi che interagiscono e s’influenzano a vicenda, con la conseguenza che le emozioni costituiscono esperienze multiformi, anche conflittuali e ambigue, che attraversano tutto il nostro potenziale investigativo e che ci spingono alla crescita culturale e all’evoluzione conoscitiva. Andiamo, dunque, alla scoperta dei diversi significati del ‘viaggio’, abbandonandoci però a quello che ‘lo spirito’, in libertà d’azione, ci riserva, e cioè di quella musica che pur sentiamo ‘dentro e attorno a noi’, senza chiederci il perché del suo fluttuare nell’universo sonoro che ci circonda, e che infine ci permette di comprendere e utilizzare al meglio la nostra esistenza, tra ‘l’essere e il divenire’, di quei viaggiatori instancabili che in fondo noi siamo.
La più evidente determinazione che lo ‘spirito del viaggio’ possa attribuire al mondo circostante, è il suo offrirsi alla conoscenza senza porsi il problema della sua realtà. All’occorrenza le immagini del sogno e della fantasia vengono ordinate secondo il desiderio di evasione che sussiste in noi, che è al tempo stesso fantastico e soggettivo come realtà identica a quella oggettiva dell’esperienza più concreta. Come dire che “la coscienza sta al di là di questa opposizione, poiché non riconosce l’illusione come illusione, né la realtà come realtà, ma conosce solo il ‘contenuto’ della propria coscienza, che può essere tanto un dato reale quanto un’immagine fantastica” (G. Simmel). Posta in questa assenza di alternativa, l’apparenza irreale risulta così immediatamente intrecciata alla vita che verosimilmente concorre, a livello inconscio, a farci scoprire tanto l’uno quanto l’altra, senza distinzione tra l’ ‘essere e il divenire’ della nostra consapevolezza esperienziale in cui lo ‘spirito del viaggio’ si manifesta.
Ed ècco allungarsi davanti ai nostri occhi, la linea che segna il confine con tutto ciò che si trova oltre la nostra identità, che va oltre il finestrino del treno, dell'aereo, o l’oblò della nave su cui stiamo viaggiando, per addentrarsi in ciò che esiste al di là del tempo e dello spazio, verso lo ‘sconosciuto’ che, forse, cambierà il nostro destino. Un ‘forse’ illusorio quanto magico, che ci rivela il ‘mistero’ dell'imprevisto, dell'inatteso, dell'inspiegabile che è nel nostro potenziale psichico, quell’infinito e infinitamente vario che è nell’essere del mondo: “il fatto semplice e immediato di ciò che le cose sono; e in questo senso, che l’essere è l’universale comune a tutti i contenuti del mondo, per quanto essi siano differenti e opposti” (G. Simmel).
Un po’ come dire che: “per viaggiare basta esistere” (F. Pessoa); così come lo è lo stesso vivere, ma anche scrivere di sé o di quello che sta attorno al sé dal punto di vista della molteplicità, nella sua forma universale. “È necessario comprendere quale prodigioso lavoro ‘spirituale’ sia raccolto in questo concetto, giacché l’infinita ricchezza del mondo, la cui molteplicità nessuno può pensare in una sintesi reale che, la disparità dei suoi contenuti sono un solo disegno, sotto la forza di questo unico pensiero che tutto è: l’astratta significazione dell’essere” (G. Simmel).
Cos’è dunque ‘lo spirito del viaggio’ se non la spinta che ci assale quando sentiamo il desiderio di dare un senso alla nostra vita, quando aneliamo conoscere la natura del creato, e vogliamo esplorare il mistero nei suoi vari aspetti: la pienezza e il vuoto, l'amore e la morte, l'estasi e il tormento, l'identità e la frantumazione. Quando, mossi dallo ‘spirito’, ci stacchiamo dal conosciuto e magari sostiamo sulla soglia, in attesa di varcarla prima di partire alla scoperta di quello che c’é oltre e iniziare una nuova fase della nostra vita. Illusoriamente parlando, quando diamo inizio al nostro ‘viaggiare’ che ci porterà lontano, o forse vicinissimo, dipende dal distacco che siamo intenzionati a creare tra noi e l’altro, tra noi e la comunità d’appartenenza, tra noi e il territorio che ci ospita.
Lo stesso può dirsi se consideriamo la nostra mortalità, e ci muoviamo entro una delle fasi di ‘passaggio’ irreversibili della vita, dall'infanzia alla adolescenza, all'età adulta, alla maturità e alla vecchiaia, nell'esperienza della maternità-paternità, della nascita e della morte, della malattia e della convalescenza. È allora che più siamo mossi dallo ‘spirito’ ancestrale che ci accompagna, come per un incontro fatale nel momento della svolta, che è sempre un momento iniziatico, catartico, necessario per affrontare la nuova identità che ci aspetta dall’altra parte, e che ci permette di accedere a un nuovo livello di coscienza, indispensabile per spogliarsi dell'involucro angusto dell'Io che abbiamo fatto nostro. Ma anche di nuova conoscenza, riferita a quelle esperienze che hanno lo scopo di liberare l'individuo dalla realtà comunemente accettata, e che si collega alla dimensione più alta, iniziatica e spirituale del ‘viaggio’.
Strumento necessario, la ‘coscienza’, ci aiuta ad ampliare il valore iniziatico del processo di acculturazione cui andiamo incontro, dando luogo a quell’interazione individuale e sociale che, ‘volenti o nolenti’ diffondiamo nel lasciare qualcosa della nostra cultura e apprendere qualcosa dalla cultura degli altri che, da quel momento, porteremo sempre con noi, sotto forma di conoscenza e di esperienza. Alla radice di questo concetto c’è che la parte ‘conscia’ di noi, considera reale solo ciò che è materialmente oggettivo trascurando, di fatto, ciò che non appare o è frutto di illusione, che dicesi ingannevole; mentre l’altra parte, ‘inconscia’ di noi attribuisce senso indistintamente al sovrasensibile assoluto e al dato sensibile della nostra esperienza soggettiva. Ciò che più importa alla nostra tesi, è che il pensiero attuale, è giunto alla conclusione che l’esperienza (dato sensibile) non è toccata dall’opposizione tra ‘soggettivo’ e ‘oggettivo’, poiché, in quanto l’‘essere’ è in sé la vera e unica realtà comune ad entrambe le parti. Per quanto, ogni avvenimento, ogni esperienza, in quanto reciprocamente si differenziano e si oppongono, in verità esse ‘non sono’, giacché l’esistenza che le divide è frutto di una contrapposizione, non di una negazione insita nel loro ‘essere’.
Pertanto il mito, il simbolo, il rituale, l'arte del nostro ‘viaggiare’ sono mezzi che l'angusta visione mette in atto per soddisfare l'Io, per cui ogni cosa deve avere un senso, deve seguire una logica razionale prevedibile e riproducibile che l’egoistico desiderio del singolo rapporta al desiderio di continuità della vita, alla sicurezza, al successo, alla ricchezza, all'amore. Ma che si scontra con l'etica del ‘viaggio’, la quale esige che mettiamo da parte ogni richiesta di scientificità ed entriamo in contatto con l'essenza insondabile del ‘viaggiare’, ciò che ci rende vivi e autentici attraverso i ‘continenti’ misteriosi centrali dell’essenza della vita. È l'esperienza della vita in tutte le sue manifestazioni, positive o negative, che alla fine forgia il carattere e ci rende profondamente autentici, dimessi e rispettosi e anche capaci di amare.
È così che l'esperienza iniziatica della ‘soglia’ ci permette un mutamento di prospettiva, per cui occorre imparare a vedere e sentire in modo nuovo; che iniziamo a cercare il senso delle cose a un livello più profondo, a comprendere lo ‘spirito’ di vita che portiamo in noi, e per quanto possa sembrare paradossale, simbolico, metaforico, dobbiamo imparare a ragionare entro questa nuova dimensione come di una ‘potenzialità’ della nostra psiche, che sempre più spesso muove (inconsciamente) le nostre azioni e ne determina le conseguenze e i successi. A fronte di un processo speculativo delle nostre risorse ‘inconsce’ costituite dagli archetipi che abbiamo rimosso dalla nostra psiche, con tutto ciò che l'Io ha dovuto negare, nascondere, rimuovere, razionalizzare, nel tempo della sua crescita esperienziale.
Dunque, se dovessimo chiederci quale è lo ‘spirito del viaggio’, la risposta non può essere che: è il potenziale sconosciuto che ha come scopo quello di farci incontrare, riconoscere ed integrare tutte le parti mancanti di ciò che è ‘oltre’ noi, per infine ritrovarci uniti nel nostro Sè superiore. Ed è questa la vera gratificazione, il premio alla nostra trovata ‘identità’, per il coraggio di aver intrapreso il cammino e di avere consolidato il nostro ‘spirito’. Se è vero che l’istinto della ricerca infinita di noi stessi nasce da una ardente aspirazione, dalla sete di ‘assoluto’ lo ‘spirito del viaggio’ ci permette di definire ciò che ci manca, ciò a cui aneliamo e, quel misterioso qualcosa che pure c’è oltre la vita di tutti i giorni.
È ancora lo ‘spirito’ che ci chiama, che ci invita ad esplorare i misteri dell’ignoto. Il cercatore interiore è un ricercatore di significato, rappresentato simbolicamente nei miti più antichi, che non si arresta di fronte a nulla pur di trovare la ‘verità’ della nostra esistenza e il senso della vita umana, sapendo, che ciò che stiamo cercando è dentro di noi. Di fatto, spesso, viaggiamo per scoprire quella parte di noi pronta a cercare, non solo per noi stessi ma per tutta l’umanità, quella conoscenza che vogliamo condividere con gli altri, all’unico scopo di spezzare le dipendenze del quotidiano, e riempirci di ‘bellezza’, che è poi come andare alla ricerca di una vita o di un mondo migliori.
Idealismo, Curiosità, amore della conoscenza, ambizione, autonomia, libertà, essere fedele a una verità più profonda, realizzazione di un’utopia, impazienza e ostinazione nel cercare, amore per il proibito, vagare, sperimentare, studiare, conoscere cose nuove, non sono che la ricerca di conoscere noi stessi. Ne vale la scalata al successo, il diventare i migliori possibili, conoscere gli altri, l’avanzamento della ricerca spirituale, la conoscenza mistica delle grandi verità, la trasformazione, il raggiungere la meta, il miglior risultato possibile, il senso reale della nostra identità. L'ultima fase affrontata dallo ‘spirito del viaggio’ è la scoperta del proprio vero Sè, quello che in fondo (conscio o inconscio), vorremmo essere. Il Sè è il raggiungimento ultimo, l’espressione della completezza, il conseguimento di una certezza, l’approdo finale del processo di individuazione:
“Only with the unknowable are you thrilled
with the wonder of life and existence.
Suddenly a song is born in your heart...
a song that cannot be contained,
a song that starts overflowing,
a song that stars searching others." (OSHO: ‘Book of Wisdom’)
“Solo l'inconoscibile può entusiasmarci / chiedersi della vita e dell’esistenza. / Improvvisamente una canzone nasce nel Tuo cuore... / una canzone che non può essere contenuta, / una canzone che comincia a inondare, / una canzone che diventa protagonista percorrendo altri ... mondi"
È così che ‘lo spirito del viaggio’ si impossessa di noi, annullando quello che è l’iniziale ‘scopo’ che abbiamo in mente di raggiungere nel senso tradizionale del termine, e che va inteso come vicinanza, prossimità, aggregazione, legame, acquisizione di conoscenza di altri luoghi, di altri popoli ecc. Niente di tutto questo, a meno che non dobbiamo metterci in viaggio per altre ragioni, ciò che anima il viaggiatore è lo spirito d’avventura che di per sé è già fonte di prospettive diverse: di possibilità mai neppure sognate, progressi istruttivamente mai immaginati, conoscenze acquisite, motivo di indagini ignote e pericolose, tutte quelle cose che nella vita vale la pena procurarsi o affrontare intrepidamente.
“I vantaggi della conoscenza maturano solo per il vero viaggiatore, e non per il turista, una distinzione questa , vitale – scrive A. C. Grayling (*). Il viaggiatore è un individuo attivo che ha ben compreso l’osservazione di Samuel Johnson: se s’intende tornare a casa con la valigia piena di nuove conoscenze, occorre partire portandosi dietro le proprie. Il viaggiatore va per vedere, osservare, imparare, simpatizzare e comprendere. Il turista, al contrario, non è attivo, ma passivo: si aspetta di essere portato all’estero, accompagnato dall’aeroporto al suo albergo, intrattenuto con spettacoli e rinfreschi e protetto da ogni fastidio esterno. Prima di partire il turista non si dà da fare per imparare i rudimenti della lingua locale, ma sia affida a un inglese ben scandito o alla guida inclusa nel pacchetto offerto dall’agenzia di viaggi. Il viaggiatore cerca l’avventura, non ultima quella della mente; il turista si aspetta che gli accadano cose carine. A onor del vero, il turista che va all’estero si aspetta qualche differenza, ma il suo approccio è quello dello spettatore, e non dello studioso; e, a quel punto, potrebbe benissimo restarsene a casa davanti al televisore”.
Diversamente da quanto affermato, qualcuno ha detto che “prima di partire per un viaggio occorre spogliarsi del retaggio della propria cultura, dimenticare da dove si viene e dove si è diretti”, allo scopo di presentarsi ‘vergini’ all’incontro con l’ignoto, per poter accompagnare e lasciarsi guidare dagli eventi, per acquisire il coraggio necessario ad andare avanti. Ancor più se si è reduci da una qualche esperienza di chiusura o di isolamento, di insoddisfazione o eccesso di ambizione e di sacrificio, come possono esserlo il troppo perfezionismo e la superbia. E allora necessitiamo di fuggire, di liberarci dalla punizione o dalla prigione in cui siamo bloccati, e sentiamo il bisogno di riscattarci, di evadere, di superare lo scetticismo che non consola.
Un tempo gli scettici sul valore del ‘viaggio’ erano meno perspicaci di quello che siamo noi oggi, o forse erano più turisti che viaggiatori nel profondo del cuore. Così Orazio brontolava:
“Chi attraversa il mare cambia clima, ma non la propria anima” ( Orazio ‘Epistole’), osservazione falsa se applicata al viaggiatore, ma che può essere appropriata se riferita al turista.
Dello stesso avviso era Emerson: “I viaggi sono il paradiso degli stupidi; quando facciamo il nostro primo viaggio scopriamo che il luogo non conta nulla”, commento alquanto sorprendente se si pensa a quanto egli stesso avesse imparato viaggiando. Per quanto una parte di ragione ce l’abbia, il commento ci dice che tutto sta nella preparazione, a come ci disponiamo ‘spiritualmente’ al ‘viaggio’ che intendiamo intraprendere.
Thomas Jefferson, negli anni ’80 del XVIII sec., mentre era in viaggio in Europa, arrivò a due conclusioni: “in primo luogo che fosse meglio viaggiare da soli, perché in tal modo si riflette di più su ciò che si vede e, in secondo luogo, che i viaggi rendono più saggi, anche se meno felici”, cosa che potremmo anche condividere se si esclude che viaggiare significa anche andare incontro e incontrare qualcuno significa anche scambio e non solo di vedute. Tant’è che Goethe, suo grande contemporaneo, la pensava in modo opposto. Secondo lui “...un compagno di viaggio congeniale è un altro paio di occhi, un’altra sensibilità, un altro magazzino di informazioni preziose per interpretare ciò in cui ci s’imbatte” (‘Viaggio in Italia’). E a questo proposito ritengo gli si possa dare pienamente ragione.
La solitudine può rendere la presenza del proprio sé fin troppo incombente e ingombrante: Seneca aveva ragione quando osservava che:
“Per quanto lontani ci si spinga, è solo per rincontrare noi stessi, alla fine del viaggio” (‘Pensieri vari’).
Con un compagno, però, è possibile incontrare qualcosa di più di se stessi: quindi si può essere felici proprio mentre si diventa più saggi e, addirittura, nonostante ciò:
“In mezzo alla folla, mentre viaggiamo, e perfino ai banchetti, i nostri pensieri interiori ci offrono un luogo privato”. (Marco Fabio Quintiliano)
“Lascia i tuoi luoghi e cerca altri lidi,
o giovane, e ti si apriranno più vasti orizzonti” (Petronio ‘Frammenti’).
“Maggiore è il desiderio di conoscere le cose ignote che di riveder quelle note” (‘Pensieri vari’).
“Noi usiamo intraprendere lunghi viaggi e navigar vasti mari, per veder cose che, quando le abbiamo sotto i nostri occhi, trascuriamo” (Plinio ‘Lettere’)
Lo sapevano bene Darwin, Metraux, Loti, Stendhal, Rimbaud, Baudelaire, ed anche Lord Byron, Saint-Exupéry, Jules Verne, Agata Christie, Marcel Proust, John Ruskin, D. H. Lawrence, e ancor meglio lo sanno Karen Blixen, José Saramago, A. Borges, Bruce Chatwin, che hanno fatto dei loro viaggi ‘scientifici-letterari-poetici’ e non, motivo di speculazioni filosofiche e quant’altro:
“Gli uomini – disse il piccolo principe – si imbucano nei rapidi, ma non sanno più cosa cercano. Allora si agitano, e girano intorno a se stessi...” (A. De Saint-Exupéry ‘Il Piccolo Principe’).
Ben lo sapeva Arthur Rimbaud che ha saputo trasformare la sua ‘essenza’ in parole che oltrepassano la ‘forma’ del viaggio e ne fanno un percorso denso di suggestioni profonde:
“Le bateau ivre” (Il battello ebbro). (essai)
Nello sciabordio furioso delle maree,
L'altro inverno, più sordo che un cervello infantile,
Correvo! E le Penisole alla deriva
Mai subirono sconvolgimenti più trionfali.
. . .
Conosco i cieli che si squarciano in lampi e le trombe
E le risacche e le correnti: conosco le sere,
le Albe esaltate tali a un popolo di colombe,
E ho visto a volte ciò che umano ha creduto di vedere
. . .
Ho visto arcipelaghi siderali! E isole
dove i cieli deliranti sono aperti al vogatore:
È in queste notti senza fondo che tu dormi e ti esili,
Milioni di uccelli d'oro, oh futuro Vigore? …
In questa poesia il giovane Rimbaud immagina l'incredibile viaggio di un battello che si perde tra le acque impazzite di un oceano furioso. L'equipaggio viene disperso durante la tempesta e il battello incontra paesaggi incredibili, quasi onirici, caratterizzati da spettacoli fantasmagorici, trascendenti ogni nozione di tempo e spazio. Metaforicamente, il battello compie quel passaggio oltre la realtà, che Rimbaud ne "La lettre du voyant" (Lettera del Veggente) definisce "deragliamento dei sensi", come abbandono alla disposizione visionaria.
Sappiamo che il tema ‘viaggio’ è sempre stato frequentato da grandi scrittori e da autori notissimi, a formare idealmente un tracciato che “unendo i puntini” ha saputo creare nuovi luoghi ubicati, talvolta, nella nostra fantasia, eppure rileggere questo testo di Rimbaud mi fa sempre pensare a un grande quadro: ‘La zattera della Medusa’ (Le Radeau de la Méduse) un dipinto a olio su tela (491x716 cm) di Théodore Géricault, realizzata nel 1818-19 e conservato nel Museo del Louvre di Parigi; che si riaffaccia davanti agli occhi, quasi facesse parte di una pinacoteca personale che giace nel mio subconscio, quasi fosse un ‘topos’ letterario o forse, ‘ricordo visivo’, che riscontro in altre opere artistico - letterarie e collego con suoi diversi significati.
A questo proposito mi avvalgo qui dell’esperienza letteraria di Lilli Monfregola (*) che, nel suo “Rimbaud e la macchina del tempo”, ha dato una possibile risposta alla domanda se può intendersi nello ‘spirito del viaggio’ il viaggio inteso come ricerca interiore per trovare risposte al mistero del tempo.
“Il tempo – scrive - come si percepisce il tempo quando si viaggia? Ha lo stesso scorrere delle lancette sui quadranti? Si sente lo stesso lacerante scorrere dei secondi e dei minuti e la stessa patetica sensazione d’incapacità a fermarle? Oppure è una lunga, coinvolgente, ipnotica discesa verso il misterioso quadrante del “tempo sospeso”? Il corpo e la mente si rinnovano, non sono più sottoposti a quella specie di strappo del tessuto muscolare a causa della irreversibilità degli eventi. Scompaiono lo stress, le (eventuali) lacerazioni d’amore, le rughe … In quell’attimo compreso tra la partenza e il ritorno si vivono momenti quasi eterni.
Forse pensava di trovarlo anche il tormentato, disilluso Rimbaud nel suo periodo africano, almeno non dopo il suo arrivo ad Harar, in Etiopia. Sì, perché dopo, l’agonia del tempo si è ripresentata, tale e quale a prima, contravvenendo alla regola del viaggiatore che vuole, appunto, un tempo dilatato e sognante. Il bellissimo, crudele, infernale, puro, estatico, geniale e ribelle poeta francese, per la seconda volta, si ritrovò vinto dai macigni della realtà. Lo raggiunsero persino lì, in Africa, nel suo viaggio memorabile in cui aveva rinnegato tutto, persino la poesia, forse per ritrovare un se stesso che non era più nemmeno «L’io è un altro».”
Si legge questo nelle sue “Lettere dall’Africa”, nel suadente, esotico libro con illustrazioni di Ugo Pratt, edito dalla casa editrice Nuages di Milano:
Harar, 6 maggio 1883, (Rimbaud alla famiglia)
...“Ma chi può sapere quanto dureranno i miei giorni fra queste montagne? E posso anche sparire, in mezzo a queste tribù, senza che nessuno ne sappia niente”…
… “Mi parlate delle notizie politiche. Se sapete quanto mi è indifferente tutto questo! Da più di due anni non ho aperto un giornale. Ormai, queste discussioni mi sono incomprensibili. Come i mussulmani, so che succede quel che succede, ed è tutto.” …
C’è solo una cosa che a noi lettori viaggiatori tra i viaggi dell’arte e dello spirito può salvarci dallo sprofondare in quest’abisso trasognato e disperato, ed è lo scoprire l’ultimo istante prima dell’arrivo, in questo caso l’ultima lettera di Rimbaud, l’approdo, l’oblio, dopo la partenza esasperata, l’abbrivio, prima del ritorno del tempo conosciuto, dei secondi, dei minuti, delle ore …
Così scrisse Rimbaud quando, con un ginocchio in cancrena qualche giorno prima della morte:
Aden, 30 aprile (Rimbaud alla madre).
“... Ho voglia di farmi portare fino a un piroscafo e venire a farmi curare in Francia, il viaggio mi aiuterebbe a far passare un po’ il tempo. In Francia, le cure mediche e le medicine sono a buon prezzo, e l’aria è buona. Dunque è assai probabile che io venga. I piroscafi per la Francia, in questo momento, sono purtroppo sempre pieni, perché in questo periodo dell’anno tutti rientrano dalle colonie. E sono un povero infermo che occorre trasportare con grandi precauzioni! Insomma prenderò una decisione entro otto giorni.
Ma non spaventatevi troppo per tutto questo, giorni migliori verranno. Però che triste ricompensa, a tanto lavoro, a tante privazioni e fatiche! Poveri noi! Quant’è miserabile la nostra vita! Vi saluto di cuore.
Rimbaud
p.s. quanto alle calze, sono inutili. Le rivenderò a qualcuno.”
Il viaggio dunque come "topos letterario" che conduce a una nuova visione del mondo. Ma tale viaggio comporta il rischio dell'annullamento dell'io nella libertà sconfinata della natura, nell'oceano infuriato e profondo che rappresenta l'inconscio umano, onde per cui, l'evasione dell'io porta a dover scendere al fondo dell'ignoto e può trasformarsi anche in autodistruzione. Cosa questa di cui dobbiamo essere consapevoli o, almeno, preoccuparci quando affrontiamo da ‘viaggiatori dell’inconscio’ le vie misteriose dell’introspezione, o dell’annullamento dell’io, facendo di noi stessi lo strumento di indagine del mistero della nostra esistenza. Un altro ‘straordinario esempio’ ci è dato da Charles Baudelaire in ‘Il Viaggio’ del cui testo riporto l’inizio qui sotto nella traduzione di Gianni Celati:
“Il viaggio”
I
Per il bimbo innamorato di carte e di stampe
l’universo è in tutto uguale a un vasto appetito.
Com’è grande il mondo alla luce delle lampe,
e agli occhi del ricordo com’è rattrappito!
Un bel mattino si parte, le menti infiammate,
il cuore pieno di livori e struggimenti amari,
e si segue il ritmo dei marosi alle murate
che culla il nostro infinito sul finito dei mari.
Lieti alcuni di fuggire da una patria trista,
altri con l’orrore dei natali ingloriosi,
altri ancora, astrologhi stregati alla vista
di tiranne Circi dai vezzi pericolosi,
per non farsi tramutare in bestie, con fiducia
s’inebriano di spazi, luce e cieli infuocati,
e il gelo che li morde e il caldo che li brucia
cancellano infine i baci che li han marchiati.
Ma il vero viaggiatore è chi parte per partire,
chi dice soltanto: “Andiamo” e non sa perché
come gli aerostati, a cuor leggero, senza mire,
e accetta il sortilegio che incombe su di sé.
Sono in forma di nuvole i suoi desideri,
e tanto il soldato sogna il fucile come
costui sogna ignoti e mutevoli piaceri,
voluttà di cui la mente non sa il nome.
Ed ecco un altro modo di interpretare quello che si considera il 'viaggiare'. E' tratto da uno spettacolo teatrale su progetto artistico di A. Genovese e G. Panozzo: “Transiti” – (da ‘I Viaggi di J.L.Borges’), nato dall’esigenza di dare uno sbocco immediato ad un modo di fare teatro, sperimentato ormai da diversi anni, basato sulla convinzione che musica e parola possano assumere delle valenze diverse agendo insieme all’interno della rappresentazione, senza diventare in nessun modo prevalenti l’una nei confronti dell’altra. Le musiche originali, composte per l’occasione, erano eseguite dal vivo a voler sottolineare l’esclusiva appartenenza a questo spettacolo e per esaltarne le caratteristiche rappresentative:
“Lo spettacolo è tratto dall’opera di J.L. Borges e, specificatamente, dai racconti che hanno per tema il viaggio o che nascono da suggestioni derivanti da viaggi. Viaggi realmente compiuti dall’autore in tutto il mondo e dai quali scaturiscono racconti ricchi di mistero, passione e dolore, cultura ed intellettualità. Lo specchio, il doppio, la morte, la relatività del tempo e dello spazio, la non definibilità dei valori etici, questi sono alcuni degli argomenti che si snodano in questa analisi, vocale e musicale dell’opera di Borges. Argomenti in qualche misura “alti”, resi però pienamente fruibili da un’ipotesi artistica e progettuale che fonde il suono della musica con quello della parola, ritmo ed immagine, producendo un risultato dall’impatto immediato e piacevolissimo. Assistere allo spettacolo diventa, quindi, un viaggio verso il nostro inconscio, ma, soprattutto, verso i nostri dubbi e le nostre passioni. In questo itinerario letterario, la parola e la musica riescono ad evocare luoghi e situazioni all’interno delle quali ci ritroviamo con sembianze diverse, a vivere vite ed esperienze che collimano perfettamente con le nostre e con le quali, misteriosamente, ci identifichiamo allo stesso modo di quando vediamo noi stessi riflessi in uno specchio”.
E se viaggiare fosse un andare ‘alla ricerca del tempo perduto’? Ammetto di non aver pensato a Proust in tal senso, pur tuttavia ‘La Recherche’ va considerata anche sotto questo aspetto, come di un ‘viaggio’ tout court nella società mitteleuropea del tempo, che amava spostarsi da un paese all’altro in cerca di tutto e, soprattutto, di se stessa. Ma, al dunque, gli esempi, potrebbero essere infiniti: da Louis Ferdinand Céline di “Viaggio al termine della notte”, a Giacomo Leopardi di “Canto di un pastore errante dell’Asia”, o perché no di quell’ ‘Infinito’ cui tutti, viaggiatori e poeti, dobbiamo qualcosa e ché rappresenta in sé l’essenza de ‘lo spirito del viaggio’; quell’andare oltre che pur ci è dato, se non nella realtà del movimento, di certo nello spaziare più ampio del pensiero umano:
"Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovraumani
silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensiero mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: E mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare". ( Giacomo Leopardi, 1819 )
Lo stesso potremmo dire di J. R. R. Tolkien de ‘Il signore degli anelli’, e dell’ultimo (ma non ultimo) ‘Harry Potter’ di J. K. Rowling; mentre voi direste che siamo approdati nella fiaba. E non è la fiaba un costante ‘viaggiare’ nel sogno e nello spirito? E allora gli esempi potrebbero non finire mai, mentre invece non ancora entriamo nell’estensione che è ‘viaggiare’ anche il puro ‘meditare’, quell’incontro magico che avvicina il ‘pensiero visivo’ alla realtà del ‘l’arte del viaggio’. Quel meditare che non significa distaccarsi dal mondo, al contrario, vuol dire avvicinarsi al mondo per tentare di comprenderlo, di amarlo, di cambiarlo, per cui la meditazione è un mezzo accessibile a tutti per coltivare la serenità e apprezzare il sapore della felicità.
È un po’ quanto incorse nella vita di Tiziano Terzani, giornalista e scrittore, famoso come corrispondente per i suoi reportage narrativi e saggi e per una certa ‘filosofia del viaggiare’ riferita allo stile di vita che lo condusse in luoghi diversi del mondo, e lo ha insignito di molti riconoscimenti anche internazionali. Autore inoltre di libri di successo, ha ripristinato in letteratura, un certo modello ‘diaristico’ ricco di notizie e informazioni utili per conoscere, non tanto la geografia dei luoghi visitati, quanto lo ‘spirito’ che li anima. Tra i più famosi della sua produzione, cito qui: “La porta proibita”, Milano, Longanesi, 1984; “Un indovino mi disse”, Milano, Longanesi, 1995; “In Asia”, Milano, Longanesi, 1998; e l’ultimo e forse il più impegnativo “Un altro giro di giostra” (Milano, Longanesi, 2004), dal quale traggo quanto segue:
“Siamo a Benares e camminiamo, reduci dal bazar, condotti dal tassista maomettano, grosso, intelligente e veloce come un europeo, verso il tassì. Camminiamo per una larga strada del centro, con le case a due passi, gonfie come pianole, tutte di legno, con gli angoli smussati rotondeggianti, i portichetti slabbrati e dipinti di colori teneri. Sotto un portichetto dipinto di fresco di verdognolo, nella confusione di tassì, cenci e vacche, sentiamo il suono insistente e primitivo di una musica. La faccia del tassista ci promette qualcosa di buono: perciò ci accostiamo, e ci uniamo a una piccola ressa, addossata a una finestrella, in un vicolo perpendicolare alla strada e alla loggetta verde. Attraverso la finestrella, vediamo una saletta non molto grande e completamente disadorna, ma non sporca: in fila sono accucciati per terra degli indù, sei o sette file di una decina di persone l'una. Tutti cantano con gran fervore. Gli strumenti musicali che accompagnano quel coro, sono pochi. Prevale un tamburo lungo e stretto battuto con grande furore dal musicante, che pare stacchi, vorticosamente, le mani dalla pelle del tamburo, come questa fosse spalmata di colla. I colpi sono ordinati, ma precipitosi e drammatici. Il canto della folla accucciata, benché elementare, com’è la melodia indiana, ha qualcosa di giocondo: ricorda i canti delle nostre osterie. Sotto la finestra, in un angolo della stanza, c'è un parapetto, dipinto di giallo, che circonda la cappella, col solito dio, l'ingam, ossia il sesso, tra le figure in atteggiamenti simbolici: arte folcloristica e moderna.
Saltato fuori da chissà dove, ecco che uno strano essere comincia a ballare davanti al recinto del piccolo altare, sui tappeto stinto e strappato. È un nano, maschio, ben adulto e peloso, ma vestito da nana: una grande sottana gialla e un corpetto verde; braccialetti ai polsi e alle caviglie: collane e orecchini luccicanti. Tra le dita agita dei sistri, che si uniscono al suono degli altri strumenti, ossessivi. All'assordante ritmo dei suoi sistri, il nano balla vorticosamente, ripetendo sempre gli stessi gesti: rotea su se stesso, facendo fare alla gonna una specie di ruota, si ferma, si rigira, va verso la folla, fa l'atto di prendere qualcosa sul palmo della mano aperto e teso, e va a gettare questo qualcosa verso l'altare. Ripete questi gesti, senza posa, coi sistri che ronzano e ringhiano come un alveare di api furenti. L'espressione del nano ha qualcosa di osceno, di maligno. Tra tutte quelle facce dolci di indiani, è l'unico a sapere cos'è la bruttezza. Lo sa in modo infantile e bestiale, chissà per quale ragione: e compie la sua danza sacra e antica, come facendone la caricatura, deturpandola con la sua inspiegabile perfida volgarità.
Non fu il solo caso. Anche a Gwalior, una cittadina tra Delhi e Benares, potei notare qualcosa di analogo. Passavamo per la piazza centrale della città, stupiti del suo aspetto moderno; una gran Porta, due tre palazzotti rossi e bianchi, una grossa aiuola nel centro. Però dappertutto, in mezzo al traffico, vacche e capre, grige di sporcizia. Tra le vacche e le capre, su un marciapiede, era disteso un sacco, grigio di sporcizia, e, sotto, un uomo, con una gran capigliatura nera che fuorusciva dagli orli del sacco. Un gruppo di gente stava intorno a lui, in ginocchio, venerandolo. Prima di andarsene, qualcuno che era stato lì in raccoglimento devoto, gli baciava o gli sfiorava i piedi con la mano. E lui, l'adorato, fermo sotto il suo straccio immondo, con tutti quegli immondi capelli sciolti sul marciapiede. Quando uno, paralizzato di venerazione, gli si accostò offrendogli una sigaretta accesa, l'adorato rifiutò, muto, limitandosi a scuotere follemente un piede, quasi desse piccoli vorticosi calci isterici all'intero mondo.
A Kajurao, il giorno dopo, abbiamo avuto modo di vedere un altro di questi santoni. Kajurao è il posto più bello dell'India, anzi forse l'unico posto che si può dire veramente bello, nel senso «occidentale» di questa parola. Un immenso prato-giardino di gusto inglese, verde, d'una tenerezza struggente, con delle buganvillee sparse a grossi cespugli rotondi, davanti a ognuno dei quali l'occhio si sarebbe perduto a goderne il rosso paradisiaco per ore intere. File di giovinette, col sari, tutte inanellate, lavoravano il prato: e, più in là, file di fanciulli, accucciati sull'erba, e, più in là ancora, giovani che portavano, appesi all'estremità di una pertica, dei secchi d'acqua: tutto in una pace di infinita primavera. E sparsi in questo prato, i piccoli templi: che sono quanto di più sublime si possa guardare in India.
Ai margini del prato, c'era una casetta, una catapecchia non lurida, di mattoni: un fuoco acceso dentro, e qualche suppellettile. Intorno, qualcuno stava trafficando, come preso dalle sue faccende. Era un uomo sui quarant'anni, con una folta barba nera e una folta zazzera nera. Il suo aspetto era immediatamente antipatico. Osservandolo bene, infatti, si vedeva che non stava affatto sfaccendando, occupato a accendersi il fuoco, a cucinarsi i fagioli o che so io: ma, con la stessa attenzione, accuratezza e albagia, di chi fa un lavoro ritenuto indispensabile, stava accudendo a un cerimoniale sacro. Girava come un matto intorno alla catapecchia, si fermava, toccava degli oggetti, faceva dei gesti con le mani, si chinava a terra. Lo lasciammo lì: chiuso nella sua maniaca concentrazione, in un cerchio infinito di tolleranza. Non riuscivamo a staccarci da Kajurao: c'erano sei templi, piccoli e stupendi, e intorno a ognuno indugiavamo almeno per un'ora, seduti sui suoi scalini, o sul prato sottostante, a goderci quella insperata pace, potentemente mite. I templi davanti a noi, coi loro due corpi (uno grande, con nell'interno l'ingam, l'altro, di fronte, più piccolo, poco più che una tettoia a coprire la stupenda vacca di pietra rivolta all'ingam) nell'oro del sole, erano di una bellezza inesauribile. Non cose di pietra, parevano: ma d'un materiale quasi commestibile, più che prezioso, aereo.
È un fatto, comunque, che in India l'atmosfera è favorevole alla religiosità, come dicono anche i referti più banali. Ma a me non risulta che gli indiani siano molto occupati da seri problemi religiosi. Certe loro forme di religiosità sono coatte, tipicamente medioevali: alienazioni dovute all'orrenda situazione economica e igienica del paese, vere e proprie nevrosi mistiche, che ricordano quelle europee, appunto, del medioevo, che possono colpire individui o intere comunità. Ma più che una religiosità specifica (quella che dà i fenomeni mistici o la potenza clericale) ho osservato tra gli indiani una religiosità generica e diffusa: un prodotto medio della religione. La non violenza, insomma, la mitezza, la bontà degli indù. Essi hanno forse perso contatto con le fonti dirette della loro religione (che è evidentemente una religione degenerata) ma continuano a esserne dei frutti viventi. Così la loro religione, che è la più astratta e filosofica del mondo, in teoria, è, ora, in realtà, una religione totalmente pratica: un modo di vivere. Si giunge addirittura a una specie di paradosso: gli indiani, astratti e filosofici alle origini, sono attualmente un popolo pratico (sia pure di una pratica che serve a vivere in una situazione umana assurda), mentre i cinesi, pratici e empirici alle origini, sono attualmente un popolo estremamente ideologico e dogmatico (pur risolvendo praticamente una situazione umana che pareva irrisolvibile). Così, in India, ora, più che alla manutenzione di una religione, l'atmosfera è propizia a qualsiasi spirito religioso pratico.
A Calcutta, ci sono sessantamila lebbrosi, e vari milioni in tutta l'India. E’ una delle tante cose orribili di questa nazione, davanti a cui si è del tutto impotenti: in certi momenti ho provato dei veri impulsi di odio contro Nehru e i suoi cento collaboratori intellettuali educati a Cambridge: ma devo dire che ero ingiusto, perché veramente bisogna rendersi conto che c'è ben poco da fare in quella situazione. A Calcutta Moravia, la Morante e io siamo andati a conoscere Suor Teresa, (una donna anziana, bruna di pelle, perché è albanese, alta, asciutta, con due mascelle quasi virili, e l'occhio dolce, che, dove guarda, «vede»). Una suora che si è dedicata ai lebbrosi e che nei tratti ha impressa la bontà vera, la bontà senza aloni sentimentali, senza attese, tranquilla e tranquillizzante, potentemente pratica.” [...]. Suor Teresa cerca di fare qualcosa: come lei dice, solo le iniziative del suo tipo possono servire, perché cominciano dal nulla. La lebbra, vista da Calcutta, ha un orizzonte di sessantamila lebbrosi, vista da Delhi ha un orizzonte infinito. Suor Teresa vive in una casetta non lontana dal centro della città, in uno sfatto vialone, roso dai monsoni e da una miseria che toglie il fiato. Con lei ci sono altre cinque, sei sorelle, che l'aiutano a dirigere l'organizzazione di ricerca e di cura dei lebbrosi, e, soprattutto, di assistenza alla loro morte: esse hanno un piccolo ospedale dove i lebbrosi vengono raccolti a morire.”
Quanti altri nomi andrebbero qui citati, e non si finirebbe mai, tuttavia nei miei ricordi c’è uno scrittore, José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas, 1911 – morto suicida a Lima nel 1969), un nome da ricordare, un grande scrittore sudamericano che va assolutamente letto per chi volesse intraprendere un viaggio in Perù. Vissuto negli anni decisivi della sua infanzia a stretto contatto con la popolazione india, scoprì la cultura indigena e imparò il quechua, lingua che utilizzò per tutta la vita e che affiancò all'uso del castigliano. Era figlio di un avvocato, che per ragioni politiche e professionali, si vide obbligato a viaggiare con frequenza attraverso il territorio delle Ande. Il futuro scrittore, che quasi sempre accompagnava il padre nei suoi viaggi, allargò i suoi orizzonti culturali ed entrò a contatto con la tradizione india. Nel 1931 entrò nella facoltà di lettere dell'"Universidad Mayor de San Marcos" di Lima.
L'opera di Arguedas abbraccia vari campi; troviamo, infatti, romanzi, poesie e studi letterari, traduzioni dal quechua allo spagnolo e viceversa. È possibile intravedere sempre una preoccupazione costante per la lingua, i suoi usi e la relazione tra il quechua e il castigliano. La sua prima opera, una serie di canti, venne pubblicata nel 1935 con il titolo "Aqua", nel 1941 scrisse la sua prima novella intitolata "Yawar Fiesta". Le sue opere mature comprendono "I fiumi profondi" del 1974 che è forse il suo capolavoro, "Tutte le stirpi" del 1964; “Il Sexto”, 1976, “Festa di sangue” e “Musica, danza e riti degli indios del Perù” 1991, tutti pubblicati in Italia da Einaudi.
Voglio inoltre dare qui un suggerimento a quanti, appassionati di viaggi e non, che mi leggono su La Recherche, dell'esistenza di una “Libreria del Viaggiatore” in Via del Pellegrino, 78 a Roma, a due passi da Campo dè Fiori. Un piccolo spazio in cui attraverso i libri si aprono porte infinite. Era questa l’ambizione del signor Bruno Bruschin, quando, nel 1991 ha dato avvio alla sua Libreria, e non c’è dubbio che c’è riuscito, grazie anche alla cortesia che usa nel consigliare chi entra nella sua libreria. E infatti, indica una targa all’ingresso che, in questo spazio non si trovano solo libri ma anche consulenze turistiche. L’idea è precisa, il pubblico vasto. C’è chi passa per trovare qualche informazione su una meta non contemplata dalle guide tradizionali e c’è chi fa un salto una volta al mese alla ricerca di un compagno di viaggio di carta. I libri qui non scompaiono se non vengono venduti dopo tre mesi. La frenesia rimane fuori della porta.
Basta entrare per accorgersene. In uno spazio piccolo, in penombra, su scaffali che coprono interamente le pareti sono stipati quanti libri fisicamente ce ne possono stare. Una copia per libro. Sono divisi per aree geografiche (per nazioni o per continenti). Entrando sulla destra si trova la sezione “Viaggi in Italia” che esplora la penisola attraverso le parole di viaggiatori illustri, allargandosi anche nei secoli e mettendo in mostra accanto a opere del Belli, quelle di Leopardi e di Montaigne. Al di fuori dell’Europa, accanto alle guide e ai libri che parlano di viaggio, si aggiungono opere di letteratura locale, anche in lingua originale. Ci sono mappe e guide turistiche per qualsiasi destinazione, ma anche libri che affrontano, in diversi modi, la tematica del viaggio: diari e resoconti, libri umoristici sui vari popoli, classici stranieri (molti in lingua originale) e italiani sui protagonisti di Grand Tour e esplorazioni. E poi guide tradizionali, libri fotografici, dizionari tascabili, mappe di ogni angolo della Terra, carte da trekking, taccuini del viaggiatore.
Ci si può lasciare avvolgere dall’atmosfera, girare e sfogliare tranquillamente, senza spingersi necessariamente a comprare qualcosa, (sono certo che troverete qualcosa di cui compiacervi, compratelo!). La Libreria del viaggiatore è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, tranne la domenica e il lunedì. Molti sono anche i frequentatori del blog dove è facile incontrarsi, tra gli scaffali pieni di libri, musica, guide, carte geografiche, cd; un click e il ‘viaggio’ è servito: www.libreriadelviaggiatore.com .
Ma eccoci giunti alla conclusione del ‘viaggio’ intrapreso in queste pagine. Ci siamo smarriti e ritrovati, abbiamo perso coincidenze ma abbiamo trovato nuovi mezzi di trasporto, abbiamo incontrato molte persone, buone e cattive, abbiamo superato momenti difficili e abbiamo gioito di panorami sorprendenti: abbiamo sperimentato i vari livelli della nostra coscienza e tutti i pezzi della nostra psiche si sono ricomposti in unità. Infine però siamo tornati a casa, ci guardiamo indietro e sappiamo chi siamo, abbiamo acquisito la maturità, il potere materiale e spirituale della conoscenza, senza esserci lasciati contaminare dall'ego o dall’esperienza di un ‘viaggio’ che ancora ci spetta di fare, nella misura in cui siamo fedeli al nostro ‘spirito’ interiore, nel desiderio di scoprire le zone inesplorate della nostra ‘vita’ e del nostro Sé. Ma adesso permettetemi di salutarvi, vi lascio per partire per un altro lungo viaggio di cui leggerete in seguito.
Ovviamente è solo un arrivederci, puntualmente vi aspetto al prossimo e sempre interessante ‘reportage narrativo' che intendo proporvi.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Cantico di Natale 3 - Anno Domini
Cantico di Natale - (3)
(mito e leggenda di una tradizione sempre viva)
(Testo originale della trasmissione omonima radiofonica scritto per “Studio A” della Radio Vaticana. Da “ANNO DOMINI”: Usanze e costumi di una tradizione – di Giorgio Mancinelli - Grafica e Arte Bergamo. Copyright 1989).
IV
“...da Te verrammi colui che dee essere dominatore in Israele,
e la generazione di Lui è da principio, dai giorni dell’eternità”.
(Michea V v.II – Antico Testamento)
E già le voci si rincorrono da una stanza all’altra festose nel fervore dei preparativi, lontane, sommesse: una chiama l’altra e un’altra ancora, fino a confondersi, come se giungessero dai ricordi. E come dietro i vetri appannati, ogni cosa si perde nell’irrealtà, per divenire oggetto di un desiderio che attraversa il tempo, che forse Natale vuol dire... il passato e il presente nell’affermarsi di antichi ritorni. L’infanzia che mai ci abbandona e che riporta la passata allegrezza, dove ognuno diventa personaggio dello scenario immaginario che s'apre al Natale.
Allora fuori dalla finestra, il paesaggio, il piccolo borgo, la città merlata, il borgo medievale, sono il Presepe di ieri, di oggi, di sempre: alcune stecche di legno, qualche foglio di carta, i colori, le forbici, la colla, le puntine, ed ècco nasce un ruscello di carta stagnola, un ponte di sughero, un albero di stoppa, alcune case di cartone abbarbicate su finte montagne come sospese sotto un cielo racchiuso fra delle tavolette, dove la luna, muta, lascia il posto a una stella che brilla al di sopra di una profonda notte incantata:
“Questa notte, quando la luna spunterà
la cambierò in moneta sonante.
Ditelo pure se volete. Non m’importa
che si sappia.
Per quanto, essa sia un vecchio ricordo
di famiglia”.
È questa una poesia di Jorge Guillén (1893-1984) che ho ritrovata in un vecchio diario che di tanto in tanto apro senza un vero perché, ma forse in segreto lo so, lo faccio per riappropriarmi del significato della festa che il Natale rappresentava per me, per risentire i suoi profumi, riempirmi gli occhi dei suoi colori e la testa di sogni, o forse, solo il cuore di mille piccole illusioni.
Natale vuol dire... ed ecco l’eco ritorna, e limpido, silenzioso, scorre il fiume della vita, che riporta sempre a un altro Natale di molto tempo prima, quando ancora Cat Stevens cantava “Morning has broken”:
“Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the world
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world”.
L'alba è sorta.
L'alba è sorta, come la prima alba / L'uccello nero ha cantato, /come il primo uccello, / Lodate il canto, lodate l'alba / Lodate la frescura che sorge dal mondo. / Dolce cade la nuova pioggia, luce dai Cieli, / Come la prima rugiada, sulla prima erba, / Lodate la dolcezza del giardino umido / Che nasce già completo dove i Suoi piedi si posano. / Mia è la luce del sole, mia l'alba, / Nata dall'unica luce che l'Eden vide giocare, / Lodate dal cuore, lodate ad ogni alba / La nuova creazione divina del nuovo giorno. / L'alba è sorta, come la prima alba / L'uccello nero ha cantato, come il primo uccello, / Lodate il canto, lodate l'alba / Lodate la frescura che sorge dal mondo.
Entrata, seppure solo di recente, nella tradizione inglese delle ‘Carols’ natalizie, la riascolto aspettando che il giorno dell'Avvento, nella ‘speranza’ che il Natale ritrovi infine un suo posto nel mondo a completamento del mosaico di ‘pace’ che noi tutti andiamo componendo. I più giovani mi scuseranno se nelle mie parole troveranno un tono un po’ malinconico e un po' 'nostalgico'; che posso farci, è colpa dell'età. Solo perché, tutto sommato, un po’ di anni ce li ho e l’infanzia che mi porto dietro, mi torna a volte all’orecchio e mi fa riascoltare vecchie melodie e canzoni che non ho mai dimenticato. Come questo ‘gospel’ ad esempio, eseguito dal vivo proprio a ridosso delle feste in tutto il mondo, dal gruppo degli Up With People: “What color is God’s skin?” di Thomas Wilkes e David Stevenson, portata al successo dagli Up With The People, un gruppo formato da bambini di tutte le razze, e che in qualche modo, mi riconcilia con questa umanità così diversa e così uguale, con le stesse speranze e le stesse disillusioni:
“Good night I said
to my little son
so tired out, when
the day was done.
Then he said as I
tucked him in,
‘Tell me Daddy,
what color is God’s skin?’
I said it’s black,
brown it’s yellow,
it’s red, it is white
every one’s the same
in the good Lord’s sight.
He looked at me
with those shining eyes.
Well I knew, that I
Could tell no lies.
When he said
‘Daddy, why do the
different races fight,
Il we’ve the same in
the good Lord’s sight?’
Son, that’s part of
our suffering past
but we whole
human family is
learning at last.
That the thing we
missed on the road
we trod.
Was walking as the
daughters and the
sons of God.
Yes, every one’s
the same in the
Good Lord’s sight”.
Di che colore è la pelle di Dio?
Buona notte dissi al mio bambino / tanto stanco quando il giorno finì. / Allora chiese: "Dimmi, papà, / la pelle di Dio che colore ha?"/ Di che color è la pelle di Dio? / E' nera, rossa, gialla, bruna, bianca, perché / lui ci vede uguali davanti a sé. / Lui ci vede uguali davanti a sé. / Con l'occhio innocente egli mi guardò, / mentire non potevo quando domandò: / "Perché le razze s'odiano, papà, / se per Dio siamo una sola umanità?" / "Questo, figliolo, non continuerà, / l'uomo al fine imparerà / come dobbiamo vivere noi / figli di Dio da ora in poi." / Si, perché ognuno è uguale / Agli occhi di Dio.
Se Natale vuol dire speranza di pace, volersi un po’ più di bene, allora l’amore è parte della memoria occulta del mondo, o forse è una bella fiaba che sentiamo raccontare da sempre, e che in fine, questo nostro mondo continuerà a girare, almeno finché ci sarà amore. Ed ecco, infatti, che dietro l’esperienza di una vita passata alla ricerca di significati, di dare un senso alle cose, ai gesti, alle parole, posso oggi apprezzare quella che ritengo sia la festa più bella dell’anno, festa dell’incontro e dell’amicizia, una festa d’amore da condividere con gli altri.
Guarda! Già il tuo Presepe s’illumina, s’accendono a cento a mille le candele sugli alberi. Attraverso le tue finestre s’intravede gente festose che si scambia auguri, baci, sorrisi, regali... è questo il tuo Natale d’amore. Natale vuol dire... esultanza, e lassù, in alto, le stelle illuminano la notte del tuo Presepe, che danzar sembra vederle. Guarda il passante che s’attarda freddoloso lungo la via, che si ferma davanti alle vetrine illuminate, che affolla i negozi in cerca di un suggerimento per i prossimi regali. Perché Natale vuol dire...il piacere di un dono, il prestigio di un regalo sapientemente scelto, ma anche di un biglietto d’auguri, o una telefonata a una persona cara o lontana. Tutto allora può servire allo scopo:
“Pensa quattro parole, scrivile su un biglietto, allegalo a una musica che sò, a un disco strenna, e resta ad ascoltare. Presto la musica si leverà nell’aria e porterà il tuo messaggio sulle note di un violino, o forse di una celesta, in un concerto di voci o nell’insieme di una grande orchestra. E il tuo Natale si trasformerà in una festa”.
Guarda il barbone che non ha nessuno, che ha freddo e non sa dove andare a dormire, anche per lui è Natale. E se ti capita di ascoltare le ‘ciaramelle’ di uno zampognaro, sappi che anche per lui Natale vuol dire...ch’è un giorno di festa, che il suono del suo strumento è ben accetto alle orecchie di Dio, che ci ha creato in tanti, proprio per non farci sentire soli. E se nel cielo scorgi una stella, afferrala, come il sole e la luna accendila, ti servirà per illuminare la tua notte, e gli astri a profusione ripeteranno all’eco il tuo messaggio d’amore, per un mondo migliore.
Scritta nel 1971 da John Lennon e la moglie Yoko Ono, “Happy Xmas” (War Is Over) è una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam; i bambini del sottofondo fanno parte dell’Harlem Community Choir:
“So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear.
And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
War is over
If you want it
War is over
Now…”
Buon Natale.
E così è arrivato il Natale, / e tu cosa hai fatto? / Un altro anno se n’è andato / e uno nuovo è appena iniziato. / E così è Natale, / auguro a tutti di essere felici / alle persone vicine e a quelle care / ai vecchi ed ai giovani. / Buon Natale / e felice anno nuovo. / Speriamo sia un buon anno / senza timori né paure. / E così è Natale, / per i deboli ed i forti, / per i ricchi ed i poveri, / il mondo è così sbagliato. / E così è Natale, /per i neri ed i bianchi, / per i gialli ed i rossi, / smettiamola di combattere. / Buon Natale / e felice anno nuovo. /Speriamo sia un buon anno / senza timori né paure. / E così è Natale, / con tutto quello che è successo. / Un altro anno se n’è andato / e uno nuovo è appena iniziato. / E così è Natale, / auguro a tutti di essere felici / alle persone vicine / e a quelle care / ai vecchi ed ai giovani. / Buon Natale / e felice anno nuovo. / Speriamo sia un buon anno / senza timori né paure. /La guerra è finita / Se tu lo vuoi / La guerra è finita / La guerra è finita, adesso.
Ed ecco! Il dono che avevo in serbo per Te e per tutti Voi è giunto appena in tempo: facciamo anche noi in modo di poter cantare un giorno ‘la guerra è finita’ nel mondo e uniamoci al coro, con Leonard Cohen in questo straordinario “Hallelujah”:
"Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah , Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah"
Ho sentito che c’era un accordo segreto / Che David suonava, e piaceva al Signore/ Ma non è che ti interessa la musica, vero? / Fa così / La quarta, la quinta / Minore diminuita, maggiore aumentata / L’imperscrutabile re compone l’Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
La tua fede era forte / ma avevi bisogno di prove / L’hai vista farsi il bagno sul tetto / la sua bellezza e la luce della luna ti sconfissero / Ti ha legato / alla sedia d’una cucina / Ruppe il tuo trono, / e tagliò i tuoi capelli / E dalle tue labbra delineò l’Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Dici che ho preso il nome invano / Non lo conosco neanche il nome / Ma se lo conoscessi, bè, davvero, / cosa significa per te? / C’è un incendio di luce / In ogni parola / Non importa quale hai sentito / L’Hallelujah santo o quello stentato
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Ho fatto del mio meglio, non è stato molto / Non riuscivo a “sentire”, / così ho provato a toccare / Ho detto la verità, / Non sono venuto a raggirarti / E anche se / Fosse stato tutto sbagliato / Starò dritto davanti al Signore della canzone / Solo con l’Hallelujah nella mia bocca
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Auguri vivissimi a tutti per un Felice Natale e un migliore Anno Nuovo.
*
 - Letteratura
- Letteratura
Cantico di Natale 2 - ’Anno Domini’
Cantico di Natale - (2)
(mito e leggenda di una tradizione sempre viva)
(Testo originale della trasmissione omonima radiofonica scritto per “Studio A” della Radio Vaticana. Da “ANNO DOMINI”:Usanze e costumi di una tradizione – di Giorgio Mancinelli - Grafica e Arte Bergamo. Copyright 1989).
III
“E metterò in movimento tutte le genti, perché verrà il
Desiderato da tutte le genti, ed empirò di gloria questa casa,
dice il Signore degli Eserciti”.
(Aggeo II v.VIII – Antico Testamento)
La creazione del Presepe, espressione dell’arte, affermatasi sul terreno artigianale popolare, ha contribuito in gran parte all’affermazione della complessa iconografia del Natale, adducendo all’immagine liturgica, contemplativa, la rappresentazione scenica, tipicamente figurativa, degli usi e dei costumi dei popoli in cui ha trovato la sua affermazione. Nell’anteporre alla realtà storica il ‘nunc et semper’ del meraviglioso, con la creazione del Presepe si è voluta sollecitare la visualizzazione estetica di un ‘effimero rituale’, entro il quale, il mito esercita la propria catarsi.
È così che le figure che compongono il Presepe, altro non sono che le immagini edonistiche di mitiche incarnazioni collettive fermate nella materia, nella gestualità attonita, illuminata dalla rivelazione divina. Natura, archeologia, etnografia, folklore, spettacolo colto e popolare, rappresentazione religiosa e di strada, a un certo momento conversero nel boccascena di quel teatro immaginario e fantasioso che fu il Presepe cortese. Un’esperienza mondana fatta di curiosità artistica e vanità culturale, ambizione ricca e di evasione, dal consueto contesto religioso ed ecclesiale. Tale da diventare quasi un ‘gioco’, originale quanto costoso, assai lontano dal piccolo e pur significativo ‘presepio popolare’ che si costruiva in casa con pazienza e modestia di intenti.
Lontano anche da quell’origine umile che il Presepe aveva conosciuto a Greccio nel lontano 1223 per opera di San Francesco d’Assisi, cui dobbiamo la prima rappresentazione ‘vivente’ con pastori e contadini umbri, secondo la devozione che ispirava i drammi liturgici del tempo, nel desiderio di rendere palesi a tutti, le verità dello spirito. Inizialmente semplici ed essenziali, le prime raffigurazioni riferite alla Natività, pongono autorevolmente l’artigianato popolare sul piano stesso dell’arte, fuse in una simbolica espressione artistica la cui spinta giungerà a lambire la grande manifestazione figurativa e pittorica dei secoli successivi.
Un simbolismo iniziatico confluito nell’arte dai racconti evangelici in quella che è oggi considerata la prima, vera e propria espressione presepiale, conservata a Roma nella Basilica di Santa Mara Maggiore, un tempo detta “Santa Maria ad Praesepe”, dove si conserva ciò che rimane della Domus Sanctae Genitricis (nella foto), così attestata già nel VII sec. Il complesso scultoreo, attribuito ad Arnolfo di Cambio (1240-1310), è costituito da singoli gruppi statuari di media altezza che per la sua collocazione angusta in cui è relegato, lascia titubanti sulla sua appartenenza specifica all’arte presepiale. Ciò nonostante che, oltre ad essere un esempio di rilevante pregio artistico, rimane la prima testimonianza plastica del Presepe, relativa all’entrata nell’arte aulica di una dichiarata tradizione popolare.
È tuttavia rilevante dire, che le prime testimonianze riguardanti il Presepe, sono successive alla datazione che viene fatta per le sculture di Arnolfo, attorno al 1289. Nelle chiese romane ma soprattutto nelle grandi basiliche sorsero a più non posso presepi permanenti formati da grandi figure lignee, di terracotta o di marmo, di notevoli dimensioni, la cui visita richiamava un gran numero di fedeli da ogni parte, rasentando talvolta la blasfemia di quale fosse il più grande e il più ricco. Lo stesso accadeva in molte capitali d’Europa e, soprattutto, nella cattolica Spagna, dove sorsero addirittura altari dedicati alla Natività del Signore, almeno pari in numero a quelli edificati con grande sfarzo per la Sua morte durante la ‘Seimana Sancta’.
Alla Natività sono dedicate alcune delle più belle “Cantigas de Sancta Maria”, attribuite ad Alfonso X el Sabio, (1221-1284) re di Castiglia e León, e che fanno parte della più vasta raccolta medievale di canti e musiche esistente: 400 composizioni strutturate sul ‘virelai’ provenzale e in parte alla ‘laude’ italiana, oggi patrimonio di una vasta area musicale che dalla Spagna si estende, attraverso l’Occitania, fino alla Lombardia e consente di cogliere gli effetti di un avvenuto interscambio musicale che ancora la Spagna alla cultura del resto d’Europa.
L’attività svolta dalle botteghe artigiane dedite alla creazione delle figurine e delle più complete scenografie presepiali che si sono viste a memoria d’uomo soprattutto in Italia diede, a un certo tempo, impulso a tutta una categoria manifatturiera di pregio artistico che ebbe un peso sociale e culturale di notevole entità. I ‘pasturari’ sicialiani e calabresi, i ‘figurari’ partenopei, i ‘pupazzari’ laziali, i creatori di ‘piputì’ bergamaschi, gli ‘intagliatori’ valdostani, tutti si misurarono nella difficile arte della miniaturizzazione, ad esempio: delle diverse tipologie somatiche delle diverse razze, delle espressioni tipiche del ‘meravigliato’, lo ‘stupito’, l’ ‘adorante’, lo ‘spaventato’ ecc., lavorando anche materie povere come la creta e il gesso, la cartapesta e il legno tenero.
Ve ne erano di finemente modellate e dai colori vistosi, vestite e agghindate secondo l’usanza del luogo di provenienza, o la moda di corte dell’epoca; che raggiungevano l’estro dell’arte o la bizzarria della ricerca parodistica, e anche della tridimensionalità scultore. Altre volte erano informi, non decorate e neppure colorate a seconda del grado di povertà e indigenza delle famiglie, eppure tutte toccate dal calore di quell’amore di chi le aveva prodotte, di chi nell’immaginazione rimetteva la speranza di una vita di pace e di serenità futura.
Ed eccoli sfilare tutti davanti ai nostri occhi: la vecchia con l’arcolaio, il pecoraio con le ricotte, la lavandaia, il ‘verduraro’ con le sue ceste, il ‘ciaramellaro’ suonatore di ciaramella lo strumento tipico del Natale, il boscaiolo, il suonatore di flauto, il pastore dormiente, il mulattiere, la portatrice d’acqua con le sue brocche che arriva dal pozzo o dal ruscello, e tantissimi altri che seguono la via che porta alla capanna, o al luogo santo, dove la sacra famiglia composta da Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, stanno attoniti, col bue e l’asinello, nella fissità e nello splendore che li attornia, aspettando la visita dei Re Magi e le schiere degli Angeli che caracollano dal cielo.
“Tu scendi dalle stelle,
o Re del Cielo,
e vieni a una grotta,
al freddo al gelo.
O Bambino mio Divino
io ti vedo qui un tremar,
o Dio Beato
ahi, quanto ti costò
l'avermi amato!
A te che sei del Mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco;
o mio Signore!
Caro eletto Pargoletto,
quanto questa povertà
più mi innamora
giacché ti fece amor
povero ancora”...
(il testo prosegue ma solitamente si canta solo questa prima parte)
Il brano composto da san Alfonso de’ Liguori (1696-1787) è così conosciuto, tanto da essere ormai un ‘classico’ della tradizione popolare, oggi eseguito e cantato anche nell’ambito delle cerimonie liturgiche ufficiali. Ma mentre il Presepio popolare artigiano, è vissuto nel tempo come esperienza comunitaria senza pretese di qualche velleità artistica, quello ‘colto’ allestito all’interno palazzi signorili e chiese, vanta una storia autonoma. Dalla fine del Cinquecento a tutto il Settecento, infatti, il diffondersi di allestire il Presepio determinò una molteplicità di manifestazioni collaterali che trovavano motivazione nell’interesse riservato ai grandi complessi scenografici, i famosi ‘scogli’ realizzati a Napoli in epoca barocca.
Nel medievale fondaco di San Gregorio Armeno a napoli, la tradizione colloca la bottega dell’artista Giuseppe Sammartino (1720-1793), il genio della scultura napoletana del Settecento, considerato il creatore delle figure da presepe più belle che si conoscono. Alcune delle quali figurano nei presepi ‘storici’ più rappresentativi che si conservano nel Museo intitolato al maestro. Purtroppo, nessuno dei molti presepi napoletani dell’epoca è pervenuto a noi nella sua interezza. Sempre trasformato, aggiornato, arricchito ma anche contaminato, è oggi impossibile risalire alle prime manifestazioni del Presepe Napoletano, determinarne le origini come forma d’arte a se stante. L’approssimazione cronologica parla dell’età di alcuni manufatti, non della sua appartenenza ai fatti della fede o in quale luogo di provenienza attribuire la sua nascita.
Scrive Mario Praz: “Nessuna scena è mai stata così affollata come quella di un Presepe napoletano; si direbbe che tutta Napoli voglia farsi intorno alla culla per scaldare col fiato il Bambino. E in tanta urgenza di figure e di gesti, e in tanta abbondanza di disparate cose offerte, v’è pure una profonda tenerezza che si scopre a poco a poco all’osservatore attento, quand’abbia superato la prima impressione d’accesso”.
Lo spazio del Presepe è pertanto lo spazio stesso del sacro nel suo divenire epifanico. Il credente è chiamato al diretto coinvolgimento, alla partecipazione del fatto ‘meraviglioso’ che lo pone in stretta comunione con la divinità che in esso si rivela. Così interiormente visualizzato, esso accoglie in sé flusso benefico dell’arte che si esprime attraverso il plagio di una realtà suggestiva, emozionale, trasognata, tipica dell’animo popolare. Un documento prezioso della credenza popolare che ripete, nell’insegnamento della fede, l’umano senso di pietà, la grandezza incommensurabile di un autentico atto d’amore.
Ancora a san Alfonso de’ Liguori è accreditato un altro canto popolare, entrato a far parte della tradizione partenopea “Quanno nascette ninno”, che egli compose in forma semplice nel linguaggio del volgo, onde renderlo accessibile a quella gente napoletana cui egli aveva dedicato il suo apostolato e che avvolse nei raggi luminosi della sua carità:
“Quanno nascette ninno a Bettalemme
era nott’è pareva miezo juorno.
Maje le stelle – lustre e belle
se vedettero accossì:
e a chiù lucente
jett’a chiammà li Magge all’Uriente.
De pressa se scetajeno l’aucelle
Cantanno de na forma tutta nova:
pe’nsì agrille – co li strille,
e zombanno a ccà e da llà.
È nato, è nato,
decevano, lo Dio , che nce ha creato.
Co tutto ch’era vierno, Ninno bello,
nascetteno a migliara rose e sciure.
Pe’nsì o ffieno sicco e tuosto
Che fuje puosto – sott’a Te,
se’nfigliulette,
e de frunnelle e sciure se vestette...”.
(il testo completo è molto più lungo e veniva cantato come 'novena' di Natale)
L’Italia centrale festeggia il natale in forma solenne. Qui, più che altrove, la Chiesa di Roma ha pienamente conservato i canoni della liturgia ufficiale; allo scopo, di accompagnare e celebrare le funzioni religiose nel rispetto dell’osservanza del culto. Inni e canti assumono così il compito di offrire un quadro suggestivo, sebbene, austero dell’atmosfera natalizia che si propaga poi in ogni regione e all'intera penisola.
*
- Letteratura
Cantico di Natale 1 - ’Anno Domini’

Giorgio Mancinelli - Cantico di Natale (1)
(mito e leggenda di una tradizione sempre viva)
(Testo originale della trasmissione omonima radiofonica scritto per “Studio A” della Radio Vaticana. Da “ANNO DOMINI”: Usanze e costumi di una tradizione – di Giorgio Mancinelli - Grafica e Arte Bergamo. Copyright 1989).
I
"E spunterà un pollone dalla radice di Jesse, e un fiore dalla radice di lui si alzerà. E sopra di lui riposerà lo spirito del Signore; spirito di sapenza e di intelligenza, spirito di scienza e di pietà".
(Isaia XI v.I Antico testamento)
Il titolo, avvolto nella sua luce atemporale, ripropone qui un tema caro alla tradizione millenaria che in assoluto è la più sentita in ambito famigliare e solitamente la più celebrata con partecipazione collettiva in tutto il mondo Cristiano. Ed è proprio alla collettività che qui mi rivolgo nel far riferimento alla festa religiosa che introduce la Natività del Signore in seno alla Chiesa Cattolica, pur con l’osservare in essa, il risvolto laico delle sue origini antichissime; sia nel far riferimento agli usi e ai costumi popolari che le sono propri, sia nell’insieme di espressioni musicali e canore, alta spiritualità e devozione, all'arte aulica e all'artigianato che, nell’insieme, danno un senso compiuto alla tradizione e ritrovano la loro ragione di essere.
Il racconto del Natale quindi, visto nei suoi molteplici aspetti, corredato da un apparato testamentario inconfutabile che racchiude in sé, un messaggio d’amore e di orgoglio, in cui il fatto meraviglioso della nascita di un 'bambino', ripete in seno a ogni famiglia l’atto della creazione divina. Il suo contenuto è quindi ‘agio-poetico’, inquanto in esso la storia e la leggenda s’incontrano sul piano stesso del racconto testamentario e della poesia popolare, come pure del canto liturgico e della sacra rappresentazione, così come negli scritti apocrifi e nei racconti orali, negli usi e nei costumi di molte genti diverse che, in qualche modo, condividono la stessa fede e la stessa speranza sotto l'egida di quanto da sempre vado professando: “affinché nulla vada perduto”, al fine che "d'ogni cosa si conservi memoria".
Un significato alto, intrinseco della maternità, con il quale si consacra il segreto nascere alla vita ad un’antica promessa di eternità, che da sempre avvolge la 'Natività' di un alone di luce, il cui abbagliante splendore, prevarica la misteriosa opacità della storia. La celebrazione del Natale officiata dal calendario liturgico, risponde, infatti, allo scandire del ‘tempo della festa’; tempo in cui l’umano intendere si fa interprete delle cose divine e si determina il naturale essere del mondo. Una festa contemplativa e poetica, devozionale ed esultante, che al di là dell’apparente semplicità, accoglie in sé esperienze acculturatrici diverse, che hanno contribuito alla sua secolarizzazione.
Al tempo stesso è una festa di luci, di colori, di canti, in cui l’avvicendarsi delle singole voci, introduce all’esultanza corale, comunitaria; onde un insieme di voci riunite dal ‘corpus’ iniziatico della tradizione si esprime in preghiere e inni sacri, laudi e oratori che si rivelano parti integranti di quel messaggio intelligibile, proprio del sacro. Un messaggio di pace e d’amore ma anche di fratellanza e solidarietà che giunge da ogni parte e da molte genti, che va oltre il significato escatologico della narrazione e rimanda ai capitoli successivi di quella ‘storia universale’ che noi tutti stiamo scrivendo. Cantiamolo insieme, dunque, questo ‘Alleluia” che meglio protende all’esultanza. Se è vero che la favola esalta la propria funzione nel ruolo catartico del mito, la tradizione costituisce il terreno della sua crescita, antepone alla storia, il ‘nunc et semper’ del meraviglioso.
Manifestazione di un sentimento profondamente umano, il Natale recupera alla coscienza cristiana l’infanzia edenica del mondo. La sua attestazione è rintracciabile fin negli archetipi del pensiero e si rivela, sopravvivenza stessa di un comportamento mitico, la cui cadenza rituale, prepone al congiungimento del tempo profano al tempo del sacro. È noto come in un tempo ormai lontano, convivessero nella coscienza umana, accanto ai riti propiziatori, credenze superstiziose e pratiche magiche che circondavano di speciale venerazione e timore riverenziale gli astri, attorno ai quali, i popoli più antichi andavano formulando gli intendimenti dell’esistenza umana.
Là dove l’occulto e il sacro si compenetrano, il Solstizio d’Inverno assolve una remota certezza: il sorprendente prodigio della natura, nel ciclico rinascere alla vita. E'così che la festa solstiziale, posta all’inizio dell’anno solare e concomitante con l’allungarsi del giorno e il miracoloso risvegliarsi della natura, si poneva all’origine dei cicli agrari più importanti. Il sole dunque, con i suoi tramonti e le sue aurore, oltre che a scandire l’ineluttabile alternanza del giorno e della notte; presiedeva, in chiave simbolica e figurativa, il principio e la fine di ogni cosa umana, l’ineluttabilità stessa della vita. Il regime diurno dello spirito, dominato dal simbolismo solare, rinviava ai principi della morte e della rinascita, così come della liberazione dello spirito dalla materia; risultato questo di deduzioni razionali che legavano l’uomo all’idea dell’esistenza di un Essere Supremo.
Ipotesi diverse, talvolta fantastiche, sono state proposte nel tempo, per giustificare il parallelismo esistente fra la supremazia dei culti solari e la diffusione della civiltà storica. Si può facilmente dedurre come e su quali favorevoli posizioni i primi cristiani, poterono compiere la totale sostituzione della solennità profana don la quale si venerava la nascita del sole con quella della nascita del Bambino di Bethleem, chiamato dagli antichi Profeti: “Sole di giustizia” (Malachia) e “Luce che illumina ogni uomo” (Giovanni Evangelista), e mettere in atto quella che fu certamente una operazione carica di significati, nel fissare l’inizio della così detta ‘nuova era’, o Era Cristiana, da cui diparte la cronologia della storia, ovvero quell’Anno Domini che da inizio al Calendario della nostra esistenza di fede.
Preannunciata nei canti biblici e nella fatidica solennità dell’Apocalisse, nei salmi di Geremia, Daniele, Ezechiele e di Isaia, sommessa e idilliaca negli inni greci e cristiani, esultante nell’innodia medievale, solenne negli oratori barocchi, augurale e cortigiana nell’epistolografia: la Natività del Signore, nella sua illuminante prodigiosità torna ad affermare, anche nelle varie manifestazioni contemporanee, quella speranza nel futuro che, nella incomparabile quiete dell’attesa, attende alla preghiera.
Un mistero impenetrabile oscura la storicità delle testimonianze dirette legate alle origini della ricorrenza cristiana; sebbene ciascuna di esse, apocrife e testamentarie, conducono infine ad una ‘stessa ‘verità univoca’ in cui si afferma l’avvenuta rivelazione divina nel Bambino di Bethleem. Sulla validità degli scritti si è molto dibattuto. Una approfondita analisi critica ha rivelato, in alcuni casi, sovrapposizioni e interpolazioni successive, sì da rendere ardua ogni supposizione. Così come è accaduto per gli scritti testamentari non possiamo che illuminarci alla luce del ‘verbo’, la conoscenza degli apocrifi in particolare, ha portato all’acquisizione di interessanti elementi sull’ambiente in cui i testi furono redatti, sui metodi di predicazione e d’insegnamento della religione delle origini.
II
Una stretta rispondenza d’intenti, unisce le remote profezie accolte nell’Antico Testamento con la storia narrata nei Vangeli sinottici, per lo più considerazioni estranee alla storia. Soprattutto di carattere agiografico e simbolico che si pongono alla base della lunga trattazione sulla data di nascita del Bambino, se bene è accertato che nacque a Bethleem al tempo di Augusto. In quel tempo, un editto imperiale romano, fissava al 25 dicembre la più antica festa del ‘Solis Invicti’ designata dalla tradizione al culto agrario:
Le genti erano allora in uso di andare per i campi a suonare e danzare in onore di déi arcaici come Pan e Bacco, Calpurnia e Sibilla, Flora e Cerere, accompagnati da suoni di tibie, buccine, cimbali e fistule, in qualche caso facendo uso della voce in brevi intermezzi inneggianti. Nella forma dei ‘Ludi scenici’ anche detti ‘circensi’ eseguiti durante le cerimonie ufficiali dell’antica Roma, in occasione dei quali, venivano distribuiti pane e frutti della terra e si componevano ghirlande di sempreverdi.
La data del 25 dicembre per la ricorrenza cristiana della Natività del Signore, celebrata dai primi cristiani il 6 gennaio, giorno detto in seguito dell’Epifania in ricordo dell’arrivo dei Magi dall’Oriente, si vuole sia stata adottata in epoca tarda, non prima del IV sec. e formulata su criteri non strettamente storici o astronomici, bensì per distogliere i fedeli cristiani dall’osservanza delle feste imperiali, ritenute pagane. Con la teofania, fissata al 25 dicembre, datazione che in seguito fu accettata e che arriva fino ai nostri giorni, la religione cristiana siglò il proprio calendario liturgico. Dovettero, tuttavia, trascorrere alcuni secoli, prima che questa data fosse definitivamente ricordata da tutta la comunità concorde, come il genetliaco della nascita divina.
Si sa con certezza che la commemorazione liturgica della Natività venne introdotta dopo l’Editto di Costantino del 313, con il quale veniva concessa la libera circolazione del culto cristiano in tutto l’Impero Romano. In questa atmosfera trionfante, che nonostante l’apparenza rivelava già i sintomi della decadenza della Roma imperiale, sorsero numerosi centri di diffusione della fede e vennero fondate le prime grandi basiliche adibite alla preghiera dei fedeli. Con la caduta dell’Impero Romano, la vita sociale, priva ormai di stabilità, smarrita e incredula, si andò lentamente strutturando attorno alla Chiesa di Roma, come all’unica autorità capace di salvaguardare il cammino terreno.
Testimonianze relative ad una prima celebrazione liturgica della Natività risalgono al 379, anno in cui fu celebrata a Costantinopoli. All’anno 386 fa invece riferimento la prima testimonianza di Antiochia; ma è solo nel 529, che l’imperatore Giustiniano ne decreta la sua celebrazione ufficiale fra le festività pubbliche della cristianità. Con la definitiva affermazione dell’iter messianico, con il quale il calendario liturgico rievoca le tappe della vita di Cristo, dalla nascita alla sua avvenuta morte, entro quindi una precisa scansione rituale, la Messa assume la sua principale importanza, formalizza cioè la secolarizzazione della fede cristiana all’interno del culto: estatica al tempo dell’Avvento, mistica durante la Quaresima, drammatica durante la settimana di Passione, di giubilo per la resurrezione.
Lo stesso accade nel canto, dapprima austero e ieratico nella forma del ‘gregoriano’, fino ad allora recluso nella liturgia officiante estatica e misurata, a un certo momento, apre al germogliare delle lingue volgari, dando un maggiore impulso alla libera interpretazione vocale nella ‘laude’ più vicina al sentimento popolare comunitario che va caratterizzando la società medievale. Ben presto la ‘laude’, in origine semplice canzone spirituale di tipo religioso ma, comunque, extra-liturgica, assunse aspetti vocali qualitativamente affrancati dalla devozione.
Nell’ispirazione profonda che tutti sempre unisce nel canto, voglio qui ricordare una bellissima ‘lauda’, tratta da Il Laudario di Cortona, la più antica raccolta di ‘laude’ che ci sia pervenuta, con la quale nel lontano XIII sec. si dava inizio alla Sacra Rappresentazione della ‘Natività’ nel raccolto dell’Annunciazione:
‘Da ciel venne messo novello / ciò fo l’angel Gabriello.
L’angello fo messo da Dio, / ben començò et ben finio:
saviamente, sença rio, /annuntiò lo suo libello.
«Ave Maria, gratia plena, / Dio ti salvi, stella serena!
Dio è con teco che ti mena / enn-el paradiso bello.»
«Come fie quel che tu ài decto? / Nom credo a torto né a dritto,
e ben ne posso far disdetto:
non cognosco hom, vecchio né fancello.»
L’angelo disse: «Non temere, / tu se’ a Dio si a piacere,
altra madre non vole avere / se non voi, con k’io favello.»
Respose la kiara stella: / «Io son qui ke so’ su’ ancella,
sia secundo la tua favella: / cusì mi chiamo et apello!»
Contemporaneamente all’evolversi della Messa, insorgono rivalità tra le varie città che si contendono zone d’influenza tra il dominio spirituale e quello temporale, tra clero secolarizzato e riformatori ortodossi. A questo mondo di dissensi e di confusione Francesco d’Assisi (1182-1226), predicatore itinerante originario dell’Umbria, reca il messaggio di una religiosità semplice e genuina e dà l’avvio, con il suo “Cantico delle Creature” ad una letteratura religiosa abbondante e di qualità: le ‘laude’. Il primo grande poeta a comporre ‘laude’ fu Jacopone da Todi (1233-1306) del quale voglio qui ricordare “Il pianto della Madonna” che veniva cantato in occasione della ‘Settimana Santa’.
Sono questi i temi che infine entreranno a far parte della tradizione popolare, liturgica e spirituale medievale e che, in seguito, trasfonderanno nel affinato impianto musicale della ‘Messa pro Nativitate Domini’, il vigore della fede propriamente sentita, in cui l’essere, dimentico della propria solitudine, recupera la seppellita coscienza, per cui la vita è sul nascere veritiera promessa: il dono più grande.
(continua)
*
- Musica
Quaderni Etno 10: I figli del vento - seconda par.
Tratto da “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” di Giorgio Mancinelli, MEF Firenze Atheneum, premio letterario “L’Autore” per la Saggistica, 2006.
Testimonianze di culture etniche.
“Quando stanchi saranno odio e rabbia, /
quando ormai si saranno /
dissanguate le liti nella guerra, / allora sì, allora tu potrai /
suonare di nuovo / con più ardente slancio.”
(M.Vorosmarty)
“Io dico le mie pene cantando, / perché cantare è piangere./
Io dico la mia gioia danzando, / perché danzare è ridere.”
(anonimo zingaro)
Dicono le parole di alcune canzoni zingare, ma più che le parole contano i sentimenti. Liriche che evocano lontane contrade, la natura con le sue stagioni, i suoi doni, le sue privazioni; uno, cento, mille amori incontrati e perduti, le privazioni e le ostentazioni di tutta una vita, forse mai capita, per lo più oltraggiata. Come si sa, la vita nomade è dura, ruba i momenti più belli in cambio di una parola che oggi ha perduto in parte il suo significato, ma che tuttavia conserva il suo antico fascino: ‘libertà’. Ed è questa libertà che l’estro zingaro si appella anche quando ‘improvvisa’ la sua musica che, a differenza di altre, presenta una adattabilità ad altre, pur mantenendo fede a formule originarie rivelatesi indissolubili.
È difficile stabilire cosa gli Zingari abbiano lasciato o smarrito, tantomeno quantificare l’entità di assimilazione della musica degli ‘altri’, durante il lungo corso delle loro peregrinazioni. Una prima risoluzione riconosce agli Zingari la capacità di aver conservato una propria cultura musicale che presenta temi ricorrenti comuni a tutti i gruppi, malgrado i cambiamenti sociali ne rendano precaria, oggi più che mai, la conservazione. In effetti essi, dotati di un profondo senso musicale ma privi di cultura letteraria, riescono ad esprimersi con straordinaria precisione ed eleganza attraverso il linguaggio musicale alla cui radice si rintracciano almeno due fonti di ispirazione: una basata sulle arie popolari apprese e, l’altra, che sorge dall’estro individuale. A queste si aggiunge uno straordinario impulso mnemonico che permette loro di suonare “a orecchio” e con estro creativo, un motivo appena ascoltato, arricchito di sovrastrutture improvvisate.
Tutta la loro vita si riflette nella loro musica: lenta e monotona come le le loro giornate solitarie, ardente come i loro amori, bacchica come le loro danze, sonora come la loro voce, che si leva nel canto. Tuttavia il motivo più ricorrente nel canto come nella musica, è però lamentoso, malinconico come il loro spirito. Languide, selvagge o semplicemente allegre che siano, le loro melodie, eseguite al violino o al flauto, cantate con un fil di voce o con l’intonazione rauca nell’inimitabile manierismo zingaro, si rivelano interessanti pur non avendo un autentico valore musicale in senso assoluto di forma e armonia. Sono per lo più composizioni spontanee, provenienti da luoghi d’origine lontani tra loro, apprese in quei paesi attraversati durante il loro continuo viaggiare e da cui derivano alcune differenze formali tipiche dello stile.
È stato detto che solo un vero zingaro può valutare la purezza del proprio stile conoscendo le condizioni esterne, sprigionatasi dall’intimo rapporto lirico del proprio essere a contatto con la natura, con i luoghi attraversati, che in certo qual modo hanno contribuito alla sua formazione. Allora ècco che qui un violino ruba la voce a un usignolo, un ‘nai’ richiama il mistero della montagna; lì una chitarre intona un canto che si ispira alla luna, una donna zingara esegue una danza antichi attorno al fuoco. La loro eco rievoca ricordi millenari, sentimenti ‘ancestrali’ pur sempre nuovi, che vanno a infrangersi come un’onda del mare sulla scogliera; come l’uomo di oggi contro la vita senza senso di domani: “Allora che importa il paese, fratello, prima di tutto ci sono gli uomini e le melodie ... sotto le iucche danza la vita” (Sandra Jayat)
Non va dimenticato che la professione dello zingaro musicante, ancor oggi straordinariamente diffusa, è presente da secoli in numerosi paesi, con differenze formali quali, ad esempio esistono fra la musica dei Gitani e quella degli Tzigani; la diversa esecuzione di una danza nella Grecia antica e la stessa danzata oggi in Bulgaria; il nome diverso dato a uno strumento medesimo; l’impostazione diversa di un canto, ecc. Così accade per le diverse forme musicali come il Jazz, il Flamenco, la Czarda, la Rapsodia, tutti termini che suggeriscono la musica di altri popoli piuttosto che quella degli Zingari. Eppure noi sappiamo, e possiamo rilevarlo, quanto in esse ci sia l’estro zingaro che, si rivela, nel soliloquio intimo e segreto del suo essere. È questo un fare musica creativo che può soltanto essere immesso in una cultura preesistente, ancor più che riceverne gli influssi. Infine, che può essere utilizzato, adattato, finanche mistificato, ma che risentirebbe in modo decisamente negativo l’intromissione di formule precostituite.
Il vero artista è per lo zingaro solo colui che prende il motivo della canzone o la sola melodia come l’epigrafe di un poema, o forse come il sommario di un discorso fra sé e lo strumento, fra sé e la sua musica, e su questo filo conduttore, mai del tutto perso di vista, esegue fioriture, cesellature come arabeschi che ricordano, ipoteticamente, la loro provenienza, il luogo ad oriente delle loro origini oscure. È ancora con l’aiuto delle scienze applicate, in questo caso l’etimologia, la scienza che studia l’origine linguistica delle parole, che oggi siamo in grado di situare geograficamente, seppure in modo approssimativo, i luoghi in cui gli Zingari hanno soggiornato e tracciare le linee itineranti delle loro migrazioni, iniziate pressoché al sorgere delle prime civiltà arcaiche, verso la fine dell’età neolitica, tra il 3500 a il 3000 a.C.
Un lento e costante procedimento in questo senso che portò, in quel lasso di tempo, al sorgere delle iniziali forme di agricoltura dando così luogo ai primi insediamenti umani e, ad una ulteriore suddivisione sociale a cui si fa corrispondere l’inizio della composizione delle differenze etniche e la suddivisione della popolazione in tribù nomadi e sedentarie. Quelli che prima erano pastori o guerrieri e si spostavano da un luogo all’altro alla ricerca di nuovi pascoli per i propri animali, o alla ricerca di un bottino da razziare, divennero stanziali e agricoltori e, solo alcuni gruppi, tra i quali appunto gli Zingari, conservarono l’antico costume nomade all’interno del vasto territorio indiano. Una prima migrazione zingara in epoca storica è attestata al XV secolo, riguardante lo spostamento di alcune tribù nomadi perseguitate dai cavalieri del Gran Tamerlano che avevano invaso l’India. L’esodo, che secondo alcuni era già iniziato tra il VI fino al’ XI secolo, si svolse molto lentamente dalla ricca e fertile valle dell’Indo, attraverso la Persia, dove alcuni gruppi sopravvissuti sono ancora oggi chiamati Luri o Luti.
In Europa queste genti arrivarono almeno in due correnti migratorie che, partite dall’Hinducush si spostarono in seguito nel vicino Pakistan e nei territori delle città di Harappa e Mohenio Daro., per poi inoltrarsi in Siria e da lì in Arabia e in tutto il bacino nord-est del Mediterraneo. Successivamente un ramo delle grandi migrazioni si spostò verso l’Anatolia raggiungendo i Balcani, mentre, un altro, si spinse in Egitto, per poi spingersi la parte sud-ovest della costa dalla Libia fino al Marocco. Fatti questi che, secondo alcuni studiosi, spiegherebbero il perché del frequente trovare parole greco - bizantine soltanto in alcuni gruppi e parole turco-arabe in altri.
Anche se oggigiorno sono davvero pochi gli Zingari che mantengono un carattere nomade, il nomadismo rimane il retaggio più importante che questo popolo ci comunica, alla base di tutte le ‘primitive’ forme di società, sulle quali si sono formati alcuni dei ‘caratteri originali’ che vengono riconosciuti come base della loro cultura, come: l’accattonaggio, derivato dall’essere originariamente un popolo raccoglitore; lo spostarsi sui carri come mezzo di trasporto; il modo di vestire colorato e fantasioso; l’uso di cucinare i cibi in un determinato modo tipico zingaro; fare alcuni ‘mestieri’ insoliti, tuttavia necessari alla loro sopravvivenza. Inoltre, l’attaccamento alla famiglia, l’anelito alla vita libera, l’essere indipendenti, evocare una sorta di nostalgia per una terra ‘edenica’ lasciata o, forse, sconosciuta, l’incuranza del tempo che passa, la ricerca instancabile d’una felicità inconseguibile e un certo modo di esternare un grande desiderio di comunicare, di divertire, di vivere, in cui principalmente si rispecchia il loro vivere.
Modo che i nomadi generalmente conducono quasi per una sorta di ‘imprinting’ più che per vera e propria tradizione. Ed è ciò che, in qualche modo, da un senso a quanto tramandato dalle generazioni passate a quelle che noi oggi possiamo osservare, e che si rivela in tutto ciò che essi trasmettono in senso artistico e culturale: dallo stile di vita di chi è sempre in viaggio, alla sete dell’ignoto e del pericolo, così come nella poesia e nelle canzoni, come nei racconti orali che rappresentano la loro inequivocabile ‘voce’ e la loro particolare ‘visione’ del mondo che in essi esprimono. Anche se è all’aspetto più ‘arcaico’ del loro misticismo che dovremmo guardare per poter maggiormente comprendere la loro ‘arcana’ fonte di religiosità, che va ben oltre la capacità di sopravvivenza fin qui dimostrata e il disadattamento profondo, che pure hanno contribuito a popolare la loro esistenza di spiriti e demoni.
Una religiosità colma di un senso quasi angoscioso del soprannaturale che gli Zingari hanno conosciuto attraverso i millenni della loro nomade esistenza, passati nella ‘nostalgia’ di una Terra che, verosimilmente, li ha generati e poi abbandonati e che, in qualche modo, riemerge nello spirito collettivo cui sono estremamente legati e, seppure, abbiano ben radicato il concetto di non appartenere a nessuna terra. In assenza di una cultura ‘scritta’ e, nel voler trovare una risposta plausibile al quesito primario: “esiste oppure no una cultura zingara?”, rispondo con l’ausilio di alcune discipline moderne che – a mio avviso – ben si rapportano al campo di ricerca specifico, quali: l’etnologia, l’etologia e, non in ultima, l’ecologia umana; branchie dell’attuale antropologia che ci permettono di studiare la specie umana nel suo complesso evolutivo, con l’intento – scrive Pietro Rossi (1) – “di riconoscere il valore delle forme di organizzazione sociale e dei costumi di tutti i popoli, anche di quelli tradizionalmente denominati ‘primitiva’.”.
Scrive Constantin Brailoiu (2): “In Occidente più ci si avvicina all’epoca presente, più si è ostacolati dalle difficoltà di una discriminazione troppo obiettiva e più si è portati, di conseguenza, a concepire il ‘popolo’ come un’entità puramente amministrativa; come un complesso umano composto dalle medesime forze storico-economiche e spirituali. Altri replicano attentamente che tratti materiali e morali ‘primitivi’, più antichi di quanto possiamo immaginare, sopravvivono nel nostro presente. La definizione, per un certo verso decisamente valida, rischia di essere errata se riferita al popolo degli Zingari, per il quale invece si potrebbe usare, al pari di tante altre: ‘mitici’, per quell’alone di storicità che li accomuna ai nuclei più antichi.”
Accettata questa definizione ‘letteraria’, dalla quale del resto siamo necessariamente partiti in questa ricerca, si pongono in primo piano alcune domande alle quali va data una risposta approfondita, al di là delle barriere imposte dalla lingua e malgrado i cambiamenti inevitabili dello stato sociale abbiano resa precaria la conservazione:
Come si è tramandata per così lungo tempo la lingua orale degli Zingari, senza il supporto seppure successivo di una grammatica scritta?
Come ha potuto, una cultura orale atipica, il cui adattamento ad altre culture presenta un aspetto così prevalente, conservare forme linguistiche originali?
Volendo riconoscere agli Zingari un proprio carattere etnico di una qualche forma ‘originale’ e che abbia una portata culturale come ‘valenza comunicativa’, questo non può che essere individuato nel linguaggio universalmente riconosciuto, secondo per antonomasia alla lingua parlata, che è la musica. Capace da sola di legittimare gli Zingari, per aver dato impulso alla propria affermazione culturale – musicale che si presenta ricca di sonorità diverse in temi comuni ricorrenti, uguali per i molti gruppi etnici in cui essi si distinguono. Ma se lo sconfinare geograficamente e l’ulteriore dilagare nelle ipotesi ci porta a non poter tralasciare alcun indizio che sia di un qualche interesse, tuttavia non possiamo ancora parlare di una ‘identità musicale’ riconoscibile come specificamente zingara.
È però rilevante l’apporto dato dalla moderna musicologia che ci permette di ampliare l’orizzonte del problema, attraverso lo studio della musica nella sua evoluzione creativa e la sua comparazione con altre culture musicali. Scrive Béla Bartòk (3): “Si chiama ‘folklore comparato’ quella disciplina scientifica che sta fra la musicologia e il folklore, e che è ormai largamente praticata dagli studiosi della musica popolare. Scopo di questa disciplina è quello di stabilire, in base a confronti fra le raccolte dei vari popoli affini o vicini, i ‘tipi originari’ presenti nelle rispettive culture musicali, e quelli che sono gli ‘elementi comuni’, per pervenire quindi alla rilevazione ed al riconoscimento delle reciproche influenze sopravvenute fra le diverse forme canore e musicali.”
Scrive ancora Constantin Brailoiu (4): “Altri però respingono ogni modello scientifico (..) dichiarando ‘popolare’ tutto ciò che a loro sembra tale, e cioè – secondo l’esempio del Davenson – tutto ciò che produce ‘una certa impressione di allontanamento dal proprio ambiente e di caratteristico esotismo che fa provare quel fremito che l’incanto dell’inatteso provoca’. Ma per fortuna trattasi di sporadici casi che tendono all’isolamento delle culture, lontani dalla cultura propriamente detta ed intesa come un tutt’uno musicale.”
Nel suo accreditato ‘The World of Music”, Frank Harrison (5) mette a punto il metodo della ricerca comparata in campo musicologico e ne fissa le coordinate di base: “sull’uso e la sua funzione”, “l’osservazione strutturale”, “la comparazione multipla” e “l’influenza della comunicazione semantica.” Spetta però ala “Semantique Musicale” elaborata da Alain Daniélou (6), musicologo e orientalista francese, l’aver definito i fondamenti della teoria comparativa e delle interazioni musicali. Tuttavia, quanto più gli orizzonti si estendono ad altre discipline specifiche, più l’obiettivo finale si sottrae alla sua individuazione. Per quanto la sociologia applicata alla musica prevalga sulla critica musicale, ancora non si è giunti a una definizione ammissibile. Non rimane che dare una ulteriore risposta a una domanda apparentemente semplice:
Perché nella musica zingara non si rintracciano elementi fortemente individualizzanti?
Una risposta plausibile sta nel definire l’intuito musicale zingaro come una risorsa culturale propria. Come ricercatore, volendo io evidenziare alcune analogie altresì presenti nello studio comparativo della loro musica, sono venuto a contatto di una funzione simbolica tipica zingara, propedeutica alla loro vita religiosa. Per dirla con C. G. Jung (7): “... il simbolo differisce sostanzialmente dal segno o dal sintomo, e dovrebbe essere inteso come l’espressione di una percezione intuitiva”. Ma come anche dice Augusto Romano (8): “Scrivere intorno alla musica significa fare della mitologia; ma la musica, quando ci accade, si sottrae alla mitologia, perché è mito in azione”. Pertanto possiamo affermare che è possibile affermare non tanto cosa la musica è, ma cosa si racconta intorno alla musica. Questo in fine è il compito che mi sono prefisso con questa mia ricerca.
Pertanto, il musicista zingaro – è stato detto e ribadisco – “...cava l’essenza della sua arte da se stesso” e “che solo un vero zingaro può valutare la purezza del proprio stile, e riconoscere al suo interno quali contributi siano utili alla sua formazione.” Anche per questa ragione, e poiché non sono ben definite le condizioni che l’hanno determinata, noi, i gadjè, il ricercatore non zingaro, non può essere certo di raggiungere l’obiettivo che si è preposto: di dare, cioè, una definizione attendibile della musicalità zingara, ma può solo avvicinarvisi, con possibilità di errore, pari a quella dimostrata nel paragonare molta della musica convenzionale ad essa.
Se, come ha affermato E.T.A. Hoffmann (9) nel n.4 di “Kreisleriana”: “...la musica dischiude all’uomo un regno sconosciuto, un mondo che non ha nulla in comune con il mondo sensibile esterno che lo circonda e in cui egli si lascia alle spalle tutti i sentimenti definiti da concetti per affidarsi all’indicibile”, ne deduciamo che allora l’indicibile è quel mono che non si presta a essere raccontato con le parole e che può essere detto solo con la musica. Si ha qui la situazione paradossale per cui qualcosa di inesprimibile si nasconde nell’espressione che un linguaggio palese contiene; per così dire, una sorta di linguaggio occulto che fa della musica zingara, un’arte non imitativa o riproduttiva, rivolta non già verso il mondo esterno, ma verso la più intima soggettività. Di qui la preferenza accordata alla musica strumentale rispetto alla vocale, come quella che meglio corrisponde alla propria vera essenza.
L’autore che più di ogni altro ha approfondito questo concetto, studiandone la radice archetipica e svelandone il carattere simbolico, è il musicologico e psicologo francese Michel Imberty (10) che fondamentalmente ha rivolto la sua analisi alla struttura musicale di forme ‘arcaicizzanti’ , allo scopo di definirne gli stili ne rivelarne il senso. In quanto ‘arcaica’ l’esperienza musicale si configura come esperienza di una realtà psicologica profonda, motivante la creatività: “Una struttura che non si apre in forma univoca, ma piuttosto come compresenza di potenzialità anche contraddittorie che spesso l’interpretazione tende impropriamente a ‘normalizzare’ e che invece assume la caratteristica ‘virtuosistica’.” Nella quale ritroviamo, a livello talvolta inconscio, quegli ‘arcaismi’ che sono tipici dello spirito creativo umano, in grado di definire un singolare ‘stile’ che possiamo definire: “...la storia anticipata o ritrovata di una parte essenziale dell’uomo.”
Nel suo “Trattato della musica”, scritto ancor prima dell’Anno Mille, successivamente tradotto dall’arabo in francese da Rodolphe d’Erlanger con il titolo “La musique arabe”, il filosofo islamico Mohammed Abu Nasr al Farabi (11), afferma: “L’uomo è capace di comporre, c Mohammed Abu Nasr al Farabi (11)reare musica in virtù di attitudini innate, si può dire per istinto, per una spinta interna che fa parte della sua natura e che lo spinge a produrre alcuni suoni, quando si sente lieto e, altri invece, quando è triste e addolorato, quasi per esaltare e rendere ‘poetici’ i suoi sentimenti. Allo stesso modo, quando ha l’intenzione di stimolare la mente e dare maggior forza espressiva a una composizione poetica, il mezzo più efficace consiste non solo nell’usare una melodia corrispondente al significato delle parole, ma anche, altri motivi dotati della speciale capacità di provocare o calmare una data emozione (..) per impadronirsi totalmente dell’immaginazione dell’ascoltatore: condurlo a comprendere meglio la poesia.”
A dirla ancora con E.T.A. Hoffmann: “Se consideriamo che la musica ha per oggetto l’infinito...”, di fatto, veniamo a trovarci di fronte a una rivelazione che può essere valutata come ‘religiosa’. Giacché, per mezzo suo, entriamo in contatto con gli “arcana dèi”, altresì possiamo meglio osservare quello che è l’aspetto, non secondario, di una ‘religiosità’ intrinseca di un fare musica che non conosciamo. Se per accezione una musica può ritenersi creativa, e lo è in genere tutta la musica, questa non può esimersi dall’essere autentica. Similarmente possiamo affermare che la musica degli Zingari è creativa senza ombra di dubbio. Nell’ascoltare la musica zingara infatti, l’orecchio del musicista colto, coglie subito la stranezza degli intervalli che è portato a considerare come una inesattezza nell’esecuzione; così com’egli è disorientato dalle sue modulazioni, che gli appaiono rozze, contrarie ai suoi dogmi musicali.
Va qui considerato che ci si trova in assenza di una cultura musicale vera e propria, e cioè scritta; per cui la ‘non conoscenza’ specifica della scala musicale’ o dell’utilizzo di uno strumento particolare, pone lo zingaro nella dimensione insolita, quantomeno inesprimibile a parole. Ma se – come è già stato detto – essere difficile stabilire cosa gli Zingari hanno abbandonato o smarrito della loro cultura musicale, tantomeno è possibile quantificare l’entità di ciò che hanno verosimilmente assimilato dai popoli che hanno conosciuto nel corso delle loro lunghe peregrinazioni, al di là delle manomissioni e delle facili contaminazioni a cui l’odierna musica fonografica ci ha abituati. È per noi più facile incorrere in approcci sconsiderati o quanto mai basati su esclusivi interessi nazionalistici; così come anche si può essere indotti a trascurare per negligenza o superficialità di ricercatori, questo o altro supporto musicale.
Ma non si tratta qui di stabilire forme di compatibilità tra sistemi musicali diversi o, viceversa, di appartenenze etniche geograficamente distinte. Bensì di approfondire il rapporto esistente fra le diverse culture e le loro interazioni musicali, che solo uno studio approfondito e comparato può individuare, al fine, di un appropriato riconoscimento e di una corretta collocazione all’interno delle diverse culture musicali esistenti. Scrive Bruno netll (12): “...che l’etno-musicologia mostra chiari segni di sviluppo, tuttavia tarda ancora a divenire una etnologia della musica, poiché rimane legata troppo saldamente a propositi musicologici, cioè alla descrizione e comparazione delle componenti musicali. (..) Ora, essa può comprendere la musica in quanto fatto culturale solo se cessa di trattarlo come fenomeno a se stante, e la situa in una globale visione di concetti estetici, della filosofia, del temperamento, condotta di un gruppo etnico che giustifica appunto l’etnologia. Si rischia altrimenti di vedere questa disciplina divenire indifferente o insensibile ad un aspetto essenziale della vita culturale dei popoli che essa studia, mentre alcune culture risentiranno della limitatezza del musicologo e dell’insufficiente qualificazione musicale dell’etnologo.”
Qual è ‘dunque’ la vera musica degli Zingari?
Quella musica misteriosa che si pensa di aver sentito ma che nessuno in realtà conosce, legata com’è a rituali ‘oscuri’ di un’altrettanto ‘oscura’ tradizione. Al punto che opinioni contrastanti arrivano finanche a negarne l’esistenza. D’altro canto, come si può pensarla diversamente se non è mai stata trascritta, e perché? Contrariamente a quanto si crede, la storia stessa del popolo zingaro, cosa comune a quasi tutti i popoli di cultura orale, è ricca di ipotesi e povera di certezze. Nonostante ciò una musica che presenta caratteri comuni ai gruppi Zingari, o perlomeno, di una musica che presenti caratteri comuni ai gruppi compresi nell’arco geografico ove questi vivono e si spostano, e cioè le aree che hanno visto le grandi migrazioni storiche, esiste; anche se nessuno si è preso la briga di trascriverla e documentarla.
Per quanto ciò rappresenti uno dei problemi insoluti della moderna etnomusicologia, la ‘ricerca sul campo’ ha tuttavia confermato la sua estrazione popolare, d’appartenenza alla tradizione del singolo gruppo che, verosimilmente, l’ha prodotta e preservata nell’anonimato. Recentemente, e soprattutto in seguito alla presa di coscienza di alcuni attenti ricercatori, si è giunti a riconoscere alla musica zingara alcune prerogative che le venivano confutate in passato, quali, ad esempio: un certo ‘virtuosistico’ uso degli strumenti musicali, la conturbante ‘leggiadria’ delle melodie, il fuoco ‘passionale’ esibito nei ritmi a ballo e un indubbio ‘carattere timbrico’ nell’intonazione della voce, entrate in seguito nella tradizione musicale di molti popoli d’Europa.
Per Franz Lizst (13) se il musicista ‘non zingaro’ rimane spesso “...interdetto di fronte a quegli intervalli inusitati nell’armonia europea”, così come in presenza della “fioritura lussureggiante eminentemente orientale”, o alle “modulazioni così aspre”, al contrario, “un uditore che abbia il vantaggio di conoscere la musica e di essere impressionabile”, si lascia prendere dalla “libertà e ricchezza dei ritmi, dalla loro molteplicità e duttilità” presenti in tutta la musica zingara. La Società Etnografica Ungherese ad esempio, che doveva riparare allo ‘scandalo’ causato dal suo libro “Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie”, si trovò a far fronte ad un vero e proprio dilemma procurato dalle affermazioni dello stesso Lizst: “...se la musica tzigana poteva dirsi musica ungherese oppure no?”. Il senso era chiaro, almeno per il grande maestro che, con la sua affermazione, riconosceva una grande affermazione della musica zingara passata alla musica ungherese e viceversa.
Lo stesso interrogativo che venne affrontato in seguito da Béla Bartok che, in “Scritti sulla musica popolare” si trovò ad affrontare il problema durante la Conferenza del 1931, non portò a nessuna presa di posizione sostanziale. Il dibattito sulla questione rimase aperto come del resto lo è ancora oggi. Lo stesso Franz Lizst se ne fece portavoce, restituendo agli ungheresi una sorta di primato, lodando il pubblico del suo paese per aver permesso agli Zingari di sviluppare pienamente i loro doni: “Senza gli ungheresi, che ne sarebbe stato dell’artista zingaro? – si chiese – dandosi poi come risposta, che “l’arte zingara appartiene agli ungheresi, come un figlio a sua madre; perché senza di loro, non sarebbe mai esistita”. Fatto è che molta della musica zingara è entrata con successo a far parte della musica ufficiale dell’Ungheria.
Tanto era sconvolgente la risposta che un altro musicologo ungherese Emilio Haraszti (14) si trovò a dichiarare: “Non esiste una musica zingara indipendente (..) lo zingaro aveva indubitabilmente assimilato la musica del paese che l’ospitava.” Negando con ciò, e fuor di ogni dubbio, una prevalenza della musica zingara su quella ungherese. Parole queste che suonarono come una prima conferma, forse quella che tutti cercavano: la dimostrazione pratica che, sotto l’archetto dello zingaro, la musica ungherese aveva preso il suo più autentico slancio. Quale che sia, la conclusione di questa diatriba andò avanti per lungo tempo, quasi che oggi interessa ormai relativamente. Successivamente Béla Bartòk nel voler riaffermare la supremazia ungherese sulla musica zingara, si servì della cosiddetta “Raccolta di Bartalus”, una raccolta musicale formata di centinaia di melodie, come testamentario della creatività del popolo ungherese, ma che, in realtà, non conteneva più di 300 o 400 canti veramente popolari, a fronte delle migliaia esistenti sul territorio. E d’altra parte, il modo con cui erano trascritte, o notate che dir si voglia, era talmente approssimativo, che non si poté fare a meno di criticarlo severamente.
L’esempio qui riportato non è tuttavia il solo ad aver rappresentato nel tempo la linea di partenza di ogni futura ricerca, ripreso a modello negli altri paesi d’Europa. Problemi analoghi si riscontrano ogni qual volta ci si sofferma a considerare la musica di un paese o di un altro, più o meno investiti dalla migrazione zingara. Venelin Krustev (15) relativamente alla musica di Bulgaria, porta ad esempio un’ampia documentazione ‘anonima’ che riconduce la sua tradizione al Medioevo. Egli scrive: “Tradizione che rappresenta una speciale riserva nell’arte della musica epica e nell’arte della danza di questo paese, eredità della più antica cultura dei popoli Balcani. Che a loro volta l’avevano appresa dall’eco giunto fino a loro di due civiltà classiche, quella ellenica e quella bizantina. Alle quali si è andata sovrapponendo la più dinamica delle culture medievali: la slava, sopravvivenza dei relitti della più antica cultura contadina autoctona.”
Indubitabilmente la cultura autoctona slava ha avuto una grande influenza anche sulla cultura musicale del popolo zingaro. Si dovrebbe qui ascoltare la musica suonata e cantata dai vari gruppi ‘vlax’ o prendere parte a una ‘slava’ o una ‘paciv’, le due feste dei Rom presenti in quest’area, ed apparirà subito evidente come la musica, e soprattutto la musica ‘a-ballo’ , sia fortemente pregna di questa influenza. Questo anche se non si segnalano eccessivi stanziamenti di gruppi di Zingari sul territorio bulgaro, ma solo esigui e sporadici passaggi. Molto più presenti invece nella ex Jugoslavia dove fornito il supporto ad una musica che risente della cultura orientale, in particolar modo quella legata ai Rom-Xorané stanziali della Macedonia.
Altri gruppi minoritari distaccatisi dalle grandi correnti migratorie sono presenti in paesi più lontani, quali la Finlandia e la Svezia, dove la musica zingara di derivazione slava, è quasi esclusivamente costituita da canzoni, sebbene la musica ‘strumentale’ rappresenti da sempre l’unico mezzo per la comprensione reciproca, utilizzata da tutti i gruppi presenti sul territorio. Il repertorio comune comprende, oltre ai canti di protesta indirizzati verso le istituzioni, melodie popolari sullo stile russo, antiche romanze e canzoni di carattere religioso, e rappresenta quanto di più originale sia da accreditarsi alla cultura musicale zingara.
La situazione si presenta diversa in Russia dove elementi zingari sono presenti in canti popolari tramandati oralmente e perpetuati nella tradizione popolare. A una attenta osservazione il contenuto dei “Canti popolari russi” raccolti da Vladimir J. Propp (16), apparentemente chiusi dentro un contegno tutto contadino, gode invece di una straordinaria libertà interiore. Gigliola Venturi (17), che ne ha redatto la prefazione italiana, scrive: “..fin dal primo impatto sembra disegnarsi già tutta la trama della canzone e dei suoi allegorici, il mondo autenticamente vissuto giorno per giorno, con una freschezza che il tempo non ha offuscato. Tutti gli avvenimenti più essenziali della vita appaiono fra le righe, sempre superati da una vena umoristica nelle canzoni tristi, melanconica in quelli allegri (e questo bilanciarsi fra gioia e mestizia si riflette anche nella musica, quando udiamo note vivaci accompagnare un testo di contenuto triste). Prerogativa questa che sembra affermare il significato più segreto della vita della zingaro, e che gli permette di riconquistare la sua dignità di uomo libero o di gettarsi alla vita del brodjaga, del vagabondo, nelle lontane terre dell’Oltre Volga e nelle steppe del Don.”
Si colloca qui un’immagine un po’ bohémien dello zingaro che avevamo forse dimenticata, soprattutto per quell’atmosfera che si ricrea alla presenza della sua musica: sottolineata da una profonda e nostalgica malinconia, lenta e monotona come una giornata passata in solitudine e, improvvisamente, scattante come un gesto ieratico e sonoro, passionale come solo l’amore sa esserlo, ardente e sensuale come solo la sua danza, consumata davanti al fuoco che divampa, può essere: “folgorata a momenti da sprazzi di straordinaria vitalità.”
Se si pensa che la grande capacità musicale degli Zingari è giunta a noi nella sola forma orale, ha già di per sé dell’incredibile. Sta di fatto che la musica zingara, da sempre impressa nella memoria di chi la concepisce, è verosimilmente portata dal vento o, altrettanto suggerita dalle ‘forme’ di un desiderio o di un amore che langue. Così come languida è l’espressione poetica i cui versi sciolti sono spesso dolenti come lo è la loro stessa vita. I canti zingari a cui per lo più si fa riferimento presentano alcune lacune formali; non in ultima quella più negligente della mancanza di informazioni riguardanti la data e il luogo dove sono stati raccolti, oppure del gruppo di appartenenza. il lettore deve tener conto, inoltre, della incompletezza di alcuni testi trascritti dalla versione orale, della diversa condizione psicologica e ideologica di chi li ha trasmessi, della possibile errata interpretazione del traduttore nei casi di mancato reperimento degli originali audiofonici, nonché della diversa personalità dell’esecutore.
Relativamente ai testi di canzoni che sono parte del patrimonio della canzone russa, Vladimir J. Propp (18) fa la seguente considerazione: “Per intendere e valutare giustamente la canzone popolare, bisogna tenere sempre presente che i canti creati dal popolo non sono destinati alla lettura. Essi non vanno letti come si leggono le poesie. Per altro non somigliano neppure alle nostre romanze o alle poesie messe in musica dai compositori. Nelle canzoni popolari più autentiche, parola e melodia costituiscono un’organica, inscindibile unità primigenia. Ma anche separato dalla melodia che lo accompagna, il contenuto letterario dei canti risulta così significativo, vario e bello, da meritare uno studio specifico e attento, anche se, infine da un’idea incompleta della natura della canzone.” Lasciando altresì intendere che come spesso la canzone sfocia nella poesia, così la musica le tiene sospese in un ‘idillio’ che le rende universali. Considerazione questa, che dobbiamo far nostra e che possiamo riferire anche ad altre culture di estrazione orale.
Il singolo canto di per sé, ha un valore inferiore se comparato con quello ‘corale’ della grande tradizione russa, anche se, a sua volta, questa è resa più fruibile da un certo decorativismo aggiuntivo comunemente riconosciuto agli Zingari. Indubbia è l’utilizzazione della musica popolare dovuta all’espansione territoriale, crogiuolo di razze e culture diverse, di espressioni musicali originali entrate a far parte della tradizione russa: melodie orientali persiane, tartare e turche, finanche indiane e cinesi che, nel tempo, si sono sovrapposte ad assonanze bizantine della lirica ortodossa praticata in tutto il paese. I compositori russi, affascinati dalle variazioni strumentali, dai contrappunti naturali, dagli arabeschi virtuosistici, hanno saputo trarre raffinate sonorità, melodie eloquenti e ritmi incalzanti ripresi da melodie autoctone o, per così dire ‘acculturate’, prese da quelle tzigano-slave o gitano-andaluse, talvolta suggerite dagli Zingari.
A seconda dell’estrazione dei compositori che, di volta in volta, si sono misurati con le melodie elaborate e trasferite nella forma ‘zingaresca’ così generalmente detta: “una rapsodia per violino solo o accompagnato dalle ampie possibilità di esibizioni e virtuosismi, e per il succedersi, dopo un’introduzione a ritmo lento, di passi vivaci e brillanti”, si è convenuto alla considerazione che gli Zingari non si sono limitati solo al ruolo di suggeritori, bensì in quello di autentici interlocutori musicali. Diffusasi sul finire del Settecento e poi per tutto l’Ottocento romantico, la forma ‘alla zingaresca’ si ritrova in ‘quartetti’ e ‘trii’ entrati nell’esecuzione classica, conosciuta e apprezzata nelle corti europee anche da molti compositori ‘non zingari’, colti dall’interesse verso le ‘altre’ forme di musica.
Scrive Massimo Mila (19): “Tutta la generazione di musicisti del XIX secolo che va da Dvoràk a Berlioz a Lizst, da Bartòk a Kodaly a Schubert a Bhrams, fino ad arrivare in epoca moderna a De Sarasate, De Falla, Strauss, Lehar, Schonberg, si è spinta a trovare un nuovo linguaggio musicale recuperando gran parte del patrimonio musicale popolare.” Vanno qui ricordate le ‘musiche spagnole’ elaborate da Michail I. Glinka, come la ‘Jota Aragonesa’ e ‘Recuerdos de Castilla’ che, a suo tempo, inaugurarono la nuova forma sinfonica basata sulla rassegna fantasiosa di melodie e ritmi popolari che, in seguito, influenzarono gran parte dei lavori orchestrali di Rimskij-Korsakov quali ‘Shéhérazate’, ‘Capriccio Spagnolo’, dal gusto arabo-andaluso; e quelle ancora più orientaleggianti di Aleksandr P. Borodin, come le famose ‘danze polovesiane’ da ‘Il Principe Igor’ e ‘Nelle steppe dell’Asia centrale’, in cui si denotano i profondi vincoli affettivi e culturali che lo legavano a quello specifico tipo di musica.
Si richiama qui l’attenzione sulla figura di Igor F. Stravinskij che, nel Novecento, letteralmente invase la scena mondiale e del quale voglio qui ricordare la raccolta dei ‘Canti popolari russi’ (poco eseguita) e quel geniale capolavoro quale è ‘La sagra della primavera’, riallacciandosi, oltre che compositamente anche semanticamente, ai riti agresti del sopraggiungere della nuova stagione, impregnata com’è del ‘sacro fuoco’ della creatività – quasi che il compositore anelasse a un mistico approccio con gli eventi del sotterraneo e dell’occulto che lo ancoravano alla sua terra russa. Precedentemente Philippe Rameau nel Settecento aveva portato in Francia una nota prematuramente romantica in senso musicale, con le ‘Suites per clavicembalo’, ed esattamente in ‘L’egyptienne’, in cui aveva raccolto un vezzo musicale zingaro.
Già André Campra aveva inserito nel suo famoso ‘Carnevale di Venezia’, rappresentato all’Operà di Parigi nel 1710, una ‘Canzone delle zingare’. Successivamente il grande commediografo Molière faceva intervenire egiziani ed egiziane nella sua opera teatrale ‘Le mariage forcé’ che, entravano cantando e ballando al suono di tamburelli baschi. Una moda che si protrasse oltre il secolo in cui il commediografo introduceva nel II atto del suo ‘Malade imaginaire’ una danza di zingari. Per approdare, infine, all’operetta di Franz Lehar ‘Zigeunerliebe’ (Amor di Zingaro); e con Johann Strauss junior ‘Der Zigeunerbaron’ (Lo zingaro barone). E, infine, nell’opera lirica di Giuseppe Verdi che, ne ‘Il Trovatore’, ambientato nella Spagna del XV secolo, fa cantare un’aria zingaresca sullo sfondo dell’accampamento dei gitani, dove alcuni fabbri battono ritmicamente sulle incudini i martelli, entrata col nome di ‘martinete’ nella forma del ‘Cante’ flamenco.
Georges Bizet fu tra i primi della scuola francese ad ispirarsi al ‘flamenco’ riprendendone i temi nella sua opera più famosa: ‘Carmen’. Ma si vuole che in tempi non sospetti il belga Françoise-Auguste Gevaert, rimasto affascinato durante i suoi frequenti viaggi in Spagna, ponesse particolare attenzione al ‘Cante gitano’ del quale ne studiò la forma. Più tardi i temi zingari apparvero frequenti nelle opere di molti compositori sinfonici e lirici, che si appropriarono dei virtuosismi della musica zingara. Su tutti spicca la figura di Maurice Ravel, colui che meglio di ogni altro evocò la musica zingara di tradizione spagnola nelle sue pagine più belle, inclusi temi e melodie che gli Zingari avevano portato dal lontano Oriente: ‘Pavane pour une enfante défunte’, ‘L’heure espagnole’, ‘Rapsodie espagnole’, ‘Alborada del Gracioso’, ed uno esplicito omaggio agli Zingari con ‘Tzigane’. Ed è ancora Massimo Mila (2o) a scrivere di lui: “Il suo interesse portò infine a tentare un ‘affresco’ nel quale un ritmo costante e monotono viene scelto come base strutturale per una raffinata, incredibile varietà timbrica degli strumenti”. Nacque così il ‘Boléro’ che in breve fece il giro del mondo e che rimane una delle musiche più ascoltate e apprezzate ancora ai nostri giorni.
Claude Debussy (21), pur non conoscendo molto la Spagna, fu profondamente influenzato dalla musica dei Gitanos. Vi si ispirò nelle composizioni ‘La Puerta del Vino’ e ‘Soirée en Grenade’, in cui maggiore si rivela la profonda influenza del ‘Cante Jondo’, per poi giungere al massimo grado della creatività nel poema sinfonico ‘Iberia’, un’opera definita geniale in cui ondeggiano come in un sogno profumi e caratteri dell’Andalusia. È altresì importante ricordare come la moda francese ‘alla zingaresca’ fu nel suo insieme molto sensibile alla musica gitana e a quella ungherese nelle corrispettive forme della ‘sarabanda’ e della ‘czarda’: Séverac, Chausson, Massenet, Lalo, Saint-Saens e lo stesso Ravel, vi trovarono ispirazione per le loro composizioni migliori.
“Sul finire del secolo XIX – riporta una cronaca del tempo – si poté affermare con ammirazione che una musica nuova animava già tutta l’Europa” e che lo spirito zingaro aleggiava sopra di essa. Fu quindi la volta del compositore ceco Antonin Dvoràk, il quale raccolse numerose ‘melodie zingaresche’ che, a loro volta, ispirarono l’altro grande musicista Johannes Brahms. Nelle sue composizioni, però, la tecnica di sviluppo non fui mai condotta a un grado di elaborazione tale da compromettere l’integrità poetica dell’immaginazione popolare, sicché questa, all’interno della costruzione dotta, acquisiva un fascino nostalgico emergendo come richiamo di un mondo originario e genuino.
L’ungherese Johannes Brahms (22) colse nella musica magiara le melodie, i canti e le danze popolari meglio conosciuti nelle brillanti e decorative versioni zingare. Famosi i suoi ‘Zigeunerlieder’ fortemente intrisi della vitalità e dei colori della tradizione zingara. Ripresi, poi, nella forma delle più famose ‘Rapsodie’, in cui dimostra mobilità ritmica e un’ardua virtuosità tecnica che ancora oggi ci ripropongono le misteriose sonorità e le inflessioni melodiche delle orchestre zigane. Sono molto note le sue ‘Danze ungheresi’, eco di quelle melodie decorative zingare raccolte per la strada ed entrare a far parte del folklore popolare ungherese.
Particolare attenzione va rivolta all’etnomusicologo e didatta Zoltàn Kodàly (23), il quale studiò il canto popolare e raccolse il patrimonio musicale della sua terra ungherese. Associandosi con Bartòk in una ricerca che non avrebbe più abbandonato e che va sotto il nome di ‘Corpus Musicae Popularis Hungaricae’, in cui sono raccolti canti e cori zingari elaborati sui modelli del folklore magiaro entrati nel repertorio popolare; così come alcune danze ‘Hungarian Gypsy Dances’ in cui il compositore sublima la ritmica zingara contenuta nella rapsodia ‘Dances of Galànta’.
Anche Béla Bàrtok (24) coltivò un appassionato interesse per il canto popolare ungherese e balcanico. Fu uno dei primi a interessarsi e a studiare la musica araba. Ben presto si avvicinò, sull’esempio di Lizst, al folklore musicale del proprio paese che approfondì metodicamente e scientificamente, ricavandone insegnamenti decisivi anche per la definizione del suo linguaggio compositivo. Ricordiamo qui ‘Sette danze popolari rumene’, caratterizzate da un’energia ritmica quasi ossessiva e da un’armonia quasi ai limiti dell’atonalità, come nelle ‘Sei canzoni popolari ungheresi’ e le ‘Canzoni popolari rumene’, composte entrambe in forma di ‘rapsodia’ per violino e pianoforte in cui si rivela peculiare il fine espressivo sulla struttura, caratteristica del canto popolare “ricostruito non mediante citazioni letterali ma attraverso l’imitazione e la ‘reinvenzione”.
Fine che gli esperti vogliono ‘suggestionato’ dalla musica di Franz Lizst, compositore delle ben note ‘Rapsodie Ungheresi’ nella forma di ‘improvvisazioni’ per piano, in cui si riflette la spontaneità ‘ad effetto’ tipica zingara. Ma, anche, dal ‘Rondò all’ongarese’ di Joseph Haydn e dal più famoso ‘Divertissement à l’hongroise’ di Franz Schubert (25), autore, fra l’altro, di numerosi ‘Lied’ in cui l’ispirazione a temi zingari e ancor più alla figura romantica del “viandante”, appaiono espliciti. Il primo ‘lied’ della ‘Winterreise’ schubertiana comincia infatti con questi versi: “Come uno straniero sono comparso / come uno straniero me ne vado”. E ancora in ‘Der Wanderer” (Il Viandante) conclude così: “Dove sei, amato mio paese? / Il paese che parla la mia lingua, / o terra, dove sei tu? / Io vago silenzioso, infelice, / e sempre mi domando sospirando: dove? / E sempre: dove? / Una voce misteriosa mi risponde: / dove tu non sei, la è la felicità.”
Felipe Pedrell (26) fu tra i primi in Spagna a introdurre lo studio scientifico e sistematico del canto popolare della propria terra ed a individuare e suddividere gli elementi di tradizione popolare da quelli di musica colta che hanno concorso a formare la ‘fisionomia’ e il ‘carattere’ della musica nazionale. L’importanza storica del suo ‘Cancionero Musical Popular Espanol’ del 1958 ne fanno uno dei massimi esponenti della cultura musicale spagnola.
Un particolare contributo lo ha dato da Manuel De Falla (27) che nel 1922, insieme al poeta spagnolo Garcìa Lorca, fu protagonista di un famoso festival del ‘Cante Jondo’, esplicitamente ricorrendo nella composizione al repertorio ‘flamenco’, nella quale però il musicista predilesse lo stile ‘impressionista’ di scuola francese, come nelle ‘Tre melodie per voce e pianoforte’ nel cui ambito diede corpo almeno a un capolavoro classico: ‘Noches en los jardines de Espana’, sorta di poema sinfonico pervaso da una struggente sensualità sonora. E nei ‘El sombrero de tres picos’, ‘La vida breve’ e nel ‘El amor brujo’ con la sua impetuosa e straordinaria ‘Danza rituale del fuoco’, fondamentali del balletto classico spagnolo e, ai quali è legata la fama che lo ha consacrato in tutto il mondo.
Sonorità del resto già emersa nelle ‘Siete canciones populares espanolas’ per voce e pianoforte, in cui la ricerca, sapiente e raffinata della composizione, che si rivelò di straordinaria ‘liricità’ nel suo ‘El retablo de Maese Pedro’ e, in ‘Concierto Madrigal’ per due chitarre e orchestra e, ancora, nella ‘Serenata Andaluza’ seguita dalle ‘Pièces Espagnoles’ in cui il maestro concepì i poli tonali e armonici ancora più prossimi alla ‘tensione flamenca’ interpretata con linguaggio moderno: “ma di un folklore autentico, non manierato, da sembrare quasi inventato”.
Vanno qui ricordati inoltre, compositori di estrazione ‘classica’ che attinsero al repertorio gitano-andaluso profondamente radicato nella cultura spagnola: il raffinato Isaac Albeniz: ‘Suite espanola’, ‘Suite Iberia’; il pittoresco Enrique Granados: ‘Danzas espagnolas’; l’intimistico Francisco Tarrega: ‘Recuerdos de Alhambra’, e Pablo de Sarasate, violinista e compositore, acclamato come uno dei maggiori virtuosi di tutti i tempi, la cui produzione, manierata e teneramente sensuale, sfrutta magistralmente le qualità cantabili e coloristiche del violino nelle così dette ‘Arie tzigane’, rappresentative del ‘patos’ zingaresco e nelle ‘Danze spagnole’, in cui i ritmi andalusi sembrano compenetrarsi magistralmente con quelli tipici gitani. Per non dire di altri strumentisti di grande talento, quali: Andrés Segovia, Joaquin Nin, José Munoz Molleda, Joaquin Turina, Miguel Llobet, i quali hanno trovato nel ‘flamenco’ di origine gitana le sorgenti della loro ispirazione.
Alla luce delle nuove discipline della etnologia comparata, della sociologia applicata e ovviamente dell’etnomusicologia, continuano fervide le ricerche avviate sulla materia musicologica. Importante e a sua volta rivelatore, fu lo studio di A. L. Lloyd (28) sui corrispettivi sociali nell’ambito del ‘Cante’ spagnolo (jondo o gitano) che egli, per primo, introdusse, nel campo della comparazione con il ‘Blues’ americano: “Il Blues come prodotto tipicamente cittadino trova nel Cante una forma musicale speculare corrispondente. Chi ascolta un cantante di flamenco fa un immediato riferimento al ‘modo’ con cui un suonatore di tromba ‘hot’ improvvisa i suoi chorus su di un tema, divenendo sempre più geniale e più caldo nel corso dell’improvvisazione. Le canzoni andaluse non vanno considerate come musica paesana, ma come musica cittadina. Come nei migliori blues, questi canti riflettono la condizione sociale, la schiavitù, la prigionia, la miserabile vita dei bassifondi e della periferia.”
Similitudini si riscontrano anche nella presenza di temi e soggetti ricorrenti tra le ‘prison songs’ e le ‘carceleras’, allo stesso modo che nel blues i temi andalusi sono eseguiti sulla scala naturale della chitarra. I testi qui di seguito riportati, sono quelli originali sui quali Lloyd si è basato per la comparazione specifica:
Esempio di ‘carceleras’:
“A la carse voy / y verlo no pueo / porque no tengo naita que darle, / Mare al carselito. / Probesito es los mineros / La stima e los yo tengo / que se meten en las minas / y mueren sin confesion. / Al ver llora a mi mare / me soltaron los siviles / me soltaron un guantaso / en mitad a las narices.”
“Vado in prigione / ma non posso vederlo / perché non ho nulla da dare, / mamma al carceriere. / Son disgraziati i minatori / e io li compiango / si ammazzano nelle miniere / e muoiono senza confessione. / Quando videro mia madre piangere / i poliziotti mi mollarono, / mi mollarono un pugno / dritto fra le narici.”
Esempi di ‘blues’:
“I sure do hate that wagon, / I mean that old police patrol. / The best that I can wish it, / I hope it falls off in some hole” (Patrol Wagon Blues).
“Chiaro che odio quel furgone, / voglio dire quello della polizia. / Il meglio che posso augurargli, / è di finire in un fosso.”
“Have you heard what that mean old judge has done to me? / He told the jury not to let my man go free / There I stood with my heart so full of misery / He must die on the gallows, that was the court’s decree” (Last Miles Blues).
“Hai sentito cosa m’ha fatto quel vecchio ignobile giudice? / Ha detto alla giuria di non assolvere il mio uomo / E io sono qui col cuore pieno di disperazione / Egli morirà sulla forca, così ha decretato il tribunale della contea.”
È interessante notare come entrambe questa forme siano espressioni urbanizzate di canto e risentano d’una stessa influenza africana trasmessa dagli arabi in Spagna e dai negri d’Africa in America. Allo stesso modo, per i gitani-andalusi come per i bluesman, ciò che infine conta è soprattutto l’emozione, l’espressività propria delle parole. La musica prende spunto da questa emozione che si sprigiona libera nel ‘Cante’ come nel ‘Blues’ stabilendo un evidente rapporto fra ‘jondo’ e ‘soul’, fra gitano-andaluso e negro-americano.
L’internazionalità di questa comparazione ha portato eminenti studiosi a divagare e ricercare un paese d’attribuzione, per così dire, un’area geografica da indicarsi su un Atlante; o forse, soltanto a voler trovare un’etichetta qualsiasi, sotto la quale depositarla e magari reprimerla all’interno di una Enciclopedia. Ma, come si sa, il divagare non aiuta a segnare il punto di alcuna questione e la musica zingara, per le sue peculiarità intrinseche, va considerata dai suoi diretti fruitori, che sono in primis i musicisti che la producono e successivamente gli ascoltatori o chi ne usufruisce per diverse ragioni, che sia l’intrattenimento o la danza o l’intimistico canto.
Quanto detto è così vero che successivamente, in epoca romantica, gli Zingari seppero facilmente adeguarsi alle ‘mode’ musicali in voga, adeguando la loro maestria strumentale alla musica ‘colta’ che si faceva nei teatri di corte e nelle opere di strada, anche dette ‘zingaresche’, spingendosi perfino a recitare ‘parti da zingaro’, la cui testimonianza è qui riportata da Mario Verdone (29), il quale scrive: “La zingarella è una danza ballata sul canto alla zingaresca recitata in brevi scenette di Carnevale, di gusto giocoso, e prese a prestito dai tentativi di predire il destino, fatti da zingare vere per la strada. La zingarella che balla e canta crea col suo stesso personaggio un genere che poi finisce per evolversi in commedia. (..) La zingaresca è registrata particolarmente a Roma e il Bourchard nel suo ‘Voyage’ (1637), nota che nell’Urbe ad ogni angolo di strada si recita una zingaresca”. (..) ‘Er ballo delli Xingari’ è famoso qui, come spettacolo delle carovane di passaggio.”
Anton Giulio Bregaglia (30) affermava e si diceva compiaciuto di questo tipo di azione drammatica, del valersi di astrologi, di sortilegi, incantesimi e ogni sorta di magie, ma anche di giochi di destrezza e di trucchi: “Venivano in scena i personaggi delle streghe, dei falsi negromanti, degli indovini. Ed era un modo in più di approccio vero con il ‘meraviglioso’ di cui si è sempre valso lo spettacolo”. Ed ovviamente il teatro, essendo le zingaresche componimenti recitati nelle fiere, sui carri o nei teatrini di piazza che alternavano le marionette e le ombre agli attori. Prima, dunque, erano semplici canzoni sceneggiate, e solo poi farse con più personaggi.
Con la definizione ‘zingaresca in forma di commedia’ nota ancora Bragaglia, si indica l’evoluzione del genere teatrale e la sua maturità drammatica, dacché, dalla zingaresca il teatro si evolse nella ‘commedia in canzone’, in particolar modo in Spagna nella ‘zarzuela’, nel ‘vaudeville’ in Francia, nell’ ‘operetta’ in Italia e, non in ultima, nel più attuale ‘musical’ dei paesi anglosassoni. Non fanno eccezione i moderni spettacoli con Zingari acrobati e addestratori di animali, fra teatro equestre e finzione in cui, al di là del tempo e della logica, si cede alle seduzioni ‘zingaresche’ da parte di un pubblico avido di libertà perdute.
Va inoltre aggiunto che gli Zingari, pur adeguandosi alle imposizioni della cultura dominante del territorio che li ospita, rimangono per lo più fedeli alle loro tradizioni che adattano a seconda dei casi, alle tradizioni dei popoli che li ospitano. Diverso è invece il rapporto con gli elementi della natura, ai quali gli Zingari riservano particolari attenzioni e che si ritrovano nei loro racconti e nelle fiabe così come nella poesia e nelle canzoni, in ugual misura dei sentimenti che in essi sprigionano. Il vento, il fuoco, la pioggia, la terra, o che siano le distese praterie o i grandi ghiacciai e le fitte boscaglie, sono quasi sempre i protagonisti, fasti o nefasti, delle storie in cui è rappresentato il mondo vegetale e faunistico, osservato in tutte le sue manifestazioni: dall’imitazione dei comportamenti amorosi, ai dolorosi quanto necessari scontri per il dominio; dalla conoscenza dei segreti custoditi nelle erbe officinali per la cura della salute, a quelle da utilizzare in cucina e l’alimentazione.
Una ‘conoscenza’ questa che gli Zingari conservano all’interno del ‘gruppo’ di appartenenza, entrata a far parte del bagaglio di tutta l’umanità, verosimilmente tramandata di generazione in generazione fino ai nostri giorni attraverso vie che sono a noi sconosciute. Così come pure è avvenuto per i manufatti quali: la lavorazione degli utensili, la cardatura del rame, le espressioni artistiche dei monili d’oro, la preparazioni dei cibi e i rituali magici ai quali essi sono legati. Nonché nella costruzione di strumenti musicali e l’esecuzione musicale, cui gli Zingari riservano un luogo nascosto nel cuore. Ed è a questa musica, così ‘piena’ e veramente ispirata che dobbiamo fare riferimento per comprendere le ragioni che la distinguono; si è detto che essi ‘improvvisano’ per se stessi, la cui originalità è racchiusa nel fatto di averla suonata migliaia di volte in luoghi sempre diversi e in diverse occasioni, talvolta con strumenti diversi a seconda del proprio stato d’animo, sempre diverso.
Una musica che tuttavia non ci è dato di conoscere e approfondire perché ‘non scritta’ e che quelli che pure la hanno ascoltata dicono: “Se anche avessimo modo di sentirla non avremmo orecchie per ascoltarla”. Quella che in realtà certamente ci è capitato di ascoltare in alcune occasioni, possiamo dire che ci ha divertiti, che ci ha spinti a danzare, ma che non sapevamo facesse parte di una ‘cultura’ così antica, più del nostro odierno bagaglio culturale. Forse, perché nessuno di noi è mai stato in grado di trascriverla e depositarla in quello che è il bagaglio musicale dell’umanità, ma che gli Zingari, da sempre tengono a mente come ‘conoscenza’ metafisica del tempo, tale da poterla richiamare al proprio ‘presente’ attraverso le vie arcane e misteriose della memoria ancestrale.
Come pure scrive Angela M. Tettamanti (31): “Noi non dovremmo esibirci nelle loro danze, perché non avremmo la stessa andatura”: cioè quella suggerita dal cavallo (mulé) o dal cane che sempre si portano dietro durante i loro spostamenti di nomadi. Semplicemente perché non ne siamo capaci, o forse perché a loro detta: “abbiamo smarrito il senso delle interferenze astrali, il piacere di guardare alla luna come a una compagna frivola e amorosa che ci invita. Così come di lasciarci avvampare dal fuoco della passione, lasciarci scompigliare i capelli dal turbine del vento, lasciare che il corpo vibri col tremito delle foglie, perché abbiamo dimenticato come parlare alla terra, madre tenera e consolatoria che ci stringe fra le braccia la notte e ci preserva e ci accoglie dopo la morte”. Tuttavia dobbiamo prendere atto che se la loro cultura è senza scrittura, noi certo non sappiamo leggere. Come dire che ci siamo persi, abbiamo perso il senso della vita, non rientriamo più nel grande congegno delle sfere celesti, né in quello dello spirito dell’universo che pure ci accoglie e tutti ci anima: loro, gli Zingari che da sempre attraversano il cielo, e noi ‘gadjé’ sedentari e immobili su questa terra ormai senza futuro.
Non rientra nell’intento di questa ricerca affermare una qualche supremazia del musicista zingaro, né che tutta la musica strumentale sia di derivazione zingara. Tantomeno possiamo affermare che lì dove è presente un fattore virtuosistico o una qualche forma di genialità compositiva o esecutiva, queste siano riconducibili in qualche modo all’estro zingaro. Ciò, sebbene, essi abbiano ampliamente dimostrato uno straordinario talento musicale e un acclarato virtuosismo strumentale, assai meno nell’esibizione canora o la danza che, solo in alcuni casi, si è fatta conoscere a livello internazionale. Gli esempi autenticamente zingari sono numericamente pochi se riferiti alla musica sinfonica: F. Szabo (compositore), E. Szervànszky (compositore), G. Cziffra (piano), N. Zabaleta (arpa), A. Karas (zither), E. Zimbalist (violino), e più recentemente jean-jacques Kantorov (violino), Alexander Balanescu (violino), Georghe Zamfir (pan-flute). Più numerosi invece quelli che hanno incrementato le fila dell’easy-listening, del rock e della musica popolare in genere, quali S. Lakatos e Y. Nemeth (lautari), D. Reinhardt (chitarra jazz), e i più recenti The Musicians of the Nile (charcoal gypsies), Orquestra Andalusì de Tanger e Juan pena Lebrian (gruppi a confronto), Acquaragia Drom (gruppo multietnico), Gypsy Kings (gruppo flamenco rock), Burhan Ocal (oriental ensamble), Taraf de Haiduks, Kocani orchestar e Fanfare Ciocarlia (gruppi tzigani).
È invece in crescita il numero dei compositori contemporanei – non necessariamente zingari di estrazione – che hanno dimostrato un vero interesse verso la musica tradizionale, come Goran Bregovic (31) (Bosnia) compositore e arrangiatore, autore di numerose colonne sonore con le quali ha internazionalizzato la musica popolare del suo paese; Anouar Brahem (32) (Tunisia), capace di far convergere la musica d’Oriente e Occidente mediterraneo in un solo strumento, l’ ‘oud’; gli Agricantus (33) gruppo rappresentativo della nuova cultura multietnica e multilinguistica; Stephen Micus (34) (Germania), considerato un ‘guru’ della musica mondiale, conoscitore delle tecniche di molti strumenti tradizionali orientali, alcuni dei quali pressoché sconosciuti in Europa, capace di accalappiare quel ‘suono del tempo’ di cui abbiamo fin qui parlato e riversarlo in una sorta di ‘visione universale’ (tuttavia non globalizzata), in cui la musica si fa narratrice di mondi inimmaginabili e tuttavia possibili futuri.
Ma già altri si affacciano nel panorama della musica mondiale e dichiarano di aver attinto a quell’inesauribile contenitore che è la musica etnica di popoli e paesi, capace com’è di trasmettere stimolanti sorprese: “se solo imparassimo a leggerla”. Ne sono un esempio: Giya Kancheli (Georgia), benjamin Yusupov (Tajikistan), Fikret Amirow (Azerbabaijan), Awet Terteryan (Armenia). Non possiamo qui lasciar passare inosservati i fautori delle ultime esperienze del Jazz, da John Coltrane, Dollar Brand, Paul Motian, The Art Ensemble of Chicago, Dino Saluzzi, Gianluigi Troversi e Gianni Coscia, Kim Hashkashian, Eleni karaindrou, Tomasz Stanko; ed anche Astor Piazzolla, un certo Max Roach e il primo Gato Barbieri; certamente Alice Coltrane e il non trascurabile gruppo dei Kronos Quartet.
Tuttavia c’è dell’altra musica che va pure ascoltata, ed è quella dell’angolo della strada’ altrimenti detta ‘musica metropolitana’. Quella dei corridoi dell’underground, o se preferite ancora delle ‘feste di piazza’, alla quale dobbiamo porgere l’orecchio se vogliamo avere accesso alla musica più autenticamente zingara di cui fin qui si è soltanto parlato, anche se non necessariamente suonata da Zingari. Che è poi la stessa dei trovieri medioevali e rinascimentali che non usavano trascrivere i versi delle giaculatorie o delle ballate o, contrassegnarle con alcuna notazione musicale; ma che pure rispondeva a quella stretta ‘conoscenza’ detta anche ‘ars musicandi’ giunta fino a noi e incorporata negli interstizi musicali della cosiddetta ‘musica popolare’, in cui è raccolto il patrimonio più cospicuo della musica del mondo.
Non ci rimane che approfondirne l’ascolto. A questo preciso scopo ho inserito qui di seguito un’ampia discografia che si spinge oltre la fin troppo etichettata musica etnica, per presentare all’ascoltatore curioso e desideroso di conoscere quegli esempi di musica colta e non, antica e contemporanea, sinfonica e rockettara, che accolgono in sé dichiarate esperienze folkloristiche e popolari, rappresentative delle culture più lontane, talvolta estreme fra loro. Come del resto estrema è l’esperienza che siamo spinti a fare quando per demagogia politica, ci abbandoniamo a negare l’esistenza di una cultura e con essa l’esistenza stessa di un popolo, e affondiamo le nostre rivalse nella negazione della loro libertà, ne facciamo l’oggetto dell’intolleranza razziale, neghiamo ad esso finanche la sopravvivenza coatta.
Note:
1) Pietro Rossi, in Preciado D,. ‘Folklore Espanol’, Studium, madrid 1969.
2) Constantin Brailoiu, ‘Folklore Musicale’, Bulzoni, Roma 1978.
3) Béla Bartòk, ‘Scritti sulla musica popolare’, Bollati Boringhieri, Torino 1977.
4) Constantin Brailoiu, (op.cit.)
5) Frank Harrison, ‘The World of Music’, International Music Council
Unesco, vol. XIX.
6) Alain Daniélou, ‘Traité de Musicologie Comparée’, Unesco Collection, e in Lerici,
Cosenza 1977.
7) C. G. Jung, .....
8) Augusto Romano, ‘Musica e psiche’, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
9) E.T.A. Hoffmann, in ‘Krisleriana’ n.4, articolo in Romano A.., (op.cit.)
10) Michel Imberty, ‘Les écritures du temps. Sémantique psychologique de la musique’,
Editions Bordas Dunod, paris 1981 ; traduzione italiana : ‘Le scritture del tempo’,
Ricordi Unicopli, Milano 1990.
11) Mohammed Abu Nasr al Farabi, ‘Fantasia musicale dell’Anno Mille’, in Il Corriere
Unesco, anno XXIV n.6 (giugno) 1973.
12) Bruno Netll, ‘Musicologia per capire i popoli’, in Il Corriere Unesco (op.cit.)
13) Franz Lizst, ‘Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie’, Paris s.i.d.
14) Emilio Haraszti, in B. Bartok, (op.cit.)
15) Venelin Krustev, ‘Bulgarian Music’, Sofia Press, Sofia 1978.
16) Vladimir J. Propp, ‘Canti popolari russi’, Einaudi, Torino 1976.
17) Gigliola Venturi, in V. Propp, (op.cit.)
18) Vladimir J. Propp, (op.cit.)
19) Massimo Mila, ‘Breve storia della musica’, Einaudi, Torino 1963.
2o) Massimo Mila, (op.cit.)
21) Edward Lockspeiser, ‘Claude Debussy’, FME, Genova 1990.
22) Johannes Brahms, in ‘Storia della Musica’, The New Oxford History of Music,
Garzanti-Feltrinelli, Milano 1991.
23) Zoltàn Kodàly, ibidem.
24) Béla Bartòk, (op.cit.)
25) Franz Schubert, ‘Winterreise’, in A. Romano (op.cit.)
26) Felipe Pedrell, ‘Cancionero Musical Popular Espanol’, Boileau, Barcelona 1958.
27) Manuel De Falla, in ‘Enciclopedia della Musica’, Garzanti, Milano 1996.
28) A.L. Lloyd, ‘Social Aspects of Andalician Folk Music’, in gruppo Arca ‘Arte Nomade’,
IGIS, Milano 1980.
29) Mario Verdone, ‘Le maschere romane’, newton Compton, Roma 1995.
30) Anton Giulio Bregaglia, in M. Verdone (op.cit.)
31) Angela M. Tettamanti, (op.cit.)
Discografia:
Per un maggiore approfondimento sulla ricerca etnomusicologica si possono consultare numerosi documenti sonori apparsi in pubblicazioni discografiche tutte di notevole interesse: ‘The History of Music in Sound’ edita dalla His Master’s Voice; ‘Ethnic Folkways Library’ Nonesuch Records; ‘Musical Atlas’ EMI e ‘Musical Sources’ per Philips Unesco-Collection; Melodya (Russia); House of Culture of Bucharest; Request Records (Romania); Balkanton (Bulgaria); Jugoton (Jugoslavia); EMI-Columbia (Grecia); Le Chant du Monde, Ocora e Editions Musée de l’Homme (Francia); AIMP Archives Internationales de Musique Popolaire (Svizzera); Hispavox (Spagna).
Copiose in Italia le collane: ‘Dischi Albatros’, ‘I dischi del Sole’, ‘Universo del Folklore’ (Arion) con documenti originali del folklore musicale europeo e del resto del mondo. Ben corredate risultano anche le collane: ‘Musiche dal mondo’ Fabbri Editori; ‘World Music’ La Repubblica; ‘Hemisphere’ EMI; ‘Real World’ di Peter Gabriel, e la più recente ‘Meridiani Musicali’ dell’Editoriale Domus con libretti interessanti ed esaustivi.
*
- Musica
Quaderni di Etno 10: I figli del vento - prima p.
Tratto da “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” di Giorgio Mancinelli, MEF Firenze Atheneum, premio letterario “L’Autore” per la Saggistica, 2006.
“Bianche ali, pian piano / senza far rumore / si posarono nella radura. / Accanto al fuoco si prepararono il nido / con canti andarono incontro / alla celeste aurora.”
(Rasim Sejdic)
Le origini.
Chi mai può dire se vanno o vengono da un mondo a noi sconosciuto?
L’alone di mistero che circonda le origini degli Zingari ha fatto sì che fin dall’antichità si formulassero numerose supposizioni mitologiche, scatenando fra gli studiosi pareri contrastanti e ipotesi avventate, mentre altre, forse più eclatanti, sono poi risultate frutto di mera fantasia, sebbene, a causa della mancanza di definizioni e modelli di riferimento, la fantasia sia risultata talvolta illuminante nel quadro più generale della ‘storia’ che qui si è cercato di ricostruire. Ciò non vuol dire che dietro il libero gioco della mente non possa esservi un proposito, una meta, per quanto fantasiosa possa apparire. Se è vero che “ci sono state grandi culture che non usavano la ruota, ma non ci sono state culture che non narrassero storie” – quella contenuta in questa tesi, in realtà, è forse la più sostanziale storia creata o forse inventata dall’immaginazione umana.
L’esistenza di esseri ‘misteriosi’ abitatori di ‘terre nascoste’, dei quali gli Zingari sono un esempio tra i più impressionanti, rappresenta un vero e proprio enigma per la moderna etnologia che, malgrado l’acquisizione di più recenti e ‘documentate’ testimonianze, non è ancora riuscita a fare luce sul mistero che circonda le origini di questo popolo, conosciuto – come vedremo – fin dalla più lontana antichità. “La ricerca delle ‘terre nascoste’ – scrive Serge Huttin (1) – e, in senso lato, delle ‘civiltà misteriose’ che vivono nelle viscere della Terra, può essere letta e interpretata a due diversi livelli complementari tra loro, anche se di diversa profondità e significato: l’aspetto esteriore, per così dire letterale; e la determinazione effettiva dell’esistenza o meno di queste terre, la loro ubicazione geografica, la loro collocazione nel tempo e, andando più a fondo, il tipo di civiltà che esse ospitarono e i suoi rapporti con le civiltà storiche.”
Scrive Nicholas Roerich (2): “Tra le innumerevoli leggende e fiabe di vari paesi, si trovano racconti su tribù perdute o abitatori di un mondo sotterraneo. In regioni lontane e diverse, il popolo parla di fatti identici. Se confrontiamo queste leggende, si nota subito che si tratta di capitoli di una stessa storia. Dapprima sembra impossibile che esista una connessione fra queste chiacchiere distorte, ma in seguito si cominciano a cogliere peculiari coincidenze nelle più varie leggende di popoli che ignorano persino l’uno il nome dell’altro. Si riconosce la stessa connessione nel folklore del Tibet, della Mongolia, della Cina, del Turkestan, del Kashmir, della Persia, dell’Altai, della Siberia, degli Urali, del Caucaso, delle steppe russe, della Lituania, della Polonia, dell’Ungheria, della Francia, della Germania (..). dalle più alte montagne agli oceani, queste leggende raccontano di come un popolo pio fosse perseguitato da un tiranno e, non volendo sottostare alla sua crudeltà, decise di rinchiudersi in un mondo sotterraneo.”
La presenza di un ‘mondo sotterraneo’ le cui ramificazioni si estendono sotto i continenti e sotto gli oceano, collegato con il supremo centro Agarttha o anche Agharti, Asgharta o Agharta, in cui “si conserva il deposito immutabile della tradizione primordiale”, è testimoniata in alcuni miti cosmogonici presentati da René Guénon (3) che costituiscono il modello di molte culture: “Sotto un profilo morfologico, queste tradizioni appaiono solidali con il simbolismo embriologico della creazione del mondo, in cui il cosmo prende forma da una materia informe e ‘caotica’. Si elabora così un complesso di immagini equivalenti e complementari che assimilano alla materia germinale l’inizio dell’esistenza umana.”
E ancora, da Julius Evola (4): “Al prevalere dell’empietà sulla terra, i superstiti delle età precedenti passarono in una sede ‘sotterranea’ – cioè invisibile – che, per interferenza con un simbolismo dell’ ‘altezza’, spesso viene situata sui monti. Là essi continuerebbero a esistere, sino a che con l’esaurirsi del ciclo della decadenza si renda possibile una loro nuova manifestazione.”
Importanti testimonianze sono rintracciabili in epoche che precedono la storia documentata e da esse provengono le prime descrizioni del mondo sotterraneo. Dal Rig-Veda, ritenuta la più antica opera letteraria indù e fondata su tradizioni orali certamente più arcaiche, apprendiamo che con la fusione delle genti ariane con le popolazioni locali, avvenuta tra il 1700 e il 1200 a.C., si foggiò in definitiva l’India, il primo nucleo ‘civilizzato’ da cui insegnamenti cosmici e dalle cui dottrine si delineò quel mondo mistico sotterraneo entrato poi nella leggenda, divenuto in seguito, punto focale di attenti studi e investigazioni.
Scrive l’orientalista Friedrich Max Muller (5): “In quegli antichi tempi, paesi che oggi ci sono noti con nomi diversi venivano chiamati tutti indifferentemente India”. E suggerisce che esistono buoni motivi per sospettare che le grandi civiltà del mondo antico, dell’Egitto, della Grecia e di Roma, derivassero le loro leggi, arti e scienze da quell’India pre-vedica: “Una delle tradizioni universali accettata da tutti gli antichi popoli sostiene ci siano state molte razze di uomini che precedettero quelle odierne. Ciascuna di queste era diversa da quella che l’aveva preceduta; e ciascuna scomparve al comparire di quella successiva”. E, inoltre, che al centro di questa ‘culla dell’umanità’ vivessero i superstiti di una razza che aveva caratteristiche davvero singolari: “Poteva vivere a piacimento e con la stessa facilità sia nell’acqua che nell’aria o ‘nel fuoco’, perché possedeva un illimitato controllo degli elementi. Erano i ‘Figli di Dio’. Furono loro a trasmettere agli uomini i più misteriosi segreti della natura e a rivelare loro l’ineffabile e ormai perduta ‘parola’” – e che , nonostante il potere assoluto di cui disponevano, non riuscirono di fatto a impedire la propria estinzione.
Al contrario , alcuni testi rivelano invece che essi furono annientati da una qualche ignota distruzione di massa. Louis Jacolliot (6) allo stesso modo parla di una tradizione indo-ellenica preservata dai popoli più intelligenti che emigrarono dalle pianure dell’India e dell’esistenza nell’antichità di un continente e di un popolo perduti. Si deve a questo studioso, la divulgazione dell’esistenza di un vasto e antico ‘mondo sotterraneo’ fiorito “secoli prima della nostra era” e governato da Brahm-atma, autorità suprema e guida degli Iniziati, seguaci devoti, discendenti di una civiltà ancora più antica, detentori di una formula mistica rappresentata dalle lettere AUM il cui significato sta per: “A” Creazione, “U” Conservazione, “M” Trasformazione, che “simbolizzava tutti i segreti iniziatici delle scienze occulte”.
Louis Jacolliot (6) così commenta: “Questa parola misteriosa, di cui nessun potere umano poteva rivelare il significato, è conosciuta come il tempio di Asgarta. (..) Coloro che vi dimorano dispongono di grandi poteri e sono a conoscenza di tutti gli avvenimenti del mondo. Possono viaggiare da un luogo all’altro attraverso gallerie sotterranee antiche quanto quello stesso mondo.” Agarttha, che in sanscrito significa ‘l’inafferrabile’ o ‘l’inaccessibile’ ma, anche l’l’inviolabile’, appare in alcune mitologie dove si parla dell’esistenza di genti che la abitano così dette civiltà telluriche, sotto l’egemonia di un sovrano, detto il “Re del Mondo”, che Ferdinand Ossendowski (7) vuole raffigurato sulla tomba del suo predecessore: “in cui si parla dell’origine degli Zingari che un tempo vi avrebbero vissuto” – quali lontani discendenti di antiche deità sotterranee.
Scrive ancora Ossendowski: “Verrà un tempo, in cui il popolo di Agarttha uscirà dalle sue caverne ed apparirà alla superficie della Terra.” Ipotizzando quanto in seguito sarebbe accaduto agli Zingari, presunti abitatori di quel ‘mondo estremo’ all’origine del mito. Una ‘terra cava’ solcata da immensi labirinti, da caverne ciclopiche e da interminabili gallerie site nei luoghi più disparati del mondo: dal deserto del Gobi, al Tibet, alla Terra Santa, all’Egitto, fino all’Irlanda e al Nuovo Mondo, Agarttha esiste sul nostro stesso piano di esistenza ma ad un livello vibratorio differenziato, difesa da una sorta di barriera magnetica ottenuta attraverso la manipolazione di forze invisibili che ne ostacolano la penetrazione.
Saint-Yves d’Alveydre (8) fa di Agarttha una realtà tangibile sita nelle viscere della Terra: “Il cui vero territorio sfida la stretta costrizione portata da ogni violenza e da ogni profanazione.” Un territorio privilegiato, simultaneamente concreto e simbolico, posto in un universo parallelo al nostro e che il “Re del Mondo”, simbolo vivente della suprema alleanza tra il potere temporale e l’autorità spirituale, muove in ordine all’evoluzione ciclica dell’umana esistenza.
Scrive ancora René Guénon (9): “Un principio, questo, che può manifestarsi attraverso un centro spirituale stabilito nel mondo terrestre da una organizzazione incaricata di conservare integralmente il deposito della tradizione sacra, di origine ‘non umana’ per la quale la primordiale sapienza è comunicata, attraverso le ere, a coloro che hanno la capacità di riceverla. (..) Tuttavia può avvenire che in seguito ad una certa degenerescenza che rende possibile l’allontanamento dalle origini, e che può spingersi fino ad un punto tale per cui un’organizzazione giunge ad avere soltanto degli iniziati ‘virtuali’, continuando essi tuttavia a trasmettere, anche senza rendersene più conto, l’influenza spirituale di cui l’organizzazione è depositaria”.
Altri scrittori attribuiscono agli Zingari un’origine ancora più misteriosa, assimilata al ruolo rituale della caverna, attestato fin dalla preistoria della Matrix - Mundi, la grande dea che un tempo presiedeva alla sacralità della terra, da cui si fa derivare l’idea d’una loro possibile provenienza sotterranea. La discesa nei meandri della Grande Madre diventa allora il contatto con un sapere superiore che purifica e migliora e che, peraltro, riguarda aspetti non solo fisici e concreti ma, anche metafisici e sacri. L’archetipo della caverna rende visibile ai nostri occhi l’immagine stereotipa dei primordi ed apre ad aspetti della vita umana altrimenti inaccessibili e certamente più letterari che reali, ai quali va tuttavia fatto riferimento.
Alla caverna va altresì rapportato il ‘dominio del fuoco’, i cui culti in relazione con la terra, testimoniano tutti un’origine divina e insieme demoniaca. Una doppia valenza che rispondeva un tempo ad alcune credenze mitologiche radicate nel pensiero umano per cui il fuoco era magicamente originato dall’organo genitale della Grande Madre, seppure qui non si tratti di una anteriorità cronologica storica ma, ancora una volta, di una anteriorità ideale, implicita in ogni variante dello stesso tema mitico centrale. Come appunto rilevato da C. G. Jung (10), il quale, afferma che:” A fondamento dell’essere, è la brama di procreare che trae origine dal fuoco. Il fuoco è in rapporto col sangue, formato caldo e rossiccio come il fuoco. (..) Il sangue si trasforma in seme nell’uomo e in latte nella donna.”
Nella concezione arcaica il fuoco era la manifestazione di una forza magico - religiosa primaria che rispondeva a una sensazione di potenza e di energia, espressione di leggerezza, di movimento, di grazia e gaiezza. Ma anche rappresentazione simbolica della vitalità interiore, della felicità e, per contrasto della paura, dell’impotenza e delle tendenze distruttive insite nell’uomo, capace di modificare la natura delle cose. Come pure della capacità di mutare, a seguito dell’avvento della metallurgia, il ‘tempo geologico’ in ‘tempo vitale’, che è alla base della sapienza esoterica. È nota, infatti, nelle più antiche tradizioni la presenza di un ‘fabbro divino’ che forgiava le armi degli déi e degli eroi.
Theodor Gaster (11) nota tra l’altro come questo ‘dio fabbro’ tenesse rapporti con la musica e con il canto. La solidarietà tra il mestiere del fabbro e l’azione di ‘cantare’ è nota presso i turchi-tartari e i mongoli, fra i quali i fabbri erano associati agli eroi, ai cantori e ai musicisti in genere. Si è dunque certi che un intimo legame tra l’arte del fabbro, le scienze occulte e l’arte del canto, così come della danza e della poesia, sia esistito fin dalla più remota antichità. Inoltre, va considerato, che le diverse tecniche, pur solidali fra loro, siano state trasmesse in una atmosfera pregna di sacralità e di mistero.
La presenza di tracce di una ‘mitologia del fuoco’ è qui più che mai evidente. Non ci resta che cercare, seppure a livelli culturali differenti, quelli che sono gli elementi dell’avvenuta aggregazione d’una convivenza protrattasi per millenni, e ha permesso agli Zingari di rapportarsi con questo elemento ed assumerne i connotati più manifesti. Il dominio del fuoco permise alle culture arcaiche di elaborare una sintesi dei culti preesistenti e dare origine al successivo culto dei ‘signori del fuoco’, identificati negli sciamani e negli alchimisti, così come nei vasai, nei maghi e nei fabbri, tutti detentori di una comune esperienza magico-religiosa data dal rapporto diretto con l’elemento, il fuoco, che consideravano vivo e sacro, al punto da assorbire per intera la loro ‘immagine’, con l’irradiare nelle loro azioni un’aura di magia occulta. E ciò, in ragione della peculiarità del fuoco di ‘trasformazione’, di ‘perfezionamento’ e, non in ultimo, di ‘trasmutazione’, sia che si trattasse di argilla, erba medicinale, d’acqua o metallo.
Le arti legate all’uso e al dominio del fuoco finirono così per essere considerate di natura sovrumana, divina o demoniaca a seconda dei casi e delle mitologie ad esse riferite, sia nei ‘riti apotropaici’, sia nei più antichi ‘misteri’ cultuali. Onde per cui, il fonditore di metalli, il forgiatore, il fabbro, legati com’erano all’uso ‘rituale’ della forgia, influenzarono fortemente la simbologia e gli usi rituali delle primitive collettività arcaiche, i cui ‘segreti’ erano trasmessi attraverso veri e propri ‘riti iniziatici’ propedeutici ai singoli mestieri. Interessante per la nostra conoscenza è il vocabolo sumerico che designava il ferro “an-bar”, costituito dai segni pittografici ‘cielo’ e ‘fuoco’, ritenuto il più antico in assoluto e riferito al metallo meteoritico, chiamato appunto ‘metallo celeste’.
Alcune leggende attribuiscono agli Zingari discendenze spesso imperscrutabili le cui tracce si perdono nella notte dei tempi. Considerati dapprima figli di antiche deità del mondo sotterraneo ed essi stessi demoni degli oscuri inferi, furono anche detti discendenti dalla stirpe maledetta di Cam e, per questo condannati all’eterno vagare, da cui deriva il loro riconoscimento fisico con il male e tutto ciò concerne la sfera dell’occulto. La loro successiva attestazione al mestiere della forgia, non fece che ampliare l’alone di mistero che li circonda, aggiungendo alle loro oscure origini quella ‘demoniaca’ del ferro.
Un’altra ipotesi ‘mitologica’ li vuole discendenti dagli Asùr, dal sanscrito ‘Asura’, una genìa di fabbri conosciuti attraverso miti elaborati da tribù aborigene dell’India centrale, probabilmente ‘munda’ o ‘dravidiche’, conosciuti come ‘spiriti delle tenebre’ e assimilati alla disarmonia che regna nel mondo. Ritenuti, anche, i primi sulla terra dediti alla fusione del ferro e dei metalli in genere; da cui la loro fama di ‘signori del fuoco’, demiurghi e abili forgiatori, “dotati di forze al tempo stesso sacre e demoniache”. E, per la stessa ragione, tenuti in disparte e perfino disprezzati.
La mitologia articolata intorno al ferro ha permesso a Mircea Eliade (12) di approfondire le ragioni e le conseguenze dell’uso della metallurgia primitiva: “...dovute – egli scrive – alla scarsa reperibilità dell’elemento meteorico e tellurico. (..) Fatto questo, che ebbe conseguenze importanti sul piano religioso in tutto il mondo antico. (..) Si ha soprattutto la sensazione di interferire in un ordine naturale retto da una legge superiore, di intervenire in un processo segreto e sacro. Si sente confusamente che si tratta di un mistero che coinvolge l’esistenza umana, perché l’uomo è stato effettivamente segnato dalla scoperta dei metalli, ha quasi cambiato il suo modo di essere, lasciandosi coinvolgere nelle attività minerarie e metallurgiche. (..) Il carattere ambivalente del fabbro e i rapporti esistenti tra la magia, in rappresentanza del dominio del fuoco, e quelli con le società segrete, nel procedimento di sostituirsi all’opera della natura” – hanno dato luogo a una mitologia del sotterraneo di difficile penetrazione etnologica.
È fatto ormai accertato che le sostanze minerarie partecipassero della sacralità della forgia, al cui rito i ‘metallurghi’ si avvicinavano praticando atti cultuali, allo scopo di raggiungere la ‘purezza’ corporea che perseguivano con la meditazione, il digiuno e la preghiera. Si ha testimonianza che la forgia fosse venerata quale luogo di culto. Lì dove non esisteva un edificio apposito per le preghiere e le assemblee cultuali, ci si riuniva presso la forgia. Gli stessi utensili del fabbro partecipavano in egual misura della sua stessa sacralità. Il fuoco, il mantice, l’incudine e il martello si rivelarono ben presto esseri animati e meravigliosi, attraverso i quali il fabbro imitava il gesto esemplare della creazione divina, la forza scatenante del dio detentore del ‘fuoco sacro’, e per questo paragonato alla folgore.
La liturgia della fucina, lo splendore della fiamma, lo sforzo smisurato del fabbro battitore, il corpo sudato che brilla nella penombra rossiccia, il vapore emanato dal ferro arroventato a contatto con l’acqua, erano insieme elementi di una scenografia dell’infernale che non aveva eguali e che trovava il suo imprescindibile riscontro con i timori e le paure legate all’inconscio collettivo. Notizie in tal senso sono rapportate all’antico Egitto da Boris De Rakelwiz (13), in cui la metallurgia veniva associata agli déi rappresentativi del male: “Ptah – colui che da la forma – era il dio forgiatore abitante in una caverna di fuoco che contiene le ombre, khaìbit. Il ferro in particolare, era identificato con le ossa di Seth, il tenebroso dio assassino di suo fratello Osiris. Ragione per cui il Egitto il suo utilizzo fu limitato e relegato allo strato più marginale degli artigiani o, forse, ad una casta occulta detentrice di numerosi segreti.”
Quasi ovunque nel mondo antico, il fabbro, vuoi per il carattere sacro della sua attività, vuoi per le mitologie che ne fanno riferimento, occupava un ruolo ‘a se stante’ dal resto della collettività che pure era custode della sua tradizione che lo relegava a una ‘casta’ detta degli ‘intoccabili’ che avevano fama di potenti maghi e considerati con grande rispetto e timore. Tuttavia il ricordo mitologico di questa esperienza demiurgica sembra non avere lasciato traccia nelle discendenze genealogiche degli Zingari. In alcune collettività del Vicino oriente e dell’Europa orientale, venivano attribuite alla casta dei fabbri discendenze regali e aristocratiche.
È il caso specifico dei Somali, presso i quali i fabbri ‘tournal’ costituiscono ancora oggi una casta a sé stante. Altro esempio fa riferimento ai Tchinghianés turchi, chiamati anche Farawni o Gylidi, fra i quali è in uso il vocabolo ‘dakhan’, cioè fabbro, oltre ad ‘eroe’ e ‘cavaliere franco’, equivalente a ‘uomo libero’, l’esatta denominazione degli Zingari. Alla figura dell’eroe va inoltre accostato l’aggettivo ‘guerriero’, così come è usato nell’accezione dei Bogos chiamati anche Bileni, un’esigua popolazione dell’Eritrea, fra i quali si tramanda ‘ab-antiquo’ la leggenda di guerrieri Rom “che scagliavano le lance contro il cielo”, dei quali esistono tombe di pietra custodite da genti infernali.
Le leggende e le credenze fin qui articolate intorno alla metallurgia ci danno la dimensione, univoca quanto arbitraria, di quello che può essere stato nel tempo l’operato dell’ ‘homo faber’ valutato però solo dal punto di vista di quei popoli che hanno prodotto e lasciato testimonianze della loro esistenza, in manufatti e agglomerati abitativi stabili o che, in qualche modo, hanno elaborato una microcoltura. Cosa che solitamente non è possibile stabilire per i popoli nomadi, ancor meno per gli Zingari, ai quali ogni attribuzione di ‘comunicazione’ storica o contingente; ciò per il fatto che la ‘cultura’ degli Zingari, all’apparenza, sembra non esistere, perché non presenta alcuna valenza di autenticità, per aver essi abbandonato da tempo l’uso di ‘creare’ e di ‘produrre’ richieste per la sua definizione. E che, altresì, permetterebbe ad essa di essere inclusa in una qualche categoria socialmente riconosciuta. Tantomeno è stata presa in considerazione la possibilità di un legame ‘intimistico’ con i ‘signori del fuoco’ per cui gli Zingari, indiscussi artefici e trasmettitori della pratica millenaria della forgia, vengono appellati.
Scrivono B. e F. R. Allchin (14) dell’Università di Cambridge, che: “La lavorazione del ferro nell’Asia meridionale sia originaria dell’Occidente. Le ricerche eseguite hanno permesso di stabilire che tale importante avvenimento si verificò verso l’anno 100 a.C. nelle aree più settentrionali dell’India e che, in seguito, l’uso del ferro si estese rapidamente verso sud e verso est. Nelle aree meridionali il diffondersi della lavorazione del ferro è collegato ai movimenti di una popolazione nomade, dispersa poi sul territorio e di cui sono note soprattutto le tombe, presenti in molte varietà, sia nel profondo sud sia in zone settentrionali come potrebbe essere Nagpur, e che presentano molte caratteristiche comuni. Quasi tutte sono costituite da pietre disposte in circolo, tutte hanno una camera sepolcrale in pietra e vengono definite ‘megalitiche’. All’interno vengono rinvenuti frequentemente oggetti di ferro, insieme a stoviglie di terracotta rossa e nera. Leghe di rame, di bronzo e di rame arsenicato erano un tempo usate comunemente al pari della pietra, per fabbricare armi e attrezzi, mentre il piombo, l’argento e l’oro venivano utilizzati soltanto per oggetti di culto o per abbigliarsi.”
Testimonianze di vasti commerci interni di oggetti artigianali inerenti a traffici d’importazione di materie prime dalle regioni confinanti con l’India e con la Mesopotamia. Non è chiaro quali merci venissero importate in India, mentre manufatti della civiltà dell’Indo, in special modo guarnizioni per collane e intarsi, sono stati trovati nelle zone archeologiche riferite a Babilonia e ai regni fioriti più o meno nello stesso periodo preistorico. Tutto ciò accadeva nei primi secoli del primo millennio a. C., alla fine del quale, anche per queste zone, iniziava l’era storica propriamente detta, nella quale si registrano le prime grandi migrazioni di popoli. Resta comunque un mistero quale rapporto i commerci dei metalli e dei manufatti abbiano con le grandi migrazioni e la brusca fine delle prime civiltà dell’Indo, di cui pure restano testimonianze certe in grandi aree archeologiche e centri urbani a Mohenjo Daro, Harappa e Kalibangan.
Nel campo specifico della metallurgia, le ultime scoperte, tendono a mettere in relazione il suo avvento con la cultura della Cina meridionale dell’epoca Chou medio-tarda, tra l’ VIII e il IV secolo a.C. ma che questa sarebbe di origine danubiana, giunta qui negli stessi secoli attraverso il Caucaso. Per quanto, questa ipotesi non sia del tutto da scartare, al momento non si ha conoscenza di una particolare attività metallurgica attribuibile agli Zingari in Cina. Considerato quanto appreso fin qui, va detto che la cultura di questi popoli oppone all’esistenza ‘demoniaca’ del fuoco l’elemento catalizzatore dell’universo, il ‘fuoco divino’ di celestiale memoria; allo scopo di dare una fisionomia ‘mitica’ pienamente riconoscibile, speculare tra il bene e il male, riconosciuto nel simbolo rappresentato dallo Jing e Jiang. Un’ambivalenza positiva/negativa che, pur essendo nell’ordine delle cose, non è riconducibile alla credenza negli Zingari del ‘fatto catartico’, in quanto da sempre conosciuti come ‘artefici del male’, e ‘figli del diavolo’, per quanto ciò possa sembrare aberrante.
Scrive Augusto Romano (15): “La nostra condizione attuale non ci permette di comprendere quella ‘lingua antichissima’ (riferita ai simboli e alla musica) risuonante nella nostra memoria immaginativa che ci conduce nel regno della Grande Madre (..) là dove non sono ammesse differenze e opposizioni. (Tuttavia) È lì che si celebra l’armoniosità totale e unitaria della voce (il richiamo) dell’origine, naturale, materna, flusso corporeo che si fa tempo del canto modulato sul respiro” – prima ancora che si corrompa nella storia. È manifestamente in questa visione che pure affonda le sue radici la teoria psicoanalitica di Giovanni Di Stefano (16) improntata sulla assimilazione della musica a esperienze fusionali primitive miranti alla spiritualizzazione interiore: “La lingua superiore degli spiriti, che addita una realtà trascendente da cui lo spirito soffia vivificando e ispirando”.
Lo ‘spirito della musica’, suggerisce C. G. Jung (17), come il mercurio alchemico, presenta il suo lato oscuro e sotterraneo associato al male e al potere, che va oltre i limiti di pura armonia. Usata come strumento illusorio di onnipotenza, essa raggiunge esiti distruttivi che rientrano nella tentazione demoniaca che, andando oltre l’umano, si identifica con lo ‘spirito creatore’. Davvero numerosi sono i riferimenti musicali inerenti al fuoco ed alla forgia rintracciabili nelle culture nomadi e stanziali fra i quali cercare una connotazione di origine zingara.
La solidarietà tra il mestiere di fabbro e il canto si riscontra chiaramente nel vocabolo semitico, dall’arabo ‘q-y-n’ che significa ‘forgiare’ ed anche ‘essere fabbro’, apparentata a diversi termini in ebraico, siriaco ed etiope che designano l’azione di ‘cantare’ o ‘intonare’ un lamento funebre. In sanscrito troviamo la parola ‘taks’, significante ‘fabbricare’, utilizzata per esprimere la composizione dei canti che formano il Rig-Veda. Nei testi ugaritici, infatti, i cantori sono chiamati ‘kòtaràt’ per la loro capacità di comporre incantesimi e canti. Quel ‘cantare’ che per gli Zingari rappresenta il supremo linguaggio, la ‘voce mitica’ che parla agli iniziati e ad essi soltanto.
Altra fonte d’interesse è l’uso di alcuni strumenti musicali che rientrano in questa ricerca per la loro connessione con la forgia e il modo virtuosistico in cui sono suonati, e nei quali si riversa tutta l’essenza dell’ ‘estro zingaro’. Di precipua attinenza con il fuoco sono anche le danze che gli Zingari hanno adottato sulla base di altre più antiche, legate a questo o a quel popolo con il quale sono venuti a contatto e, verosimilmente, ‘reinventate’ dal loro impeto espressivo, straordinariamente vivace, nel ricordo di terre appena conosciute e già lontane. Entrando nella speculazione filosofico - letteraria, un’altra pista suggestiva è fornita da un’antica leggenda zingara che recita: “Quando non v’erano uomini nel mondo, il Cielo e la Terra formavano una coppia felice e in armonia” (18), nella quale intravediamo un certo rimpianto per una qualche ‘terra perduta’ ma mai dimenticata, che va collocata in un punto vago dell’India immensa.
Una Terra dei ricordi lontani cui gli Zingari spesso fanno riferimento nei loro canti intrisi di nostalgia, e nei lamenti funebri, sorta di canzoni-nenie riferite, inoltre, a una qualche ‘morte iniziatica’ o a delle ‘tenebre mistiche’, conseguenti all’improvviso impoverimento delle condizioni generali di vita, un tempo privilegiate dall’appartenenza a una possibile ‘casta’ non meglio identificata, e la successiva schiavitù di massa che li ha costretti alla fuga e, conseguentemente nella condizione di nomadismo. L’impossibilità di collocare geograficamente questa ‘terra perduta’ credibilmente successiva a un’oscura circostanza ‘apocalittica’, che ne avrebbe determinato la ‘scomparsa’, tale da far dire agli Zingari che “non esiste più”, ha fatto supporre alcuni studiosi ad una loro probabile provenienza da Atlantide, la terra sommersa di platonica memoria, alla quale alcuni gruppi nomadi fuoriusciti che non avrebbero potuto più farvi ritorno dopo la sua catastrofica scomparsa.
Un’ipotesi che spiegherebbe la somiglianza di culture e vestigia presenti sui due versanti opposti dell’Oceano Atlantico e che, per certi aspetti, comproverebbe l’idea ipotizzata, di un possibile collegamento fra le terre sommerse e l’esistenza effettiva di Atlantide. G. Predari (19) aggiunge un’ipotesi alquanto stravagante e immaginaria datata 1841: “A nostro avviso noi ci perderemmo fra le tenebre che involgono tuttavia la storia dei popoli che abitarono Atlantide, della cui esistenza oggidì, non pure la storia, ma la fisica e la genealogia, hanno stabilita l’incontrovertibile certezza. Niente di più facile che in quel tremendo cataclisma che inabissò in mare quell’immensa regione, alcuni di quei popoli si rifugiassero sul propinquo continente africano; stanziatisi in Egitto ne assumessero quella parte di abitudini e di doti morali, comuni agli antichi Egizi come agli Zingari; penetrata l’Asia, si spargessero per quelle regioni e porzioni di essi si portassero alle parti prime dell’India, mentre altri si dirigessero verso l’Asia più limitrofa all’Europa, nella Tracia e nel Ponto, ove li trovò popoli nomadi e già antichi lo stesso Erodoto nei Sinti.”
Per quanto suggestiva questa ipotesi offre all’antropologo e all’etnologo di porsi alcune domande che destano inquietudine su una possibile origine antidiluviana di questo popolo nomade che, ai nostri occhi, resta comunque uno degli ultimi rappresentanti del più primitivo stadio umano prima della sua sedenterizzazione: “Credo non esista problema istorico – scrive ancora Colocci – che abbia più occupato le menti degli eruditi di quel che non abbia fatto la questione che riflette l’origine degli Zingari.” Tuttavia il mito di Atlantide quale terra d’origine degli Zingari è forse quello che più ha entusiasmato le menti e in definitiva quello che ha resistito nel tempo.
Nel Popol Vuh (20) , l’antico manoscritto guatemalteco definito “la grande miniera di leggende e mitologie Maya”, si parla di “una terra a est delle sponde del mare”, una localizzazione che corrisponde perfettamente alle nostre conoscenze sulla posizione di Atlantide, da cui “i padri del nostro popolo erano giunti”, e che sopportarono “una grande catastrofe” in seguito alla quale, la terra situata a est scomparve. Ed ancora: “Sopravvenne una grande inondazione (..) e gli uomini, in preda alla disperazione e alla follia, corsero di qua e di là. Fuori di sé dal terrore (..) tentarono di entrare in grotte e caverne e vi furono immediatamente chiusi dentro. Quando sulla Terra scesero le tenebre...”.
Se si tiene in conto ch tutti i miti riferiti ad Atlantide e le leggende Indu di Meru furono tramandate da più antiche civiltà veramente esistite e misteriosamente scomparse, viene da chiedersi per quale motivo non è stato trovato alcun reperto o quasi ad esse riferibile. Un’interessante postilla riferita all’argomentazione atlantidea, è qui proposta da Lewis Spence (21): “Engel e il Conte de Corli sostenevano dottamente che i confini di Atlantide raggiungevano Europa e Africa da una parte e America dall’altra. Secondo questi studiosi, gli uomini erano passati dal Vecchio al Nuovo Mondo attraverso un istmo atlantideo, l’inabissamento del quale aveva troncato gli antichi collegamenti fra i due continenti.”
Una congettura alquanto azzardata e comunque piena di fascino sull’utilizzo delle energie positive del pianeta è esposta da James Redfield (22), il quale scrive: “Quando una società progredisce fino a saper creare mentalmente i beni materiali, se succede qualcosa e un’ondata di negatività fa abbassare il livello di energia, ogni cosa si limita a scomparire.” Ciò che in ultima analisi avalla le ipotesi della possibilità di un popolo superiore al nostro, ‘scomparso’, per così dire, dallo stato ‘materiale’ dopo aver raggiunto lo stadio ‘aureo’ della luce. Nel caso di Atlantide tuttavia i fatti devono essere andati diversamente. È opinione confermata che la deriva dei continenti e dei ghiacciai seppellì la maggior parte delle terre sommerse e i sopravvissuti all’avvenuto sconvolgimento geologico, se mai ve ne furono, riuscirono a prendere terra un po’ ovunque e non restò loro che insinuarsi nelle altre terre rimaste e di vivere nei luoghi abitati insieme ad altri popoli. Da cui, la probabile ‘dimenticanza’ nella memoria di certi popoli – il fatto non è prerogativa dei soli zingari – del luogo originario di provenienza.
Scrive in proposito Mircea Eliade (23): “...accade che questa e quella tradizione non abbia avuto mai coscienza dell’insieme mitico dal quale deriva (la sua conoscenza), tanto più che le ideologie circolano e sono veicolate dalla storia, e quasi sempre un popolo riceve o conserva solo frammenti di essa. (..) Ora tra queste non esiste, talvolta, alcuna contiguità storica, e ciò rende ancora più difficile il lavoro d’interpretazione.” Vale a dire che, quando si verifica un distacco totale dalla storia e dalla tradizione, a distanza di tempo viene a mancare quella “memoria collettiva” capace di avvalorare le ragioni precipue dell’esistenza di gruppo. Ragioni che, sulla base di quest’ultima ipotesi unicamente ‘letteraria’, hanno permesso di attribuire agli Zingari – da qualunque parte del mondo essi siano giunti ed a qualunque tribù facciano riferimento – lo status di “popolo senza memoria”.
Una diversa prospettiva è qui offerta da un’altra vicenda ripresa dalla tradizione orale e tuttavia puramente ‘letteraria’, piuttosto che ‘mitologica’, con la quale viene sancito un possibile ritorno dell’umanità alla barbarie pre-culturale, e che porta a una sorta di ‘consumazione finale del tempo’. Scrive Alfonso maria Di Nola (24): “L’apocalittica nell’attuale e corrente fruizione del termine, evoca subito una situazione esistenziale collettiva di fine o di prossimità alla fine. (..) Si costituisce in un meccanismo inquietante o gratificatorio delle crisi culturali, proprio perché relega ad una consumazione dell’essere l’angoscia dell’essere, prospetta lo sviluppo della storia verso una negatività totale e consumante, dalla quale può nascere il caos primigenio (ritorno alla natura) o può originarsi una rifondazione del tempo. (..) Gli aspetti essenziali di questo modulo possono essere individuati, al di fuori dell’area giudaico-cristiana, in tutte le costruzioni escatologiche, messianiche e profetiche presenti in altre religioni, dall’Iran all’India e alle culture senza scrittura.”
E ancora: “Avviene di fatto che il quadro apocalittico, attestato negli scritti o semplicemente presente come tendenza religiosa, si contrappone al quadro scritturale tradizionale e afferma un suo diritto esclusivo di recupero dei significati veri ed ultimi delle strutture religiose. (..) I momenti religiosi ‘apocalittici’ nella loro diretta corrispondenza con situazioni di conflitto e di crisi culturali, esprimono proposte finali che sono, nella loro sostanza, fughe dalla realtà attuale e dal mondo, o espedienti ideologici per sottrarsi al tempo presente, in una prospettiva di liberazione che è realizzata in un futuro escatologico o che cerca, in un passato astorico e mitico, il paradigma di una perfezione e di una felicità perdute e la causa dei mali presenti.”
Accanto a quella ora enunciata, faccio qui riferimento a un’altra teoria introduttiva al fattore dialettico, qui riferita da Augusto Romano (25): “Non è con gli strumenti della ragione che si può dare risposta alla contraddizione tra l’essere qui e il desiderio di un altrove che, incredibilmente, esiste nella propria illusorietà”, e che porta la discussione sul piano della psiche e, se vogliamo, della filosofia empirica, che sposta il discorso in un luogo non ben identificato nella mediazione del caos, delle emozioni e delle ipotesi che non finiremmo più di avallare, stupefacendo noi stessi per inventiva e suggestività.
Sono infine le parole di un Vangelo apocrifo (26), a permettere all’odierno fruitore, per così dire, un possibile riscatto dalla situazione, ‘deviante’ in cui fin qui si è spinta questa ricerca. È scritto che: “Davanti alla verità l’uomo non si trova come di fronte al mondo: vede il sole, pur non essendo il sole; vede il mare pur non essendo il mare; ma se tu hai visto qualcosa di quei luoghi, sei diventato quello che hai visto. Egli (Gesù) parlò del luogo da cui ciascuno è venuto e della regione nella quale ha ricevuto il suo essere essenziale. Il luogo al quale (per primo) rivolsero il pensiero, quel luogo è la loro radice.”
Il ‘passo’ di indubbia origine gnostica permette qui di rintracciare almeno un’altra ‘verità’ inoppugnabile pronunciata da Gesù il Vivente a Tomaso: “Siate transeunti” che pure sembra tenere presente il lungo estenuante peregrinare che il popolo degli Zingari si trova ad affrontare da tempo immemorabile. La frase va riferita alla condizione ‘solitaria’ del predicatore nel perseguimento della perfezione, la cui scelta di solitudine, consiste nella separazione dalla famiglia d’origine (dal proprio popolo pur predicando al popolo), soprattutto nella cancellazione di vincoli terreni. È detto: “poiché l’uomo appartiene originariamente al cielo”, che, se riferita agli Zingari, assume un risvolto illuminante, come se Gesù parlasse a un piccolo gruppo di “perfetti” che qui vengono chiamati “operai nei quali sono scintille divine cadute nella materia”.
Un ‘mito’ religioso, dunque, è alla base del riconoscimento etnico a cui addiviene lo storico desideroso di rintracciare le origini dei ‘figli del vento’, che possiamo definire catartico, inteso in senso di ‘transito’ purificatorio che condiziona la vita degli Zingari e che li trasporta alle origini del tempo e che, in termini sociologici, si traduce nell’attaccamento di un popolo alle proprie origini. Si può certamente attribuire a questo singolare gruppo umano quella sacralità primigenia a cui fa riferimento il testo evangelico, come alla genesi della nomadizzazione, ancora oggi celebrata da quegli Zingari che hanno abbandonato la vita migratoria per diventare sedentari. Se pure, va detto, sussiste la possibilità che un’inchiesta sul ‘mito zingaro delle origini’, potrebbe avvicinare di fatto gli Zingari anche ad altre realtà religiose.
Noi ci fermiamo qui, non serve indagare oltre, avremo modo di percorrere altre strade, altri itinerari di questa storia infinita che attraversa i millenni. Accendiamo quindi il nostro fuoco in questo ipotetico accampamento e godiamoci la notte stellata. C’è nell’aria il profumo della buona stagione, apprestiamoci dunque a celebrare il nostro rito propiziatorio. Come scrive Françoise Cozannet (27): “La cerimonia ha luogo in primavera, nel momento in cui la natura riunisce di nuovo nel suo seno la morte dell’inverno e la rinascita alla vita. Gli Zingari ammassano allora su loro poveri carri tutto ciò che possiedono e se ne vanno da una estremità della città dove dimorano, per ritornarvi dall’estremità opposta, compiendo una specie di cerchio il cui inizio si chiude su di sé, riattualizzando per se stessi il vecchio mito umano dell’eterno ritorno alle origini.”
“Ci basta avere per tutto il cielo / un fuoco per scaldarci /
e le nostre canzoni quando siamo tristi”. (Spatzo)
Ai primordi della civiltà.
Alcuni popoli a livello culturale impropriamente definito ‘primitivo’ oggi in via di estinzione, dolcemente assorbiti o brutalmente ‘sterminati’, continuano a subire la contraddizione di almeno due vettori evolutivi: la frantumazione etnica o l’omologazione all’interno di un più ampio e comunque inadatto ‘villaggio globale’. Tra questi, gli Zingari, da sempre rappresentano un rompicapo per quanti: antropologi, etnologi, sociologi, che li vorrebbero inglobati all’interno di un predeterminato ‘confine culturale’, al fine di demarcare precise barriere territoriali in termini di lingua e di estrazione che essi stessi pongono come limite invalicabile, oltre e sotto il quale qualunque popolo ‘etnico’ non è riconosciuto come tale.
La moderna antropologia applicata, pur avendo permesso il raggruppamento su vasta scala delle componenti sociali che definiscono l’appartenenza culturale a questo o quel gruppo socio-biologico, ha dato tuttavia una risposta sconcertante al problema della pari - dignità etnica di alcuni popoli. Tra questi, gli Zingari esulano dal far parte di alcuna categoria riconosciuta, rientrando con ciò, nel ‘concetto di etnocentrismo’, per effetto del quale sono considerati al di fuori della vera umanità. Questo benché siano stati evidenziati dati significativi della loro esistenza, relativi al loro essere nomadi, alla fluidità degli spostamenti di gruppo e all’attività di penetrazione nelle culture diverse dalla loro.
Non in ultimo – dato questo molto rilevante nell’ideologia socio-politica del nomadismo – il loro essere sparsi su gran parte della faccia della terra, pur avendo conservata una loro ‘identità socioculturale’ riscontrabile negli usi e nei costumi che gli sono propri. Ciò, malgrado la sostanziale difficoltà di comunicazione relativa alla mobilità fra i vari gruppi, talvolta formati da una sola famiglia, offra – a mio parere – un quadro non trascurabile della loro origine etnica, sulla base della quale si dovrebbe riesaminare il problema del riconoscimento della loro ‘esistenza’ e restituirli alla dignità umana all’interno delle minoranze etniche e della storia.
Siamo qui di fronte a uno dei rari casi di ‘non classificazione’ che pone un popolo, nello specifico gli Zingari, oltre il ‘relitto umano’, cui non è riconosciuta alcuna forma di cultura, malgrado essi , pur essendo parcellizzati in gruppi diversi tra loro, facciano uso di un identico idioma di base, comune ai ‘romani’, (popoli di etnia Rom), il quale, pur spezzettato in numerosi dialetti, si presenta come un insieme di lemmi consimili basati sulla trasmissione orale, piuttosto che tramite la scrittura o altri mezzi d’attestazione non verbali. Un controsenso in termini se, da una parte, A. L. Kroeber (1) afferma che: “L’uomo è parte dell’evoluzione di ambiente, società e cultura, e che tutti questi elementi retroagiscono sulla persona fisica istante per istante”. E da un’altra, Bruno Netll (2) che: “Va sempre tenuto presente che si possono definire gli individui senza separarli grossolanamente dal proprio flusso genico, mettendoli in rapporto con antenati e discendenti – e che – si possono definire altresì concetti quelli derivanti dal formarsi in clan, per lignaggio, per etnia o tribù, o in seno alla propria popolazione di appartenenza, al fine di fornire essi stessi un modello di comportamento umano di tipo dinamico, che va visto in divenire.”
Va qui detto che in alcune aree specifiche in cui i gruppi Zingari sono vissuti più a lungo in condizioni precarie e talvolta separati da confini culturali estremi, si è verificata un’eccezionale parcellizzazione delle tribù e un fortissimo isolamento genico e linguistico, con conseguente allontanamento dal modello originale. Per contro, in altre, pur non essendosi verificata alcuna commistione da parte di nuclei Zingari con le popolazioni autoctone con le quali sono venuti in contatto, essi hanno mantenuto legami comunitari e, in alcuni casi, hanno dato forma a veri e propri nuclei compatti ed eterogenei.
Tutto questo, a conferma di quanto ancora sostenuto da Bronislav Geremek (3): “...che se all’interno di una popolazione si verifica una qualche separazione per un tempo sufficientemente lungo, si ha un processo di differenziazione analogo alla lingua e agli usi, per cui si è tagliati fuori dal processo di inculturazione. Ciò che in effetti non è accaduto alla lingua zingara, che si presenta invece come una commistione di più elementi alla base di molte forme di acculturazione. (..) L’approccio al problema della collocazione degli Zingari nella società odierna, pone lo storico di fronte all’immenso materiale documentario di una disciplina di studio autonoma: la ‘zingarologia’, i cui primi documenti si possono rinvenire nella letteratura del XVI sec. con i lavori di Grellman, ma che solo da poco ha cominciato a conquistarsi una sua autonomia.”
A questo proposito egli aggiunge: “Il carattere di questo tipo di letteratura poneva in essere gli interessi etnografici e linguistici. La problematica storica occupava in essa un posto notevole, per lo più sulla base della descrizione di fatti e aneddoti. Negli ultimi anni si può riscontrare un progresso considerevole sia nell’ampliamento degli orizzonti di ricerca della ‘zingarologia’ grazie alla penetrazione dei metodi messi in atto dalle scienze sociali, soprattutto l’antropologia e la sociologia; sia nelle prove sintetiche di esposizione storica.
Egli per di più aggiunge che: “La sfera di informazioni storiche fino al XIX sec. è comunque ridotta e le notizie provengono inoltre da osservatori esterni. A complicare ulteriormente la questione interviene l’ambivalenza dello status etnico degli Zingari, che uniscono (a loro favore) un sentimento di identità di gruppo e il tradizionalismo a un grande spirito di adattamento all’ambiente circostante. Per questo, proprio negli studi contemporanei, non c’è unanimità circa la definizione stessa di appartenenza degli Zingari, che ha creato molti problemi anche nelle decisioni in materia legislativa”.
In campo scientifico la ‘linguistica’, più d’ogni altra, ha consentito di esaminare le fasi del processo di formazione del linguaggio verbale, fondamentale nella trasmissione d’una cultura specificamente orale che accomuna tutti gli Zingari e che, verosimilmente, lo hanno tramandato da una generazione all’altra e da un gruppo all’altro sebbene le distanze che spesso intercorrono nella ‘comunicazione’ attiva fra loro, comprensibile della cultura che l’ha generata e del corrispettivo ambiente in cui questa si è formata. Ma di quale ‘ambiente’ si tratta se, come è noto gli Zingari per loro scelta, sono e rimangono nomadi da generazioni?
Se vogliamo considerare ‘ambiente’ l’insieme dei territori in cui essi si trovano a ‘vivere’ possiamo affermare quanto segue: che ogni ‘tribù’, ogni ‘cultura’, per quanto primitiva possa essere, ha dignità sufficiente per essere rappresentata, ivi compresa quella zingara. Non a caso l’UNESCO (4), per voce dei suoi parlamentari si è espressa in tal senso: “Non si può stabilire alcuna gerarchia fra culture maggioritarie e culture minoritarie, perché anche quella in apparenza più umile, la meno conosciuta, può essere portatrice di verità a tutte le altre.”
Ma non solo la linguistica, anche l’etnologia e la musicologia ad essa applicata, nonché la medicina popolare e la scienza alimentare possono dirci oggi qualcosa in proposito. Come, ad esempio, la realizzazione delle ‘mappe geniche’ realizzate da L. Sforza-Cavalli (5) e del suo prestigioso team, che ha messo recentemente in evidenza la possibilità di sovrapporre agli alberi genealogici delle popolazioni umane le lingue da esse parlate: “Le mappe dei geni della Terra rivelano realtà stupefacenti che da un solo idioma parlato circa centomila anni fa, derivano tutte le famiglie linguistiche, cioè le migliaia di lingue parlate attualmente”, a cui si va ad aggiungere la storia delle rispettive lingue, a dar forma ad “una sorta di spina dorsale degli studi sulle origini.”
Ciò che avvalora quanto ipotizzato a suo tempo da Charles Darwin (6) il quale, anticipando di molto i tempi, aveva altresì immaginato quanto segue: “Se possedessimo un perfetto pedigree dell’umanità, una sistemazione genealogica delle razze umane fornirebbe la miglior classificazione delle diverse lingue oggi parlate nel mondo; e se venissero incluse tutte le lingue estinte, e tutti i dialetti intermedi, allora una tale sistemazione sarebbe l’unica possibile.”
Il procedimento più idoneo per ricondurre tutti i gruppi zingari a un indirizzo comune, pur tenendo conto delle diversità e delle accezioni, rimane dunque quello del riconoscimento del ‘romanì’ o ‘romanés’, la lingua parlata dagli Zingari, come fenomeno culturale ‘diverso’ all’interno di una più ampia cultura autoctona. La letteratura concernente mostra elementi di giudizio per lo più suggeriti dall’emotività o dettati dall’entusiasmo dei ricercatori, solo raramente compatibili con la realtà multiculturale degli Zingari. D’altra parte, l’enorme capacità di adattamento degli Zingari alle diverse culture ha prodotto una tale diversità di soggetti linguistici che qualsiasi generalizzazione risulterebbe arbitraria, per cui si è portati a pensare all’esistenza di un qualche linguaggio segreto.
R. J. Forbes (7) cita numerosi esempi di un ‘linguaggio segreto’ utilizzato in Mesopotamia, comune agli sciamani delle società arcaiche e ai mistici delle religioni storiche, che: “...è contemporaneamente l’espressione di esperienze altrimenti non trasmissibili attraverso il linguaggio quotidiano e comunicazione criptica del senso riposto dei simboli”. Sebbene non riferita alla cultura zingara in particolare, l’esistenza di un ‘linguaggio segreto’ assume valore e significato in una cultura che non fa uso della scrittura, che si serve di forme verbali e le utilizza in senso ‘astratto’, non considerandole di per sé entità isolabili dal contesto simbolico in cui è immersa.
L’africanista Amadu-Hampate Ba (8) ha rilevato che: “...l’uomo, in un primo stadio del processo simbolico, non creava simboli, ma si rapportava simbolicamente con l’ambiente circostante.” Questo ci permette di riconoscere alla cultura zingara la prerogativa di ‘cultura in movimento’, capace di prendere e lasciare ‘forme’ qui intese non solo come usanze e costumi non propri, ma anche come ideologie e concetti presi in ‘astratto’ e verosimilmente prestati da altre culture. Si deve ad alcuni insigni linguisti l’aver svelato il mistero della lingua zingara parlata da molti gruppi eterogenei, partendo dall’identificazione del nome Rom, accreditato al ceppo indoariano e strettamente connesso con alcune tribù ancora oggi presenti nel bacino dell’Indo - Gange e nella zona nord occidentale del Deccan; cosa che ha permesso di stabilire con certezza l’origine indiana degli Zingari, anche se sono ancora in molti a sostenere che vi siano delle affinità con gli idiomi della Persia e dell’Indostan.
L’apporto dato dalle componenti lessicali e sintattiche delle lingue parlate nei paesi da essi attraversati nel corso dei secoli ha in qualche modo accresciuto l’uso di parole e cadenze di altra provenienza all’interno del ‘romanì’, dando forma a un linguaggio, per così dire, ‘diversificato’ e, verosimilmente ‘segreto’. Tuttavia, la sua decifrazione ha reso doverosa la comparazione di numerose sotto-lingue e forme dialettali, presenti all’interno delle lingue indiane maggiormente diffuse, quali il ‘sanscrito’, il ‘pracrito’, il ‘maharate’, il ‘punjabi’ e l’‘hindi’, solo per citarne alcune, con il ‘romanì’ parlato oggigiorno da tutti i gruppi zingari. Comparazione che ha portato alla rilevazione di sostanziali somiglianze con alcuni dialetti parlati ancora oggi nel Punjab e nel Rajastan, derivati dall’antica “lingua perfetta”. O, come per il ‘sanscrito’, formatasi su varietà dialettali medio - indiane molto più antiche, di cui anche l’‘hindi’ probabilmente fa parte, e solo di recente assurte a “lingue di cultura e che oggi costituiscono la base originaria delle lingue indoeuropee.
Scrivono Friedrich Max Muller e Fracesco Botey (9) che: “L’origine di questa sorta di ‘madrelingua’, la cui genesi resta comunque avvolta nel mistero, lascia ancora da chiarire alcuni dubbi relativi al gruppo etnico, la casta o la classe sociale, fra le molte conosciute, cui sia possibile attestarne la nascita. Per dare una qualche risposta a queste non facili incognite, alcuni studiosi e ricercatori hanno avanzate le ipotesi più disparate, continuando così a fomentare credenze a dir poco fantasiose, sulla base delle grandi fasi migratorie del genere umano, succedutesi nell’India nord-occidentale verso la fine del primo millennio, e protrattesi in gran parte fino al XV sec. con la successiva espansione dell’Islam verso l’Occidente.
Si è quindi pensato a un possibile popolamento tardivo degli Zingari in quest’area, a causa delle difficoltà di accettazione del loro stile di vita e dell’incapacità di penetrazione della loro lingua, tali da far ipotizzare una loro possibile infiltrazione in Occidente avvenuta per gradi successivi e attraverso modelli diversificati che hanno reso problematico l’impatto linguistico sul territorio, in assenza di una vera e propria integrazione socio-culturale, del resto mai avvenuta. Ipotesi questa che ci permette però di riconoscere agli Zingari, seppure distinti per similitudini di comportamento, l’appartenenza a un unico “agglomerato umano” e a un unico “ambiente abitativo” in cui essi si sono riversati in massa, come ad esempio la vasta area formata dal bacino del Mediterraneo.
Non manca chi, come C. von Furer-Haimendorf (10) ritiene che: “...se la lingua è un importante mezzo di identificazione dei vari gruppi, l’equazione lingua = cultura è fin troppo semplicistica. Per gli Zingari l’unità linguistica non necessariamente sottintende l’unità culturale. Per quanto essi parlino la stessa lingua, alcuni gruppi hanno poco in comune (..) ed esistono anche differenze notevoli nei sistemi di parentela delle varie tribù.” Nulla di più vero se si vuole puntualizzare che gli Zingari, pur appartenendo a un’unica etnia, non rappresentano un popolo compatto e omogeneo. Ma per noi è ormai evidente che il significato dato alla vita sedentaria, è diverso da chi pratica il nomadismo, con tutto quello che ne deriva.
Possiamo quindi dire che conosciamo quali sono i contrasti che possono generare le differenze fra la tendenza alla sedentarizzazione di alcuni, contro la spiccata vocazione al nomadismo di altri. Tuttavia, nonostante la sua affermazione, lo studioso di antropologia asiatica dell’Università di Londra ha impugnato “scusanti etnologiche” che riscattano infine la sua personale presa di posizione, con l’apertura a soluzioni storico-sociologiche diverse: “...per cui i popoli nomadi possono anche essere identificati e riconosciuti con vari sistemi culturali”. Infatti, nel successivo libro, “I popoli del subcontinente indiano” (11), egli ci presenta un altro quadro storico, nel quale propone: “...il riconoscimento di tutti i gruppi etnici esistenti sul territorio”, affermandone i possibili ‘contrasti culturali’ e le stesse ‘differenze profonde’ che prima aveva contestato agli Zingari.
Scrivono ancora B. e F.R. Allchin (12) dell’Università di Cambridge: “Nell’India attuale, le differenze razziali colpiscono anche l’osservatore più disattento, e riflettono la natura composita di un popolo creatosi grazie all’apporto di ondate successive di invasori che penetrarono nel subcontinente sia da nord-ovest, sia da nord-est. (..) Sebbene siano avvenuti incroci fin dal secondo millennio a. C., quando le popolazioni arie di pelle chiara invasero l’India, dove trovarono genti indigene di pelle scura, in molte regioni continuarono a coesistere fianco a fianco tipi razziali ben distinti. Questa coesistenza durata secoli, e forse millenni, sta a indicare la difficoltà di ‘distinguere’ talvolta una comunità dall’altra”.
Ai due noti studiosi si deve inoltre la seguente affermazione che apre la porta dell’etnologia applicata allo studio delle origini dei popoli e che ci permette di affrontare il problema da una prospettiva decisamente più autonoma: “...più importante è stata la fondamentale propensione dell’ideologia indiana ad accettare la varietà delle forme culturali come naturale e immutabile, e perciò a non considerare desiderabile l’assimilazione a una sola linea culturale”.
Se dentro i confini del subcontinente indiano esiste una varietà incomparabile di gruppi etnici, di forme e di stili di vita diversi, ancor più numerose risultano essere le lingue distinte e senza alcun legame fra loro. Scrive ancora C. von Furer-Haimendorf (13): “Esistono almeno quattro famiglie linguistiche principali, ognuna delle quali è divisa a sua volta in numerose altre lingue reciprocamente incomprensibili, alcune delle quali parlate da poche centinaia di individui. I censimenti governativi parlano dell’esistenza di oltre quindicimila lingue. Molte delle quali sono soltanto dialetti tribali incomprensibili che non sono mai stati trasformati in una lingua scritta”.
È questo il caso del ‘romanì’ parlato dagli Zingari? Forse, secondo i risultati della linguistica esso presenta numerose somiglianze, più che con gli altri dialetti fra i molti registrati nel subcontinente indiano, con quelli più specifici facenti parte del gruppo delle lingue ‘muda’ di derivazione sanscrita, che molti studiosi considerano la più antica famiglia linguistica sopravvissuta e quindi ancora parlata dalle popolazioni che raggiunsero l’India dal nord-est, probabilmente parecchio tempo prima che gli Arii invadessero il paese dal nord-ovest. J. Alexander Vaillant (14), nel suo “Histoire vraie des vrais bohémiens”, comprende addirittura sotto l’appellativo di ‘Romi’ (Zingari), tutte quante le popolazioni ariane che si diffusero in Occidente durante i flussi migratori delle razze.
È opinione ormai accettata che l’India, in periodo preistorico anteriore ai testi rinvenuti nella forma arcaica nota come pre-vedica e risalente ad almeno tremila anni fa, si estendeva su un’aria più vasta dell’odierno Iran che comprendeva il Tibet, la Mongolia e le regioni tartare della Russia, fino all’Europa, un tempo tutti considerati sub-continenti indiani. La successiva migrazione in massa verso l’Occidente e la loro diffusione dell’Europa, portò rilevanti cambiamenti sul territorio e modificazioni alla lingua originaria, trasmessa oralmente, a sua volta inglobando apporti persiani, armeni, ebrei, greci e bizantini che, diedero inizio alla differenziazione dei dialetti parlati dai diversi gruppi e tribù zingare. Da cui, i cambiamenti anche fonetici della loro lingua, il ‘Romanì’, principalmente evidenziatisi attraverso i contatti con quella persiana e le regioni limitrofe del vicino Oriente.
Lo studioso di linguistica Françoise de Vaux de Foletier (15), mette in relazione i diversi idiomi usati per i loro nomi con le diverse realtà territoriali di provenienza: “Gli Zingari non fanno però uso del romanì se non quando s’incontrano tra gruppi affini. (..) La maggior parte di essi fanno uso di parole ‘prese in prestito’ dai popoli che li ospitano. In Spagna, ad esempio, hanno da tempo abbandonato il romanì più autentico in favore delle dominazioni costruite su assonanze linguistiche: Lom in Armenia, Dom in Persia, Dom o Dum in Siria, Manus in gran parte dell’Europa”.
Jeles Bloch (16) individua con il nome Dom, una tribù dell’India, o meglio: “...un agglomerato di tribù molto numerose e conosciute nell’antichità, i cui membri già nei testi sanscriti, vengono associati agli ‘intoccabili’ ma, che sono più conosciuti soprattutto come ‘harija’, appartenenti a una casta inferiore di fabbri”; e considerati tanto impuri che anche la semplice vista o il solo contatto con la loro ombra avrebbe insozzato qualsiasi persona di ceto superiore.
Non privo di interesse è inoltre constatare l’entità dei rapporti intercorsi tra i Dom fonditori, provenienti forse dal nord, precedenti agli Asùr, ed i riconosciuti maestri fabbri ferrai, ai quali – come abbiamo già avuto modo di constatare – erano assimilati agli Zingari. Scarsa è però la documentazione relativa al periodo che possiamo chiamare della ‘preistoria degli Zingari’, perché – come scrive ancora Jeles Bloch: “...gli antichi scrittori indiani si interessavano solo degli déi e dei re, e pochissimo di quei personaggi che erano chiamati gli Zott, gli Jat, i Luli, i Nuri o i Dom”; dei quali si conosce davvero pochissimo. Francesco Botey (17) in proposito, ritiene del tutto: “...inutile tentare di conoscere la storia del popolo zingaro nell’epoca anteriore a quella del loro esodo dall’India, ma si può dedurre che dal momento dell’invasione ariana avvenuta verso il 1500 a.C., la loro vita divenne seminomade”.
Scrive Françoise de Vaux de Foletier (18): “Alcuni nomi fanno allusioni ad un particolare fisico e soprattutto al colore della pelle dello zingaro, il quale usa per se stesso l’aggettivo ‘kalò’, cioè nero in questo senso. Non a caso gli Zingari sono soprannominati ‘negri’ in Bretagna e ‘karachi’, ovvero neri, in Persia. Analogamente i Tedeschi attribuiscono loro l’appellativo di ‘neri’; mentre gli Svedesi li definiscono Svart Tattaren, cioè ‘Tartari neri’, e i Finlandesi ‘Mustalainen’.. altre denominazioni loro attribuite alludono invece alla condizione di nomadi, come: Harami o Bokharani fra gli arabi e i Mori”.
Siamo però a conoscenza di altri gruppi, più o meno numerosi, presenti nella fascia occidentale dell’Asia, e dei loro nomi con i quali, essi stessi, si appellano: Hurbat, Duman, Nawar, Helebi, Bocha e decine di altri, propri di sottogruppi che pure si trovano a condividere la medesima minoranza etnica. Questi, sono presenti in piccoli gruppi in Uzbekistan e in Tagikistan, e prendono i nomi di Luli e Chugi, ma anche di Makrani, dall’area del Makran in Pakistan, più famosi per essere provetti giocolieri e addestratori di cavalli. Ivi compresi i Darzada, Nakib, Lori e Med, alcuni dei quali sono tradizionalmente Zingari ‘chiromanti’ e ‘cantastorie’ che maggiormente svolgono mansioni artigianali. Di un nutrito gruppo rintracciato in africa, si conosce invece il solo nome Gha’gar e che, straordinariamente, ricorda il Ghaggar del Punjab, un confluente del fiume Indo.
Altri gruppi formati da pochi elementi sono rintracciabili lungo la fascia mediterranea comprendente Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco, per lo più inseriti tra le fila delle genti berbere dell’Atlas. Modesto Lafuente (19), ad esempio, sostiene che: “Gli attuali Zingari, sono i discendenti dei semila Egiziani esiliati a Susa, in Mesopotamia, dal re persiano Cambise, affinché accompagnassero nella sua prigionia lo sconfitto faraone Psammetico III (XXVI dinastia). Dopo la morte di Cambise e la rivoluzione che ne seguì, i prigionieri sarebbero fuggiti in India, dove dimorarono per dodici secoli”.testimonianza questa che avvalora maggiormente l’epiteto ‘faraonico’ di Egiziani o Gizzi che spesso è attribuito agli Zingari.
Il noto egittologo Franco Cimmino (20)a sua volta conferma la presenza di tribù di Zingari nel delta del Nilo, spesso confusi con i popoli egittizzati sotto la XVIII e la XIX dinastia, che osservavvano uno stato di servaggiooo: “L’aver essi ricevuto un nome egiziano, rende oggi più difficile accertare la loro provenienza, tranne nei casi in cui sia indicato il nome originale. Nella mitologia egizia si narra che quando il dio egizio Ra sconfisse presso Edfu i suoi nemici, i superstiti di coloro che avevano tentato di abbattere il potere della divinità solare, fuggirono verso i quattro punti cardinali: a sud si rifugiarono gli antenati dei Nubiani, a ovest quelli dei Libici, a nord quelli degli Asiatici, a est gli antenati dei beduini, mentre in Egitto rimasero solo le genti che si definivano Romethi, cioè gli ‘uomini’”.
L’archeologo Pierre Montet (21) indica in un dipinto che appare in molte tombe reali egiziane, il cui esemplare più noto si trova nella tomba di Seti I (XIX dinastia), quella che egli considera: “...La raffigurazione di almeno quattro razze conosciute nel Nuovo Regno: in primo luogo gli uomini ‘Romet’, contrapposti agli déi. Mentre, nel dipinto detto ‘delle razze umane’, lo stesso nome indica gli ‘uomini’ per eccellenza, e che poi non sono altro che gli Egiziani”. È rilevante che in entrambi i casi figuri il termine Rom avente lo stesso identico significato di ‘uomini’, cioè gli Zingari per antonomasia.
Lo storico persiano Hammizha ibn Hasan-el Isfalini (22) registra l’arriva verso il 550 a.C. di 12.000 musicisti provenienti dall’India, quando: “Il buon re Bahram Djour di Persia accolse i lamenti di una parte dei suoi sudditi resi poveri per le privazioni. Questi chiedevano di poter fare della musica per celebrare le feste come facevano i ricchi. Fu così che egli chiese a suo suocero, re Shankal de Kanauj, che viveva nell’alta valle del Gange, di mandargli dodicimila musicisti. Quando questi arrivarono, il re gli fece dono di che vivere nel coltivare la terra. Diede ad ognuno un asino, una mucca e mille balle di frumento. Passato un anno, essi si presentarono a lui completamente affamati, poiché avevano semplicemente mangiate tutte le provviste. Arrabbiato, il re consigliò loro di mettere le corde di seta ai loro strumenti, di saltare sui loro asini e di mettersi sulla strada ... e vivere della loro musica”.
Sin qui la leggenda, o forse la storia, che ci offre una suggestiva chiave di lettura sull’origine di un singolare gruppo ‘scelto’ di musicisti, sospinti verso il nomadismo clandestino e dei quali non si conosce altro; né se fossero partecipi di uno stesso agglomerato umano o di una stessa ‘casta’ fra le molte esistenti in India; né, tantomeno, quali fossero gli strumenti con i quali avrebbero rallegrato il popolo penitente. Alcuni studiosi sostengono che appartenessero al popolo dei Luri, già noti in India come eccellenti musicisti che, in seguito a questo evento presero a girovagare per le strade del mondo.
Il poeta e filosofo persiano Al-Firdusi (23) che attorno all’anno 1010 compose lo ‘Shahnamah’ o “Libro dei Re”, in cui si tratta delle vicende storico-leggendarie dell’epica persiana, ricorda che i Rom abbracciarono la vita nomade fin dalle loro origini facendo i musicisti di mestiere. Per tradizione usavano accompagnarsi con strumenti a corda sui quali cantavano e declamavano poemi alla maniera dei poeti professionisti ‘langa’ o ‘manghaniyar’ al servizio dei signori del Rajastan, anch’essi nomadi, che cantavano in ‘dari’, l’antica lingua derivata dal persiano. Sempre dal Rajastan provengono gli echi delle danze ‘kalbelya’, derivazione di ‘kali’, il colore nero tipico degli abiti indossati dalle danzatrici appartenenti al gruppo degli ‘Yogi’, essi stessi nomadi, riconosciuti maghi e incantatori di serpenti che viaggiavano a dorso di mulo accompagnati dai loro cani, ritenuti la personificazione vivente di quegli antenati ancestrali dai quali forse gli Zingari traggono origine.
Alcune testimonianze rivelano che essi furono in Persia accomunati agli Jats, un popolo che viveva ai piedi delle montagne, la cui fama di musicisti e danzatori era conosciuta in tutto il mondo antico. Si vuole fosse un popolo felice e dedito alla gioia e al divertimento, formato da abili giocolieri e saltimbanchi che sapeva suonare flauti e tamburelli, strumenti a corda e trombe d’ogni specie. I quali, in un certo momento storico, iniziato all’incirca verso il II millennio a.C., furono sottomessi dalle tribù balcaniche che invasero l’Asia Minore, allorché un flusso migratorio di grandi dimensioni, portò dalle steppe danubiane popoli di una stirpe non semita, definiti in seguito ‘Indoeuropei’, per indicare in una sola parola l’estensione del loro definitivo insediamento, sia verso l’India che verso l’area egeo – anatolica, e attraverso il Vicino Oriente, in Europa centrale e meridionale.
Questi, venuti a contatto con le preesistenti culture semitiche sul territorio, divennero in breve tempo il gruppo dominante soppiantando talora le popolazioni autoctone e, in qualche caso, fondendosi con esse, dando così il via a nuove e originali civiltà. A questo proposito cito Vladimir Propp (24), il quale scrive: “Non sono trascurabili le due grandi popolazioni degli Sciti e dei Messàgeti, almeno per quanto riguarda il nomadismo centroasiatico, poiché esse rappresentano le più antiche società nomadi suddivise nelle stirpi degli Ancati, Càtiari, Traspi, Paràlati.”
Va qui ricordato che alcune di queste popolazioni avevano fama di essere ‘indovini’ e conducevano una vita esclusivamente nomade, servendosi di carri e dediti alla lavorazione dei metalli, tra cui principalmente l’oro. Il contatto con le civiltà mesopotamiche influenzò fortemente questi popoli ma non al punto di alterare l’originalità della loro cultura improntata sulla forgia dei metalli da cui avevano ereditato il nome di ‘signori del fuoco’. Torquato Perez de Guzman (25) attribuisce la rapida evoluzione degli Indoeuropei proprio alla diffusione del ferro che, a partire dal II millennio a.C. coincise con un’epoca di grandi sconvolgimenti e trasformazioni politiche, cioè a: “..quando i famosi popoli del mare ruppero il monopolio Ittita della forgia e disseminarono ai quattro venti il ‘sapere’ fin lì tanto gelosamente custodito, dando così origine alla seconda rivoluzione mitologica, dopo quella del fuoco.”
Un’affermazione degna di considerazione, che affonda le proprie radici nella storia ed è convalidata da testimonianza e da reperti archeologici che, sebbene una recente datazione abbia rivelato una maggiore antichità, ci permette di attribuire a quei popoli uno sviluppo dell’industria estrattiva e metallurgica in senso autonomo. Paolo Bataillard (26) concede ad essi una possibile origine preistorica, rintracciando nella loro pratica dei metalli una traccia atavistica dell’età del bronzo. Più fedele al resoconto storico è la corrente migratoria che dall’Indo si è spinta nel cuore dell’Europa alla ricerca di nuove terre più doviziose e popolate, che da sempre rappresentavano il principale incentivo all’esodo, e che raggiunse le coste della Grecia e successivamente dei Balcani, dove le tribù zingare si presume abbiano sostato più a lungo.
Ciò va considerato alla luce della ricchezza di elementi lessicali medioevali e bizantini presenti nella loro attuale lingua. Ancora nell’Europa preistorica si fa riferimento a un’altra tribù originaria dell’Armenia e delle regioni intorno al Mar Nero, i Chaliby che, secondo la tradizione greca, furono i precursori della fusione e diedero il nome all’acciaio. Questi erano i progenitori dei Kemiti di Midian, una delle cui figlie sposò il profeta e legislatore ebreo Mosè, e di quel gruppo di fabbri che forgiarono le armi per le tribù nomadi dell’Arabia. Secondo la tradizione greca, trova maggior forza l’ipotesi di una possibile discendenza degli Zingari dal più antico popolo dei Pelasgi, il cui nome era associato alla metallurgia ed era conosciuto già nel 1200 a.C. in tutta l’Anatolia e nelle isole dell’Egeo.
La presenza stanziale di gruppi Zingari è confermata in Grecia, in Tracia e nel Ponto, ove li trovò nomadi e ancor più antichi lo storico Erodoto (27) attorno al 560 a.C., da cui l’assimilazione già evidenziata dell’uso di lettere alfabetiche greche all’interno del loro linguaggio. Tuttavia l’appellativo di ‘griegos’ loro attribuito è ancora oggi un arcano per quegli storici che più recentemente si sono avvicinati alla “zingarologia”. Pur non essendo determinante al fine della ricerca qui avviata, ciò rappresenta una nuova ipotesi e comunque la conferma della loro provenienza da un’area diversificata d’estremo interesse etnologico.
Altro centro di profusione della corrente migratoria è stato individuato nelle pianure valacche e moldave, da dove alcune minoranze zingare si sarebbero in seguito spinte in Russia e in Siberia. Mentre è assai probabile che gruppi più consistenti siano giunti dall’Arabia e, presumibilmente, attraverso lo stretto di Gibilterra, nella Spagna medioevale, sospinti o al seguito non meglio specificato degli eserciti Mori e Saraceni d’istanza nel Mediterraneo. Una importanta comunità, per lo più sedentarizzata, è presente in Andalusia presso il Sacro Monte di Granada, alla quale una recente statistica poco più di qualche migliaia di soggetti sono distribuite in Francia, in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi, ai confini con la Svizzera e l’Austria, nonché in Norvegia e in Finlandia. Mentre equivalenti a poche centinaia di individui si contano nelle Americhe, nello stato del Brasile, in Australia e in Nuova Zelanda.
Sappiamo ormai per certo che gli Zingari presenti in Europa si suddividono in due gruppi fondamentali: l’uno e l’altro contrassegnati linguisticamente dai dialetti ‘vlax’ e ‘non vlax’. I primi comprendono le parlate in cui la lingua rumena prevale sulle altre europee. Appartengono al secondo gruppo quelli le cui parlate risentono in maggioranza degli influssi greci, slavi e tedeschi. Abbiamo così i Rom che parlano in prevalenza ‘vlax’ e i Sinti per i dialetti ‘non vlax’. Attualmento i nomi Rom e Manus in senso più stretto si applicano ai due principali gruppi zingari occidentalizzati esistenti in Francia: i Rom arrivati abbastanza di recente dall’Europa orientale; e i Sinti o Manouches, presenti da tempo sul territorio, in parte sedenterizzati nel sud del paese. Ai Manouches si possono accostare i Kalé della Spagna, presenti anche in Inghilterra e in Finlandia; e i SInti della Jugoslavia, Slovacchia, Polonia e dell’Italia, per i quali il vocabolo ‘manus’ significa letteralmente il ‘maschio’ e non soltanto lo zingaro in senso lato.
I Sinti si indicano generalmente con il nome delle zone di insediamento: ‘gackane’ tedeschi, ‘estrekaria’ austriaci, ‘havati’ croati, Sinti piemontesi, lombardi, marchigiani, ecc.. per alcuni di essi la parola ‘sinte’ altro non significa che ‘sundò’ (zingaro) dal verbo ‘shunava’ traducibile con ‘celebre o rinomato’. Altri lo connettono con Zincalo da ‘Sindhu’ (Indu), usato dagli Zingari in Germania, Polonia e Scandinavia. Mentre per i Rom i nomi più frequenti indicano i mestieri tipici cui si dedica il singolo gruppo di appartenenza: ‘kalderasa’ per i calderai, ‘lovara’ o addestratori e mercanti di cavalli, ‘curara’ o fabbricanti di setacci, ‘ursari’ o ammaestratori di orsi, ecc. ; a loro volta suddivisi in altrettanti clan, distinti per nome dell’antenato di discendenza, che diventa in patronimico comune.
Ben si comprende la difficoltà di addentrarsi nell’intricata questione del significato etimologico dei nomi, tuttavia la risposta più persuasiva finora fornitaci, è quella dello studioso Françoise de Vaux de Foletier (28), il quale si è confrontato con un nutrito elenco di nomi e di appellativi riferiti agli Zingari in ogni parte del mondo, e che ha permesso di conoscere e individuare geograficamente i flussi migratori delle tribù nomadi in epoca storica.
Egli scrive: “Uno dei nomi più antichi attribuito sembra ad una ‘oscura’ setta eretica, è quello degli Astingani, la cui fama di maghi e indovini si era mantenuta viva fin nella Grecia classica. In un momento storico accertato, questi fecero la loro apparizione nell’impero bizantino, dov’erano anche detti Athinganos o, secondo la pronuncia popolare, Atsinganos o anche Atsinkanos. Da cui la provenienza dei nomi: Tchinghiané in turco, Acingan o Cingan in Bulgaro, Ciganin in serbo, Cygan in polacco, Cykan in russo, Czigàni in ungherese, Cigonas in lituano, Zigeneur in olandese e tedesco, Zuyginer o Zeyginer in alsaziano, Xeginer in svizzero tedesco, Zigenar in svedese, Cingre o Cingar e Cingan in francese antico, Tsigane in francese moderno, Zingaro o Zingano in italiano, Cigano in portoghese. (..) Il latino medievale usava le forme Acinganus, Cinganus, Cingerus, mentre gli autori tedeschi del XVI secolo come Wangensil e Fritsch, collegavano Zigeuner a Zig o Zieche Cinher, oppure a Cinherziehen.”
Gli Zingari slavi, invece, si dividono in due gruppi: Daxikané e Karakhané, dei quali, quest’ultimi di religione musulmana. Entrambi i nomi stanno a significare l’ ‘errare’, cioè riferiti al nomadismo in genere ma, anche, al semplice girovagare o vagabondare, per estensione comprensibili in una realtà nomade indipendente dalla loro origine. Seppure ogni gruppo di quelli citati presenti caratteri fisici e linguistici affini ma diversi all’interno di una stessa etnia, alcuni di essi sono considerati ‘stanziali’ in Scandinavia con il nome Yénische, mentre in Scozia e in Irlanda sono conosciuti col nome Tinkers. Anche se diversi per estrazione sociale e culturale dagli altri gruppi ‘autonomi’ presenti nel resto dell’Europa, sono invece di tipica estrazione zingara quei gruppi che vanno sotto i nomi di: Lautari, Boemi, Tzigani, Gypsies, Gypsy, Gitani, tutti accomunati da uno ‘straordinario’ estro musicale, scaldati dal ‘fuoco’ interiore tipico del musicista che li rende unici, e cioè ‘vibranti di vita’.
Il nome stesso di Zingari, da cui derivano ‘zingaros’, ‘segnor’, ‘egiziani’, raccoglie tutti gli appellativi successivi coniati dal mondo occidentale per dare un nome a un popolo che apparentemente non ne possedeva uno e che, ha assunto a proprio riconoscimento il termine ‘Rom’, fino al più moderno ‘Romano nav’. Pur tuttavia Rom resta il nome che essi si diedero e col quale continuano a chiamarsi ovunque essi si trovino e a qualunque gruppo o famiglia appartengano, da cui il significato di ‘uomo’ per antonomasia. Ogni altro appellativo è da essi rifiutato perché riduttivo o, quantomeno, dispregiativo. Lo straniero, il ‘non zingaro’ è da essi chiamato ‘gorgio, gagio, busnò’, secondo una dicitura ormai sorpassata e attualmente ripristinata in ‘gagi kano nav’, dal più antico ‘gadjé’, da cui quel ‘gagì’ con cui ci sentiamo oggigiorno appellare per strada.
Più recentemente Daniell Soustre de Condat (29) elenca altri nomi tra antichi e nuovi in qualche caso illuminanti, ampliando maggiormente il campo di ricerca. Sotto il nome di Tsigani – che afferma essere il più conosciuto e usato, – egli accoglie Tsignos, Tsingani, Tsiganes, Cingan, Zigenuer,, Zigojenere, Sigoyner, Zigenare, Zingari. Cita, inoltre, gli Astingani da cui i già conosciuti Atsinganos o Atsinkanos in greco-medievale, riferendosii agli Athinganoi, che fa risalire alla setta bizantina detta degli ‘intoccabili’; da cui: Yifti, Yeflos, Giftos, Gitans, Gitanos, Gitani, Gypsies alcuni dei quali non avevamo ancora incontrati. Egli scrive, con una linearità quasi sconvolgente, che: “Oggi, possiamo affermare che la società zingara è una società pluralista. Ma è necessario, quando si afferma un concetto di pluralismo, fare una precisazione, che è quella di guardarla nel suo insieme: gli Zingari.”
Note e riferimenti bibliografici:
(prima parte)
1) Huttin Serge, ‘Civiltà misteriose’, Edizioni Mediterranee, Roma 1974
2) Roerich C. Nicholas, in McLellan A., ‘Agharti, il mondo sotterraneo’, Piemme, Casale Monferrato 1988
3) Guénon René, ‘Il Re del Mondo’, Adelphi, Milano 1977
4) Evola Julius, ‘La dottrina del risveglio’, edizioni mediterranee, Roma 1995
5) Muller Friedrich Max, in McLellan A. (op.cit.)
6) Jacolliot Louis, in McLellan A. (op.cit.)
7) Ossendowski Ferdinand, ‘Bestie, Uomini, Dèi’, Edizioni mediterranee, Roma 1972
8) Saint-Yves D’Alveydre, in D’Amico Roberto ‘Le terre del mito’, MEB Torino 1979
9) Guénon rené (op.cit.)
10) Jung Carl Gustav, ‘Il Simbolismo della Messa’ , Bollati Boringhieri, Torino 1968
11) Gaster Theodor, in Colocci A., ‘Gli Zingari. Storia di un popolo errante’, Arnaldo Forni Ed. ristampa anastatica dell’edizione del 1889
12) Eliade Mircea, ‘Storia delle credenze e delle idee religiose’, Sansoni Firenze 1979
13) De Rakelwiz Boris, ‘Egitto magico e misterioso’, Bollati Boringhier,i Torino 1961
14) Allchin B. e F.R., ‘La preistoria dell’India’, in ‘I popoli della Terra’ vol. XI, Mondadori, Milano 1974
15) Romano Augusto, ‘Musica e Psiche’, Bollati Boringhieri, Torino 1999
16) Di Stefano Giovanni, ‘La vita come musica’, Marsilio, Venezia 1991
17) Jung Carl Gustav, ‘Gli archetipi e l’inconscio collettivo’, Bollati Boringhieri, Torino 1980
18) Tettamanti Angela M., ‘Gli ultimi nomadi’, IGIS, Milano 1982
19) Predari Francesco, ‘origini e vicende degli Zingari’, Milano 1841 e in Colocci A. (op.cit)
20) ‘Popol Vuh’, Einaudi, Torino 1976
21) Spence Lewis, ‘The problem of Atlantis’, Econ Verlag, London 1976
22) Redfield james, ‘Il segreto di Shamballa’, Corbacci Ed., Milano 2000
23) Eliade Mircea (op.cit.)
24) Di Nola Alfonso M., ‘Inchiesta sul Diavolo’, Laterza. Bari 1978
25) Romano Augusto (op.cit.)
26) ‘Vangelo apocrifo di Tommaso’, in ‘vangeli gnostici’, Adelphi, Milano 1984
27) Cozannet Françoise, ‘Mythes et coutumes religieuses des tsiganes’, Pauot, Paris 1973
(seconda parte)
1) Kroeber Alfred L., ‘Antropologia’, Feltrinelli, Milano 1983
2) Netll bruno, ‘Mitologia per capire i popoli’, articolo in ‘Il Corriere Unesco’, anno XXIV n.6 – Giugno 1973
3) Geremek Bronislav (intervista), cit. in ‘Zingari’, Prometeo n.20, Dicembre 1987
4) Netll Bruno (op.cit.)
5) Sfoza-Cavalli Luigi L., articolo in ‘Il Messaggero’, Roma 14 Maggio 2000
6) Darvin Charles, ‘L’origine della specie’, Bollati Boringhieri, Torino 1967
7) Forbes R. J., ‘L’uomo fa il mondo’, Einaudi, Torino 1960
8) Amadu-Hampate Ba, ‘Kaidara’, Rusconi Ed., Milano ...
9) Muller Friedrich Max e Botey Francesco, in McLellan A. (op.cit.)
10) Furer-Haimendorf C. von, ‘I popoli del subcontinente indiano’, in ‘I popoli detta Terra’ vol. XI, Mondadori, Milano 1974
11) Ibidem
12) Allchin B. e F.R., ‘La preistoria dell’India’, in ‘I popoli della Terra’ vol.XI, Mondadori, Milano 1974
13) Furer-Haimendorf, (op.cit.)
14) Vaillant J. Alexander, ‘Histoire vraie des vrais bohémiens’, Peyot, Paris 1857, cit. in Colocci A., (op.cit.)
15) De Vaux de Foletier François, ‘Mille anni di storia degli Zingari’, jaca Book, Milano 1978
16) Bloch Jeles, ‘Les Tsiganes’, Payot, Paris 1969
17) Botey Francesco, ‘Le peuple gitan, une culture folk parmi nous’, Toulose 1971
18) De Vaux de Foletier François, (op.cit.)
19) Lafuente Modesto, in Infante Blas, ‘Origenes de lo Flamenco y Secreto del cante Jondo’, Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, Sevilla 1980.
20) Cimmino Franco, ‘Vita quotidiana degli Egizi’, Rusconi, Milano 1985
21) Montet Pierre, ‘Egitto eterno’, Il Saggiatore, Milano 1964
22) Hammizha ibn Hasan-el Isfalini, in Habib Hassan Touma, ‘La musica degli Arabi’, Sansoni, Firenze 1982.
23) Al-Firdusi, ‘Il libro dei Re’, in De Vaux de Foletier François, (op.cit.)
24) Propp Vladimir, ‘Canti popolari russi’, Einaudi, Torino 1976
25) De Guzman Torquato Perez, ‘Los Gitanos herreros de Sevilla’, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 1982
26) Bataillard Paolo, ‘Les Tsiganes de l’age du bronze’, Payot, Paris 1876, cit. in Colocci A. (op.cit.)
27) Erodoto, ‘Storie’, Mondadori, Milano 2000
28) De Vaux de Foletier François, (op.cit.)
29) Condat daniell Soustre, ‘Rom una cultura negata’, Edizioni Città di Palermo, Plermo 1997
*
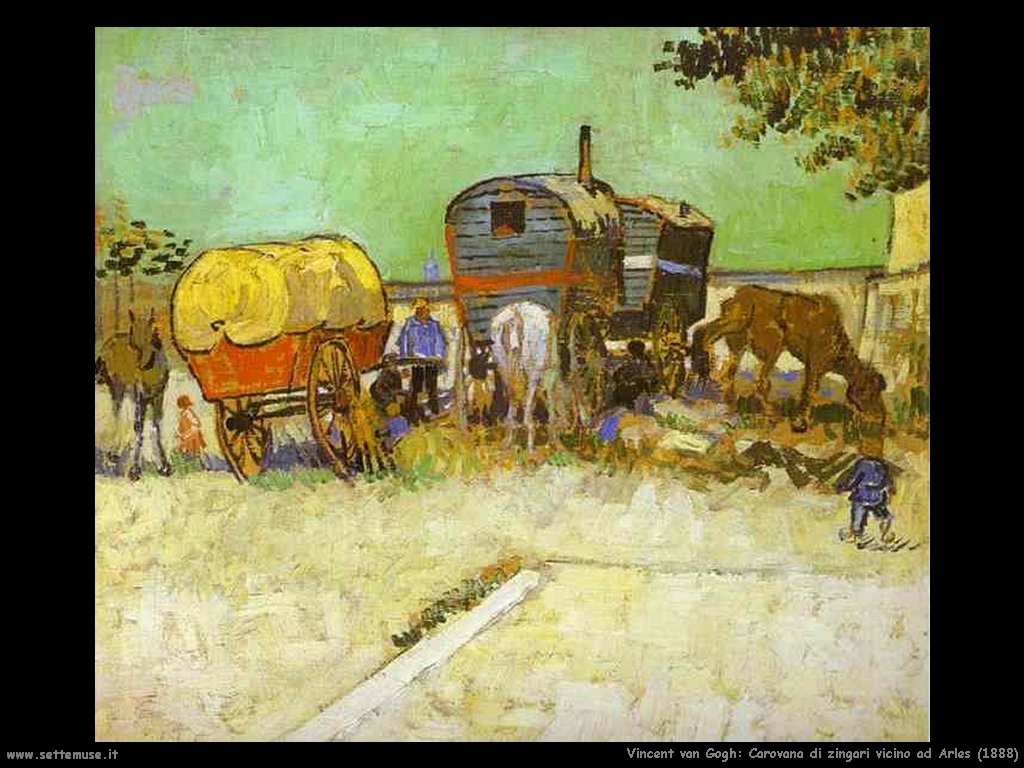 - Musica
- Musica
Etnomusica 9: Sulla strada degli Zingari - 2 parte
Tratto da “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” di Giorgio Mancinelli, MEF Firenze Atheneum, premio letterario “L’Autore” per la Saggistica, 2006.
Dipinto in copertina: (V. Van Gogh: Carovana degli Zingari vicino ad Arles).
“A piedi nudi seguono le stelle
E sono insieme nel vento e nella pioggia
Dalla nascita fino alla morte.”
“Che importa il paese fratello,/
prima di tutto ci sono gli uomini / e le melodie”.
“Non bisogna / sollevare le sciabole.../
ma ‘nascondere’ fino alla morte /
il quadro del proprio dolore /
moltiplicando la propria giovinezza /
e scavalcare il destino”.
“Restare là / quando tutto crolla: /
sotto le iucche danza la vita”. (1)
(anonimo zingaro)
Dove vanno le rondini quando disegnando contorni screziati di nero s’allontanano nell’azzurro del cielo che tende all’imbrunire?
Ed ecco, nel tempo sospeso di un interrogativo, spalancarsi davanti ai nostri occhi innumerevoli cieli solcati di nuvole d’argento e di piombo, di tramonti d’oro e di rame, di carri stellati che si rincorrono per il firmamento e di un numero incalcolabile di lune che vagano nella notte. Forse è lì che vanno i ‘figli del vento’ – come qualcuno poeticamente li ha definiti prima ancora di chiamarli ‘gli zingari’ – senza una ragione apparente, senza un vero perché, verso quel cielo lontano dove sono dirette le rondini, sicuri che per ogni orizzonte cui andranno incontro ci sarà sempre una luna diversa e altrettante stelle a dar loro la certezza che non si perderanno.
A differenza delle rondini gli Zingari vanno senza fermarsi mai, attraverso montagne irte e distese solitarie, specchi d’acqua e fiumi profondi, valichi innevati e valli dorate, aride steppe e foreste di alberi nodosi, cresciuti troppo alti e troppo in fretta, ai margini delle città metropolitane. Il loro cielo è rappreso di sguardi lontani, di speranze incolmabili. Un cielo diverso per ogni diversa contrada. Vanno incontro a gente diversa, di diversa estrazione, lungo le strade misteriose e sconosciute del loro infinito peregrinare, segnate da interminabili passi, attraverso i lunghi silenzi delle loro notti. Vanno, come ombre che il vento sospinge verso mete sempre più lontane, forse soltanto sognate, sferzate da una ostilità crescente che osteggia la loro già difficile sopravvivenza.
La musica viaggia con loro tra struggenti grida d’amore, improvvisazioni e ritmi tribali, con la voce di chi, ancora oggi, ha scelto di non restare imprigionato nei confini di nessuna nazione, di alcuno stato. Una musica “che non ha bisogno di note e spartiti per viaggiare nel tempo e nel vento: che non conosce confini o barriere e che è fatta di tante altre musiche e diversi modi di eseguirle” che, quasi ci è permesso dire ‘che non conosce tempo’ e, per estensione ‘che è fuori del tempo’. Poiché essa rappresenta la ‘forma del tempo’, assunta nel superamento delle barriere del linguaggio e delle tendenze musicali più o meno originali di questo o quel popolo con cui è entrata in contatto e, per il ‘tempo’ più o meno lungo della sua sedimentazione.
Una musica che non conosce la sua forma ‘passata’ ma solo la forma ‘presente’ che prende vita durante il ‘tempo’ della sua esecuzione, e che per questo, si dice difficile da catturare. ‘Viva’ in quanto ‘dal vivo’ procede il suo esecutore materiale, per il quale la sua ‘esecuzione musicale’ e ‘tempo d’ascolto’ sono la stessa cosa, poiché rappresentano il ‘vissuto’ temporale e aleatorio del suo essere musicista. Considerata nelle sue molteplici sfaccettature, la versatilità che si accompagna al fatto musicale, accomuna tutti gli Zingari in un ipotetico ceppo di appartenenza relegato a un lontano passato ‘senza memoria’ – come per un misfatto del destino che essi sembrano aver rimosso o, debitamente occultato, a causa di un ‘trauma originario’ ancora oggi privo di riferimento storico.
Versatilità che tuttavia ha permesso loro di dare forma a linguaggi musicali diversificati, con implicazioni talvolta profonde, confluiti in modo trasversale dalla radice ‘etnica’ originaria, all’interno del folklore popolare e che, in qualche modo, ha contribuito alla trasformazione in atto della ‘nostra’ sensibilità musicale. Di essere, se osservata in senso critico, di fronte a una fase evolutiva della musica mondiale, partecipe dello straniamento dovuto alla sua ‘globalizzazione’, trasformata in una sorta di ‘finzione’ perché ricreata in sala d’incisione, ove è persa ogni connotazione di riferimento ‘etnico’ e ‘musicologico’ proprio per il fatto che non tutti gli elementi sono rappresentativi di formazioni autentiche ‘zingare’. Soprattutto, per effetto di implicazioni commerciali che, in qualche caso, hanno contribuito negativamente al ‘crescendo’ intrinseco della musicalità zingara, entrata successivamente, attraverso le divergenze del jazz, nelle attuali tendenze del rock e della world-music.
Di contro, va qui considerato che per il musicista zingaro, fare musica non ha affatto una funzione di mero intrattenimento o di soddisfazione estetica, bensì è un momento fondamentale di riconoscimento individuale, futuro punto di coesione di tutta la ‘comunità’ alla quale egli appartiene. Il musicista zingaro, infatti, non definisce per scelta i confini fisici della propria creatività ma riconosce il proprio naturale ‘intuito’ che si sprigiona libero attorno al fuoco acceso nell’accampamento, sotto il cielo stellato. È insita nell’animo zingaro la necessità primaria di esprimere attraverso la musica il proprio individuale sentimento che mette al servizio del proprio gruppo di appartenenza. Per quanto, l’individualismo delle proprie idee, non è che un’illusione priva di significato, che il ‘tutto’ è rappresentato dalla ‘famiglia’ comprendente, oltre al proprio nucleo, tutta la parentela, con la quale vengono mantenuti rapporti di convivenza.
Per lo zingaro la ‘musica’ è per se stessa ‘colui che suona’, espressione profonda di ciò che egli porta dentro di sé che improvvisamente si sprigiona, che s’infuoca ‘dentro il presente’, così come al ‘presente’ egli rivolge la sua estemporanea esecuzione. Va inoltre tenuto in considerazione che sia essa di festosa gioia come nella ‘hora’ lauterasca, o colma di malinconia profonda come nella ‘doina’ rumena, o accesa di struggente passione nelle oscurità delle ‘cuevas’ gitane; che insegua i fantasmi della notte come nel ‘duende’, o che si prostri al religioso misticismo di una ‘saeta’ durante la ricorrenza della ‘Seimana Santa’. In mancanza di altre forme espressive quali sono l’uso di immagini e la scrittura, o la notazione musicale del tutto inesistente, la musica rimane il punto più alto dell’espressione culturale zingara, inquanto è fonte di espressione di sentimenti e creatività artistica che, altrimenti, non siamo in grado di attestare. Una musica che parla d’amore e di passioni, di libertà e di orgoglio e, soprattutto, della vita nomade e del nomadismo cui come popolo, gli Zingari, malgrado le inadempienze imposte dai confini territoriali e dalle leggi degli stati nazionali, è ancora oggi di affermare.
Chi (davvero) sono ‘i figli del vento’?
In generale le opinioni sugli Zingari spaziano dall’interesse allo stupore. Le descrizioni che ne vengono fatte sottolineano anzitutto la diversità dell’aspetto esteriore: il colore scuro della pelle, i capelli lunghi talvolta annodati e la barba incolta per gli uomini; i fazzoletti multicolori che avvolgono la testa delle donne, il loro indossare un numero eccessivo di costumi uno sull’altro, i lunghi scialli legati alle braccia nei quali portano i bambini, il vociare disordinato apparentemente sconnesso con il quale attirano l’attenzione, il portare molti monili d’oro malgrado il loro aspetto miserabile.
Le prime cronache che li riguardano risalgono agli inizi del Quatrrocento, in cui vengono descritti come: “gentes non multum morigeratae, sed quasi bruta animalia et furentes”, ossia “gente tuttavia non troppo morigerata, simile a un’orda di animali selvatici e di ladri”. Allo stesso modo in un ‘cronicha’ più tarda, sono descritti “magri e negri che mangiavano come porci” in aggiunta a che “le donne truffavano la gente con la chiromanzia”. Il loro aspetto nel maggiore dei casi è considerato ripugnante, uomini e donne sono “gli esseri più poveri mai visti a memoria d’uomo”, come appunto riporta un’altra ‘cronicha’ del tardo Seicento.
Lo storico Adriano Colocci (2) ancora nell’Ottocento, nel ripercorrere le tappe della loro storia, riferisce che: “Gli Zingari – strano popolo! (..) Era in principio del secolo decimoquinto (..) – quando si videro sbucar fuora da mille parti queste orde ariane e scorrere, furtive e inermi, tutta quanta l’Europa, cangiando incessantemente dimora, stupefacendo per la bellezza delle loro donne, favellando idiomi strani, praticando usanze arcane e diaboliche, adorando forse in segreto iddii sconosciuti”.
Françoise Cozannet (3), nel tentativo di esplorare il mondo interiore di questa comunità umana misconosciuta, a suo tempo scrive: “Quando gli Zingari arrivarono in Europa, molto tempo dopo le grandi migrazioni, non erano altro che nomadi, troppo pochi e arrivati troppo tardi, in un mondo le cui strutture erano ormai fissate. Le loro attività economiche di sussistenza perciò palesano una forma parassitaria rispetto alle attività dei sedentarizzati. Di qui la diffidenza e il timore dell’immagine più abituale dello zingaro (..) che abitualmente difende il mistero delle sue strutture sociali dalla curiosità e dal timore del mondo esterno”.
La situazione non sembra migliorare se ancora nel 1999 Antonio Tabucchi (4) li descrive nel seguente dei modi: “Sono privi di tutto. Non hanno nessun tipo di infrastruttura, né di sussistenza. Spesso neppure i documenti che provino che esistono come creature. Solo il loro corpo testimonia che essi sono persone vive, in questo breve deserto senza alberi e senza erba che è loro concesso a questo mondo”.
Ecco qui reso manifesto quello che è il contesto tipico in cui gli Zingari appaiono alla nostra considerazione, costituito da una parte dall’essere vagabondi e quindi aditi alla delinquenza che dipende dalla loro condizione di nomadi; dall’altra, dal loro misterioso occultare un minaccioso ‘mondo magico’ che, ancora oggi, nel terzo millennio, offre una loro immagine decisamente negativa. Esattamente come lo ‘zingaro’ è apparso a Paulo Cohelo (5), il quale in una sua opera lo ravvisa nelle fattezze del ‘diavolo’: “Lì, seduto sul terreno, un uomo sui cinquat’anni, dai capelli neri e l’aspetto da zingaro, stava frugando nel suo zaino in cerca di qualcosa. (..) Gli domandai chi fosse lo zingaro. (..) Petrus, pensò che lo zingaro fosse il demonio. Sì’, lo era”.
Se si considera l’aspetto funzionale di queste diverse immagini convenzionali, ci si accorge che esse svolgono un medesimo ruolo negativo, in quanto razionalizzano barriere reali fra i non-zingari (gadjé) e gli Zingari veri e propri ma, anche, fa distinzione fra i gruppi ‘nomadi’ e le popolazioni ‘stanziali’ in rappresentanza d’una loro presunta civilizzazione. Mentre è la specificità dell’intera popolazione zingara che va qui presa in considerazione e che, per così dire, assume in sé un valore esemplare: “per essere riuscita ad affermare” pur nelle infinite contrarietà, “una sua continuità attraverso il proprio inserimento nelle diverse società”.
“Gli Zingari è vero – risponde Vanko Rouda (6) – sono esseri umani isolati dalla società, che vivono fuori delle cultura, residenti nella periferia dei villaggi e nei sobborghi delle grandi città; ma sono gente come noi, che vive in mezzo a noi, che ci chiama con grida di colore e di luci. Tutti i momenti della luce. Il blu intenso del cielo, il verde tenero dell’erba. Tutta la scomposizione della luce che musicalmente parlando fa parte del loro sguardo interiore”. Conferma Petru Radita (7): “È vero, vivono in miseria, vagabondando, vestiti di stracci colorati, sono sempre affamati, però si amano tra loro. Amano la vita e la natura nel seno della quale vivono, amano le stelle, la luna che risplende per loro nella notte e il sole che li riscalda, che riscalda i loro cuori, risvegliando in loro sentimenti d’amore”.
“Quell’amore che – scrive Marcella Uffreduzzi (8) – è elemento essenziale alla vita dello zingaro, nella famiglia, nell’amicizia, nella solidarietà. Amore per la natura e per i paesaggi, amore per la Madre Terra. Essa è intravista tramite la grandezza della foresta, la polvere della strada, la nuvola nera, il temporale, il vento, la leggiadria di un fiore. (..) Così che ognuno riconosce ul suo posto, oltre i mari, le montagne, le frontiere”.
Come ci dice Derek Tipler (9): “Per noi Zingari, la vita è insita nella parola ‘rom’ che infatti significa ‘uomo’; il fulcro attorno a cui gravitano le ‘cose’. Per cui la libertà è l’essenza del nostro vivere, la ragione per la quale noi viviamo la nostra vita come vogliamo. Per noi l’altra costa della collina è sempre più verde di quella dove abitiamo, e una frontiera è una sfida interessante piuttosto che un ostacolo insormontabile”.
Sfida che riferita allo zingaro Federico Rasetschnig (10) poeticamente interiorizza con: “L’armonia delle sue voci e dei suoi silenzi, con il cacofonico concerto di mille fragori assordanti e artificiali, e la sua pace bucolica, con gli spietati assilli di un ritmo di vita che non concede tregua. (..) Ma che, al tempo stesso, plasma il suo abito mentale, complicato da superstizioni, da credenze singolari e da una mentalità pittoresca, dalle tendenze tutt’altro che conformiste, ribelli e talvolta persino asociali”.
Cosa accomuna gli Zingari gli uni agli altri?
Risponde Giulio Soravia (11): “Un elemento che sfugge alle categorie di pensiero occidentale, è quello che costituisce il ponte più ovvio tra la cultura zingara attuale e le sue origini. Si tratta di quella flessibilità di pensiero, di quella tolleranza alle diversità, di quel senso di unità, pur nel rispetto delle differenze, che sono una delle più grandi conquiste del genere umano. Quella capacità di assimilazione onnicomprensiva che ingloba tutto e tutto riproduce in forma nuova, spesso irriconoscibile, e che la ‘vitalità’ zingara rende nei tratti più pertinente e più prepotentemente autentica”.
Per Petru Radita (12): “L’autenticità degli Zingari è da ricercarsi nell’aver fatto del ‘mito’ l’elemento portante di tutta la loro cultura; all’origine di tutte le usanze, del modo di porsi di fronte alla vita, e che permette di ritrovare in questo singolare gruppo umano le caratteristiche di una sacralità che non è semplicemente sincretica, che ha qualcosa di originale rispetto a tutto ciò che ha assorbito dai vari popoli e religioni”.
Cosa realmente significa essere Zingari?
Scrive ancora Vanko Rouda (13): “È avere altra carne, un’altra anima, un’altra pelle, istinti, passioni, desideri. È un altro modo di vedere il mondo con sentimento, odiare il routinario, il metodico castrante. Convertire in un’arte sottile, in fantasia e libertà, la vita. Fare di tutto un invito, assaporare, darsi, sentirsi. È vivere!”.
Secondo Derek Tipler (14): “Si tratta sempre e comunque di un’esperienza personale di vita-in-diretta, e la capacità di riconoscere valori umani anche in quelle culture trascurate o disprezzate, capaci invece di affermare qualche lezione di saggezza”.
Conclude Marcella Uffreduzzi (15): “Per gli Zingari la vita è fatta per essere vissuta intensamente, non si può riflettere o filosofare su di essa. Se esiste una filosofia zingara, questa è imperniata sull’uomo centro dell’universo. La libertà allora è l’essenza di un modus-vivendi, l’unica ragione di vivere. L’unica possibile”.
Ecco che alla luce di tali affermazioni l’essere zingaro ritrova, inaspettatamente, quell’autenticità che gli è propria e che, da sempre, gli viene negata. Cioè essere egli quell’ ‘uomo libero’ che, insito nel suo stesso nome Rom, avevamo trascurato fin qui di considerare: un nomade, non un vagabondo da espellere dalla società, o un ladro da consegnare alle autorità. Che, piuttosto, definirei “un ospite, se vogliamo, sempre un po’ furtivo e misterioso, che ha mantenuto abitudini diverse dalle nostre”. Tuttavia è sbagliato trasformare una possibilità d’incontro fra ‘culture’ diverse a causa di un unico problema isolato che, invece, va considerato dentro un processo naturale di diversità, che è insieme fonte di arricchimento dialettico, da cui può derivare un costruttivo progresso culturale.
L’Europa del futuro deve prestare attenzione a tutto questo se vuole progredire nella democratica convivenza delle genti che la formano, poiché uno dei più gravi errori commessi in passato è proprio la convinzione della propria superiorità sugli altri e che, col senno di poi, la sta portando alla rovina. Non a caso Sir Edward Evans-Pritchard (16) ci ha spesso ragguagliati dell’enorme “...debito che l’Occidente ha nei confronti delle culture cosiddette minoritarie; soprattutto verso quelle più fragili o precarie, dalle quali tanto potremmo apprendere anche sul valore della nostra”.
Più recentemente l’antropologo Arnold Toynbee (17), nella sua opera “Incontro e mescolanza di razze” ha evidenziato, una componente dell’intero processo di interazione fra i popoli che lo ha portato, in modo estremamente drammatico, a scrivere: “Il maggior e avvenimento del secolo ventesimo è stato l’impatto della civiltà occidentale con tutte le altre forme di organizzazione sociale esistenti al mondo, impatto tanto poderoso e capillare da aver sconvolto e rivoluzionato la vita di tutte le sue vittime, minando alle fondamenta il loro modo di essere, le loro prospettive, i loro sentimenti e i loro credi”.
Fatto, questo, che dovrebbe allarmarci sulla reale capacità di adattamento e di mescolamento che l’umanità dovrebbe assolvere con l’ambiente e che non fa, e sulla priorità di accesso a quelle che sono le reali risorse sociali. Considerato che, contrariamente alle credenze comuni, nessun nomade vaga a caso, e che tutto dipende dalle risorse e le possibilità di sfruttamento dell’ambiente e della società in cui il nomadismo si rende possibile, non vedo quale via d’uscita avremmo ‘noi’ se un giorno tutte le porte ci venissero sbarrate, come noi facciamo con gli Zingari e non solo con essi. Applicando qui, una sorta di tecnica di straniamento dalla realtà attuale, non vedo altre vie se non un restrittivo e catastrofico ritorno ai primordi in cui l’antropofagia era pratica comune a tutti i ceppi umani.
Fortunatamente, accanto al movimento dei pessimisti più eterogenei, vi sono ancora individui ‘altri’ che si dislocano in modo autonomo un po’ ovunque e che sfuggono a questo catastrofismo, vuoi per presenziare e dare continuità ai cosiddetti ‘riti di passaggio’; vuoi per fronteggiare necessità che in qualche modo li rimettono in viaggio, auto-escludendosi, per così dire, da quella fine da topi sedentarizzati che si prefigura essere il destino del resto dell’umanità. È dunque a quei singoli esponenti del nomadismo, a quegli ‘spiriti liberi’ che vagano per le contrade dell’Europa tutta che, pur andando incontro a mille difficoltà, che questa ricerca si rivolge con la man o protesa alla solidarietà, affinché prevalgano i principi di uguaglianza e di fratellanza e, al loro riconoscimento in qualità di ‘cittadini del mondo’ cui gli Zingari, popolo nomade per eccellenza, fanno riscontro.
“Noi non cerchiamo di insegnarvi
Come vivere la nostra vita,
perché voi
volete imporci la vostra?”
(Derek Tipler)
“Que ningùn hombre vagabundo no sea osado de vivir en la ciudad, que no tenga amo, sino fuere hombre labrador, so penade cien azotes, y que lo echen fuera de la ciudad: porque asì està mandado, y pregonado antiguamente, desde el ano de mil y cuatrocientos y dos anos”.
“Che nessun uomo vagabondo osi vivere in città, che non tenga casa, anche se è un operaio (lavoratore), pena cento frustate, e che lo portino fuori della città: poiché così è stato ordinato e già ripetuto in passato, fin dall’anno mille e quattrocentodue”.
È davvero lontano il tempo in cui questa Ordinanza di Siviglia prescriveva quanto appena letto? Da allora, con frequenza costante, la società dei ‘gadjé’ (noi occidentali) ha manifestato attivamente contro gli Zingariche per molti aspetti è difficile da comprendere e ancor più difficile condividere il loro stile di vita. Occorre però considerare che talune forme di ‘devianza sociale’ non sono peculiari alle genti zingare ma, più spesso, sono la conseguenza del secolare rifiuto opposto loro dalle società circostanziali. Oggi, consapevoli di trovarci di fronte ad una realtà complessa e in qualche modo indecifrabile, anche noi viviamo una fase di costanti mutamenti e in mezzo a situazioni di disgregazione sociale che somigliano a una perdita d’identità mai vista prima, tale da sembrare ormai irreversibile.
D’altra parte assistiamo, per nostra fortuna, al sorgere di segnali contrapposti di speranza e rinnovamento che ci danno la forza di andare avanti, quasi a voler testimoniare una presa di coscienza da parte di frange volenterose, sempre meno, che sentono il dovere di non restare indifferenti di fronte al problema della sopravvivenza dell’umanità tutta, assunta nel processo di formazione di una coscienza ultranazionale che dovrebbe sfociare in una più ampia cultura comunitaria.
Un’opinione auspicabile che dovrebbe essere altresì condivisa dalla maggior parte degli osservatori e dei responsabili delle politiche interne in seno al Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. Ma non è così. L’ostilità verso gli Zingari e tutti i gruppi etnici minoritari è da sempre uno dei fattori negativi del sentimento nazionale di molti popoli verso gli ‘altri’, spesso accompagnato da fenomeni xenofobi, in ragione di un’avversione storica, mai venuta meno, verso tutti coloro che sono al di fuori dell’economia comunitaria.
Divergenza questa solo di opinione, che ha spinto molti governi a condannare lo stile di vita nomade come un anacronismo dal quale le vittime devono essere liberate e obbligate a diventare sedentarie: vale a dire “a mettersi al passo, culturalmente e socialmente, con il resto dell’umanità”. E ciò, non perché i suoi componenti ‘nomadi’ siano più primitivi dei sedentarizzati, o perché conducono un tenore di vita più semplice dal punto di vista materiale, il che è facilmente riscontrabile, bensì perché rimasti bloccati in una condizione di arretratezza inaccettabile, dalla quale il resto dell’umanità è ormai uscita da tempo.
È vero, non c’è nobiltà nell’ignoranza come nella povertà o nella malattia, eppure quelle genti così ‘irrazionali’ e forse superstiziose, hanno avuto la consapevolezza di appartenere a questo smisurato universo che noi, esseri razionali, probabilmente non conosceremo mai, e lo hanno fatto con grande dignità. Vi sono tuttavia dei cambiamenti che lasciano intravedere un cammino verso una presa di coscienza diffusa, sul piano sociale e politico che, nel corso degli ultimi anni si è andata delineando, e che ha visto la nascita di forme associative e di movimenti di portata internazionale a sostegno della ‘causa zingara’, a favore del riconoscimento e a tutela della loro cultura.
Scrive Sergio Franzese (18) lanciando un appello dalle pagine di Internet: “Tutti noi, siamo chiamati a difendere il diritto alla diversità che, nel caso degli Zingari, costituisce forse l’ultima sfida a un modello di vita abbarbicata alla speculazione ed al cemento. Il loro futuro dipende da noi; essi continueranno ad esistere nella misura in cui la nostra società saprà rispondere ai loro problemi ed alle loro aspirazioni”.
Esiste in proposito, un’ampia documentazione inerente alla volontà di risolvere quella che più comunemente è chiamata la ‘vicenda zingara’, a cominciare dall’UNESCO impegnato nel dare un’istruzione scolastica ai bambini zingari, il cui diritto è sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; seguono la Comunità Europea con fondi destinati specificamente agli Zingari nel quadro delle iniziative contro la povertà; e, ovviamente, Amnesty International che si esprime in difesa dei diritti dei nomadi. Tuttavia, fin qui, tutte le iniziative prese sembra abbiano portato a favorire una loro crescita culturale o ha portato a un loro stile di vita socialmente accettabile, perché risulta sbagliato il principio di fondo.
Non è nel voler integrarli in strutture a loro non confacenti, farne dei sedentarizzati umiliati o cancellare la loro cultura, di cui tra l’altro vanno orgogliosi, che si può risolvere il problema; bensì lasciare loro la possibilità di attraversare le frontiere, ricavare dal suolo quello di cui hanno bisogno, e pretendere dalle società industrializzate di provvedere, secondo le possibilità, al loro sostentamento. Questo, in funzione del fatto che ogni cultura, anche la più miserrima che va perduta, rappresenta una perdita di una parte grandiosa della cultura dell’umanità, e questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Non ci preoccupiamo forse della sopravvivenza delle specie animali e vegetali, delle quali abbiamo già perso una gran parte? Con esse, va detto, abbiamo perso una gran parte della conoscenza universale. Si pensi allo sterminio dei pellerossa negli States, degli aborigeni Australiani, degli indios dell’Amazzonia, dei pigmei in Africa e quant’altri di cui non sapremo mai della loro esistenza.
Di fatto, è una perdita di gran parte della nostra stessa conservazione. Va qui ricordato che non c’è cosa peggiore che dismettere la cultura della sopravvivenza delle specie, siano esse umane, animali che vegetali, e ben presto noi stessi saremo avviati verso l’annientamento definitivo. Anche per questo i nomadi, sfavoriti o perseguitati – scrive Arthur R. Ivatts (19): “..sono l’unica minoranza che, a nessun livello, è riuscita a farsi rappresentare da se stessa. Per far ascoltare la propria voce i nomadi continuano ad esprimersi attraverso gli altri”, e questo non è giusto, non può continuare così, vanno in qualche modo riconosciuti come entità etnica all’interno del conglomerato umano.
La situazione si presenta oggi, per certi versi, diversa, o almeno lo è in parte; non vengono emanati editti, non si ricorre alla deportazione in massa, non vengono mandati a colonizzare terre aride e paludose, anche se nel Giorno dell’Olocausto, qualcuno dovrebbe ricordare il massacro perpetrato dai nazisti di circa un milione di Zingari: “ma tutto questo non è che un atroce ricordo del passato, dobbiamo guardare al futuro, a quel futuro che è già oggi” – scrive Vanko Rouda (20).
Va qui ricordato che nel 1981 il Consiglio d’Europa di Strasburgo si è interessato delle questioni del ‘popolo viaggiatore’ (per non usare l’appellativo di nomade) ed ha invitato i Governi della CEE a riconoscere gli Zingari quale ‘minoranza etnica’ e al “..dovuto rispetto della loro cultura e della loro lingua”. Ma è solo dal 1989 che il Consiglio d’Europa ha adottato la suddetta risoluzione. Ce ne da notizia Bruno Crimi (21) nel suo articolo apparso in “Panorama”, Luglio 1990: “...nel preambolo si afferma che la cultura e la lingua degli Zingari fanno parte, da oltre 500 anni, del patrimonio linguistico e culturale della Comunità Europea”, sebbene non venga in seguito specificato cosa s’intende per ‘cultura degli Zingari’.
Secondo Jean-Pierre Liegeois Ligny (22), professore all’Università Descartes di parigi e responsabile del Centro di Ricerca sugli Zigani: “Questa dichiarazione è un passo in avanti verso il riconoscimento e il rispetto di comunità culturali che non hanno alcun riferimento territoriale e che ancora oggi vengono respinte, perché considerate marginali”.
Come sottolinea Rita Capponi (23), segretaria nazionale dell’Opera Nomadi: “È un piccolo fatto straordinario di cui tutti dovremmo tener conto. Le testimonianze fin qui raccolte hanno dimostrato questa tesi. oggi sappiamo che il nomadismo sviluppatosi a beneficio dell’intera umanità non può essere ricondotto alla sedentarizzazione come allo ‘stadio finale’ del suo sviluppo. Bensì considerato più vicino allo stadio contingente della ‘sopravvivenza’.”
Le premesse non nascondono la necessità di approntare un tavolo di dialogo per una convivenza ormai necessaria in cui si pone l’urgente problema della sopravvivenza e dell’integrità della cultura del popolo Rom. Numerose fondazioni e organizzazioni umanitarie hanno di recente finalizzato una coscienza comune in confronto dei popoli minoritari, ma non risulta si adoperino al recupero della identità etnica degli Zingari, o siano impegnate a riconoscere agli Zingari una qualche forma di ‘nazionalità’ a se stante, universalmente accettata. Una petizione a questo scopo è stata inoltrata alle Nazioni Unite.
Delegati di ventisei paesi si sono dati convegno a Pregny, in Svizzera, in rappresentanza di tutte le ‘tribù’ nomadi del mondo che, Marco Sorteni (24) dice essere stato: “Un Congresso apparentemente come tutti gli altri, signori in giacca e cravatta, mozioni, contromozioni, cabine per la traduzione simultanea, osservatori di organismi internazionali. Scopo del Congresso, quello di interrompere una tradizione di incomunicabilità, creando attraverso un comitato internazionale un interlocutore tra il mondo dei gadjé e le strutture rappresentative che questa società si è data e quello senza patria degli Zingari. I congressisti hanno infine decretato di riconoscersi come un unico popolo sotto la denominazione di Rom, accomunato sotto un’unica bandiera di colore verde e blu, i colori del cielo e della terra su cui campeggia una ruota di carro, simbolo degli Zingari erranti su tutta la terra”.
Che significa allora essere Zingari?
Sappiamo come gli Zingari per procacciarsi di che vivere si sono adattati ai diversi mestieri nel corso delle loro migrazioni. Oggi, il mondo industriale ha tolto loro ogni possibilità di reddito da lavoro manuale ‘artigianale’ ch’erano per gli Zingari fonte di sostentamento eccezionale. Ridotti pressoché in miseria, dediti all’accattonaggio, schiavi della società ‘avanzata’ che li affama e li priva della libertà di spostarsi da un luogo all’altro lungo le tappe di quel nomadismo di cui non riconoscono più neppure i sentieri. Tuttavia non si sentono affatto umiliati e si dicono fiduciosi “nel rivisitare il mito di una società primordiale a ricchezza comunitaria”. Che abbiano ragione loro?
Gli Zingari, a differenza dei gadjé sono semplicemente felici d’essere quelli che sono, oppure? La domanda è ovviamente tendenziosa. Gli Zingari hanno un certo sprezzo per i non-zingari, pari o forse maggiore dell’avversione che hanno sempre incontrato da parte nostra. Sebbene la loro venga considerata dai più una libera scelta, volutamente in contrasto con la nostra. Noi gadjé sappiamo di essere succubi di una compromissione sociale che abbiamo ereditato dal passato e non dovremmo prendercela se gli Zingari, a loro volta, provano commiserazione per quanti hanno avuto la disgrazia di non essere Zingari, o siano stati privati della loro libertà.
Dice ancora Vanko Rouda (25): “Non si può separare il popolo zingaro da tutto il suo accompagnamento magico che rappresenta il suo essere diverso, insieme a tutto l’orpello delle sue manifestazioni esteriori. Si deve tenere anche in conto lo scetticismo, la saggezza, la profondità dei pensieri di questo popolo, forse il più antico del mondo, la cui storia non si racconta attraverso secoli ma attraverso i millenni. Lo zingaro accetta il ritorno ‘cosmico’ alla natura; accetta il dono della sua energia affinché essa rinasca in altre forme. C’è in questa sottomissione il principio del fatalismo zingaro che si libra all’amabile carezza della natura seduttrice e materna. Da sempre egli dorme sul seno della natura disdegnando le cose passeggere e le debolezze umane, la saggezza zingara si attacca solo al perdurare di questa natura, avendo egli visto tutto, certo che sarebbe follia voler arrestare il suo corso, lo scorrere del tempo e della vita”.
E noi, chi siamo noi?
Se, da una parte, il benessere attrae tutti e alcuni zingari hanno optato per la vita dei gadjé, avere una casa solida sopra la testa o sostituito il carro coperto di stracci con moderne roulotte dotate di tutti i confort, dall’altra, il nomadismo caratterizza ancora un po’ tutti quanti, indistintamente Zingari e gadjé. Oggi, nell’era dei facili trasporti siamo tutti un po’ nomadi e forse anche un poco Zingari; vuoi per ragioni di lavoro, spostandoci da un capo all’altro della città, quando non addirittura di città in città o di paese geografico; vuoi per ragioni di svago per cui optare di attraversare gli oceani e i continenti.
La globalizzazione tutt’ora in atto ha reso necessari una patente di guida internazionale, il saper leggere le indicazioni urbanistiche metropolitane nelle diverse lingue diverse dalla nostra, e ha fatto in modo che cambiassimo le nostre abitudini, la nostra alfabetizzazione come condizione necessaria per farci riconoscere, per commercializzare i nostri prodotti, esportare all’estero la nostra cultura e la nostra arte. Quanto resterà di noi, di ciò che eravamo all’origine, della nostra società, se non salvaguardiamo l‘umanità cui pure apparteniamo?
Cosa significa, al dunque, essere Zingari?
Ed ecco che la domanda che c’eravamo posta all’inizio non richiede più alcuna risposta, ormai. Tuttavia l’interrogativo resta e con esso l’ulteriore dubbio: che sia questo il segreto essere della loro eterna giovinezza? Non ci rimane che affidare i nostri passi al vento, nella speranza di incontrare zingari felici a mostrarci il senso, la vita migliore cui affidare i nostri passi e incamminarci con essi là, dove le rondini vanno. Poi si seguono le nuvole, le ruote del carro, assieme con le donne e i bambini, le tende, gli attrezzi, fin dove...
Oh, per andare dove? Non ha importanza ormai. Ovunque ci sia un pascolo, ovunque ci sia un fuoco, avendo per compagna la luna, per amiche le stelle, per tetto il cielo. È così che infine, l’inizio coincide con l’inizio del viaggio, l’Uno con il Tutto, nel ciclo dell’eterno ritorno.
“Se non sai,
siediti tranquillo
e fissa intensamente il fuoco.”
(proverbio zingaro)
Note:
(1) da “Lunes Nomades” di Sandra Jayat, tradotte da Fulvia Alemanno.
(2) Adriano Colocci, “Gli Zingari. Storia di un popolo errante”, Arnaldo Forni Ed. Ristampa anastatica dell’edizione di Torino, 1889.
(3) Françoise Cozannet, “Mythes t coutumes religieuses des tzigannes », Payot, Paris 1973
(4) Antonio Tabucchi, “Gli Zingari e il Rinascimento”, Feltrinelli, Milano 1973
(5) Paulo Cohelo, “Il cammino di Santiago”, Bompiani, Milano 2001
(6) Vanko Rouda (intervista), in “La Voix Mondiale Tzigane”, Parigi s.i.d.
(7) Petru Radita (intervista), in “La Voix Mondiale Tzigane”, Parigi s.i.d.
(8) Marcella Uffreduzzi, “Canti zigani”, Sabatelli Ed., genova 1973.
(9) Derek Tipler (intervista), in “Lacio Drom”, Roma s.i.d.
(10) Federico Rasetschnig, “Usi e costumi degli Zingari” Ed. Mediterranee, Roma 1965.
(11) Giulio Soravia (intervista), in “Dialetti degli Zingari Italiani”, Pisa 1977
(12) Petru Radita (intervista), op. cit.
(13) Vanko Rouda (intervista), op. cit.
(14) Derek Tipler (intervista), op. cit.
(15) Marcella Uffreduzzi, op. cit.
(16) Sir Edward Evans-Pritchard, in “I popoli della Terra”, vol.1, Mondadori, Milano 1974
(17) Arnold Toynbee, “Incontro e mescolanza di razze”, in “I popoli della Terra” op. cit.
(18) Sergio Franzese, “O Vurdon”, (articolo) – www.geocities.com
(19) Arthur R. Ivatts, “Istruire gli Zingari” (articolo) in “Il Corriere Unesco”, Novembre 1974
(20) Vanko Rouda (intervista), op. cit.
(21) Bruno Crimi, « Arrivederci Rom » (articolo) in Panorama, Luglio 1990
(22) Jean-Pierre Liegeois Ligny, (articolo) in Bruno Crimi, op. cit.
(23) Rita Capponi, (intervista), in Opera Nomadi, Roma.
(24) Marco Sorteni, “Gitani di tutto il mondo unitevi”, (articolo), in “L’Europeo”, Marzo 1990
(25) Vanko Rouda (intervista), op. cit.
*
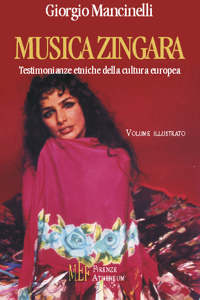 - Musica
- Musica
Etnomusica 9: Sulla strada degli Zingari - 1 parte
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Presentare un popolo diverso dal nostro è sempre un azzardo per cui si azzarda di dare una definizione a dir poco avventata, nel rischio di vedere solo ciò che vogliamo vedere o, quantomeno, di imporre la nostra gerarchia di valori, di misurare e valutare una determinata cultura coi nostri mezzi e i nostri criteri di valutazione di quelle che sono le diverse ‘categorie mentali’, pretendendo di giudicare chi non la pensa come noi, con mezzi non idonei a sindacare l’operato degli altri. Ancor più pretendendo di giudicare chi è ‘diverso’ da noi, vuoi per colore della pelle, razza e quant’altro riferito alle proprie scelte religiose o tribali, totemiche o sessuali, come qualcuno inferiore a noi o, non idoneo di far parte della specie umana in cui tutti, nessuno escluso, dobbiamo infine riconoscerci.
Non a caso la popolazione ‘zingara’, di cui ci occupiamo in questa ricerca, presenta una fisionomia sicuramente umana, seppure oscura ed enigmatica fin dall’origine. Nessuna altra etnia umana è così sparsa sulla faccia della terra come la loro, eccetto forse, quella ebraica, da cui pur differisce, ne più ne meno, come da quella egizia, con la quale, in epoche diverse è stata spesso confusa. Che si chiamino Zingari o Zingani, Gitani o Gipsy, Sinti o Manusci, Lautari o Bohemien, ogni specifico gruppo nomade da sempre fa riferimento a “Rom”, nome che essi stessi si sono dati e che sta per ‘uomo libero’. Un appellativo questo di cui vanno fieri e che sempre affrontano con dignità anche davanti alle difficoltà che la nostra società ‘acculturata’ impone loro relegandoli alla più estrema disconoscenza umana.
Conforme a un ‘percorso itinerante’ sulle rotte di un nomadismo millenario di cui tutt’oggi non si conoscono appieno i confini, la ‘storia’ del popolo zingaro, come ogni etnia di cultura orale non ascrivibile a un’unica area geografica, si basa su ipotesi scarsamente attendibili e quanto meno di autentiche certezze. Diversamente da quanto si pensa, l’esistenza di una ‘cultura’ tipica degli Zingari, o perlomeno di una cultura che presenti caratteristiche comuni a tutti i gruppi conosciuti nell’arco geografico ove si sono ormai ‘sedenterizzati’ o, in cui continuano a ‘spostarsi’, rappresenta uno dei problemi irrisolti di grande interesse etnologico. Negli ultimi tempi, soprattutto in seguito alla presa di coscienza di ricercatori attenti, si è giunti a riconoscere agli Zingari alcune prerogative che in passato erano confutate loro, tra le quali, ad esempio, quella riferita alla lingua ‘romani’ della quale non si conosce la sillabazione né la forma grammaticale, e tramandata oralmente mediante il semplice mezzo mnemonico.
Un’altra peculiarità è la loro ‘cultura’ prevalentemente atipica, la cui adattabilità alle culture ‘altre’, scritte od orali che siano, ha permesso loro di conservare espressioni ‘rituali’ e ‘nomi propri’, rivelatesi inscindibili dalla ‘cultura zingara’ di riferimento. Ma se da una parte è difficile stabilire cosa gli Zingari abbiano smarrito, o meglio, abbandonato della propria cultura, nelle molte ‘altre’ visitate o soltanto frequentate nel corso delle millenarie peregrinazioni lungo le strade del mondo, ancor meno è possibile quantificare l’entità di ciò che hanno assimilato. Studi in proposito, in special modo quelli di riferimento etnologico, hanno rivelato l’esistenza di una cultura ‘tipicamente zingara’ da non confondere con quella di altri gruppi etnici stanziali dell’area indo-europea.
Pur riconoscendo alla cultura zingara di aver trovato in Europa un terreno fertile per affondare le proprie radici, permettendole, a un tempo, una naturale simbiosi culturale, il fenomeno antropologico della loro esistenza sul territorio si offre come piattaforma particolarmente interessante per affrontare il problema della legittimazione etnica all’interno dell’intero agglomerato umano, rappresentato dalle culture ‘altre’ con le quali gli Zingari sono messi costantemente a confronto. Nel caso specifico di questa ricerca conseguita ‘sul campo’, dapprima dal Gruppo Arca diretto da Angela Maria Tettamanti per conto dell’Università Bocconi di Milano, e successivamente da chi scrive, per la parte relativa alla ‘musica comparata’, va qui posto in oggetto il lungo lavoro svolto per la RAI, da cui il libro/reportage “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” stampato per i titoli di Firenze Atheneum e vincitore del Premio letterario “L’Autore” per la Saggistica nel 2006, dal quale sono tratte alcune delle seguenti parti.
Premessa.
“... ho incontrato anche Zingari felici.”
Ma perché gli Zingari?
Perché ovunque mi sia recato, negli innumerevoli luoghi del mio viaggiare, ho incontrato gli Zingari davanti a me, che mi avevano preceduto o che facevano ritorno da una qualche terra, sempre più lontana e sempre più vaga, che avrei voluto conoscere, e della quale – cosa meravigliosa e misteriosa insieme - portavano il ricordo: la tangibile testimonianza di una cultura arcana ed enigmatica che non conosceva né dove, né quando, né come, e che pure continuava in me a suscitare un certo interesse. O forse soltanto per la curiosità di comprendere come, ancora oggi, agli albori di questo terzo millennio e soprattutto nell’attuale società super comunicativa ed eccessivamente informata quale è la nostra, la loro lingua si presenti verosimilmente riconducibile a un popolo senza scrittura che, al tempo stesso, è potuta sopravvivere. E come, pur venendo essa, a contatto costante con realtà socio-culturali fortemente dominanti, quali quelle europee, capaci di annientarne i contenuti e cancellarne finanche il ricordo, abbia potuto conservare la sua autenticità.
Compresi ben presto che il mio compito sarebbe stato quello di affrontare una lunga strada verso l’ignoto, al seguito “di una percezione intuitiva che..” per dirlo con i termini di C. G. Jung: “..non poteva, allora, né essere compresa in modo migliore, né essere espressa in modo diverso”. Tuttavia, intenzionato a dare un senso a una sfida che fin dall’inizio si presentava ardua oltre ogni considerazione, mi sono spinto lontano nel tempo e nello spazio, superando le barriere imposte dalle difficoltà linguistiche, in un vocabolario fatto di forse e di perché, dove niente o quasi era detto in modo definitivo, in una ricerca dove nulla o quasi avrebbe avuto la tangibile perspicacia del ‘dunque’.Sfida che mi ha permesso, infine, di aprirmi alla conoscenza di una cultura antichissima, prima a me del tutto sconosciuta e che, a un certo punto, ho sentito affiorare come un’eco che risuonava attraverso il ‘suono del tempo’ per essere comunicata ad altre conoscenze – quasi che la sua voce, ancor viva, fosse strumento di mediazione tra il caos originario delle emozioni e il linguaggio articolato dell’intelletto.
Un ‘suono’ in cui, ancor prima di essere musica, si riaffacciava l’eco di sedimentazioni sonore avvenute agli albori dell’esistenza umana, ancor prima forse dell’avvento delle culture primitive, per effetto di sovrapposizioni e interazioni maturate nel corso di contatti prolungati lungo il corso dei millenni. Quello stesso ‘suono’ che Charles Darwin ipotizzava si fosse sviluppato successivamente nel linguaggio della musica dalle vocalizzazioni dei “primati subumani” che funzionavano come segnali emotivi, per cui “..prima di essere colto sfugge costantemente e insieme sfida a essere decifrato”. Lo stesso ‘suono primordiale’ che Eduard Hanslick dice “non avere modelli in natura e non esprimere alcun contenuto concettuale”, e che forse, in origine, anche il nostro spirito era capace di comprendere e che poté tornare a comprendere, per quella sorta di rinnovamento che la natura è solita imporre all’uomo come ritmo del tempo della vita.
Certo, l’idea di un ‘suono’ che percorresse l’intera esistenza di un popolo distribuito sulla quasi totalità della faccia della terra, poteva anche avere un senso, a patto però che quel popolo si riconoscesse in esso, cioè in quella musica che il ‘tempo’ – preso in senso ciclico – aveva verosimilmente impresso in modo virtuosistico e geniale nella sua gente. Era indubbiamente un argomentazione che avvalorava la mia tesi, pensai. Pur tuttavia, ero convinto che non l’avrei dovuta considerare come punto di arrivo o giustificazione per una ricerca che si delineava interattiva, vuoi per la complessità degli innesti, vuoi per la stratificazione delle contaminazioni, bensì alla stregua di ‘ponte’ tra passato e presente, malgrado quest’ultime, intese in senso di interscambio acculturato, togliessero spessore alla sfida che mi ero proposto di affrontare.
Mi ritrovai così a percorrere strade scoscese e discontinue che non portavano da nessuna parte per la mancanza di quel ‘carattere etnico’ che pure è riscontrabile nella tipologia di tutti gli agglomerati umani e che pensavo mi avrebbe in qualche modo aiutato a distinguere la ‘singola’ cultura zingara dalle altre. Non fu così: non riuscivo a trovare un’argomentazione che avesse una specifica valenza ‘etnica’ riconducibile ad essi – quasi gli Zingari non fossero mai esistiti e continuassero a non esistere ancora oggi. Il fatto era dovuto soprattutto alla carenza delle informazioni relative ai ‘rapporti storici’ che, necessariamente, essi dovevano aver avuto con le numerose ‘genti’ che avevano incontrate o che abitavano le aree geografiche prima di loro, e che li avevano visti nomadi quando già l’insieme delle loro culture formava la futura conoscenza dell’Europa delle Nazioni.
Ero consapevole del fatto che conoscerli più da vicino sarebbe stato l’avvio necessario per meglio comprendere la loro cultura orale. Fu così che “andando imparai dove dovevo andare”, per così dire incontro a quanti di essi avrei incontrato lungo la strada: un numero imprecisato di genti diverse, autoctone e transeunte, nomadi e sedentarizzate che mi avrebbero accompagnato nel viaggio, con l’apparente semplicità dei loro racconti orali e dei frutti ‘acerbi’ del loro nostalgico poetare. Ancor più, attraverso le loro canzoni e i suoni che essi sapevano ricavare da ogni strumento, qualunque esso fosse, con innato virtuosismo; come pure dal ritmico frenetico delle loro danze, seducenti e arcane che eseguivano davanti ai fuochi accesi negli accampamenti e che, ai miei occhi, sembravano evocare un misticismo segreto, le cui radici si perdevano nelle profondità oscure dei tempi. Fino al raggiungimento di quel ‘suono del tempo’, nucleo indivisibile eppure ampiamente condiviso, cui agognavo in questa mia ricerca.
Al fine di fornire un riconoscimento non solo alle nazioni ma anche alle etnie che le compongono e, conseguentemente, a ogni singola cultura espressiva, anche la più povera, e salvaguardarla dall’essere dimenticata, o peggio definitivamente cancellata, mi sono trovato ad affiancare il Gruppo Arca di Milano nel quadro di una ricerca sulla comunicazione di base, che questi aveva intrapreso già dal 1978 con lo scopo specifico di approfondire il rapporto esistente fra le diverse culture nomadi e la cultura egemone, sfociato poi nella pubblicazione in tre volumi illustrati di un ampio panorama della cultura zingara: “La mano allo zingaro” (1978), “Arte nomade” (1980), e “Gli ultimi nomadi” (1982), per i titoli della IGIS edizioni. Fu così che grazie alle personali esperienze acquisite ‘sul campo’ fra le comunità ROM presenti nel Lazio e in Lombardia, che apportarono alla mia cultura socialmente ‘civilizzata’ non poche sollecitazioni e ripensamenti illuminanti, ho potuto infine approntare la mia personale ricerca etnomusicologica.
Fu però importante per me valutare l’idea originaria che ha poi dato il titolo alla mia ricerca, quel: “Testimonianze etniche della cultura europea” che, in qualche modo anticipava quanto detto da Bruno Crimi “..di essere gli Zingari – a modo loro – i precursori dell’unità europea, nel senso che per primi hanno abolito le frontiere”, e che mi ha permesso in seguito di approfondire i contenuti con studi specifici di altri autori, per lo più apparsi in sporadiche e pressoché introvabili pubblicazioni, che in qualche caso si sono rivelati utili ed eloquenti. In un primo momento pensai che lo studio degli effetti del ‘nomadismo’ in Europa e, più in generale, nell’area asiatica, mi avrebbe consentito di analizzare e comprendere l’arcano delle loro origini ma, ben presto, dovetti ricredermi, poiché constatai di essere soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga trafila di studiosi e ricercatori che avevano tentato di svelare il ‘mistero’ delle loro origini, destinato ahimè a rimanere tale.
Sebbene il nomadismo, fin dalla prima apparizione degli Zingari sul continente europeo, fosse alla base della loro condizione strutturale, e che avessero sviluppato su di esso il solido attaccamento che regola tutta la loro esistenza, la scelta degli esempi e dei testi acclusi nella pubblicazione sopra citata, prese spunto da più approfondite conoscenze interpersonali di Zingari incontrati sulla strada, e da testimonianze raccolte durante il lavoro di ricerca che, non in ultimo, mi hanno permesso di dare maggiore spessore al mio enunciato. Poiché era mio specifico interesse conoscere come gli Zingari si ponevano di fronte alla storia ‘altra’ dalla loro, com’erano riusciti a preservare il carattere ‘ancestrale’ e la sacralità dei loro ‘miti’ e delle loro usanze, ho iniziato con il raccogliere quelli che erano i frammenti di una cultura solo apparentemente dispersa ma, che pure, ‘sentivo’, tendere ad affermare la propria autenticità all’interno della propria esistenza.
In seguito mi sono affidato alle testimonianze storiche documentate, assai poche in verità, ed a quei testi orali, trascritti solo in piccola parte, che presentavano un più specifico interesse storico-letterario o riferito a una qualche forma di religiosità. La lettura di brevi opere letterarie scritte in forma lirica infine, e in particolare di testi di canzoni, diede luogo a quella che ancora oggi ritengo fosse la prima intuizione del ricercatore, mi ha permesso di creare una cornice musicale al discorso ‘esistenziale’ sui ROM; quello stesso che, man mano e, in assoluta autonomia, si è andato delineando dalla musicalità atipica dei testi, così vicina a quella musicalità che il noto compositore Richard Strauss, aveva a sua volta riscontrato in musica, come in poesia e che: “..desta sentimenti che premono verso la parola e nella parola vive un anelito che tende verso il suono e la musica”.
Sulla spinta di questa affermazione ho quindi iniziato col raccogliere quelle esperienze che, a mio parere, più di altre risultavano formative di una possibile “cultura musicale” zingara, quindi partendo dal presupposto della sua esistenza, o meglio, della sua sopravvivenza in molta della musica non solo europea. Quella stessa che Gino castaldo, con lucida intuizione, includeva nella cosiddetta “musica globale” che più trovava affermazione nel mondo: “Una musica che non ha alcuna cittadinanza, ricca di mille suoni, strutture e atmosfere differenti; in cui echi africani, melodie europee, ritmi balcanici, elettricità rock americana, suoni asiatici, sono fusi insieme in brani che non hanno passaporto, che non vogliono né conoscono confini e che hanno mille radici ma nessuna appartenenza”.
Nel voler sostenere il primo autentico riconoscimento della ‘cultura zingara’ all’interno del processo di formazione della coscienza europea, si è reso fin dall’inizio necessario fare determinate scelte, onde evitare di calcare la mano sugli aspetti dalla connotazione negativa, benché ve ne siano, e di proposito, prefigurare nuovi scenari culturali e artistici, consoni a una società sempre più multietnica, multilinguistica e multimediale quale si prefigura sarà – è ormai nella coscienza di tutti – la società prossima futura. È così che mi sono inoltrato nell’ascolto di centinaia registrazioni su nastro e incisioni fonografiche raccolte in gran parte del mondo: India, Medio Oriente, bacino Mediterraneo e, soprattutto, nel cuore dell’Europa centrale, fino ai Balcani e alla Russia, nell’affannosa ricerca di quanto gli Zingari avevano raccolto e lasciato nelle culture che l’avevano ospitati e che - per dare alito alla premonizione di Ernesto Assante – “...anticipavano quello che il mondo potrebbe o dovrebbe essere, e forse sarò, ovvero una straordinaria comunità nella quale culture differenti sapranno non solo stare insieme, ma dar vita ad ulteriori culture”.
Una società multiculturale dunque, nella quale far confluire a pieno titolo quella che fin d’ora con rispetto chiameremo “cultura zingara” che si avvale di una tradizione orale rigorosamente tramandata per generazioni seguendo metodi iniziatici che hanno talvolta del ‘soprannaturale’ e che, si esprime con manifestazioni non dissimili da quelle riconosciute ad altri popoli, e per lo più rintracciabili in quelle che sono da considerarsi autentiche manifestazioni dell’esistenza umana, e che vanno dal tramandare propri usi e costumi; conservare una ritualità specifica all’interno della propria religiosità; indossare vesti multicolori e gioielli per adornarsi secondo un proprio gusto estetico; possedere una propria cucina ‘tipica’; fare uso di utensili e praticare alcuni fra i mestieri più antichi del mondo e, non in ultimo, utilizzare strumenti musicali per l’accompagnamento di canti e danze, così come, esprime particolare gioia in occasione delle festività.
Pur tuttavia, di là da ogni stereotipo e da implicazioni politico-sociali, va qui tenuta presente una realtà – fondamentale in questa ricerca – cui non possiamo restare indifferenti, e cioè che si continua a considerare gli Zingari dentro l’emarginazione sociale, alla stregua della mortificazione, maltrattati contro ogni logica, rifiutati e appellati, ancora oggi, come ‘maledetti’. Il che è rivelatore di diffidenze celate e rancori antichi mai venuti meno. Al contrario, penso, che un piccolo passo in avanti nel pur difficile corso della ‘comprensione’ vada fatto. Sono convinto più che mai di dover dare voce alle ‘diversità’ culturali, al pari delle altre grandi culture, al fine di pervenire alla reciproca quanto auspicabile umana ‘accettazione’ di tutte le minoranze etniche identificabili.
Coloro i quali credono in una categoria umana coerente, pur dissimile da ogni altra per sua natura, accordano con ciò anche agli Zingari il privilegio e il riconoscimento di una ‘civiltà’ che gli è propria, e che si incarna in quelle che sono le sue caratteristiche più originali. Come appunto deve considerato il nomadismo, attraverso il quale si pongono in evidenza gli aspetti tipici del vivere zingaro e, con ciò, il loro modo di essere “diversi nella diversità”, ancor più dotati di una cultura originale che gli è propria, se confrontata con le altre culture esistenti e altrimenti considerate ‘primitive’. Un riconoscimento in tal senso che li riscatta definitivamente dal ‘non esistere’ come agglomerato umano, restituendo loro quella identità che gli Zingari rivendicano quale espressione ‘reale’ e ‘simbolica’ che in larga misura consente loro di rimanere se stessi: i soli protagonisti della propria storia.
Ma qual è la vera musica degli Zingari?
In accordo con quanto affermato da Augusto Romano: “..non vi sono società cui il fenomeno musicale sia sconosciuto”. Onde per cui la ricerca qui approntata sulla ‘musica zingara’ ha significato di scavare nell’apparente semplicità multiculturale, rintracciare gli aspetti ‘tipici’ accomunanti, avvalendomi della ormai indiscussa universalità della musica. Universalità qui usata in una prospettiva diversa che si avvale di tante discipline e di nessuna in particolare ma che trova ampia conferma in quanto affermato da Hegel, secondo cui: “..la musica prende le mosse dalle interazioni” ed evolve dalla sua esistenza di voce dell’emozione alla condizione di arte “in forza dalla sua aggregazione”.
Se condividiamo la definizione di Hegel ci sembra quasi che l’esistenza della ‘musica zingara’ sia tale solo in funzione del processo di commistione con le altre culture. Cioè equivale ad ammettere che non si conosce una musica zingara autonoma se non quella che possiamo ascoltare in ambito ‘tradizionale’ di altre culture, entrata oggi, sebbene con qualche forzatura, nel panorama della musica globale. Ma non è così. Pur dovendo ammettere di essermi trovato alle prese con una tradizione orale molto frammentaria e apparentemente senza possibilità di recupero, che pur andava rintracciata all’interno di un’area culturale molto vasta fino ad essere estesa ai cinque continenti, posso qui affermare non solo della sua esistenza, ma anche di una sua essenziale originalità, la cui fonte è pressoché sconosciuta talvolta agli stessi Zingari.
Frutto di un’intuizione prevalentemente musicologica, questa ricerca tenta di configurare un ‘corpus musicale’ nascosto, in parte occultato da coloro che ne sono i fautori, che risulta in qualche caso atipico ma altrettanto vitale, capace ancora di sorprenderci. Come sosteneva Claude Lévi - Strauss: “Fra tutti i linguaggi la musica riunisce i caratteri contraddittori d’essere a un tempo intellegibile e intraducibile, giacché il suo privilegio consiste nel saper dire quello che non può essere detto in nessun altro modo”. È come ammettere che la musica altro non sia che la “metafora musicale” di se stessa e che, lo ‘spirito’ che anima l’ ‘ars-musicandi’ sia solo un diverso genere di musica: “..le cui strutture sonore – per dirla con Cristina Cano – non sono inventariabili in un vocabolario, per cui la musica si presenta come un linguaggio aconcettuale”. All’interno del quale, come rivelato da Ida Magli: “...anche la musica si esprime in una forma di tempo senza tempo, che non comincia e non finisce, e che per ciò è una musica non musica”.
Linguaggio che noi possiamo più facilmente intendere se recuperiamo il suo significato originario di ‘suono del tempo’ che si fa metafora di quell’ ‘assoluto naturale’ che è poi la musica elargita all’uomo nell’età dell’oro. Cioè, quando uomo e natura non erano ancora scissi e si trovavano in armonia e che, rievoca il tempo della perfezione originaria. Perfezione che “..può essere recuperata solo in condizioni eccezionali, quando il nefasto incantesimo che ha dato luogo alla separazione dell’uomo dalla natura si rompe” e ci permette di cogliere i ‘suoni naturali’ che sono ‘vivi’ dentro e fuori di noi. Poiché, come affermato da Károly Kerényi: “..una cosa viva non può essere conosciuta che in stato vivo, in cui si evidenzia una immediata commozione”.
Lontano da questa possibilità ho qui cercato di trasmettere quelle che sono le mie esperienze nell’ambito di una più ampia conoscenza culturale estesa alla musica e a quello che essa rappresenta oggi in Europa, in cui l’arrivo sempre più numeroso di immigrati extraeuropei sta dando avvio a una complessa forma di interazione culturale, anche in senso propriamente musicale, che deve essere ancora valutata, quantomeno nelle sue strutture di linguaggio sonoro, non del tutto assorbito nella sua originale autenticità. Linguaggio che, in qualche modo, ho usato per indicare quelle che sono le linee di questa ricerca basata sull’impronta delle ‘varianti’ strutturali all’immaginazione cui C. G. Jung ha dato nome di “archetipi”.
In questo contesto, altro sarebbe un approccio ‘diretto’ con la letteratura zingara, alfine di trovare quella che è la sua funzione primaria di ‘testimonianza viva’ dell’estro spontaneo di una certa parte ‘sconosciuta’ della creatività umana; così come lo sarebbe l’ascolto diretto della musica originale o, quantomeno, quella eseguita da autentici gruppi zingari, e che faciliterebbe quel ‘processo di riconoscimento’, all’interno delle pur diverse culture qui investigate, e che darebbe indubbiamente i suoi frutti. Vuoi per l’aprirsi di un nuovo fronte di conoscenza comprensivo di quella espressività popolare che è alla base della primitiva cultura del mondo; vuoi perché permetterebbe l’accesso allo straordinario ‘virtuosismo’ di cui la ‘musica zingara’ sembra pervasa.
Se, come si è detto, la musica non è un genere ma una condizione dello spirito, quanto raccolto nelle pagine di questa ‘premessa’, tuttavia, non la fa riecheggiare in noi, per cui l’ascolto ‘dal vivo’ dissolverebbe ogni dubbio lecito. In accordo con Augusto Romano: “..se ne può parlare solo nel modo tecnico che, per così dire, circonda l’ascolto tuttavia senza farne parte, (..) per cui, parlare della musica è solo un modo per convincerci che esiste”. A voler trarne una conclusione e, allo scopo di ampliare una più diretta conoscenza della materia trattata, fornisco qui di seguito una cospicua discografia, purtroppo di non facile reperimento, che aspetta solo di essere rovistata oltre i confini delle mode e degli stili o delle barriere linguistiche, ed ascoltata senza preconcetti di sorta. È necessario quindi superare le ‘barriere razziali’ che separano gli Zingari da Noi, e andare oltre le divergenze culturali e le discriminazioni politiche o i limiti posti dalle religioni, nella convinzione che l’aggregante prospettiva della ‘musica zingara’ possa essere riconosciuta come musica patrimonio dell’intera umanità, solo allora potremo un giorno riscrivere una ‘storia’ migliore.
Tratto da “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” di Giorgio Mancinelli, MEF Firenze Atheneum, premio letterario “L’Autore” per la Saggistica, 2006.
Per un maggiore approfondimento di questa ricerca, sono consultabili numerosi documenti bibliografici e sonori di notevole interesse etnomusicologico apparsi in collane librarie e discografiche prestigiose, qui sotto elencate:
Bibliografia:
“Storia del mondo antico” – vol.I, II, IV, e “Storia del mondo medievale” – vol. I, II, III, Cambridge University Press – Garzanti, Milano 1988
“Atlante delle popolazioni” – Garzanti, Milano 1997
“I popoli della terra” – Mondadori, Milano 1974
“Il Corriere Unesco” – anni 1973/1974 – Editalia, Roma
“Il Corriere Unesco” – anno 1984 – Giunti, Firenze
“L’origine della specie”, Charles Darwin – Bollati Boringhieri, Torino 1967
“Antropologia strutturale”, Claude Lévi-Strauss – Il saggiatore, Milano 1980
“Gli archetipi dell’inconscio collettivo”, C. G. Jung – Bollati Bor.,Torino 1980
“Modelli di cultura”, Ruth Benedict – Garzanti, Milano 1960
“La cultura orale”, Tullio De Mauro – Laterza, bari 1977
“Dialetti degli zingari italiani”, Giulio Soravia – Pisa 1977
“Storia delle religioni”, Mircea Eliade – Peyot, Parigi 1951
“The Larousse Encyclopedia of Music” – Amlyn, London 1978
“The History of Music in Sound” – Oxford University Press, London 1966
“Storia della Musica”, vol. I,II,III,V, - Feltrinelli-Garzanti, Milano 1991
“La musica nel mondo antico”, Curt sachs – Il Saggiatore, Milano 1966
“La musica nel Medio Evo”, Gustave Reese – Sansoni, Firenze 1981
“Storia degli strumenti musicali”, Curt Sachs – Il Saggiatore, Milano 1966
“Storia della danza”, Curt Sachs – Il Saggiatore, Milano 1980
“Dizionario della Danza e del Balletto” – Jaca Book, Milano 1998
“”Gli strumenti musicali e il loro simbolismo nell’arte occidentale”, Emanuel Winternitz – Bollati Boringhieri, Torino 1982.
“Simboli sonori”, Cristina Cano – Franco Angeli, Milano 1985
“La maschera e il pregiudizio, la storia degli Zingari”, Loredana narciso – Melusina Editore, Roma 1990
“Music in the World of Islam”, J.jenkins e P. Rovsing-Olsen – Horniman Museum, London 1976.
“Monumentos Historicos de la Musica espanola”, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Education y Ciencia, Madrid 1977/1982
“Situation de la musique et des musiciens dans les pays d’Orient”, Alain Danielou – Olschki, Firenze 1971
“Le structure sociale de l’inde traditionnelle”, Alain Danielou – Buchet-Chastel, paris 1976
“Semantique Musicale”, Alain Danielou – Hermann Editeurs, Paris 1978
“Musica e Psiche”, Augusto Romano – Bollati Boringhieri, Torino 1999
“De bouche à l’oreille”, Cahiers de Musiques Traditionnelles – Georg Editeur, Geneve 1988
“Lacio Drom” anni 1973/1974, Bruno Nicolini e Mirella Karpati, L.C. Roma
“The Journal of the Gypsy Lore Society – Wolver Hampton, England
“Les Etudes Tziganes” – Paris VII, France
Discografia :
The History of Music in Sound – His Master’s Voice
Ethnic Folkways Library – Nonesuch Records
Musical Atlas – Emi/Unesco Collection
Musical Source – Philips/Unesco Collection
Melodya – (Russia)
Request Records - House of Culture of Bucharest – (Romania)
Balkanton (Bulgaria)
Jugoton – (ex Jugoslavia)
Emi/Columbia – (Grecia)
Le Chant du Monde, Editions Musée dell’Homme, Ocora, Universo del Folklore / Arion – (Francia)
Archives Internationales de Musique Populaire – (Svizzera)
Hispavox – (Spagna)
Per l’Italia sono disponibili le seguenti collane, nelle quali sono rintracciabili brani di musica zingara dedicati:
Dischi Albatros – Vedette Records
I dischi del Sole – autonoma
Musiche dal Mondo – Fabbri Editore
World Music – la Repubblica
Hemisphere Real World – Emi Italiana
Meridiani Musicali – Editoriale Domus
*
 - Musica
- Musica
Ecco la Primavera! - La tradizione in Italia
ASPETTANDO ‘MADONNA PRIMAVERA’ - La tradizione in Italia
Ecco la primavera!
Ch’el cor fa rallegrare
Temp’è d’annamorare
E star con lieta cera... (1)
Al suono gagliardo di un tamburello giunge per le contrade la voce schietta di un Menestrello a dar l’annuncio della stagion novella. Canta una canzona antica e sempre nuova, che la natura intende risvegliare con suoni e balli e lazzi, e con soavi ‘laudi’ e ‘madrigali’. Il suo cantar galante il verso rima, ricco di ammiccamenti salaci e gai che al cor danno allegrezza e a novi amor sollecita gli amanti. “Temp’è d’annamorare...”, invita il ritornello. Di calle in calle, di bocca in bocca, ripete l’eco la fresca voce d’una pulzella, ed è già un coro:
Ecco la Primavera!...
Così cantando si rinnova in questo periodo dell’anno il nostro benvenuto alla stagione amica che, oltre ai significati propiziatori d’appartenenza a più antichi riti agrari della fertilità, assume nell’allegoria medievale carattere simbolico. Messer Boccaccio nel ‘Decamerone’ parlando dell’equinozio di primavera fa ripetuti accenni a danze, girotondi e canzoni in cui si rende offerta di rami fioriti e di ghirlande di sempreverdi all’intrecciarsi di nuovi amori. Il giovine Botticelli trae ispirazione per una composizione nuova in cui si intessono carole danzanti a salutare l’arrivo di Madonna Primavera.
Entrata nell’espressione cortigiana medievale, intenta a rallegrare lo spirito e a riappropriarsi dei significati terreni dell’esistenza, la forma poetica della ‘laude’ e successivamente del ‘madrigale’ è scritta per essere cantata, successivamente divenuta moda, gioco, vezzo nell’espressione convenzionale del corteggiamento amoroso:
S’odan la notte e’l giorno in versi tanti...
E gl’infelici e stravaganti amanti
Piglian conforto a suoi aspri martìri
e scaccian via da lor l’affanni e pianti... (2)
Ciascun suoni, balli e canti...
Dicono i versi di un’altra canzona in voga composta dal Magnifico Lorenzo, ed è già festa. Nelle contrade dell’umbra Assisi, fra stendardi e bandiere, i Nobili della «parte di sopra» già fan tenzone con gli Artigiani della «parte di sotto». La disputa di giochi medievali si contende davanti al Maestro di Campo che assume simbolicamente i poteri della città. Vengono stesi sulla via tappeti floreali tessuti di petali di rose, di margherite, d’anemoni e papaveri sui quali, circondata dalle sue ancelle, passa la proclamata Madonna Primavera, “della città la giovine più bella”. Intanto che gruppi di sbandieratori, alfieri e tamburini, danno il via alla grande giostra in cui si rievoca la storia in chiave sfarzosa e allegra.
Ecco la Primavera!...
Intona il menestrello al suono della controdanza, e i danzatori in coro ripetono il ritornello:
Hor che la nuova e vaga Primavera
Ritorna più che mai leggiadra e bella,
...
rallegranci ancor dunque e cantiamo
con chiare voci un canto allegr’è adorno,
acciò risuoni il ciel per ogni intorno. (3)
È questo il tempo in cui si rinnovano le promesse amorose, già espresse nel libro di ‘Laude’ da Jacopone da Todi (XIII secolo) e che seppur rivolte a un’altra Madonna ben più mistica, ha permesso il fiorire nella monodia profana un rinnovato fervore. Dal punto di vista strettamente vocale la ‘laude’ è già una canzone seppure religiosa, espressa nella lingua del volgo, liberamente reinterpretata dalla spontaneità popolare. Il genere musicale utilizzato talvolta per l’accompagnamento è prevalentemente quello della ‘mèlica’ di Giuliano da Spira (1250 circa), il cui testo poetico, successivamente adattato per musica, solistica o corale, o per voce sola o accompagnata da strumenti, varia modificando in molti casi quella strofica. La ‘laude’ è all’origine della rappresentazione popolare della Sacra Rappresentazione nei suoi diversi aspetti e rivolta soprattutto alle grandi festività religiose come la ‘Natività di Nostro Signore’, e la ‘Settimana Santa’ che precede la Pasqua.
Alla ‘primavera’ umbra si vuole faccia eco il rinnovarsi del fervore mistico della ‘laude’ francescana conosciuta come “Cantico di Frate Sole” che è di solito intonato da una voce solista e ritenuto, a ragione, uno dei più bei cantici rivolti a tutte le creature della natura, e che ha dato nel tempo, il maggiore impulso al germogliare del fenomeno linguistico così detto ‘volgare’ strettamente legato alla parola.
Cantico di Frate Sole (attribuito a San Francesco d’Assisi)
Altissimu onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore
Et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullo homo ene dignu Te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
Et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
Per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et erba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke
Perdonano per lo Tuo amore
Et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke’l sosterranno in pace,
ke da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no’l farrà male.
Laudate et benedicite mi’ Signore et rengratiate
E serviateli cum grande humilitate. (4)
Nella storiografia musicale si fa risalire il ‘madrigale’, messo in relazione al soggetto pastorale poetico musicale degli inizi, attorno al XIV secolo. Indicante una forma musicale fiorita della così detta Ars Nova, contrapposta all’Ars Antiqua che l’aveva preceduta e di un diverso sistema di notazione ritmico-musicale che suscitò polemiche e resistenze a causa dello spirito diverso che animava questo tipo di composizione. La Chiesa in particolare, ne avversò il carattere profano, che prescindeva decisamente dai modi liturgici. Il sorgere dell’Ars Nova coincise infatti significativamente con il periodo cruciale che segnò la crisi del medioevo, il tramonto dei principi universalistici della chiesa e dell’impero, l’ascesa di ceti e strati sociali portatori di contenuti nuovi in seno alla società.
L’Ars Nova che dalla Francia si era divulgata in tutta Europa, e quindi in Italia, presenta caratteristiche peculiari di semplicità e genuinità che contrastano con gli schemi più intellettualistici e sofisticati della musica francese dell’epoca. Inoltre, in Italia, praticò più raramente la musica religiosa e ignorò quasi del tutto il ‘mottetto’ che era invece espressione tipica francese del ‘virelai’. Forme proprie dell’Ars Nova italiana furono appunto il ‘madrigale’ a due o tre voci, la ‘caccia’ e specialmente la ‘ballata’ polifonica. Fra gli autori di questi generi si ricordano Giovanni da Firenze, Jacopo da Bologna, Lorenzo e Gherardello da Firenze, Francesco Landini e Matteo da Perugia. L’altra forma del ‘madrigale’ polifonico a quattro e a sei voci si svilupperà molto più tardi nel XVI secolo, con prevalenza della voce superiore a uso della scrittura isoritmica.
Verso la fine del secolo il ‘madrigale’ incarna più d’ogni altra forma le esigenze di sentimentalità e di espressione degli ‘affetti’ che caratterizzano il tardo rinascimento. Ed è ancora il tema amoroso, o meglio il tema dell’amore per l’amore che qui più ci interessa e che si risveglia dal rinascimento in poi; e che segna quel “Cominciamento di Gioia” che Madonna Primavera porta con sé come riflesso della novella stagione:
Ecco la Primavera!...
“Al venire della Primavera
Vattene via, inverno!
Lasciaci ballare fra noi!” (5)
Canta la novella gioventù a ‘l’entrada del temps clar’: (di anonimo)
A l’entrada del temps clar, eya
Per joia recomençar, eya
E per jelòs irritar, eya
Vòl la regina mostrar
Qu’el’es si amorosa
A la vi’, a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.
El’ a fait pertot mandar, eya
Non sia jusqu’a la mar, eya
Piucela ni bachalar, eya
Que tuit non vengan dançar
En la dansa joiosa.
A la vì, a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos.
Los reis i ven d’autra part, eya
Per la dança destorbar, eya
Que el es en cremetar, eya
Que òm no li vòlh emblar
La regin’ aurilhosa.
A la vì, a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.
Mais per nient lo vòl far, eya
Qu’ela n’a sonh de vielhart, eya
Mais d’un leugièr bachalar, eya
Qui ben sapcha solaçar
La dòmna saborosa.
A la vì, a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.
Qui donc la vezés dançar, eya
E son gent còrs deportar, eya
Ben pògra dir de vertat, eya
Qu’el mont non aja sa par
La regina joiosa.
A la vì, a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos. (6)
Ed è alla poesia che ancora una volta ci rivolgiamo, quella poesia che ci vuole amanti e che suggerisce parole nuove, versi e canti per la stagion novella che siamo in uso chiamare ‘primavera’:
“Al cor gentil ripara sempre Amore...” (Guido Guinizelli)
“Questa rosa novella che fa piacer sua gaia giovanezza...” (Lapo Gianni)
“Per una ghirlandetta ch’io vidi, mi farà sospirare ogni fiore...” (Dante)
“Chiare fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei...”
(Francesco Petrarca)
“Ardo d’amore e conviemme cantare per una dama che mi strugge el
cuore...” (Lorenzo il Magnifico).
Ecco la Primavera!...
Ben venga Maggio, (Angelo Ambrogini detto Il Poliziano)
...e ‘l gonfalon selvaggio!
Ben venga Primavera
che vuol l’uom s’innamori
e voi donzelle, a schiera
con li vostri amadori,
che di rose e di fiori
vi fate belle il maggio... (7)
Conviene anche a noi cantare (i tempi di crisi lo richiedono), sulle note del più famoso dei canti composti per il 'Trionfo di Bacco e Arianna' del ‘carnasciale’ fiorentino. Un canto che è la celebrazione della gioia di vivere, anche se vi affiora un fondo di malinconia per l’incertezza del domani e una reminiscenza oraziana nell’invito a cogliere il momento presente e la gioia che esso può dare:
Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non v’è certezza.
...
Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi sian, giovini e vecchi,
lieti ognun, femmine e maschi;
ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non v’è certezza.
Donne e giovanetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Quel c’ha esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non v’è certezza.
Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia! (8)
Note:
1) Francesco Landini “Ecco la Primavera” in “Landini and Italian Ars Nova” – Alla Francesca – CD Opus 111.
2) “Landini e la Musica Fiorentina” – Micrologus - CD Opus 111.
3) “Madrigale” di anonimo, in “Chominciamento di Gioia” - Ensemble Unicorn – CD Naxos.
4) Francesco d’Assisi “Cantico di Frate Sole” in “Laudario di Cortona” – Quintetto Polifonico Italiano di Clemente Terni - PCC – LP 0098.
5) “A l’entrada del temps clar” (trad. di Luisa Zappa) in Angelo Branduardi “Chominciamento di Gioia” – CD La Voce del Padrone.
6) Ibidem.
7) Angelo Ambrogini detto Il Poliziano, “Ben venga Maggio”, in “Pagine d’Oro della Poesia Italiana” – Selezione dal reader’s Digest – 1968.
8) Lorenzo il Magnifico, “Quant’è bella giovinezza”, in “Pagine d’Oro della Poesia Italiana” – Selezione dal reader’s Digest – 1968.
Bibliografia:
“Storia della Musica” Vol. III – Feltrinelli/Garzanti 1992.
Luigi Lucchi “Intorno alle melodie del Laudario di Cortona” in “Laude dugentesche” di Giorgio Varanini – Padova 1972.
Discografia (altra):
“Laude del Duecento e del Trecento” – Coro dei Concerti Spirituali della Cattadrale di Verona diretto da Luigi Lucchi.
“Laudi dal Quattrocento al Seicento” - Coro dei Concerti Spirituali della Cattadrale di Verona diretto da Luigi Lucchi.
“Francesco Landini Studio der Fruhen Musik” – EMI STUDIO – LP 3C 053-30113
“Musica del Trecento all’epoca di Jacopo da Bologna” - EMI STUDIO – LP 3C 053-30111
“Musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico” – Ensemble L’Homme Armé – CD Collection Europa 012.
“Chominciamento di Gioia” Musica all’epoca di” Boccaccio’s Decamerone” – CD Naxos.
“Codex Faenza”, Instrumental music of the early XVth Century – Ensemble Unicorn - CD Naxos.
“Il Cantico delle Creature” in Angelo Branduardi “L’infinitamente piccolo” – CD EMI contiene 11 canzoni su testi tratti da fonti Francescane.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etno 9: Indiani d’America - sec. parte
“Indiani d’America: tra storia e leggenda”, di Giorgio Mancinelli.
(Da “Folkoncerto”, RAI-Radio3, e “Itinerari Folkloristici”, reportage trasmesso dalla RSI – Radio della Svizzera Italiana).
O Grande Spirito
che vivi nella memoria dei giorni che furono
oggi risveglia una nuova alba
fa che il Tamburo del Tuono
risuoni in tutti i cuori
e che il seme della Vita
conosca il suo Risveglio.
Sotto l’auspicio di un felice “Awakening/Risveglio” originario degli Indiani Apache (XIT vedi dis.), abbandoniamo l’accampamento dei ‘tepee’, del ‘grande fuoco’ e del ‘To-tem’, che di fatto appartiene al passato remoto e avviamoci, non senza costernazione, nella “riserva”: luogo di segregazione e di esilio degli Indiani d’America che abbiamo conosciuto nella prima parte di questa stessa ricerca, il cui scopo precipuo, è bene riconfermarlo, è appunto quello di trasmettere, anche se in ridottissima parte, una cultura che va estinguendosi insieme al popolo che ne è stato l’artefice. È prioritario dire che si è di fronte a una straordinaria cultura di cui andava fatto tesoro, comprenderla e forse accogliere quanto di essa vi era di importante per la salvaguardia dell’habitat in cui tutti viviamo, per apprendere da essa quelle tecniche di sopravvivenza che hanno permesso loro di interagire con l’ambiente e la violenza delle forze naturali che da sempre governano il mondo. Questo mondo, il nostro mondo, tutto un pianeta che abbiamo finito per distruggere, anche se alla fine sarà esso a distruggere tutti noi.
Tuttavia senza essere volutamente catastrofici, cerchiamo almeno di apprendere quelle “nozioni di vita” che possono, se non aiutarci a sopravvivere, almeno a capire alcuni perché, e sono molti, e che ci hanno portato a questa sconfitta. Tutto nasce da una primaria incomprensione (ovviamente da parte nostra), volutamente ignorata, che ha portato all’enigmaticità della specie umana sconosciuta prima del 1492, con la quale avremmo dovuto imbastire una relazione di reciproco rispetto e che invece, successivamente, ha portato a quell’incredibile comportamento distruttivo (sempre da parte nostra), che ne è seguito e ancora oggi prosegue nell’errore iniziale. Come potrebbe dirsi per il ‘peccato originale’ dal quale deriva che siamo tutti peccatori, e allora, essendolo (è una conferma), possiamo tranquillamente continuare a peccare, seppure siano passati 10 o 2omila (ma forse anche 50mila chi lo sa?) anni da che i nostri antenati si distinguevano in cacciatori e raccoglitori. Come scrive Carleton S. Coon (*), uno dei più grandi studiosi di antropologia fisica:
«L’intervallo di tempo di dieci millenni abbraccia circa quattrocento generazioni: troppo poche per produrre mutamenti genetici degni di nota. Dato che il comportamento umano, come il comportamento delle altre specie animali, dipende in ultima analisi da capacità ereditate, le nostre tendenze naturali non possono aver subìto enormi trasformazioni. Noi siamo uguali ai nostri antenati».
Se non altro abbiamo messo un punto fermo sul quale attestarci:
«Ma non si tratta né di fantascienza né di un’oziosa congettura – aggiunge Coon – ma di una seria conclusione professionale. Non è necessario che mi soffermi in questa sede sui fatti, ben noti e impressionanti, circa gli effetti cumulativi della radioattività sugli organismi viventi, l’irreversibile impoverimento dell’atmosfera terrestre provocato dallo spreco del suo ossigeno, o altri aspetti della crisi globale di cui abbiamo cominciato a preoccuparci solo ieri o l’altro ieri. Altri autori più qualificati di me possono descrivere questi pericoli».
Questo e moltissimo altro ancora Coon lo diceva già nel 1971 all’uscita del suo “The Hunting Peoples”, non ci si meravigli quindi se quarantenni dopo la situazione è solo peggiorata. E soprattutto se, si continuano a fare le guerre e a ‘sterminare’ sotto l’etichetta di ‘pulizia etnica’ popoli e culture ancora ai giorni nostri, vuol dire esattamente la stessa cosa, cioè: che “… noi siamo uguali ai nostri antenati”, anzi peggiori. In questo caso la ricerca e l’esposizione di Coon sono il compendio di una vita spesa in “ricerche sul campo” di tipo fisico socio-antropologico e archeologico. Illustra gli strumenti e i metodi di caccia e di pesca, i sistemi di recupero della preda, i mezzi di trasporto per terra e per acqua, i procedimenti di cucina e di conservazione del cibo. Non sono trascurate le organizzazioni politiche e sociali, i metodi impiegati per conservare la pace interna ed esterna tra i gruppi e i territori, i legami matrimoniali, i rapporti commerciali e quelli che sono considerati “i riti di passaggio” dall’adolescenza alla maturità e dalla vita alla morte, con un’accurata analisi del “mondo simbolico”: alle cerimonie, ai riti e all’universo fantastico degli déi, degli spiriti e delle mitologie che hanno un ruolo vitale nelle culture dei “primitivi”.
Un altro punto fermo da cui ripartire, ma questa volta con lo sguardo rivolto all’indietro, perché la conoscenza del sistema di vita dei nostri predecessori, o comunque dei popoli che attestiamo come ‘esseri primitivi’, può aiutarci a scoprire che cosa saremmo in grado di fare se dovessimo ricominciare tutto daccapo, come avvenne 10 o 20mila (ma forse anche 50mila chi lo sa?) anni fa. L’intervallo cronologico potrebbe assomigliare allo iato dell’insediamento umano che in passato si credette esistere tra Paleolitico e Neolitico europei, e che successivamente fu colmato dalle scoperte ora note sotto il nome di Mesolitico. Ovvero l’intervallo potrebbe essere soltanto apparente, perché in realtà disponiamo di una documentazione sufficiente a conferire continuità al racconto, ma siamo noi stessi a creare un vuoto interpretando le prime vestigia come più antiche, perfino del necessario, e quelle tarde come più recenti di quanto siano, col risultato di separarle artificialmente.
‘Canto di un iniziato’ – Tribù degli Huichol (*)
Salii l’azzurra scala celeste
Salii dove sbocciavano le rose
Dove parlavano le rose
Nulla sentii nulla da sentire
Sentii silenzio
Salii dove cantavano le rose
Dove gli dei attendevano
Azzurra scala celeste
Ma nulla sentii, nulla da sentire
Ero il mio pensiero
Sentii silenzio, solo silenzio.
È noto che in America i primi sicuri reperti di attività umana – Folsom, Sandìa, ecc., hanno un’antichità comprovata in primo luogo dall’essere associati a ossa di animali estinti, il che conferisce loro, indubbiamente, una certa antichità, ma senza che se ne conosca la portata, e potrebbe essere minima, da un punto di vista geologico, sicuramente enorme se abbiamo sbagliato i calcoli della presenza dell’uomo sulla Terra. Alcune di queste scoperte di manufatti associati a fossili potrebbero risalire a 25000 anni or sono in America, altre a solo 500mila anni.
Scrive Alfred L. Kroeber (*) antropologo di particolare importanza teorica:
«A tutt’oggi non abbiamo modo di accertare esattamente a quando risalga la scomparsa di una data specie animale in una data regione. All’altra estremità troviamo la documentazione archeologica che procede a ritroso, più o meno, ininterrottamente, dal tempo presente: innanzitutto con reperti che provano contatti con la civiltà caucasica, poi in seguito con il materiale precedente al 1492, e così sempre più indietro fino all’inizio di questa colonna temporale retrospettiva, con una continuità di mutevoli tipi culturali, scoperti in parecchie regioni dell’America del Nord e del Sud. Periodo che, in ogni caso, sarebbe piuttosto recente per farvi risalire la scomparsa delle specie estinte di animali. (..) Il fatto che questa lacuna nel nostro sapere duri più a lungo in merito all’America che non nell’emisfero orientale ha più di una ragione. Dopo tutto, la storia documentaria è molto più recente: è tutta successiva al 1492, tranne le leggende raccolte dagli Spagnoli in alcune aree, l’autenticità di molte delle quali non è affatto scontata. (..) Se guardiamo a ritroso a partire dalla metà del ‘900, è significativo come in più di una zona dell’America, come gli Stati Uniti orientali e sudoccidentali, si fossero da tempo accumulate considerevoli masse di informazioni archeologiche senza che nessuno si ponesse la domanda, ben oltre il 1900, se non fosse magari possibile scindere questa massa in fatti relativamente precedenti e relativamente successivi. Soltanto la regione azteca-maya costituiva una parziale eccezione, in forza delle leggende indigene e financo dei libri di storia conservativi degli Spagnoli. Una conseguenza di questo ritardo nello svilupparsi di un punto di vista storico nell’archeologia americana fu che parte del carico finì col pesare sull’etnografia, l’indagine cioè delle tribù native sopravvissute, in particolare negli Stati Uniti e nel Canada.
Eppure, queste tribù, che spesso tutt’ora vivono nelle riserve, risultavano facilmente accessibili all’indagine senza lunghe e dispendiose spedizioni ufficiali. Conseguentemente, prima una poi l’altra, furono quasi tutte studiate, finché furono disponibili dei dati culturali caratterizzati da una insolita continuità geografica. Continuità di informazioni che, a sua volta, rese possibile la sistematica classificazione zonale delle culture tribali dell’America del Nord, l’abbozzo dei fenomeni diffusivi, e l’applicazione dei principi di irradiazione dai centri originari, di residui marginali, e di età e area. Il risultato curioso fu che per un certo periodo – più o meno dal 1915 al 1930 – l’etnografia di fatto fu superiore all’archeologia di scavo per la mole di soluzioni deduttive che fu in grado di offrire al problema dello sviluppo storico della cultura indigena americana. (..) Queste diverse considerazioni ci fanno concludere che gli studi etnografici hanno contribuito probabilmente non meno di quelli archeologici all’attuale conoscenza della storia della cultura dell’America indigena. Il preciso succedersi degli sviluppi culturali, e le loro avarianti locali in passato: di ciò siamo debitori agli archeologi; il rivestimento di questo scheletro od ossatura col tegumento di una cultura integrale, e la ricostruzione delle maggiori linee di sviluppo sull’intero emisfero, a ciò gli etnologi hanno contribuito in pari misura e forse maggiore efficacia».
Fin qui dunque, abbiamo lasciato spazio all’antropologia, trascurando quello che è il fine della ricerca da noi avviata e che riguarda più da vicino l’etnomusicologia, altra branchia della medesima che pur non avendo ricevuto particolari riconoscimenti ha, permesso di penetrare la materia archeologica ed etnografica studiata e a dare ad essa quella continuità che nella tradizione si perpetua automaticamente, senza la necessità di intromissioni o fattori ad essa esterni. È quindi forse il caso di riprendere da dove avevamo lasciato nel capitolo precedente, cioè dal titolo: “tra storia e leggenda”, andando alla ricerca di forme culturali contenute nella tradizione degli Indiani di quella parte d’America da noi presa in considerazione, e tuttavia, farlo, “senza nostalgica rivisitazione di un passato arcaico, né esotico primitivismo, ma riconoscimento indifferibile di un’umanità da sempre calpestata e conoscenza obbligatoria per la costruzione di un futuro migliore, definitivamente affrancato da valori artificiali e falsi miti messaggeri di sopraffazione e annientamento”. Ed è proprio attraverso il ricchissimo e fecondo patrimonio di poesie e canti, miti e leggende, come anche di narrazioni sacre e profane, che possiamo raggiungere il cuore della cultura orale, il suo carattere di rappresentazione-evento, la presenza di fenomeni apparentemente privi di elementi concettuali trasmessi da questi popoli entrati nell’emisfero della ‘mitologia’.
‘La Rete di Luna’: Una visione dal ‘Gioco della Mano’ – Tribù Pawnee (*)
Notte di Luna Piena … la gente
si diverte al Gioco della Mano in una tenda
tutti escono per danzare
Un uomo comincia a vacillare
poi piange … le mani tese
verso la Luna (dice): Lo sentii
qualcosa nella mia mente
quando uscimmo … sembrava
che stessi vedendo qualcosa
stava arrivando
uscimmo … mentre danzavamo
ad un tratto alzai gli occhi
verso la Luna … Vecchia Luna abbassa gli occhi
e mi vede … e ride di me
solo allora piansi.
Di estremo valore è dunque la testimonianza di questo popolo in quanto ha saputo valutare realisticamente il nostro sviluppo materiale e l’ideologia che lo ha sorretto, conosciuti fino alle conseguenze ultime, percependo senza incertezze le motivazioni di fondo della razionale trasformazione del mondo, vero obiettivo della civiltà occidentale e radice della fatua presunzione che aleggia sul nostro orizzonte. La pretesa dell’uomo bianco di imporre il proprio modo di pensare, di ritenerlo l’unico valido, di considerare tutti gli altri generi di vita come una condizione d’inferiorità che doveva essere forzatamente cambiata in nome di una cultura, di una religione, di una tecnica superiori, ha portato a numerosi malintesi fra i popoli, primi fra tutti i pregiudizi razziali e lo sfruttamento. L’accusa più lucida e pregnante, infatti, è pervenuta da Sitting Bull (Toro Seduto) che, tralasciando ipocrisie ed eufemismi, ha colto nel segno ponendo l’accento sul nostro patologico ‘desiderio di possesso’. Scrive Franco Meli (*):
«La critica degli Indiani d’America non è oscurantista, sterile o tanto meno nichilista ma improntata a visioni dei rapporti umani e delle relazioni con la totalità dell’universo che per la loro dignità e bellezza non dovrebbero ulteriormente essere ignorate o derise ma appartenere all’umanità intera e contribuire ad un arricchimento che di giorno in giorno si fa più urgente e auspicabile. (..) Ma è sul piano egualitario che il ‘bianco’ (viso pallido) ha sempre negato, sistematicamente la parola data, scritta e orale, perseguendo nell’etnocidio per ridurre all’impotenza un’umanità che richiedeva solo rispetto ed era pronta a condividere tutto con l’invasore a un livello, appunto, egualitario e di tolleranza reciproca. (..) Ciò non è avvenuto. Agli Indiani non è stato concesso adeguare e inserire i mutamenti alle specifiche esigenze e ai caratteri peculiari della loro civiltà; si è piuttosto imposta, con ogni mezzo possibile, (fino all’etnocidio) un’acculturazione immediata e completa nell’intento di cancellare ogni legame con la realtà tribale, il diritto alla sovranità nazionale, di autodeterminazione e indipendenza».
In conclusione:
«Non è più possibile situarci come gli unici, i privilegiati solutori dei problemi del vivere, presupponendo che l’umanità intera sia plasmabile a nostra immagine e somiglianza; la ‘nostra’ implacabile e determinata fermezza non possono costituire attestati di valore e superiorità. Nella sofferenza indiana dobbiamo vedere riflessa la nostra degradazione ed essere così in grado di accogliere e meditare le critiche amare e le accuse fondate che ci vengono mosse. La nostra cultura deve infine trovare una risposta ai perché che oggi, ancora, l’AIM (American Indian Movement, la più incisiva e combattiva Organizzazione per i Diritti degli Indiani, sorta a Minneapolis nel lontano 1966), ci pone: perché abbiamo infranto le promesse sottoscritte nei trattati, perché li odiamo, li uccidiamo e distruggiamo tutto quanto è in loro possesso, perché non rispettiamo la terra, perché abbiamo spezzato il cerchio? Risposta, ci si augura, equa e risolutrice, anche se è fuori dubbio che le ferite aperte difficilmente potranno essere risanate».
Da “Walum Olum” – Indiani Delaware (*)
In principio
regnavano saggezza letizia
e serenità
i pensieri erano dolci.
Vi era fratellanza tra tutte le creature
acque dirompenti
alle colline
inondavano le terre
divoranti acque
gli uomini e le creature tutte nella corrente delle acque.
La figlia di uno spirito giunse in aiuto
tutti si riunirono
implorando aiuto.
In altri tempi si attraversavano
le acque del duro mare di sassi
vi era pace tempo fa.
Vasta ed estesa era la terra ad oriente
abbondante e fertile
potremo poi essere felici
nei nuovi territori?
Desideriamo serenità pace saggezza.
Canti – Indiani Chippewa (*)
Dal centro della terra
provengo.
Vivo in una caverna
vecchio Nonno
ho piume
sulle braccia
devo essere un uomo delle caverne.
Scorre l’acqua
il rumore
viene verso la mia casa.
Davvero
Sono uno spirito!
Vedi che divento visibile?
Questa volta mi mostrerò
alla terra tutta
indossando pelle di martora.
Ecco la mia clava di guerra
che rimbomba nel cielo
lucente come una stella
l’animale che alza lo sguardo
dalla mia luce è accecato.
In mezzo al mare
spaziosa stanza marina
nella quale mi siedo
potevo supporlo
uccelli d’acqua si posano
lungo tutto il mio corpo.
Sai cosa ti prometto?
Cieli luminosi e limpidi
Questo è quanto ti prometto.
Il suono si smorza
sembra piuttosto cinque suoni
libertà
il suono si sta veramente smorzando
sembra piuttosto cinque suoni.
Studi specifici sulle singole tribù, portati a compimento da eloquenti antropologi, hanno consentito fino ad oggi di approfondire le fasi evolutive delle società indiane come cronaca di un emblematico incontro/scontro tra due concezioni opposte della vita, della natura e del ruolo dell’uomo, benché alcuni aspetti della moderna società occidentale rispondano ad agglomerati delle diverse culture provenienti dal contatto diretto con le popolazioni ‘altre’ di ogni parte del mondo. Questo perché, in un certo contesto, la natura dell’uomo ha manifestato e continua a manifestare le stesse esigenze e ha dato agli eventi gli stessi valori sostanziali, inscindibili per la sopravvivenza. Quindi uguali, sebbene articolati diversamente, in tutte le società umane più o meno sviluppate, che si ripetono in modo paritetico con quello naturale studiato da Charles Darwin (*); ed animale, come ha dimostrato Konrad Lorenz (*), per il quale problemi capitali, acquistano un aspetto del tutto nuovo se considerati in rapporto al regno animale: il rito, la cerimonia, il codice di comportamento, il territorio, l’aggressività, la natura degli istinti. Su tutti questi temi gli studi di Lorenz hanno aperto prospettive, indotto a riconoscere sempre più l’enigmaticità, la compiutezza formale, la ricchezza dei significati latenti anche nei fatti più elementari del comportamento animale, riuscendo così a rimuovere i più rozzi schemi antropomorfizzanti. Non solo, “anche la psicologia umana ha trovata uno stimolo a un ausilio prezioso in queste ricerche, che cominciano a permetterci di situare l’incredibile comportamento umano di fronte all’incredibile varietà dei suoi comportamenti”.
Non ritengo opportuno scomodare Carl G. Jung (*) per azzardare una definizione del soggetto psicologico a cui apparteniamo, tuttavia è necessario fare delle considerazioni appropriate e, poiché non ho altri fra le mani, utilizzo una sua affermazione che ritengo sufficientemente calzante:
«Se prendiamo a considerare la vita umana nel suo svolgimento, vediamo che vi sono uomini il cui destino è determinato in prevalenza dagli oggetti dei loro interessi e altri il cui destino è invece determinato piuttosto dalla loro propria interiorità, o soggettività. Poiché tutti noi ci avviciniamo un po’ più a questo o a quel modo d’essere, siamo naturalmente inclini a intendere sempre ogni cosa nel senso che è peculiare al nostro proprio tipo».
A che proposito scomodare Jung, vi sarete chiesti?
Non è facile caratterizzare in modo chiaro e comprensibile questo opposto comportamento e grande è il pericolo di pervenire a formulazioni paradossali atte a ingenerare più confusione che chiarezza, nonché l’insorgere di eventuali malintesi. “Destino, interiorità o soggettività, naturalmente inclini”, non sono forse queste le parole usate dal grande studioso? Beh, se noi le applichiamo per un discorso sugli Indiani d’America, troviamo che ogni singola parola corrisponde esattamente al tipo psicologico che abbiamo di fronte in modo estremamente aderente fin dalle sue origini. Cosa che spiega perché i pellerossa da sempre occupano un loro habitat che gli è congeniale, un territorio come quello delle ‘grandi pianure’ enorme, che ha consentito loro di vivere secondo la loro naturale inclinazione, dove sviluppare a fronte di una cogente interiorità, la soggettiva capacità di forgiare il proprio destino all’interno di una comunità arbitrale.
Fatto questo che è rivelato dai testi delle narrazioni mitologiche, dalle poesie e dai canti, dalle nenie e lamentazioni di riferimento a situazioni spesso connaturate e irrisolvibili, quasi una sorta di imprinting che la natura, cioè il territorio, ha fissato ad essi, e che, a loro volta, essi hanno aiutato a imprimere alla natura circostante, adeguandosi ad essa e favorendo lo sviluppo nella sua germinazione. Il fatto che distingue il grado di questa evoluzione è che in essa è rintracciabile il modo di organizzazione il pensiero: da ciò deriva anche una comune visione del mondo, che amalgama, più o meno, usanze e costumi, credenze, abitudini, modi di vita e di comportamento propri degli Indiani d’America. Se esiste una differenziazione fra una società tribale e quella di uno stato moderno essa consiste proprio nel grado di maggiore individuazione dei suoi punti fermi, come ad esempio, il problema “delle origini”, dei “riti di passaggio”, o quello di rispetto riservato ai “tabù” circondati da un complesso cerimoniale che è frutto di coazione (costrizione, imposizione,violenza), e che sfocia nella religione.
Informa Raffaele Pettazzoni (*):
«C’è un tema che è comune alle varie mitologie nord-americane, ed è il ‘mito delle origini’; origini del mondo e del genere umano. Ad esso è fatto riferimento in ragione della sua grande importanza religiosa. Nelle mitologie qui riferite ricorre con particolare frequenza il racconto della creazione e la persona di un Essere Supremo, talvolta in figura di animale, talaltra in figura elevatamente antropomorfa (California centro-settentrionale). Frequente è anche il motivo della ‘creatio ex nihilo’, in forma adeguata al pensiero primitivo, che anche ai fattucchieri e sciamani suole attribuire la facoltà di creare per solo atto di volontà e forza di pensiero. La figura più popolare in tutta la mitologia e il folklore nord-americano è il Coyote, o lupo delle praterie, concepito usualmente come mariuolo imbroglione, autore di beffe ignobili e scandalose, spregiudicato, irriverente e maligno, ma talvolta anche come compagno e collaboratore (per quanto indocile e dissenziente) del Creatore nell’opera della creazione, originariamente forse un Essere creatore egli stesso, poi detronizzato e decaduto al grado di riluttante demiurgo in sottordine».
Questo processo rituale, studiato da eminenti antropologi moderni, quali Arnold Van Gennep, James G. Fraser, Mircea Eliade, Victor Turner, poi elaborato da Carl G. Jung e, non in ultimo da Sigmund Freud, prende avvio da una sorta di “nostalgia delle origini” che ha portato i popoli dell’America Nordoccidentale alla consapevolezza di un mondo reale intimamente connesso alla scoperta del ‘sacro’, attraverso la maturata esperienza dello spirito umano che, a un certo punto della sua esistenza, ha afferrato la differenza tra che si rivela reale, potente, significativo, e ciò che non lo è, vale a dire il caotico e pericoloso flusso delle cose della natura.
Scrive Mircea Eliade (*) nella prefazione al suo “La nostalgia delle origini”:
«È difficile immaginare come la mente umana possa funzionare senza la convinzione che esista qualcosa di irriducibilmente reale nel mondo, ed è impossibile immaginare come potrebbe sorgere la consapevolezza o coscienza, se non conferendo un significato alle tendenze e alle esperienze dell’uomo. (..) È sufficiente dire che il ‘sacro’ è un elemento strutturale della coscienza, e non uno stadio della sua storia. Un mondo pieno di significato – e l’uomo non può vivere nel caos – è il risultato di un processo dialettico che può essere definito con la manifestazione del sacro. La vita umana si carica di significato attraverso l’imitazione di modelli paradigmatici rivelati da esseri soprannaturali; l’imitazione di questi modelli al di là dell’umano costituisce una delle caratteristiche fondamentali della vita ‘religiosa’ strutturalmente comune a qualsiasi cultura ed epoca. Come norma e direttiva all’umana esistenza non fu mai interrotta, e di fatto, non sarebbe potuto essere diversamente. Ai più arcaici livelli di cultura, il vivere come essere umano è un fatto religioso in se stesso perché il nutrirsi, la vita sessuale e il lavorare, hanno un valore sacramentale. In altre parole essere – o piuttosto, divenire – un uomo, significa essere ‘religioso’».
‘Canti di Pensiero’ – Tribù Tepehua (*)
Sapendo che la musica sa
che cosa daranno a Pensiero,
coloro che hanno bisogno
o dove entrerà e chi
chiederà perdono
così come la musica sa cosa verrà suonato.
Sarebbe stata presente
là dove qualcuno andava a trovare un amico povero
perché vuole che si curino di lui
perché vuole che gli sia donato il necessario per vivere
è quanto fecero quando ci diedero questa luce
quando ci diedero leggi in questo mondo
Perché là fuori userà il Pensiero che gli diedero
Con il quale entrerà nel luogo dove sta giungendo
E con esso inizierà le sue opere
E le compirà là dove andò a trovare l’amico.
Canto II.
Il Pensiero fu
e benché sia stato
tuttora permane
o era appena nato quando
ragazzi e ragazze furono.
Benché non fossero degli Anziani
con esso trovarono la loro direzione –
così ebbero Pensiero
e la vita dai loro padri.
Quando la musica inizia
narra del tempo in cui entrò Pensiero
vuole rendere nota la sua felicità
afferrare la musica là fuori
sapendo dov’è
e sapendo adesso dove entrare
giunto là dove si trovavano i suoi padri
li salutò.
L’antropologo belga Arnold Van Gennep (*), per primo nel 1909, notava come certi riti in tutto il mondo avevano strutture simili. Si trattava dei riti associati con il procedere (o il passare) delle persone da una posizione all’altra della struttura sociale. Per cui “i ‘riti di passaggio’ erano di per sé un rituale che segnava il cambiamento di individuo da uno status socio-culturale ad un altro, cambiamenti che riguardavano il ciclo della vita individuale; il caso paradigmatico era quello riferito ai ‘riti di iniziazione’, ma anche ad altri avvenimenti come la nascita, la morte, il matrimonio o la menopausa, o anche altre situazioni connesse o meno ad avvenimenti biologici, che potevano essere gestite socialmente mediante tale tipologia di riti. Il rituale si attuava, il più delle volte, in una cerimonia o in prove diverse. Ciò permetteva di legare l'individuo al gruppo, ma anche di strutturare la vita dell'individuo a tappe precise, che permettevano una percezione tranquillizzante dell'individuo nel rapporto con la sua temporaneità e con la sua mortalità. Tale tipologia rituale è stata indicata come universalmente diffusa e successivamente è stata costantemente utilizzata dagli studiosi di scienze etno-antropologiche per descrivere rituali presso i più disparati gruppi sociali.
Il rito è riconosciuto tale per tre importanti caratteristiche: la convenzionalità, ovvero segue un preciso ordine di gesti e atti; la ripetitività, ovvero il continuo ripetersi all'interno di un tempo definito ciclico; l'efficacia, ovvero l'avvento di qualcosa che modifica lo status di una persona. Esempi di eventi del ciclo della vita che tipicamente vengono gestiti tramite pratiche che possono essere classificate come riti di passaggio sono: la nascita, l’iniziazione o il raggiungimento dell'età adulta, il matrimonio, la morte. L'esempio più classico è la cerimonia di iniziazione, che segna il passaggio alla maturità. Van Gennep osservò durante i suoi studi la tripartizione in tre stadi di tali rituali: separazione (fase pre-liminare); transizione (fase liminare; limen significa confine, soglia); reintegrazione (fase post-liminare). Nella prima fase l'individuo viene separato dal contesto in cui si trova (es. l'individuo viene mascherato e portato nella foresta), nella seconda attraversa una passaggio simbolico che rappresenta il culmine della cerimonia (es. affronta una prova), nella terza viene reintegrato alla sua esistenza con un nuovo status sociale. Caratteristica fondamentale di tali passaggi è la fisicità con cui vengono messi in atto: il rituale prevede generalmente effettivi movimenti dell'individuo che viene fisicamente distaccato, attraversa fisicamente una soglia simbolica (oppure subisce delle modifiche corporali permanenti), viene fisicamente reintegrato. Tale aspetto rende i riti di passaggio di grande interesse per l'Antropologia del corpo.
‘Poesia sonora n.1’ – Tribù Navajo (*)
Ohohohò héhehe héya héya
Ohohohò héhehe héya héya
Èo làdo éo làdo éo lado nasé
Hàuani hao ouòu oué
Èo làdo éo làdo éo lado nasé
Hàuani hao ouòu oué
Hàuani hàuani hao héyeyéye yéyeyàhi
Hauouòu éya héya héya héya
Hàua héhehe héya héya
Hà ‘hayà éaheòo éaheòo éaheòo éaheòo.
Il fatto che tale tipologia di rituali sia generalmente accompagnata ai fondamentali avvenimenti "biologici" o "naturali" della vita dell'individuo (nascita, pubertà, morte, etc.) non significa che essi rappresentino una mero atto di accettazione di tali eventi. Il rituale è un potente atto sociale che proprio nel momento in cui l'ordine sociale viene alterato dagli eventi naturali ricrea un nuovo stato sociale, differente da quello precedente. È un atto creativo che costruisce la realtà, che produce i mutamente sociali, non che li segue. Nello stadio finale della ‘riaggregazione’ l’individuo viene reintrodotto nella società con la nuova posizione, inteso come movimento da un tipo di persona all’altro (nuovo). Qui entra in campo una nuova figura che ha dato un notevole contributo alla comprensione dei ‘riti di passaggio’: Victor Turner (*) che ha concentrato la sua opera principale “Il processo rituale” sul periodo di transizione, considerato importante sia per il rito in sé, sia per la vita sociale in genere e che Van Gennep aveva chiamato ‘liminare’. Come osserva Turner, il simbolismo che accompagna il rito di passaggio esprime uno stato ambiguo, pur sostenendo che tutte le società hanno bisogno tanto di un qualche genere di struttura, pari a un legame umano generico ed essenziale, senza il quale non ci sarebbe nessuna società:
«La liminalità, è di frequente assimilata alla morte, allo stare nell’utero, all’invisibilità, alle tenebre, alla bisessualità, alla selvatichezza e a un’eclisse di sole o di luna. Le persone in stato liminale tendono a sviluppare un intenso cameratismo, che cancella o svuota le distinzioni precedenti».
Turner chiama questa modalità di relazione sociale ‘communitas’, da intendersi come comunità di eguali poco o per nulla strutturata. Nel contesto rituale degli Indiani d’America quello della ‘communitas’ consiste di fatto nella comune umanità che sottende la società e la cultura tutta. Ciò porta a considerare in termini più generali i processi rituali come tali, e in particolare la fase ‘liminale’ dei ‘riti di passaggio’ i cui partecipanti si muovono tra stati e condizioni sociali antecedenti e susseguenti.
«All’apice della comunità – scrive Carl G. Jung (*) – c’è la parola ‘parlata’ ancor prima che scritta, e ovviamente il linguaggio dei segni, oltre i quali entriamo nel mondo dei ‘simboli’ intesi come sostituzione di un parlare limitato che diventa illimitato se ad essi diamo connotati specifici in aggiunta al loro significato ovvio e convenzionale. Quel poco di più, o forse tanto, che in essi c’è di vago, di sconosciuto o di inaccessibile per noi, ma che tuttavia implica qualcosa che sta al di là del suo significato più immediato quanto ‘inconscio’ che non è mai definito con precisione o compiutamente spiegato, e che raggiunge il limite della certezza al di là del quale la sua conoscenza non può procedere».
Ma non è tutto, nel parlare del concetto di ‘inconscio collettivo’ Jung pone al centro quella che prenderà poi nome di ‘psicologia analitica’ a fondamento della sua scuola di pensiero. E che aprirà le porte a “La psicologia del transfert”, e agli “Archetipi e l’inconscio collettivo”, che tanto riguardano le manifestazioni nei miti, nei sogni, nell’arte figurativa. Scrive Luigi Aurigemma (*) nella premessa a “Archetipi”:
«È noto come i concetti di ‘archetipo’ ed ‘inconscio collettivo’ occupino un posto centrale nella riflessione di Jung, che ha esercitato su di essi un continuo sforzo di approfondimento che ha portato a un vero rovesciamento della dimensione psichica, vista non più come l’appendice personale dell’organizzazione biologica, ma come l’aspetto significante degli istinti, la possibilità di rappresentarne il dinamismo».
Infine, ma come ho detto non in ultimo, va qui ascoltato Sigmund Freud (*) che nel suo “Totem e tabù” introduce uno dei temi lapalissiani della società ‘primitiva’, il cui testo è quantomeno illuminante. Nella vita sociale tribale, e il fenomeno è analogo presso tutti i popoli primitivi, ‘totem’ è considerato l’animale sacro, (il palo scolpito o inciso presso gli Indiani dell’America del Nord), il progenitore e lo spirito protettore del clan (villaggio e comunità che lo abita). Ucciderlo è gravissimo: è “tabù”, per cui “..tradire la voce del sangue della propria tribù, è un’audacia che dev’essere presto o tardi, pagata” (Jung). Tuttavia il tabù non ha per oggetto il solo totem, esso difende con una cortina invisibile i re, i sacerdoti, i morti, e si estende anche alle donne che non possono avere rapporti sessuali con membri della stessa tribù. Nella psiche del primitivo, è oggetto di venerazione poiché, nel cammino a ritroso verso una probabile origine, sfocia nella religione delle origini, concorde con la vita psichica dei selvaggi dell’esistenza di forze soprannaturali – “l’importanza di un sostituto credibile del mito biblico del peccato originale” (Karoly Kerényi).
Perciò gli etnologi hanno inventato un’altra teoria per spiegare il comportamento dell’uomo primitivo: la teoria dell’animismo, totemismo per gli Indiani d’America, e la ‘forza del mana’. Per questo, essere ancora immerso completamente nella natura, egli come anche tutte le cose, ha un’anima, sono viventi, e perciò capaci anche di azioni autonome che possono essergli favorevoli o sfavorevoli.
‘Poesia sonora n.2’ – Tribù Seneca (*)
gah non uey yo hei
yah ney heeyo
no heyah heyah
yah ney heeyo
ho uey yah heenay
yah ho ho yo
o ho uey yo hey
yah ney heeyo
no heyah heyah
yah ney heeyo
yah ney heeyo
ho uey yah heenay
Scrive l’antropologo Giovanni Vignola (*): «La magia connessa al To-tem non è altro che un’azione per favorire al massimo gli eventi benefici e neutralizzare quelli malefici. Tutto sta nel saper dominare, comandare, sottomettere ai nostri voleri, l’anima di quelle determinate cose che possano risultare utili o dannose. Rapportata ai tempi in cui il mondo umano era, per così dire, avvolto in un’atmosfera satura di magia, non esitiamo a definire le stesse pratiche magiche come il primo tentativo scientifico che l’uomo ha condotto per dominare la natura secondo le proprie esigenze. (..) Questa potenzialità insita nel ‘mana’ (parola di origine polinesiana) che gli studiosi hanno definito ‘forza ambigua’ per la sua capacità di produrre sia il bene che il male, non è riservata ai soli soggetti umani, ma si estende anche alle cose. In breve tutto ciò che esiste ha il suo ‘mana’. Lo spirito umano di tutti i tempi soggiace al fascino di questa forza misteriosa. I selvaggi troveranno questa potenza espressa al massimo grado in una freccia che saetta verso il suo obiettivo, in una lancia scagliata contro il nemico, in un fulmine che colpisce e incendia un albero, in una bestia feroce che assalta e divora un membro della loro tribù, per non parlare del ‘mana’ sessuale».
Così, l’assenza e il richiamo dello spirito (ancestrale), diventa un pericolo da scongiurare, un ‘tabù’ da esorcizzare con riti e sacrifici tribali. Nella teoria preanimistica il ‘tabù’ è considerato come fenomeno correlato a quello del ‘mana’, di cui costituirebbe l’aspetto negativo: il ‘mana’, infatti, sarebbe una carica di potenza sovrannaturale positiva per chi la possiede, e soggetta a cautela sacrale per gli altri che, venendo a contatto con essa, ne possono essere annientati. Questa ambivalenza della ‘potenza’ è stata messa in rapporto con quella del sacro in generale. Infatti il ‘tabù’ risulta inseparabile da un bisogno di scissione tra sacro e profano, ed è precisamente dalla necessità di conservare il sacro incontaminato dal profano che deriva la convinzione della pericolosità del sacro e da questa l’istituzione del ‘tabù’. Presso gli Indiani d’America, ad esempio, la convinzione è così forte che non c’era più bisogno di punire la violazione del ‘tabù’, poiché il trasgressore involontario, rendendosi conto di quanto aveva fatto, cadeva ammalato o moriva. In altro caso, lì dove esisteva anche la punizione, questa mirava soltanto a eliminare il trasgressore con la morte o l’esilio, poiché automaticamente era divenuto impuro e quindi fonte di contaminazione per la società.
‘Canto degli Indiani del Nuovo Messico’ (*)
Perché io guarisca
lo stregone ha dipinto
l’immagine tua sul deserto:
dorata sabbia per i tuoi occhi,
sabbia rossa per la tua bocca,
azzurra sabbia per i tuoi capelli,
sabbia bianca per le mie lacrime.
Tutto il giorno ha dipinto,
tu come dea crescevi
sull’immenso canovaccio giallo.
Di sera il vento disperderà
la tua ombra multicolore.
Secondo la legge, nella ne resta,
nulla oltre il simbolo delle mie lacrime:
la sabbia d’argento.
Scrive Hyemeyohsts Storm (*), artista, scrittore e oratore indiano meticcio della tribù dei Cheyenne del Montana, sulla “teoria del cerchio”, diffusa in tutte le tribù Nordamericane:
«Tutte le cose che noi percepiamo stimolano la fantasia individuale in modo diverso, cosa che contribuisce a creare un’interpretazione originale di ciò che si è appreso e che resterà sempre unica. Amore, odio, paura, confusione, felicità, invidia e tutte le altre emozioni che possiamo provare agiscono su di noi dipingendo la percezione delle cose con colori diversi. Se, ad esempio, nel mezzo di un cerchio poniamo un’astrazione come un’idea, un sentimento o una filosofia, le nostre percezioni di essa sarebbero ancora più complicate che se si trattasse di una cosa tangibile. E inoltre, i modi di percepire quell’oggetto o quell’idea aumenterebbero se altre persone si unissero a noi nel cerchio. La percezione di qualsiasi oggetto, tangibile o astratto, è resa in definitiva mille volte più complessa quando l’oggetto è visto nel cerchio formato da tutto un Popolo nella sua totalità».
Capire questa verità è la prima lezione della ‘Ruota di Medicina’, ed è parte vitale dell’insegnamento della ‘Danza del Sole’, della quale abbiamo ampiamente trattato. Per molti aspetti quest’ultima può essere meglio compresa se ce la immaginiamo come immersa in uno specchio di luce nel quale riflettono tutte le cose:
«L’Universo è lo Specchio del Popolo, ci dicono gli antichi insegnanti e, ognuno di noi costituisce uno Specchio per gli altri».
Fatta nostra questa affermazione, apprendiamo che ci sono molti e diversi livelli di prospettiva che dobbiamo considerare quando cerchiamo di capire quale sia la percezione che abbiamo delle cose o quando cerchiamo di rapportare tali percezioni a quelle dei nostri fratelli e sorelle. Ciascuna delle nostre precedenti esperienze può infatti influenzare la prospettiva mentale con la quale guardiamo il mondo intorno a noi. Storm prosegue:
«Qualsiasi idea, persona o oggetto, può essere per l’uomo una Ruota di Medicina, uno Specchio: può esserlo un fiore minuscolo, oppure un lupo, una storia, un contatto, una religione o la cima di una montagna. Per esempio, può capitare che una persona abbia paura trovandosi da sola di notte sulla cima di una montagna, mentre magari un’altra può provare un senso di pace e di calma, una terza sentirsi sola e una quarta non provare alcuna sensazione: in ciascun caso, è chiaro che la cima della montagna è sempre la stessa, ma viene percepita in maniera diversa in quanto riflette le sensazioni della persona che ne ha fatto esperienza. (..) I nostri Insegnanti solitamente costruiscono la Ruota di Medicina servendosi di piccole pietre e sassolini che dispongono sul terreno in un cerchio grande attorno ad uno più piccolo raggiato che suddivide lo spazio interno. Ciascuno dei sassolini entro all’interno della Ruota di Medicina rappresenta una delle tante cose dell’Universo. Un sassolino rappresenta te (seconda persona), e un altro rappresenta me (in prima persona), altri contengono le nostre madri, padri, sorelle, fratelli e i nostri amici. Altri simboleggiano falchi, bisonti, alci e lupi; altri ancora rappresentano religioni, governi, filosofie, persino interi popoli. Nella Ruota di Medicina sono contenute tutte le cose e dentro di essa tutte sono uguali. La Ruota di Medicina è l’Universo Totale. I nostri Insegnanti ci dicono che tutte le cose all’interno della Ruota dell’Universo conoscono l’Armonia e sanno come Donare l’uno all’altro, tranne l’uomo. Fra tutte le creature dell’Universo, infatti, noi soli cominciamo il cammino della vita senza conoscere questa grande Armonia».
Storm inoltre, ci avverte che il primo Insegnamento che un bambino del Popolo delle Pianure riceve, concerne i Quattro Grandi Poteri della ‘Ruota di Medicina’:
«Tutte le cose della Ruota di Medicina dell’Universo hanno spirito e vita, inclusi i fiumi, le rocce, la terra, il cieli, le piante e gli animali, ma solo l’uomo, fra tutti gli Esseri della Ruota, possiede la capacità di discernere. Tale capacità, però può essere completa solo se prima abbiamo imparato l’Armonia con i nostri fratelli e le nostre sorelle e con tutti gli altri Spiriti dell’Universo. Per fare ciò, occorre che impariamo a cercare e a percepire, in modo da trovare il nostro posto all’interno della Ruota di Medicina. Ma per trovare questo posto dobbiamo soprattutto imparare a Donare. La Ricerca della Visione, o ricerca di un modo di percepire le cose, è il modo in cui dobbiamo iniziare questa ricerca. Tutti quanti dobbiamo sottoporci alla nostra Ricerca della Visione per scoprire noi stessi, per capire in che modo percepiamo noi stessi e per trovare la relazione che ci lega al mondo che ci sta attorno».
Un insegnamento questo che continua per l’intero libro illustrato dal titolo: “Sette Frecce”, di Storm, che ci spiega quello che è il messaggio universale della cultura degli Indiani dì America, la loro saggezza intrisa di armonia e spiritualità legati ai Quattro Grandi Poteri della ‘Ruota di Medicina’ strettamente legati ai Quattro Punti Cardinali, rispettivamente: Nord ‘Saggezza’ o del Bisonte Bianco; Est ‘Illuminazione’ o dell’Aquila e del Giallo’; Sud ‘Innocenza’ o del Topo e del Verde; Ovest ‘Introspezione’ o dell’Orso e del Nero. E inoltre, ciò che riguarda i ‘Nomi’, il ‘Toccare’, gli ‘Scudi’ con i quali èspiegata la ‘danza del Sole’:
«Per capire la danza del Sole, dobbiamo prima penetrare il significato degli Scudi, il cui potere abbiamo ricevuto dai nostri Padri e dal Potere di Medicina il Grande Sipito. È il dono di Miaheyyun a tutti noi, perché possiamo apprendere e diventare insieme Danzatori del Sole. In origine c’erano Dodici Scudi Sacri che una volta all’anno, in occasione del Rinnovamento, venivano riuniti tutti insieme e posti all’interno dei Dodici Pali Biforcuti, che formavano il cerchio più esterno della Tenda della Danza del Sole, la Tenda del Popolo … anche la Via della Danza del Sole è qualcosa di vivo, che cresce e che viene dall’aver toccato e sperimentato tutte le Quattro Grandi Direzioni».
Racconto: “Prima di infondere la vita nelle cose parlarono” (di Lucario Cuevish).
Terra distesa i piedi verso Nord la testa verso suo fratello Cielo seduto alla sua destra domandò: Si sorella devi dirmi che sei. Ella rispose sono Tomaiyowit. Gli chiese chi sei tu? Rispose sono Tukmit. Poi ella disse:
Mi stendo piatta fino all’Orizzonte.
Tremo provoco un rumore simile al tuono.
Sono Terremoto.
Sono rotonda e roteo.
Scompaio e riappaio.
Poi Tukmit disse:
Mi inarco su di te e ti ricopro.
Ti orno come un cappello.
Mi innalzo sempre di più.
Sono la morte afferro con un sol morso e ingoio.
Ghermisco gli uomini ad oriente e li disperdo.
Morte è il mio nome.
Poi infusero la vita nelle cose tutte.
Arrivati qui dove siamo, avrei voluto trascrive alcune delle molte storie che ho appreso nel mio lungo excursus nel mare di libri, fascicoli, illustrazioni, registrazioni e note di cui sono sommerso, ma data la loro lunghezza, pensate che possono durare anche per interi giorni, capite anche voi che ciò non è possibile, quindi ho optato per alcune poesie e canti di più facile consumo, come quelli che avete letto e che penso di inserire anche in questa seconda parte. Tuttavia l’invito a documentarvi e a rivivere un po’ quella che è la ‘vita’ degli Indiani d’America, resta valido e accetterei di buon grado suggerimenti e contributi che potrete aggiungere come commenti in chiusura di questo lungo articolo su questo stesso sito. Siete i benvenuti. Il mio suggerimento rimane comunque quello di visitare la bibliografia e discografia che sono solito aggiungere in chiusura del mio lavoro che da sola già si presenta copiosa.
In ultimo, e vorrei qui riprendere da principio, in ragione del fatto che numerosi ostacoli si frappongono all’indagine accurata e sicura dell’etnologo, sopratutto il tempo, la lontananza dai fatti raccolti per lo più narrati oralmente quando ormai non c’era più nessuno a confermarli o, viceversa, a contestarli. Oggigiorno tutto risulta più o meno artefatto, coreografico, con aggiunta di elementi di affetto, lontano dalle sue origini quanto lo può essere una nostra processione nei confronti di una sacra rappresentazione medievale. Per rispetto dell’obiettività, prima di procedere oltre nell’esemplificazione necessaria per quella che possiamo definire la ‘cultura rimasta’ dobbiamo accontentarci di quello che la cultura del vincitore ha lasciato trapelare fino a noi. Anche se va detto che oggigiorno è possibile muoversi, seppure in un percorso non proprio agevole, attraverso quello che è un vero e proprio labirinto di informazioni. Il quadro d’insieme si presenta sintomatico già dalla avvenuta disgregazione della tribù. L’Indiano vestito all’europea, appartiene da tempo alla categoria degli ‘urbanizzati’, si ostentano nuove abitudine, nuovi vestiti, nuovi comportamenti con una punta di disprezzo o di bonaria ironia verso gli usi che fino a qualche tempo prima erano stati i loro e che per amore di autenticità non vorremmo vedere.
Come scriveva il vecchio e sempre valido James G. Frazer (*) nel suo libro ‘cult’ “Il Ramo d’Oro”:
«Sarebbe ingrato a questo punto quanto antifilosofico stigmatizzare queste premesse come ridicole per la ragione che noi possiamo scoprirne facilmente la falsità. Noi stiamo sulle fondamenta erette dalle generazioni che ci hanno preceduto e possiamo solo debolmente apprezzare quanto siano costati all’umanità i suoi penosi e prolungati sforzi per alzarsi sino al punto, non molto alto in fin dei conti, che abbiamo raggiunto. (..) Il disprezzo, il ridicolo, la ripugnanza e il biasimo sono troppo spesso il solo riconoscimento concesso al selvaggio e ai suoi costumi. Tuttavia tra i benefattori che siamo tenuti a commemorare con riconoscenza, molti, o forse i più, erano i selvaggi. Perché, in fin dei conti, le nostre somiglianze con i selvaggi sono ben più numerose delle differenze; e quello che abbiamo in comune con loro e che riteniamo vero e utile lo dobbiamo ai nostri progenitori selvaggi che acquistarono lentamente con l’esperienza e ci tramandarono in eredità quelle idee apparentemente fondamentali che siamo portati a considerare come originali e intuitive. Noi siamo come gli eredi di una grande fortuna tramandata da tanti secoli che si è persa la memoria di quelli che l’hanno costruita, sicché i possessori del momento la considerano come possesso originale e inalterabile della loro razza. (..) La riflessione e la ricerca dovrebbero convincerci che dobbiamo ai nostri predecessori molto di ciò che credevamo più nostro e che i loro errori non erano volute stravaganze o pazzie, ma semplicemente ipotesi ingiustificabili dato il tempo in cui erano proposte e che una più piena esperienza dimostrò inadeguate. È solamente dopo la successiva prova delle ipotesi e l’eliminazione del falso che può alla fine emergere la verità, e soprattutto ricordarci che dobbiamo dar loro il beneficio dell’indulgenza di cui un giorno noi stessi potremo avere bisogno: cum excusatione itaque veteres audienti sunt».
Tuffiamoci quindi nella storia più recente e recuperiamo il punto da dove avevamo lasciato; cioè dall’incontro/scontro tra due razze e dell’incomprensione fra le due diverse culture. recenti studi antropologici prima etnologici poi consentono oggi di approfondire, e in certi casi, comprendere, quella che è stata l’evoluzione musicale degli Indiani d’America, come è dimostrato in un’antologia musicale ad essi riferita curata da Alberto Paleari (*), musicista e studioso di musica etnica riferita ai popoli primitivi:
«Da un punto di vista metodologico di studio, la musica dei popoli originari dell’America del Nord viene compresa nella cosiddetta musica dei ‘popoli primitivi’. (..) E si riferisce al contesto socio-culturale entro cui tale musica si manifesta: infatti, normalmente non è eseguita da musicisti professionisti, (almeno nell’accezione comune del termine) e si vuole appartenga a quelle comunità che si trovano in uno stadio precedente alla cultura scritta. (..) A differenza della Musica Folkloristica, la Musica Primitiva è indipendente, come dire, a sé stante, cioè non trova collocazione all’interno di nessun’altra cultura ma è assolutamente autonoma. Mentre alla prima appartiene tutta la cosiddetta Musica Popolare (i canti dei contadini europei ne sono il primo classico esempio), nella seconda rientrano le manifestazioni musicali delle popolazioni indigene africane, australiane, sudamericane e nordamericane. Come si vede per definire la Musica Primitiva ci si deve riferire ad un parametro storico-sociale e non ad uno strettamente stilistico-musicale, dato che a tale genere di musica appartengono stili diversissimi, che nulla hanno in comune fra loro. Si deve inoltre sottolineare che il termine ‘primitivo’, qui riferito alla musica, ha un valore strettamente funzionale e non storico, dal momento che non vi sono affatto elementi per riconoscere in molte manifestazioni di questa musica i primordi ‘primitivi’ della civiltà musicale; anzi, ad esempio, troviamo del materiale musicale (come quello dei Pueblo nordamericani) che è senza dubbio il risultato di un lungo e raffinato processo evolutivo.
Musica primitiva vuole semplicemente indicare che si fa riferimento al prodotto di una civiltà che non conosce la cultura scritta, che è ‘preletteraria’. È quindi anche da sfatare categoricamente il luogo comune che vuole inchiodare tutto il patrimonio culturale ed espressivo di questi popoli in una, in verità poco credibile, staticità assoluta. I diversi caratteri della musica degli Indiani Nordamericani, Canadesi ed Eschimesi, dimostrano che non è così, in quanto possono essere rintracciati nella netta prevalenza di acculturazione reciproca secondo uno schema che segue quello delle ‘aree culturali’ di riferimento. La distribuzione degli strumenti musicali, sovente unita al altri culturali, aiuta nella delimitazione delle aree culturali, in genere assai più collegata nella loro globalità di quanto non lo siano gli stili musicali. Questi, possono essere inizialmente rintracciati nella netta prevalenza di strumenti essenzialmente ritmici (tamburi di vario genere e sonagli) e nel tono aspro dell’emissione canora. Dal punto di vista vocale si può ancora aggiungere la notevole tensione degli organi ad essa devoluti, la mancata accentazione e le note sovente tenute; le melodie sono poi in maggioranza costruite secondo uno schema ‘discendente’, dai toni alti a quelli più bassi.
Più in particolare, si rileva come la maggior parte dei canti si sviluppino entro l’ambito di una scala ampiamente usata, quella pentatonica. Quasi tutti i canti sono monofonici, mentre la polifonia è praticamente assente, ad eccezione dell’uso (assai raro, comunque) di una nota fissa in funzione di bordone, o là dove le donne accompagnano il canto degli uomini, il che succede molto di rado. I canti sono per lo più strofici, e ogni strofa si divide in un numero di strofe variabile (da due a dodici) di parti minori che non sono quasi mai di lunghezza uguale ma, anzi, tendono a diventare più lunghe man mano che il canto va verso la conclusione. Nei testi è sempre presente una parte formata da sillabe senza significato (a volte tutto il canto è senza significato letterario) e per i canti vengono ancora usate parole o espressioni che sono ormai uscite dal linguaggio comune, creando così uno squilibrio fra la lingua parlata e quella cantata. Gli strumenti musicali svolgono soprattutto una funzione ritmica: rarissimi sono gli strumenti ed i brani strumentali melodici. Prima dell’arrivo degli Europei gli strumenti a corda erano per lo più sconosciuti, con la sola eccezione, (ma non del tutto accertata) dell’uso dell’arco da caccia, anch’esso impiegato come strumento ritmico. In pratica l’unico strumento melodico di una certa diffusione fu il flauto, usato soprattutto nel corteggiamento. In ogni caso il flauto non veniva mai usato per accompagnare il canto. Altri strumenti a fiato abbastanza diffusi furono i fischietti. Ovviamente invece sempre presenti erano gli strumenti ritmici, sia tamburi che sonagli di varia foggia o bastoni. I tamburi potevano essere sia completamente di legno (idiofoni), che ricoperti da una o due pelli (membranofoni).
In conclusione, la musica aveva una funzione assolutamente essenziale nella vita cerimoniale degli Indiani, sia in sé che come accompagnamento alle danze. Qui la presenza della donna è quasi sconosciuta ed è comunque sempre relegata ad un ruolo secondario: depositari dell’attività musicale in tutti i suoi stadi (dalla composizione all’esecuzione, alla costruzione di strumenti) erano gli uomini. Una delle rare eccezioni si trova nelle ninne-nanne. Le donne comunque disponevano di un proprio repertorio di danze e di canti, complessivamente più omogeneo di quello degli uomini e nel quale si nota una minore ‘drammaticità’. In ogni caso si può notare come in linea generale la musica accompagni praticamente tutta l’attività degli Indiani, e ne sottolinei – anche come componente rituale – tutti gli aspetti e comunque il metro in base al quale gli Indiani stessi valutano la loro musica è strettamente correlato alla prospettiva ‘funzionale’ in cui la inquadrano: la musica non deve essere ‘bella’ ma ‘utile’. Non mancano tuttavia esempi – anche se rari – di musica in cui si trova la presenza non secondaria di una soddisfazione estetica».
Ma vediamo di ricapitolare a quale punto di approdo siamo pervenuti dall’inizio di questa ricerca, avendo qui sperimentato un modo di procedere atipico della materia etnomusicologica. Per ovvie ragioni non poteva essere esaustiva, bensì un’infarinatura generalizzante sulla cultura degli Indiani d’America che presupponeva e perciò includeva la società nella sua analisi, più di quanto l’analisi della società tenda a prolungarsi nello studio sistematico della cultura. Quello che abbiamo fin qui appreso è probabilmente ciò che l’aspetto basilare o, comunque, quello che originariamente emerge per primo nell’evoluzione testuale dei canti e delle danze che li diversificano da ogni altre popolo. Al dunque possiamo certamente affermare che la cultura di questi popoli è per certi versi un qualcosa di più ampio della società tribale in cui essa si è formata, al punto che sembra essere suscettibile di una gamma più ampia di cambiamenti. Una cosa è certa: i ‘primitivi’ americani e le loro culture resteranno probabilmente l’interesse primario degli etnomusicologi dato che nessun altra disciplina sembra all’altezza di assumersi questa responsabilità, in primis perché l’antropologia ufficiale, al momento, non sembra preoccuparsi di loro, né vede in essi il diritto originario della loro autonomia intellettuale.
Protagonista di centinaia di romanzi, film, cartoon, per lungo tempo simbolo del selvaggio astuto e crudele, l’Indiano d’America è fin dall’inizio un ‘mito’ negativo. Il mito del West, delle scorribande e delle guerre più volte immortalate da Hollywood in kilometri di celluloide, che non ha certo reso giustizia alla sua autonomia e al diritto di esistere. Si è dovuto aspettare film come ‘Piccolo Grande Uomo” di Arthur Penn, per far cadere l’eroe dalla giubba blu dal suo piedistallo; film quali “Un Uomo chiamato Cavallo”, “Willie Boy”, “Soldato Blu” o “Indians” prima che la società americana e il resto del mondo dei ‘visi pallidi’ scoprissero un volto dell’Indiano più vicino alla realtà di quello propinato da decine di western pre-confezionati. Tant’è che è bastata un’apparizione alquanto simbolica della figura dell’Indiano nel film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, a far comprendere, al più vasto pubblico internazionale, il senso di una identità che sfugge alle trame dell’attuale società destinata a perdersi per sempre.
Diversamente, e molto più tardi, l’editoria ha sfoggiato libri di un certo valore contenutistico che in breve sono divenuti veri e propri best-seller internazionali, come nel caso di: “Seppellite il mio cuore a Wounded Knee” di Dee Brown, in cui raccolse le testimonianze dell’avvenuta distruzione della cultura e della società dei pellerossa, vista come un ostacolo al trionfo della nuova civiltà, andando alla ricerca delle fonti storiche andando e avviando l’esame critico degli avvenimenti, oltre alla stesura di una narrazione davvero coinvolgente. In un altro libro divenuto famoso: “Memorie di un guerriero Cheyenne”, Thomas B. Marquis raccolse una preziosa descrizione dei costumi e dei riti del popolo Cheyenne dai testimoni oculari della clamorosa battaglia di Little Big Horn. In “Sul sentiero di guerra”, l’autore che abbiamo già apprezzato, Charles Hamilton, offerse preziose testimonianze della cultura degli Indiani d’America penetrando il pensiero indiano e cogliendone l’estremo interesse della loro cultura.
L’elenco potrebbe non finire mai, ma fra i molti che occupano lo scaffale delle librerie mi sento di indicarne almeno uno in particolare: “Il Lungo Inganno” di Lucio Ranucci (*) che presenta, per la prima volta, e potrebbe essere una riscoperta, una sintesi storico-fotografica del vero dramma vissuto da questo popolo e che non può fermarsi solo alla semplice presa di coscienza. Lo sguardo che noi abbiamo fin qui gettato oltreoceano vuole essere una conferma che non sono stati dimenticati e che, proprio attraverso questa rivisitazione non mistificata dalla storia che ci viene raccontata, vuole ritrovare un senso, quello di restituire loro la propria dignità di esseri umani e riconoscere ad essi la propria identità. All’insegna di questa speranza, mai venuta meno, si leva alto il grido della ‘Danza degli Spettri’ che preannuncia il ritorno del bisonte e della selvaggina, il ritorno dei guerrieri uccisi:
“We shall live again” (da ‘Ghost Dance’ di Patty Smith).
… noi vivremo ancora, noi vivremo ancora
noi vivremo ancora e ancora, e ancora.
Il giorno in cui gli déi torneranno!
Bibliografia:
Campbell Grant, “L’Arte Rupestre degli Indiani Nord-Americani” in “Le Orme dell’Uomo” – Jaca Book 1983.
George Catlin, “Indian Art in Pipestone” - Portfolio in The British Museum – Smithsonian Institution Press – City of Washington 1979.
Dean Snow, “The American Indians: Their Archeology and Prehistory” – Thames and Hudson –London 1976.
J.C.H. King, “Thunderbird and Lightning: Indian life in Northeastern North America 1600-1900” – Museum of Lankind – London 1982.
Jaime De Angulo, “Indian Tales” – New York 1940. “Racconti Indiani” – Adelphi 1973.
Aldo Celli, “Canti Indiani del Nord-America” - Firenze 1959.
Eckart v. Sydow, “Poesia dei popoli primitivi” - Parma, 1951.
Joyce Sequichie Hifler, “Diario Pellerossa: L’eredità spirituale degli Indiani d’America” - ….
Alfonso M. di Nola, “Canti dei Primitivi” – Garzanti 1961.
John G. Neihardt, “Alce Nero parla” – Adelphi 1968.
Note:
(*) Carleton S. Coon, “The Hunting Peoples” 1971; e in “I popoli cacciatori” – Bompiani 1973.
(*) Alfred L. Kroeber, “Antropologia” – Feltrinelli 1983.
(*) AA.VV. a cura di Franco Meli, “Canti e Narrazioni degli Indiani d’America” – Guanda 1978.
(*) Dal “Walum Olum” – Indiani Delaware
(*) Canti – Indiani Chippewa
(*) Charles Darwin, “Le origini della specie” – Rizzoli/Bur 2009.
(*) Konrad Lorenz, “L’Anello di Re Salomone” – Adelphi 1979.
(*) Carl G. Jung “L’Uomo e i suoi Simboli” – Longanesi 1980.
(*) Raffaele Pettazzoni, Prefaz. a “Enciclopedia della Leggenda”- UTET 1957.
(*) Mircea Eliade, “La nostalgia delle origini” – Morcelliana 1972.
(*) Arnold Van Gennep, “I Riti di Passaggio” – Boringhieri 2006.
(*) Victor Turner, “Il processo rituale” – Morcelliana 1972.
(*) Carl G. Jung, “La psicologia del transfert”, in “Opere” Vol. VIII - “Gli Archetipi e l’inconscio collettivo”, in “Opere” Vol.IX – Boringhieri 1980.
(*) Luigi Aurigemma, “Premessa ad Archetipi di Jung” (op. cit.)
(*) Sigmund Freud, “Totem e Tabu” – Boringhieri 1969.
(*) Giovanni Vignola, “Riti di iniziazione” – “Riti magici di ieri e di oggi” – De Vecchi Ed. 1972.
(*) Hyemeyohsts Storm, “Seven Arrow” – HarperCollins 1972; “Sette Frecce” – Corbaccio 1997.
(*) James G. Frazer, “Il Ramo d’Oro” –Boringhieri 1973.
(*) Alberto Paleari, in Michael I. Asch, (vedi disc.).
(*) Edward Evans-Pritchard, “I Popoli della Terra: America Settentrionale” Vol. 17 – Arnoldo Mondadori Ed. 1974.
(*)Lucio Ranucci, “Il Lungo Inganno” – Savelli 1978
Discografia:
Michael I. Asch, “Musica degli Indiani e degli Eschimesi dell’America del Nord” – Antologia di musiche e canti a cura di Alberto Paleari. 2LP Albatros – Folkways Records – 1974.
Willard Rhodes c/o The United State Office of Indian Affairs, “Musica delle tribù Indiane d’America Sioux & Navajo” – LP Albatros – VPA 8441.
La Voce dei Poeti: “Canti Indiani del Nord America” letti da Lina Volonghi – LP Fonit-Cetra LPZ 2070.
D. Hamilton, L. Clancy, P. Clayton, “Musica Strumentale degli Appalachi” - LP Albatros – VPA 8301-
“Yaqui: Music of the Pascola and Deer Dance” – LP Canyon Records C-6099.
R. Carlos Nakai, “Desert Dance” – CD Celestial Harmony 13711 30332.
“Sacred Spirit” (Canti degli Indiani d’America) – 2CD Virgin 841245.
Meridiani Musicali: “Canti tra Terra e Cielo” – CD Editoriale Domus/Red Ed. n.88.
Musiche dal Mondo: “America: Musica dei Nativi Americani” – CD Fabbri Editori/Amiata Rec.
The Golden Collection: “Flue Music of the American Indian” and “Traditional Chants and Spiritual Songs” - RCD2.
XIT – (discografia)
LP “Plight of the Readman” 1972
“Silent Warrior” 1973
“Relocation” 1977
“Entrance” 1994
“Without Reservation Wante Alive” CD 2009
Robbie Robertson, “Music for the Native Americans” – CD Capital 28295 2.
Patty Smith, “Ghost Dance” - CD
*
 - Musica
- Musica
Etnomusica 8: Viaggio nella Musica dei Popoli
“Viaggio nella Musica tradizionale dei Popoli”, di Giorgio Mancinelli.
Si è già parlato di come, mettendo deliberatamente insieme persone di diversa tradizione culturale, la “ricerca sul campo” etnografica fa sì che malintesi, intese e sorprese del genere siano all’ordine del giorno, ma è con simili incontri, e con molti altri, che la ricerca produce gran parte di quanto gli antropologi arrivano a conoscere su gente di altre società. La raccolta dei dati nel corso di un lungo periodo passato a stretto contatto con i membri di un’altra società, considerata ‘osservazione partecipante’, fondamentale nel fornire dati sull’interazione sociale, di quelle che sono le credenze e i valori culturali di una società propriamente formata. Senz’altro il metodo migliore a disposizione di ricercatori e studiosi che aspirano alla comprensione olistica della cultura e della condizione umana. Per la maggioranza degli antropologi culturali la ricerca sul campo (musicologica, sociologica ecc.) è l’esperienza etnografica che caratterizza l’intera disciplina. Pertanto, ogni singola forma di ricerca a qualsiasi livello, anche elaborata, purché veritiera, cioè inconfutabile perché raccolta da fonti attendibili e documentate, ha ragione di essere svolta e trascritta, affinché nulla vada perduto di quanto l’umanità ha prodotto in seno alla formazione, crescita e avanzamento della propria cultura.
Due sono i termini delle scienze sociali per indicare questo processo di sviluppo cognitivo culturale e sociale che il ricercatore deve tenere sempre presenti: socializzazione e inculturazione. Il primo, socializzazione, mette a fuoco i problemi organizzativi che si pongono agli esseri umani in quanto organismi materiali che devono vivere insieme e far fronte alle regole di condotta sancite dalle rispettive società. Il secondo termine, inculturazione, mette a fuoco i problemi cognitivi incontrati da esseri umani che vivono insieme e devono venire a patti con i modi di pensare e di sentire ritenuti appropriati nelle rispettive culture. Serve quindi ascoltare simultaneamente al pensare e all’agire partecipando alle attività caratteristiche riscontrate nel gruppo umano o area culturale che si vuole conoscere, per poterla poi rappresentare, scrivere, o anche agire con l’esperienza stessa. L’opera di socializzazione/inculturazione in realtà produce un ‘sé’ socialmente e culturalmente costruito, non sempre in grado di definire se stesso come identità definita, pertanto necessita di una conoscenza approfondita della teoria olistica dello sviluppo cognitivo, per poter svolgere i compiti richiesti, nella fase di sviluppo della specifica società che il ricercatore tiene sotto osservazione. La distinzione è utile per l’antropologia, perché consente di descrivere le somiglianze e le differenze che si osservano comparando i modi di pensare e sentire nelle diverse culture. la scoperta del mondo in tale contesto non è attività solitaria ma, al contrario, va di pari passo con l’apprendimento delle forme simboliche (di solito la lingua) usate dagli altri per rappresentare il mondo.
Alcune tra le ricerche più interessanti nell’ambito dell’antropologia cognitiva, furono svolte da G.H.Mead (*) e Lev Vygotskij (*), le cui ricerche hanno rivelato che la vita umana è sociale sin dal principio e l’identità individuale si acquista solo nel contesto sociale. Come scriveva Vygotskij. «La dimensione sociale della coscienza è primaria sia cronologicamente che oggettivamente. La dimensione individuale della coscienza è derivata e secondaria». Come Vygotskij, Mead credeva che « ..lungi dal conculcare e danneggiare la natura umana, la socializzazione e l’inculturazione la completino ed esaltino». Infatti, il segreto dell’umanizzazione sta nella padronanza dei simboli, che comincia quando si impara a parlare: «È con il controllo dei sistemi simbolici della cultura che si acquisisce la capacità di distinguere gli oggetti e le relazioni che popolano la realtà e, soprattutto, si impara a vedersi come oggetto e come soggetto». Ma se l’analisi di Mead si concentra in primo luogo sulle interazioni dirette, gli antropologi (e i ricercatori), dal canto loro, hanno bisogno di una cornice teorica che le trascenda. A questo punto ècco diviene importante quanto necessaria l’opera di Vygotskij, il quale offre una visione ampliata del contesto, compatibile con l’analisi marxiana della società, più attenta all’interazione diretta: «Insomma – conclude Vygotskij – l’estensione della zona prossimale dipende da fattori sociali, culturali e storici, che variano da società a società, con conseguenti e prevedibili riflessi sullo sviluppo cognitivo, sociale e ovviamente culturale e artistico».
Non ci rimane che cercarci uno spazio fattivo per il prosieguo della nostra ricerca che ormai spazia in ogni direzione lecita (e illecita), che miri a cogliere fra i molti che abbiamo scandagliato, un carattere universale degli esseri umani e delle culture, che si discosti dall’angusta applicazione della categoria solo ai fenomeni estetizzanti, prodotti da intelletti raffinati nelle civiltà superiori. Noi invece, abbiamo deciso di spingersi oltre, andando a cercare proprio quelle definizioni che più ci permettono di travalicare le barricate della cultura ufficiale che non ci hanno permesso, fino ad ora, di assecondare la conoscenza, con quella che è la realtà odierna. Secondo la definizione del noto antropologo Alexander Alland (*):
«Il prototipo (culturale) occidentale contempla la distinzione fra arte e non-arte. Certi dipinti, canzoni, racconti, sculture, danze ecc. sono considerati arte, altri no. Chi sposa questa opinione sosterrebbe, per esempio, che è arte ‘La Gioconda? Ma non l’immagine di Elvis Presley dipinta su un velluto nero, perché? la risposta forse ha a che fare con la bravura dell’artista nel cogliere qualcosa di importante incarnato da Elvis e con la cultura alla quale appartengono sia l’artista sia Elvis, cioè con il grado di felicità estetica della trasformazione-rappresentazione. Ma la risposta implica in parte anche la forte specializzazione delle società occidentali, che ha fatto emergere un «sistema dell’arte», formato da critici, storici, insegnanti, giornalisti, scuole, musei e simili, come pure artisti di professione. Costoro si arrogano il diritto di definire la vera arte, di decretare gli stili, i mezzi e le forme appropriati, di distinguere tra arte e artigianato. Che per i molti che hanno comprato quei dipinti l’immagine di Elvis creata dal pittore sia piena di significato – che lo stile e il mezzo tocchino la loro sensibilità – non dissuade i suddetti santoni dal considerarli paccottiglia. Così, Elvis su velluto per loro non è arte, perché non affronta problemi di estetica, non concerne né il bello né il vero, non palesa la lotta dell’artista per produrre un nuovo stile di espressione, diverso da tutti gli altri che l’hanno preceduto, o perché l’artista sembra ignorare o disprezzare la sperimentazione stilistica che compone la storia dell’arte occidentale. Ciò nonostante, arte non è solo quel che una casta di esperti definisce tale, ma anche significato, abilità, mezzo».
E se noi rispondessimo che Elvis è arte perché nella trasformazione e rappresentazione della sua immagine, l’artista ha espresso ciò che già era bello in natura?
Ovviamente non è questa la diatriba in cui vogliamo cacciarci in questa sede, tuttavia bisognerebbe rifletterci su e magari farne oggetto di una peculiare ulteriore ricerca, (che ne dite?).
Per comprendere il termine trasformazione-rappresentazione della definizione di arte proposta da Alland, dobbiamo qui ricordare che i simboli rappresentano altro da sé. Essendo arbitrari, in quanto privi di connessione necessaria con ciò che rappresentano, si possono separare dall’oggetto o dall’idea in questione per essere apprezzati in sé, e addirittura servire per esprimere un significato del tutto diverso. Ci sono infatti teorie che dimostrerebbero il contrario, almeno sotto l’aspetto cognitivo interiorizzato. Scrive ancora Alland: «Poiché trasformazione e rappresentazione dipendono l’una dall’altra, esse viaggiano accoppiate. Non è che un altro modo per parlare di metafora: un disegno, per esempio, è una trasformazione metaforica dell’esperienza in segni visibili su una superficie; del pari, una poesia trasforma metaforicamente l’esperienza di un linguaggio denso e compatto. Il processo è uno di quei casi che impegnano l’attività tecnica dell’artista».
Il senso di questa affermazione serve qui a confermare la nostra convinzione che come per la poesia, portata ad esempio da Alland, lo stesso accade per la musica, per il canto o la danza, esattamente allo stesso modo che per ogni altra forma d’arte. Ciò aderisce in modo uniforme al nostro concetto primario che la ‘musica dei popoli’ corrisponde esattamente a quello che i popoli sono nella propria cultura, quindi che i popoli non solo fanno la musica, essi sono la musica che producono. Potremmo anche affermare che la musica è la metafora del mondo in cui viviamo, e viceversa che la musica influisce sulla cultura tanto quanto la cultura influisce sul nostro essere ‘musicali’, ma questo riguarda più quello che è l’effetto della cultura che ci siamo dati sulla musica che produciamo. Quando all’opposto abbiamo visto come una sorta di musica esisteva già in natura, ancor prima che noi umani ne cogliessimo l’intrinseco significato. E questo è un dato di fatto. Ciò a cui invece vuole portare la lunga dissertazione tenuta fin ora, opera in ragione del considerare arte e non, quella che è la trasformazione e la rappresentazione di quanto i popoli hanno trasmesso e continuano a trasmetterci in musica, indipendentemente dalle esigenze tecnologiche e commerciali che ne stanno impedendo la continuità.
Ciò che si vuole qui dimostrare è che, al di là dall’essere perfetta tecnicamente parlando, in quanto artigianale e frutto di esecutori improvvisati, nonché spesso virtuosi, la musica dei popoli va ascoltata e vissuta nel contesto del popolo e della ‘terra’ che l’ha prodotta. La globalizzazione ha recato danni irreparabili alla politica di conservazione delle ‘differenze’, (lasciatemi passare il termine che non è e non vuole avere alcuna declinazione col razzismo), che si cerca di portare avanti nell’arte come nella musica, che invece va letta come opportunità di un distinguere che l’ha fatta grande, altrimenti, ad esempio, non esisterebbero il ‘tango argentino’; la ‘dojna romena’, il ‘trallallero genovese’ ecc. ma solo il tango, la dojna, il canto a orecchio ecc. Ciò vale per tutte le altre forme di espressione popolare, che riguardano le cose e gli esseri umani. Se la natura ci ha fatto diversi l’uno dall’altro ci sarà pure una ragione? Dunque ci ostiniamo a voler essere tutti uguali, perché lo pretende la globalizzazione? Io dico no, siamo perfetti così come siamo. Un mio amico azzarda anche dire che siamo uno peggio dell’altro, ma questo è un altro discorso, e sono certo che il riferimento fosse alla politica, mai la natura comunicazione umana è stata così problematica come nel cercare di costruire il significato di ciò che forse un significato non lo ha. Manteniamo quindi il potere dell’immaginazione che è in noi, conferito a noi stessi, da quel ‘libero arbitrio’ di cui siamo sostenitori, per attingere al potere indipendente direttamente, seppure in modo olistico, dalle fonti cosmiche che, nel determinare le azioni che possiamo o non possiamo intraprendere, pure ci governano.
Facoltà essenziale di tutti gli esseri umani che ci permette di rivestire di significato tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo attraverso quell’immaginazione che ci da la capacità di intraprendere sempre nuove esperienze: «indipendentemente dal grado di complessità del sistema sociale e dal fatto che il potere di coercizione sia o non sia monopolizzato da un’autorità centrale». Hoyt Alverson (*) sostiene che «la fede nel proprio potere di investire il mondo di significato (la “volontà di credere”) e nell’adeguatezza della propria coscienza per ragionare e influire sull’esperienza personale, sono tratti essenziali di ogni identità personale»; e solo quando quell’identità personale è irrimediabilmente annientata dalla deprivazione estrema, quell’essenziale facoltà umana si spegne. Ma il potere dell’immaginazione umana di investire il mondo di significato è anche potere di resistere agli influssi esterni, materiali e retorici. Questa capacità – non solo di scegliere ma anche di rifiutare le scelte alternative che altri vogliono imporre – costituisce il nucleo dell’identità personale dell’uomo, che Alverson definisce come «le convinzioni autentiche della persona riguardo a chi e che cosa è, capaci di resistere ai cambiamenti delle forze esterne che ne dettano le varie azioni sociali. Ciò non vuol dire che gli individui elaborino il significato delle esperienze in perfetto isolamento.
Del resto, tutte le attività dell’uomo, compresi crescita e sviluppo dell’identità personale, si svolgono in un contesto sociale, culturale e storico; inoltre, ogni individuo ha la facoltà di interpretare quel contesto dal proprio peculiare punto di vista, in conformità con le sue esperienze particolari. Ed è su queste leve che invito il ricercatore a fare le proprie valutazioni quando sceglie come campo di investigazione la musica etnica o popolare che sia, pensando che un possibile sradicamento dal contesto sociale, economico, culturale, snaturi la musica dal suo naturale coinvolgimento intrinseco nelle popolazioni che l’hanno prodotta. Dando così luogo a quei cambiamenti sostanziali di valutazione che Emile Durkheim (*) designava come ‘anomia’, cioè «l’incapacità di assegnare un senso (o anche un valore), a quelle attività (manufatti, prodotti, oggetti, cose) elaborate dall’uomo che tuttavia gli sono correttamente riconosciute», in cui pure rientra la musica in qualità del suo carattere ludico. Carattere che Umberto Eco, nel saggio introduttivo a “Homo Ludens” di Johan Huizinga (*), considera «..uno spregiudicato coraggio nel livellare, agli occhi dell’indagine, i portati della cultura “alta” alle manifestazioni della vita (..) come realizzazione di una razionalità immanente, il riconoscimento dei rapporti interumani come base concreta dello sviluppo storico».
Non va qui dimenticato che E. Durkheim si è espresso più volte su come l’oggettivazione della realtà sociale abbia portato al formarsi della coscienza collettiva; che «la realtà sociale possiede una sua oggettività, che si pone come una cosa, come un fatto di fronte a noi; che il fatto sociale è trans individuale: una volta costituito è esterno alle singole soggettività che l’hanno generato, vive di vita autonoma ed è indipendente dalle volontà-intenzionalità dei singoli, e che, una volta costituito come fatto oggettivo, condiziona l’individuo con una forza coercitiva a cui egli non può più sottrarsi, sia dall’esterno (norme scritte, istituzioni, tradizioni..), sia dall’interno (attraverso l’interiorizzazione delle norme e i sentimenti della coscienza). Fautore inoltre del riconoscimento di una “coscienza collettiva” per cui l’individuo scompare completamente nella realtà sociale che Durkheim definisce: «la consapevolezza collettiva è la più alta forma di vita psichica» in senso assoluto. Dal che possiamo ben far derivare la concezione della musica come espressione ricreativa dello spirito all’interno di una sua funzione sociale ben definita. Interpretata così, ècco che l’indole imitativa della musica subito diventa gioco, ludo, elemento competitivo, acquista senso di collettività, uno dei fattori che spingono alla creatività, si consegna al potere intrinseco dell’immaginazione. Sotto questa nuova luce infine, anche la rivalità degli strumenti, lo scambio delle reciproche parti, finisce per essere un gioco, un bellissimo scambio di partiture, di assonanze, di pause, di silenzi, tale è che anche la danza col suo intrecciarsi di passi, di movenze, di salti è gioco, gioco allo stato puro.
Non è forse in questo modo, o i modi, in cui dobbiamo re interpretare il nostro ‘gioco’ di andare alla ricerca della musica dei popoli? Sono sicuro di sì, perché ci offre la possibilità di vedere il tutto con altri occhi, ascoltare con altri orecchi, muoverci e saltellare con altri ritmi, che forse fino ad ora non avevamo mai conosciuti o soltanto mai compresi. Perché è in essi lo spirito del tempo che li conduce, che ha permesso loro di formarsi in una, in molte, tradizioni di cui molti sono i popoli che ne vanno fieri, che non hanno perso l’istintivo piacere che la musica trasmette, da sempre, in ogni angolo del mondo. Non mi stancherò mai di parlare della forza comunicativa della musica e di quella etnica in particolare, perché è in essa infine che ci scopriremo ‘vivi’ , nel ‘senso’ ultimo costante e infinito della nostra esistenza. Come ha scritto Leonardo D’Amico (*), etnomusicologo, in apertura del volume “Musica dei Popoli”:
«Scoprire così che la voce non è solo come ci sembra di conoscerla ma che può essere modulata in mille modi producendo suoni e melodie che vibrano a ogni livello. Scoprire il canto armonico, dove l’artista “canta” due suoni contemporaneamente e che le stesse generano un terzo suono armonico. Per cui il corpus di queste conoscenze orali, delle capacità manuali nel costruire e suonare strumenti, dell’insieme delle conoscenze musicali che ogni popolo ha in sé ed è in grado di esprimere, fino alla sua estinzione, sono un patrimonio di grande valore per tutta l’umanità, carico di significati per la comprensione di se stessa e delle altre culture che la formano, una ricchezza di cui continueremo ad avere bisogno».
“Musica dei Popoli: viaggio nella musica tradizionale del mondo” edito da Atlasmundi.com - Castelvecchi Editore, è però molto di più, a suo modo è un libro di ricerca illustrato e documentato, uscito in sordina nel 2005, sfuggito ai più senza una vera ragione, e del quale sono venuto in possesso solo recentemente. Al cui indice troviamo numerosi nomi conosciuti, oltre a Leonardo D’Amico s’intende, Paolo Scarnecchia, Roberta Tucci, Ignazio Macchiarella, Giovanni De Zorzi, Gilberto Giuntini e altri. Nonché delle belle fotografie che illustrano il volume, firmate da Alessandro Botticelli, Maurizio Mancuso, Giulio Meazzini, Carlo Razzolini, Enrico Romero, Mario Serni, Antonio Sferlazzo. Straordinario il materiale raccolto, l’impaginazione grafica, le ricerche iconografiche, il mare di parole spese nei testi introduttivi e le schede di presentazione degli artisti, tutti di gran pregio artistico da solleticare la curiosità degli addetti ai lavori ma, ancor più, di quanti si avvicinano per diletto o per piacere alla musica etnica. Un viaggio che si ripete con maggiore fantasmagoria nel DVD allegato, regia di Francesco Mizzau che, visto il materiale a disposizione, avrebbe potuto darci qualcosa di più. Pur tuttavia, la sottile polemica intrisa nelle mie parole, vuole significare che non si è voluto cercare il bello in assoluto, proprio perché, come si è detto più avanti, è il contesto che fa la differenza fra il naturale etnico, e il sublime artato. Dunque un DVD che va apprezzato come valore aggiunto a un libro che già dice molto di sé e della materia che tratta e l’azione del Centro FLOG e del Festival Musica dei Popoli come contributo attivo nella salvaguardia e impegno nel prendere coscienza dell’importanza culturale di un patrimonio immateriale che possiamo paragonare alle grandi opere dell’arte del passato, e del nostro più recente presente.
Bene ha fatto Leonardo D’Amico, responsabile per FLOG e direttore artistico del Festival Musica dei Popoli e del Festival del Film Etnomusicale, a realizzare quest’opera che davvero mancava e tutt’ora manca sul mercato librario italiano, e che documenta l’attività partecipata del FLOG (Fondazione lavoratori Officine Galileo) nata nell’insospettabile data 1945, nel cui statuto, pensate, si legge:
IL FLOG.
«..la fondazione si propone di svolgere un’attiva opera educativa allo scopo di migliorare la cultura dei lavoratori delle Officine Galileo e le loro facoltà tecniche e morali, poiché solo attraverso un maggiore approfondimento delle cose della natura e del mondo, gli animi acquistano carattere e gli uomini coscienza del proprio destino».
Incredibile riportare a quella data, il 1945, un’apertura tale e un’iniziativa senza precedenti, l’ultime risalgono alla fine dell’800 inizio ‘900 con Pestalozzi, Pitré, De Martino, Carpitella, Leydi. No, dimenticavo uno scrittore importantissimo che certamente non è sfuggito neppure a voi che leggete, il suo nome era Pier Paolo Pasolini (*) che nel 1975 realizzò la più importante raccolta mai vista sul folklore italiano, titolata “Canzoniere Italiano”. Ma questa è tutt’altra storia che sono certo di poter riprendere in futuro e che comprenderà tutte le Regioni d’Italia. Tuttavia questa del FLOG è degna di essere conosciuta dal più folto pubblico possibile e spero proprio che il Presidente del FLOG dott. Andrea Bellucci, non me ne vorrà, se nell’impossibilità di chiedergli l’autorizzazione, mi permetto di pubblicarla, nel rispetto di come egli l’ha trasmessa a noi nelle pagine del libro sopracitato, e neppure la Castelvecchi Editore:
«Con queste idee, ventisette fra dirigenti, impiegati, e operai delle Officine Galileo si trovarono insieme, di fronte ad un notaio per dare vita alla FLOG. Da quella data e per i sessant’anni successivi, la FLOG. soc. coop. È stata compagna delle Officine Galileo e del quartieri di Rifredi, in tutto il loro travagliato percorso lavorativo e sociale, ha subito necessariamente tutte le trasformazioni che quel percorso le ha chiesto, e principalmente ha dovuto rassegnarsi, nei primi anni ’80, a vedere gran parte del proprio corpo sociale allontanarsi dalla sede originaria di Rifredi, quando le Officine Galileo si sono trasferite nel sito di Campi Bisenzio. Tuttavia ha avuto, nel tempo, anche il merito di realizzare e di diventare proprietaria di uno dei più belli impianti sportivi, ricreativi e culturali della città di Firenze: il Poggetto, mantenendo, unico esempio in Italia di società cooperativa gestita dai lavoratori in modo totalmente volontario, gran parte di quei principi, che sono a fondamento della sua costituzione. Una delle trasformazioni decisa dagli amministratori della FLOG in una riunione del 1975, grazie anche alla collaborazione di alcuni esperti e con il sostegno delle istituzioni locali, fu la costituzione del Centro FLOG Tradizioni Popolari, dove confluì tutto il lavoro, documenti audio-visivi sul folklore nelle varie regioni italiane, archivio fotografico e ricerche bibliografiche, svolto fino ad allora dalla Gestione Culturale. Si trattò di una scelta importante e lungimirante, poiché in meno di un decennio il Centro FLOG Tradizioni Popolari arricchì la sua proposta culturale con il Festival Internazionale del Film Etnomusicale, grazie anche alla volontà della FLOG di offrire al proprio corpo sociale e alla città di Firenze una significativa testimonianza delle tradizioni popolari non solo italiane, ma addirittura mondiali, grazie anche al sostegno di nuovi partners istituzionali: il Ministero dei beni Culturali, la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Firenze. Il lavoro svolto dal Centro FLOG Tradizioni Popolari nei trenta anni successivi alla sua costituzione è andato ad arricchire una già fornitissima Mediateca, documentazione registrata in suono ed in video, che ha avuto il riconoscimento del proprio valore storico e culturale dalla Sovraintendenza Archivistica della Toscana. Proprio questi due aspetti, l’interesse da parte della Sovraintendenza e la qualità di materiale archiviato, ma registrato totalmente su supporti magnetici, hanno destato il mio interesse, come attuale Presidente di questa Istituzione, ad avviare il recupero e la salvaguardia di tutto questo materiale, a volte unico, trasferendolo dai supporti magnetici, degradabili con il tempo, su supporti più sicuri quali CD-ROM e DVD. questo impegno deve essere considerato tuttavia il primo passo, poiché è mia convinzione che questo materiale artistico, pregevole in sé e certamente di grandissima importanza storica, debba diventare patrimonio della collettività, mediante la possibilità di consultazione in rete, in modo che possa essere raggiunto uno dei principi fondanti della cooperativa, cioè il miglioramento degli uomini nello spirito e nella mente. Questo volume, che celebra le trenta edizioni del Festival Internazionale Musica dei Popoli, raggiunge in parte quell’obiettivo, e mi auguro che il lavoro svolto durante il mio mandato di Presidente della FLOG, sia ripreso e possibilmente migliorato dai miei successori» - firmato Il Presidente della FLOG Andrea Bellucci.
Che dire, un bel traguardo raggiunto davvero, e “Musica dei Popoli” è diventato un Festival storico, che dopo tre decenni è entrato a pieno titolo a far parte della storia culturale fiorentina e toscana, e che ha avuto ed ha tuttora, una risonanza a livello nazionale e internazionale. Fin dagli anni Settanta, con i suoi concerti di musica tradizionale e popolare europea ed extraeuropea, il Festival ha dischiuso un universo musicale sconosciuto prima di allora (o noto solo ad una ristretta cerchia di etnomusicologi), introducendo per prima in Italia musiche tradizionali di tutto il mondo: africane, asiatiche, latinoamericane e popolari europee. In tutti questi anni, il Festival ha contribuito a mettere in evidenza il fatto che “la musica” non è solo la musica classica, il pop/rock angloamericano e il jazz, ma che le “musiche del mondo” costituiscono un vasto e ricco patrimonio artistico e culturale, per niente marginale o inferiore rispetto alla musica prodotta dalla civiltà occidentale. Con ciò il Festival ha sempre avuto come obiettivo primario la valorizzazione della musica come bene artistico e culturale, proponendo attività di spettacolo tendenti alla diffusione della conoscenza delle musiche dei popoli all’insegna del relativismo culturale.
Nelle sue 30 edizioni, dal 1979 al 2005 – considerando che per tre anni (1980, 1985, 1987) vi sono state due diverse edizioni, una estiva e una invernale, nello stesso anno – “Musica dei Popoli” ha presentato più di 300 proposte artistiche, tra solisti e formazioni strumentali, vocali, musico-coreutiche e musico-teatrali di ben 80 nazioni dei cinque continenti. Anche per questo “Musica dei Popoli” va considerata come la prima rassegna internazionale di musica etnica e folklorica in Italia e una delle prime nel mondo. Si pensi che la prima edizione del WOMAD , il festival di musiche del mondo voluto da Peter Gabriel e Paul Simon, è del 1982. “Musica dei Popoli” ha dunque il merito di essere stato anticipatore delle mode e dei gusti musicali legati al fenomeno ‘world music’, etichetta comparsa intorno alla metà degli anni ottanta. Né va dimenticato che “Musica dei Popoli” è stato il primo festival a presentare in Europa ensemble come i Musicisti del Nilo (1979), e i Tamburi del Burundi (1980), successivamente passati all’etichetta discografica Real World di Peter Gabriel e quindi entrati nei circuiti commerciali mondiali.
Il Festival “Musica dei Popoli” per primo in Italia ha fatto conoscere il patrimonio musicale di popoli fino allora poco conosciuti o pressoché ignoti, come gli Uzbeki, i Tgiki, i Kazaki dell’Asia Centrale (1985), o come gli Yacuti, i Buriali e i Tungusi della Siberia (1987); inoltre, ha portato in scena feste e riti tradizionali di gruppi etnici africani che, grazie all’isolamento geografico e culturale, hanno mantenuto modi e stili di vita tradizionali, come i Bafut del Cameroun, i Senufo-Fodonon della Costa d’Avorio o i Dogon del Mali. La presenza al Festival di questi gruppi etnici un tempo detti “primitivi”, poi “arcaici” e oggi “di interesse etnografico” , ha indubbiamente messo in luce la problematica inerente la “messa in scena” di pratiche cerimoniali decontestualizzate e defunzionalizzate rispetto all’originale habitat naturale e culturale, lo sradicamento dei musicisti tradizionali e del conseguente effetto di spaesamento, il rischio di eccessiva “spettacolarizzazione” di un evento rituale originariamente non concepito come forma di spettacolo e il rischio di cadere in facili esotismi.
La legittimità o meno di tali “esplorazioni” etnoculturali è un problema tutt’oggi dibattuto (e irrisolto) a livello internazionale tra gli etnomusicologi e i direttori artistici di festival etnomusicali; ma ritenere che per conoscere ed apprezzare la musica di una cultura “altra” si debba “assaporarla” nel proprio ambiente, rischia di diventare una posizione elitaria, snob o (peggio) radical-chic. Forse la risposta a questo dilemma proviene dalla testimonianza di uno spettatore disabile, assiduo frequentatore da molti anni di “Musica dei Popoli” che, dopo uno spettacolo africano, ha ringraziato commosso perché questi spettacoli gli hanno permesso di compiere straordinari viaggi in luoghi lontani. Con l’immaginazione.
Infatti, molte delle manifestazioni che si sono susseguite negli anni, non sono state dei semplici concerti – nel senso di manifestazioni prettamente musicali – ma delle forme di “performing art”, in quanto racchiudevano al proprio interno rappresentazioni coreutiche e teatrali oltre che musicali, laddove il gesto e il suono costituivano un’unità inscindibile. Le forme di teatro orientale pure presentate al Festival, come il Kathakali del Kerala, l’Opera di Pechino, il Teatro delle Ombre Cambogiano, o il Bharata Nathyam indiano, sono vere e proprie forme d’“arte totale”, che includono musica, danza, recitazione, gestualità. Ma non solo. “Musica dei Popoli” inoltre ha avuto anche un ruolo importantissimo nella divulgazione della musica italiana di tradizione orale. «In un paese come l’Italia – come scriveva Diego Carpitella – dalle alte cime colte e dalle altrettanto profonde radici etno-musicali», la rappresentazione di musiche popolari di tradizione agro-pastorale o artigiana ha costituito un momento fondamentale nella concorrenza di stili, generi, repertori e strumenti musicali legati al mondo popolare. Le presentazioni di suonatori e cantori tradizionali hanno messo in luce la ricchezza della musica strumentale e vocale del Meridione italiano, la polivocalità dei ‘tenores barbaricini’, delle squadre di ‘cantori genovesi di trallallero’ o delle ‘confraternite laicali sarde e siciliane’, il ‘folklore vesuviano’ con i ‘cantatori a fronne’ e le ‘tamburiate delle paranza’ di Somma Vesuviana, gli ‘stornelli toscani’ di Caterina Bueno, gli ‘zampognari calabresi e siciliani’, i grandi ‘maestri di launeddas’, da Dionigi Burranca a Luigi Lai, e le grandi voci della musica popolare italiana, da Beppe Barra a Elena Ledda, da Giovanni Coffarelli a Marcello Colasurdo. Alcuni vecchi maestri che hanno partecipato al Festival, come il violinista Melchiade Benni o il suonatore di launeddas Dionigi Burranca, sono oggi scomparsi e le loro esecuzioni, registrate e depositate presso i nostri archivi, costituiscono oggi documenti importantissimi per l’etnomusicologia italiana.
E ancora, al Festival, sono stati rappresentati stili, generi e repertori che difficilmente possono rientrare in una griglia tassonomica, e comunque faticosamente etichettabili come “musica etnica”, tantomeno come world music. Pensiamo, ad esempio alle tradizioni musicali devozionali, come il ‘qawwali’ pakistano, il ‘sama’ dei dervisci turchi, il ‘lila’ degli gnawa marocchini o i ‘canti della Settimana Santa’ delle confraternite laicali sarde o siciliane. Passando dall’ambito sacro a quello profano, questa grande “scatola magica” musicale che è stato il Festival “Musica dei Popoli”, ha visto inclusi anche i canti conviviali d’osteria, dal ‘rebetiko’ greco al ‘fado’ portoghese passando per il ‘trallallero’ genovese, o le musiche di festa, come quella ‘lauterasca’ degli zigani romeni e ‘klezmer’ degli ebrei ashkenaziti. Grazie alla conservazione e catalogazione di questi materiali durante tutti questi anni, oggi la Mediateca FLOG è uno degli archivi più ricchi esistenti in Europa, soprattutto per quanto concerne il campo delle discipline demo-etno-antropologiche (in primis l’etnomusicologia). Il valore scientifico e culturale del nostro patrimonio archivistico è dimostrato dal fatto che dal 1986 parte dei nostri materiali sono sotto la tutela della Sezione Beni Archivistici del Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
Il Festival “Musica dei Popoli” che fu iniziato e guidato da Gilberto Giuntini ha visto nel tempo la presenza nel Comitato Tecnico e Scientifico del FLOG: Diego Carpitella (La Sapienza di Roma), Ivan Vandor (Istituto Inter. di Musica Comparata di Berlino), Simha Arom (C.N.R.S. di Parigi), Roberto Leydi (DAMS di Bologna), Guido Turchi (Accademia Chigiana di Siena); mentre la segreteria e il coordinamento organizzativo era a carico di Ingrid van den Assum, il cui contributo è stato notevole non solo nel lavoro organizzativo e promozionale delle attività del Centro, ma anche per il meticoloso e scrupoloso lavoro di conservazione ed archiviazione dei materiali che oggi compongono la Medioteca del FLOG. Va inoltre attestato che il Festival negli ultimi anni, ha saputo tenere fede al suo intento originario, quello di rappresentare culture extraeuropee ed euro folkloristiche tramite le manifestazioni musicali e coreutiche come espressioni artistiche e culturali dei popoli d’appartenenza, e nel rispetto assoluto della politica culturale del Centro FLOG, che si sempre espressa attraverso attività interculturali come festival e rassegne di musica e cinema etnomusicale, diretta al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità culturali espresse attraverso il linguaggio dei suoni. Ed è in questa direzione che il Centro FLOG intende proseguire il suo cammino.
Ma vediamo quali sono stati i programmi di questa importante organizzazione attraverso le locandine e le intenzioni di programmazione dei vari “festival” che troviamo elencati a conclusione del libro, prima di accede al DVD che dimostra “de visu e de facto” quello che il Centro FLOG ha prodotto in questi anni:
1979, 1980,1981, 1995, 2004: “Musica dei Popoli” I, II, III, IV
1980, 1983, 1987, 1996:”Africamusica” I, II
1982: “Sud America Tre culture”
1984: “Musica dell’Himalaya”
1985, 1987: “Musica Tradizionale dell’URSS”
1985: “Genti d’Europa”
1986: “Americamusica”
1988: “Suoni dall’Asia”
1989: “Le vie della musica: Africa, Asia, America”
1990: “Tamburi nel mondo”
1991: “Mosaico Tzigano”
1992: “Le grandi voci della musica etnica”
1993: “Voci e vocalità della musica tradizionale”
1994: “Danzamusica”
1997: “Sonorità Mediterranee”
1998: “Suoni d’Oriente”
1999: “Suoni in movimento”
2000: “Le vie dei canti”
2001, 2002: “La festa e il rito”
2003: “Storie, miti, leggende”
2005. “Pulsazioni”
Vale qui la pena di citare almeno alcuni dei grandi artisti di nostra conoscenza che si sono esibiti, solo per rendere loro omaggio, sebbene anche tutti gli altri presenti nel DVD-Video con una selezione di brani per un totale di 120 minuti di musica e immagini. A loro chiedo venia di non potergli dedicare maggiore spazio benché siano più che degni del nostro riconoscimento. Grazie.
Un bell’esempio non c’è che dire di come avviare e sviluppare un certo interesse in una ricerca che si consolida strada facendo e diventa organizzazione, tendente, a tutti gli effetti, a ‘fare’ della cultura musicale del mondo, un punto di eccellenza della cultura del nostro paese. Che è anche un fare ‘politica culturale’ s’intende, che dovrebbe coinvolgere non solo i semplici cittadini, come si è visto, bensì quegli Enti che sono istituiti per farlo, cioè promuovere la cultura italiana e non solo in tutti i suoi molteplici aspetti e su tutto il territorio nazionale, a cominciare dal Ministero per la Pubblica Istruzione, al Ministero per i Beni Culturali. Non di meno la Chiesa che in quanto a tradizioni millenarie ne avrebbe di cui rivendicare il diritto, e che invece non ha saputo discernere o meglio, ridefinire quelle utili alla comunità cristiana e non, necessarie o quanto meno utili nel promuovere un incontro delle diverse confessioni basato sulle vere ‘necessità’ umane. Così come pure dovrebbe fare l’ “antropologia” madre di tutte le discipline che ne conseguono, che invece di riporre la sua dedizione al cambiamento stando al passo coi tempi, si è consacrata più a descrivere e a spiegare la realtà piuttosto che cambiarla, mentre avrebbe dovuto elaborare strategie atte a risollevare questa nostra società dal torpore spirituale, sociale e creativo che l’ottunde, e aprendo a spazi incontaminati di ricerca. I tempi sembrano reclamare una azione sociale svolta in questo senso.
“Saggezza Tribale e Mondo Moderno”.
È questo il sottotitolo della serie di documentari televisivi Millennium: dieci ore di programma, realizzata dalla PBS, la Tv di stato americana, con il coordinamento dell’antropologo David Maybury-Lewis (*), distribuita in circa 60mila esemplari nelle scuole pubbliche e proposta con successo in diverse reti nazionali: “L’idea è di cercare e conoscere la saggezza dei popoli tribali, di esaminare i sentieri che hanno scelto di non prendere e acquisire da questi processi nuove possibilità per l’uomo. Se iniziamo a capire i differenti popoli nella loro piena umanità, siamo molto meno disposti ad accettare la loro distruzione di massa” – riferisce Raffaello Carabini (*) nel suo articolo pubblicato in New Age /Music del (?), riferendosi al serial documentaristico, girato in 15 paesi diversi del mondo, esamina la sopravvivenza delle culture indigene nel mondo attuale, comparandone il loro assetto sociale con il progresso contemporaneo, in un continuo scambio di idee sulla possibilità di migliore realizzazione dell’individuo nei suoi vari aspetti, famigliari, artistici, politici, di rapporto con la natura, con la spiritualità, con il sesso, con la morte. Nei filmati, infatti, sono illustrati usi e costumi di dieci popoli in via di estinzione, dai messicani Huichol ai colombiani Makuna (all’epoca solo 600 superstiti), dagli aborigeni australiani ai Nyinba nepalesi, dei quali, malgrado le artificiosità, si riesce a compenetrare la forza e la vitalità “millenaria” di canti e suoni antichi, con la modernità e la tecnologia dell’oggi, lanciando un ponte carico di presupposti culturali e umani verso il futuro.
Non va qui dimenticato che lo sviluppo del pensiero e delle facoltà logiche e razionali ha permesso all’uomo di evolversi sino alla realtà attuale. La rapidità con cui è avvenuto questo processo ha però provocato una profonda frattura sia interna che esterna, tra natura e cultura, tra corpo e mente. La sfida dell’uomo contemporaneo è dunque quella di superare questa dialettica, riavvicinando le due polarità opposte, ed in questo lavoro ecco che “l’uomo primitivo che è ancora in noi” ha un suo ruolo, e può contribuire alla nostra autorealizzazione insegnandoci a sperimentare il mondo anche con quella immediatezza e sensibilità che gli sono proprie. Una riscoperta, questa, avviata da innumerevoli nuove proposte portate alla ribalta da artisti musicalmente qualificati che non solo hanno contribuito a portare la musica etnica alla ribalta del grande pubblico internazione, bensì l’hanno fatta ‘rivivere’ in modo splendido alle nostre orecchie, spesso recuperandone lo ‘spirito’ che l’animava. Operazione di recupero? Rivisitazione? Contaminazione? Tutto questo e niente di questo, se ci manteniamo che nel concetto che la musica è vita e continua a vivere con noi, nel susseguirsi delle generazioni e che quindi il riproporsi sulla scena sociale e culturale equivale al suo rinvigorire in altre forme e combinazioni possibili e inimmaginabili. Quelle forme che Roberto Valentino (*), in un articolo pubblicato in New Age /Music del (?) dedicato all’ensemble newyorkese del Kronos Quartet (*) spintosi ad esplorare i confini del suono, ha definito come “nuova proposta” nell’ambito della nuova identità di questo Terzo Millennio:
«Un’immagine quasi da rock band che non è certamente quella consueta del quartetto d’archi di impronta accademica. David Harrington e John Sherba, violini, Hank Dutt, viola, Joan Jeanrenaud, violoncello, hanno dato luogo a un repertorio eterogeneo che abbraccia aree sonore tra le più disparate che va dal jazz al minimalismo, dal rock al tango argentino, dalle avanguardie storiche del Novecento a quelle più provocatorie e graffianti dello scenario odierno. Che, al di là del riconosciuto valore tecnico individuale e collettivo, hanno aperto a un modo di intendere la musica senza più barriere culturali, senza più ostacoli e muri frapposti fra un genere e l’altro, senza più preconcetti verso musiche considerate “altre” o “extra”. Questi i segni distintivi più apparenti del gruppo, proprio per il suo modo di proporsi e per le sue scelte artistiche non propriamente convenzionali, fin dal suo apparire sulla scena mondiale, rompendo con certi canoni della cultura così detta ‘colta’ per sconfinare in aree ad essa estranee, provocando piccole rivoluzioni estetiche dimostrando un’apertura interpretativa fino a non molti anni fa impensabile, fino a conquistarsi uno spazio specifico nella musica contemporanea e probabilmente futura. Insomma, il Kronos Quartet sembra porsi come punto di incontro ideale di musiche e culture diversissime fra loro, in un gioco di commistioni solo apparentemente azzardate e di accostamenti solo di primo acchito disorientanti».
«Ma non è tutto – ha aggiunto poi – dando uno sguardo alla loro copiosa produzione discografica le sorprese non mancano, soprattutto nel confrontarsi con compositori di svariata estrazione artistica e provenienza geografica: se i primi due album si muovono amabilmente attorno a materiale tematico esclusivamente jazzistico (‘Monk Suite’, evidente omaggio a Thelonious Monk, che include però anche un paio di brani di Duke Ellington; e ‘Music of Bill Evans’), i successivi ne ampliano considerevolmente il raggio d’azione, che di volta in volta si trova a confrontarsi con compositori di svariata estrazione geografica, come l’australiano Peter Sculthorpe ‘String Quartet No. 8’, del finlandese Aulis Sallinen ‘String Quartet No. 3’, degli americani Conlow Nancarrow ‘Sting Quartet’ e Philip Glass ‘String Quartet No. 2,3,4,5’, oltre ad una singolare versione di ‘Purple Haze’ di Jimy Endrix, mentre in ‘White Man Sleep’ e il successivo ‘String Quartet No. 2’ compare per la prima volta il nome del sudafricano Kevin Volans, che diverrà uno dei compositori prediletti dal Krons Quartet – insieme a quelli di Bela Bartok, Witold Lutoslawski, H.Mikolaj Gòrecki, Alban Berg, Franz List, e inoltre Charles Ives, Ion Hassell, Thomas Oboe Lee, Ornette Coleman e ben Johnstone autore del celebre ‘Amazing Grace’».
«Niente male come manifestazione di eclettismo, in ‘Winter Was Hard’, John Lurie e John Zorn vanno a braccetto con Astor Piazzolla ‘Five Tango Sensation’, Terry Riley, Arvo Part, Anton Webern. Ma non è finita, per lo più è con i minimalisti che il quartetto sembra voler instaurare un rapporto privilegiato: Terry Riley si avvale del Kronos Quartet per alcune sue ambiziose partiture come ‘Cadenza On The Night Plain’ e ‘Salome Dances For Peace’; Philip Glass chiama David Harrington e compagni per alcuni episodi della colonna sonora del film “Mishima” diretto da Paul Schrader; Steve Rech per ‘Different Trains’ che sul disco fa coppia in ‘Electric Counterpoint’ con l’appannaggio della chitarra di Pat Metheny. Altra prestigiosa e particolarmente significativa collaborazione con David Byrne in ‘True Stories’ e con altri autori di segno diverso, come Sting e il sopranista Stev Lacy, unitamente a pagine di Thomas Tallis, istvan Marta, Dimitri Shosatakovich. Ma sono forse ‘Blak Angels’, scritta da George Crumb ispiratosi alla guerra del Viet Nam e inclusa nell’album omonimo, insieme a ‘Pieces of Africa’ e “Night Prayers”, ispirato da Giya Kancheli, che più ci informano del lavoro impegnativo nella ricerca musicale del Kronos Quartet», e scusatemi se è poco.
Come riporta Raffaello Carabini nella recensione a ‘Pieces of Africa’ (*), e come ha detto durante un’intervista il portavoce del Quartet:
«Crediamo che la nostra musica sia una specie di spugna che ne assorbe altre. È una risorsa naturale che vogliamo dividere con gli altri. nessuno di noi sa da dove verrà la prossima ispirazione, ma la cosa più importante è tenere sempre pronta ed aperta la nostra immaginazione, l’immaginazione è tutto» - e se lo dicono loro, possiamo davvero crederci.
«E infatti, chi se lo sarebbe mai immaginato che il sofisticato quartetto d’archi all’avanguardia musicale colta newyorchese sarebbe andato in Africa a trarre linfa vitale per la sua ricerca musicale a 360 gradi. Dopo un assaggio ridotto con musiche del compositore sudafricano Kevin Volans in ‘White Man Sleeps’, eccoli alle prese con otto artisti del continente nero, presenti in prima persona come virtuosi di strumenti etnici locali. Con il marocchino Hakmoun ‘Shade’ propongono musica cerimoniale sufi; con il gambiano Foday Musa Suso ‘Tilliboyo’ (collaboratore anche di Philip Glass e Herbie Hancock) ci presentano musica tradizionale mandingo; eccoli con il ghanese Obo Addy a fare i cori che accompagnavano i riti sciamanici, sempre combinando il loro stile elegante e raffinato con la forza dei ritmi e delle pulsioni di questi musicisti pieni di naturale vitalità, a dimostrazione della millenaria capacità creativa che l’Africa accoglie in sé, di pura ricchezza sonora».
Eccoci quindi giunti alla conclusione di un altro appuntamento con l’Etnomusicologia, sebbene in parte soggiogati dalle domande personali e dalle risposte forse poco soddisfacenti dovute alle esperienze da me (che scrivo) in parte vissute durante i molteplici viaggi cui ho preso parte con sincero spirito di ricerca, andando a cercare situazioni e a creare presupposti per incontrare alcune popolazioni, talvolta mettendo a rischio la mia incolumità. E ciò non perché abbia incontrato singole persone o intere popolazioni male intenzionate, quanto invece sono occorso in pericoli che avrei dovuto evitare, mentre altri, almeno quelli riguardanti l’integrità fisica o igienico-sanitari è stato più difficile scongiurare, ma questo non scusa il fatto che in qualche caso non ho potuto approfondire la ricerca come avrei voluto. Pur tuttavia a favore della ricerca etnomusicologica fin qui realizzata e che vede la luce una seconda volta, grazie alla diffusione on-line del sito che mi ospita: larecherche.it, che ho cercato di assecondare almeno nel titolo, mi ha permesso di entrare in contatto con “altri” modi di vita e mi ha fatto comprendere quanto l’arbitrarietà della mia concezione originaria, in realtà fosse ristretta. E questo grazie anche al confronto coi risultati soddisfacenti riportati dalle numerose trasmissioni radiofoniche, per anni sollecitate, dalla RAI-Radio, e dalla RSI (Radio della Svizzera Italiana).
Come del resto, se noi tutti, esseri umani, viviamo in mondi plasmati dalla cultura, avviluppati nella trama di significati e interpretazioni che ci siamo tessuti, il nostro compito di ricercatori non poteva e non può essere più preciso, cioè andare per il globo a osservare, raccogliere, registrare, la creazione multiforme delle società culturali che lo compongono e che fanno la storia della nostra specie. Voglio qui ricordare che la scomparsa di queste forme di cultura sarebbe per noi tutti una perdita tragica, perché con essa svanirebbe anche qualcosa di squisitamente umano e la consapevolezza di possibili alternative all’esistenza precaria che conduciamo. Ma come dicono gli autori Emily A. Schultz e Robert H. Lavenda (*), in “Antropologia Culturale”, più volte citato, l’insegnamento dei quali ho preso a piene mani:
«Conoscere ed esperire la varietà culturale fa sorgere, forse inevitabile, il dubbio. Arriviamo a dubitare della validità ultima delle verità fondamentali racchiuse nella nostra tradizione culturale, sancite e consacrate dalle generazioni che ci hanno preceduto. Dubitiamo perché la consuetudine con altri stili di vita rende assai ambiguo il significato ultimo di ogni azione, di ogni oggetto. L’ambiguità è parte integrante della condizione umana e gli uomini l’affrontano da tempo immemorabile grazie alla cultura, che ponendo azioni e oggetti all’interno di un contesto conferisce loro un significato palese. Il dubbio suscita angoscia, ma è anche liberatorio».
Tuttavia esso esiste e come la libertà, è in qualche modo temibile, difficile da impugnare e brandire, e alla dialettica tra libertà e costrizione è affidato il nostro futuro. Sta a noi cercarlo.
Bibliografia:
E.A. Schultz – R. H. Lavenda, “Antropologia Culturale” – Zanichelli – Bologna 1999.
AA.VV. “Enciclopedia della Musica” – Garzanti 1996.
AA.VV. “Music” – Geoffrey Hindley – Hamlyn – London 1978.
R.J.Forbes, “L’Uomo fa il Mondo” – Einaudi Ed. - Torino 1960.
Note:
(*) George Herbert Mead, filosofo, sociologo e psicologo statunitense, è considerato tra i padri fondatori della psicologia sociale.
(*) Lev Semënovič Vygotskij, psicologo sovietico, padre della scuola storico-culturale, è stato definito dal filosofo Stephen Toulmin il «Mozart della psicologia». Solo negli anni ottanta è cominciata una ricostruzione critica dell'opera Vygotskij.
(*) Alexander Alland, “L'imperativo umano”, Ed. Bompiani. Lo studio di Alexander Alland ci offre un importante punto di osservazione su come fondamentali bisogni economici ed esigenze di appagamento emotivo vengono fatti corrispondere a particolari forme di strutture della società, dei rapporti di produzione e dello spazio fisico. Conosciamo dagli studi di etologia l'importanza della territorialità fra gli animali e sappiamo che in parte anche l'uomo risponde a questo esigenza. Ma sono proprio gli studi di etologia comparati a quelli di antropologia che ci evidenziano il radicale distacco dell'uomo dagli istinti elementari degli altri animali, anche dei primati. La caratteristica dell'animale umano è la capacità di strutturare l'ambiente in cui vive per renderlo funzionale non solo ai propri bisogni materiali, ma anche in funzione delle proprie esigenze emotive. Cioè l'uomo organizza lo spazio in cui vive, gli affida delle funzioni simboliche e normative per mantenere la sua struttura organizzativa.
(*) Hoyt Alverson, "From Time to Time Clock Storied” – sulla globalizzazione economica del nuovo millennio," in “Tempo all'alba del nuovo millennio: cambiamenti e continuità, (The Study of Time, X vol.), M Soulsby e JT Frazer (a cura di), (2001 ) 177-188.
(*)Émile Durkheim, francese, è stato un sociologo, antropologo e storico delle religioni. La sua opera è stata cruciale nella costruzione, nel corso del XX secolo, della sociologia e dell'antropologia, avendo intravisto con chiarezza lo stretto rapporto tra la religione e la struttura del gruppo sociale. Durkheim si richiama all'opera di Auguste Comte (sebbene consideri alcune idee comtiane eccessivamente vaghe e speculative), e può considerarsi, con Karl Marx, Vilfredo Pareto, Max Weber, Georg Simmel e Herbert Spencer, uno dei padri fondatori della moderna sociologia. È anche il fondatore della prima rivista dedicata alle scienze sociali, L'Année Sociologique, nel 1898.
(*)Johan Huizinga, “Homo Ludens” – Einaudi Ed.- Torino 1982.
(*)Leonardo D’Amico a cura di, “Musica dei Popoli” con DVD – A. Castelvecchi Ed. – Roma 2005.
(*)Pier Paolo Pasolini a cura di, “Canzoniere Italiano” – Guanda Ed. 1975.
(*) David Henry Peter Maybury-Lewis was an anthropologist, ethnologist of lowland South America, activist for indigenous peoples' human rights and professor emeritus of Harvard University. Born in Hyderabad, Pakistan, Maybury-Lewis attended Oxford University, at which he earned a D.Phil. In 1960, he joined the Harvard faculty, and was Edward C. Henderson Professor of Anthropology there from 1966 until he retired in 2004. His extensive ethnographic fieldwork was conducted primarily among indigenous peoples in central Brazil, which culminated in his ethnography among the Xavante, as well as post-modernist renditions. In 1972, he co-founded with his wife Pia Cultural Survival, the leading U.S. based advocacy and documentation organization devoted to "promoting the rights, voices and visions of indigenous peoples." Former president of the American Ethnological Society. Grand Cross of the Brazilian Order of Scientific Merit, Brazil's highest academic honor, in 1997. Anders Retzius gold medal of the Swedish Society for Anthropology and Geography, in 1998. Sue pubblicazioni: “Prospects for Plural Societies: 1982 Proceedings of the American Ethnological Society” (1984). “Akwe-Shavante Society” (1974);“Dialectical Societies: The Ge and Bororo of Central Brazil” (1979); “The Attraction of Opposites: Thought and Society in the Dualistic Mode (1989); “Millennium: Tribal Wisdom and the Modern World” (1992); “The Savage and the Innocent” (2000) Indigenous Peoples, Ethnic Groups, and the State (2001);“The Politics of Ethnicity:Indigenous Peoples in Latin American States” (2003)
(*)Roberto Valentino, articolo in New Age /Music del (?)
(*)Raffaello Carabini, recensione a ‘Pieces of Africa’, in New Age /Music del (?)
(*)Emily A. Schultz e Robert H. Lavenda (op. cit.)
Discografia Kronos Quartet: (essenziale)
“Released 1985 – 1995” 2CD – Nonesuch 7559 79394-2
“Short Stories” – Elektra Nonesuch 7559 79310-2
“Cadenza On The Night Pain”, con terry Riley –Gramavision 8122-79444
“Winter was Hard” – Elektra Nonesuch 7559 181-2
“Kronos” – Nonesuch 759-79111-2
“Five Tango Sensations”, con Astor Piazzolla - Elektra Nonesuch 7559-79254
“Plays Music of Thelonius Monk”, con Ron Carter – Landmark 2521-81505-2
“Performs Philip Glass” – Nonesuch – 7559-79346-2
“Night Prayers” - Elektra Nonesuch 7559-79356-2
“Black Angels” - Elektra Nonesuch 7559-79242-2
“Hunting Gathering”, con Kevin Volans - Elektra Nonesuch 7559-79253-2
“Pieces of Africa” - Elektra Nonesuch 7559-79275-2
“All The Rage”, con Bob Ostertag - Elektra Nonesuch 7559-79332-2
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etn. 9 Indiani d’America: prima parte
QUADERNI DI ETNOMUSICA 9 - (prima parte)
“Indiani d’America: tra storia e leggenda”, di Giorgio Mancinelli.
(Da “Folkoncerto”, RAI-Radio3, e “Itinerari Folkloristici”, reportage trasmesso dalla RSI – Radio della Svizzera Italiana).
'Fratello, sii il benvenuto!/Vieni a sederti accanto al fuoco,/Sii uno di noi!/Fratello sii il benvenuto./Vieni a sederti accanto al fuoco,/Vieni a fumare il calumet della pace'.
È questo un canto che la tribù dei Winnebago, grande famiglia degli Irochesi che abitano il Nord Est della grande prateria, usano ancora oggi come forma di ‘benvenuto’ per quei turisti e curiosi che si recano in visita presso di loro. L’usanza di offrire di fumare la ‘pipa della pace’, un tempo ritenuta sacra presso le comunità di molte realtà tribali pellerossa, assolveva a un preciso patto sociale stabilito tra le forze del bene e del male che, per l’occasione, trovavano una pausa nella costante lotta in cui erano impegnate, e si sedevano insieme per una tregua che sarebbe durata fintanto che dall’una o dall’altra parte si riaccesendessero le ostilità. E ciò poteva accadere per una infinità di ragioni, dall’aver sconfinato nei territori adibiti al pascolo dell'una, o nelle riserve di caccia dell'altra, i cui confini, stabiliti da patti inscindibili, erano ritenuti sacri, poiché decisi e prefissati dai ‘grandi’ padri delle tribù in tempi immemorabili, e che le generazioni più giovani erano tenute a rispettare. Più genericamente questo particolare uso era legato a cerimonie o festività che possiamo definire ‘religiose’, ma solo se diamo a questa parola un senso diverso da quello universalmente accettato, sulla falsariga di ‘praticante’, o meglio ‘osservante delle tradizioni’, e quindi di natura sociale e politica.
Di fatto il passarsi il 'calumet' l’uno con l’altro rappresentava il fulcro di una cerimonia colma di significati: dal parlare ‘chiaro e sincero’ all’essere ‘onorato e rispettoso’ dei partecipanti all’assemblea. E questa era di solito indetta ogni qual volta c’era qualcosa di cui discutere ‘in pace’ o, in caso di dispute, per ‘pareggiare i conti’ che, in alcun modo, dovevano rimanere in sospeso e divenire causa di guerre feroci tra le tribù. In caso di acceso contrasto, spettava al capo tribù dissotterrare ‘l’ascia di guerra’ dal luogo ove ‘riposava’ e dichiarare aperta la conflittualità. Altresì la sua sepoltura rendeva neutrale il terreno che tutte le tribù erano tenute a rispettare. Avveniva così che durante le assemblee il 'calumet' continuava a circolare dall’uno all’altro dei partecipanti fintanto che ognuno avesse parlato e tutti i problemi in agenda per quel giorno fossero messi in discussione. Il che talvolta significava che le riunioni dei ‘capi tribù’ spesso coadiuvati dagli sciamani, potevano durare per giorni. L’importante era che ogni questione, infine, trovava una sua conclusione e gli accordi presi o riconfermati tra le varie realtà tribali, fossero mantenute nel rispetto delle antiche tradizioni, o meglio, delle rigorose ‘leggi dei padri’.
'Eccoci giunti quindi, e qui alzeremo le tende del nostro accampamento indiano!' – mi viene quasi spontaneo dire, nell’avvicinarmi quest’oggi a una cultura di cui davvero conosco molto poco, le cui nozioni sono per lo più derivate dalla pletora di film visti al cinema fin da ragazzo, e giocavo con altri alla guerra tra “indiani e cow-boy” senza dare alcun senso a ciò che facevamo. In realtà nei nostri futili giochi c’era sempre una sorta di agonismo in cui ognuno si aspettava che lo scontro infine non fosse così violento come nei film, oppure che infine si trovasse una forma di accordo che, per le cinque del pomeriggio, vincitori e vinti, fossimo tornati tutti a casa senza esserci fatti del male. A ripensarci senz'altro c’era in ognuno di noi ragazzi un senso recondito e comunque segreto occulto nelle nostre scelte, altrimenti non si spiega perché uno sceglieva di stare dalla parte dei cow-boy e un altro da quella dei pellerossa, non vi pare? Soprattutto perché era quello che faceva la differenza, ma se non avete mai provato a indossare i panni dell’uno o dell’altro, non la scoprirete mai. Che i pellerossa rappresentassero quel lato perdente ma pieno di dignità e orgoglio, da essere quasi sempre da me prescelti? Non saprei dirlo. Fatto è che per affrontare questo tema di ricerca sono andato a rivedermi molti di quei film in cui i pellerossa hanno la meglio o, come si usa dire, perdono in battaglia ma vincono in onore: “The Alamo”, “Soldato Blu”, “L’ultimo dei Mohicani”, “Balla coi lupi” e tanti altri. Nel rivederli ho ricordato soprattutto che mi piaceva il loro lungo peregrinare attraverso la prateria innevata dal rigido inverno, il loro fermarsi ai bordi della foresta o nei pressi di un fiume e costruire il loro accampamento, l’accendere il grande fuoco dal quale ognuno poi avrebbe preso il suo ceppo acceso e lo avrebbe portato nella propria capanna (tepee), e tante altre usanze, a cominciare dalla concia delle pelli degli animali cacciati, ai loro metodi di pesca, al cibo preparato e cotto in un unico orcio, ai costumi e i copricapo piumati, alle maschere rituali ai canti anomatopeici, alle danze scalmanate. Sì che tutt'ora mi coglie un che di famigliare in presenza di un grande fuoco, al ricordo forse del 'ceppo' che veniva bruciato nel camino di casa per tutto il periodo natalizio e che avrei voluto che mai venisse spento. Ecco ora ricordo, s’aspettava sempre il momento in cui i pellerossa avrebbero danzato. la tipica danza di guerra detta 'del serpente' che si snodava in forma di marcia attraverso l’accampamento.
Ma parlare qui di 'Indiani d’America' può sembrare fuori luogo, non meno che chiamarli 'pellerossa' che può sembrare un voler fare una qualche distinzione dovuta al colore della pelle, chi mi legge sa che non soffro di queste dissociazioni, tuttavia è così che li conosciamo e così che continuerò a chiamarli nell’ambito di questa ricerca. A riguardo però c’è una sottile linea conduttrice sia nell’uno che nell’altro termine: ‘pellerossa’ in origine era chiamato l’indigeno del Nord America in ragione del fatto che aveva in uso di cospargersi il corpo con ocra rossa (terra) e che venne poi esteso a indicare gli amerindi degli odierni USA e Canada; mentre la denominazione ‘indiano/i’ pure in uso, deriva da ‘indios’, come C. Colombo nomò le popolazioni delle isole caraibiche, nell’errata convinzione di aver raggiunto le Indie orientali. Entrambi i termini, se usati in senso positivo, sono però scambievoli se derivati dalla conoscenza acquisita e che riguardano le grandi migrazioni che videro intere popolazioni o parti di esse, migrare da un emisfero all’altro per cause ancora oggi non meglio specificate, spintesi dalle continente indiano verso il Nord e quindi ridiscese ad occupare quei territori che oggi formano l'America Nordoccidentale e del Nordeuropa. La denominazione ‘indo-europei’ è significativa, come allo stesso modo lo è ‘indo-americani’ o ‘amerindi’ che sia. Eccoci dunque proiettati in uno dei grandi problemi che affliggono l’umanità costretto in una semplice frase: “chi siamo e da dove veniamo?”. La risposta è racchiusa nella mobilità caratteristica di alcuni gruppi etnici, così detto ‘nomadismo’, in genere, limitato all’interno di un territorio definito, ma che in certi periodi della storia dell’uomo ha assunto gradi diversi a seconda delle regioni e delle popolazioni. Come ad esempio presso i popoli raccoglitori o quelli che praticavano l’allevamento del bestiame, per cui lo spostarsi in cerca di cibo o al seguito di mandrie assumeva carattere periodico, con il ritorno ciclico delle stagioni, al luogo di partenza, o anche il trasferirsi dalla pianura ai monti e viceversa. In questo caso specifico, quello dei pellerossa va considerato un semi-nomadismo, causato dall’abbandono di alcuni territori dopo lo sfruttamento stagionale, nel rispetto della natura per farvi poi ritorno una volta l'avvenuto rigenerarsi della natura.
Caratterizzate da una profonda eterogeneità etnico-linguistica, le popolazioni amerindie presentano tuttavia alcune caratteristiche comuni, come la credenza in un solo creatore, il Grande Spirito, e nella presenza di una forza vitale in tutte le cose della natura, ‘mana’, come la grande importanza che esse attribuiscono alla musica. Vi sono sicuramente differenze formali tra il modo di vivere delle tribù sparse in territori talvolta vasti quanto un continente, sia tra quelle del Nord che del Sud, sia tra quelle forzatamente stanziali che abitano all’interno dei Parchi USA, che quelle occupanti gli spaziosi territori del Canada; tra coloro che hanno preferito l’integrazione da quanti, ancora oggi, ostentano il separatismo contro la più totale emarginazione. Come pure diversità sono presenti nell’Est, tra le tribù degli Irochesi coltivatori che sono riusciti a produrre ben quindici tipi diversi di mais, senza per questo aver abbandonato la caccia e la pesca; e quelle del Sud-Ovest come i Navajos dediti alla pastorizia, e le tribù del profondo Sud come i Cherokee, i Cooctaw, i Seminole; oppure quelle delle grandi pianure come i Sioux, i Cheyenne, gli Arapahoes, i Piedi Neri, i Crown e gli Shoshones, che un tempo si spostavano di continuo all’inseguimento delle grandi mandrie di bisonti. Così come alcune diversità sono rintracciabili tra i Pueblos costruttori di villaggi murari scavati nella roccia, e gli Zuni, gli Hopi, i Tewa, che hanno sviluppato un’agricoltura molto avanzata; fino ai Comanches e agli Apaches cacciatori e razziatori che vivevano ai limiti delle zone aride e desertiche del Sud-Ovest; o ancora, gli Ojibway (Chippawas), che pescavano nelle ricche acque dei Grandi Laghi.
Caratteristica uguale tra tutte le tribù era il fuoco da campo che soprattutto le donne e i bambini collaboravano a mantenere acceso, mentre i ragazzi e gli uomini erano fuori dell’accampamento impegnati in una battuta di caccia o nella pesca lungo i fiumi, quando non erano presi in un’azione di guerra con altre tribù. Il fuoco era il centro della vita sociale dei pellerossa che, in occasione di particolari avvenimenti o nelle festività fissate dal calendario lunare, assumeva una funzione di rilievo in tutte le manifestazioni comunitarie. Attorno al fuoco, infatti, si radunavano i capi tribù per parlare al popolo, sia per prendere decisioni che riguardavano tutti, sia nelle consultazioni con i guerrieri, o nel caso di previsioni sciamaniche; ma anche per ‘acculturare’ le rispettive tribù coi racconti riferiti alla loro storia, alle credenze specifiche riferite agli spiriti della natura e, in ambito religioso, al culto degli antenati e, tramandare allo stesso modo, quelle che erano le loro conoscenze in ambito creativo e manifatturiero. E ancora intorno al fuoco, si radunavano i guerrieri per raccontare ai più giovani le loro avventure di caccia a dimostrazione del coraggio avuto nell’affrontare un animale selvatico con tanto di descrizione delle tecniche usate nel costruire una trappola, o una canoa, oppure ad alzare il ‘tepee’ la classica capanna a cono, dell'uso di archi e frecce, o a scolpire un ‘totem’. I più vecchi, dal canto loro e talvolta con rimpianto, narravano ai bambini di quando: “… le frecce erano più appuntite e gli archi più resistenti”, rinverdendo così un passato definitivamente lontano e tuttavia mai dimenticato. Ma anche insegnavano loro come rappresentare con le sabbie colorate le divinità appartenenti alla religiosità e alla non meno importante mitologia, per cui ogni sfumatura aveva un suo precipuo significato all'interno di una tecnica singolare che richiedeva doti di esperienza e precisione e che andava appresa fin da piccoli. Riguardo alle donne, esse per lo più si adoperavano in lavori utili alla comunità fabbricando suppellettili in terracotta, lavorare al telaio, conciare pelli, salare le carni e cucinare, insegnare alle bambine a tenere in ordine la tenda e, non in ultimo, le arti del canto e della danza. Vi erano infatti specifici canzoni e danze intitolate ‘alla tela di canapa’, alla ‘macina’, al ‘gioco di destrezza’, al ‘fumo del fuoco’, ed anche alla natura in ogni sua espressione e aspetto, conservate nell’ambito della vita quotidiana fino ad oggi, e che noi conosciamo per essere state raccolte in edizioni librarie e pubblicazioni discografiche di rilevante importanza etnomusicologica:
‘Canto del fumo’ - Indiani Pawnee (vedi disc.)
‘Canto degli alberi e delle acque’ - Indiani Pawnee (v.d.)
‘Canto per il cielo’ – Indiani Chippewa-Ojibwa (v.d.)
Camminando nel cielo accompagno un uccello.
‘Canto per l’arcobaleno’ – Indiani Papago (v.d.)
Tu che possiedi il giorno, fallo bello./Prendi i colori del tuo arcobaleno e sarà bello.
‘Canto per il sole che sorge’ – Indiani Papago (v.d.)
‘Canto di primavera’ – Indiani Teton-Sioux (v.d.)
Gli occhi miei/scrutano la prateria;/sento aria d’estate nella primavera.
‘La stella del mattino’ – Indiani Papago (v.d.)
La stella del mattino è sorta./Valico montagne,/nella luce del mare./Laggiù al limite della terra/ha posto la mia meta.
Di rilevante importanza questo canto relativo al culto detto ‘della stella del mattino’ che secondo i Papago aveva il potere di dare la vita e la forza della fecondità. In suo onore si celebravano riti sacri in alcune altre tribù come, ad esempio, fra gli Ojibway e i Chaui-Pawnee:
‘Canto per la stella del mattino’ – Indiani Chaui-Pawnee (v.d.)
‘Canto per la stella del mattino’ – Indiani Arapaho (v.d.)
Semplici e carezzevoli questi testi che potremmo definire preziosi haiku quasi naif, nei quali il sussurro lieve del canto ha un effetto rigenerativo, vicino a quello che forse, un tempo, doveva sussistere tra l’essere umano e la natura. ve ne sono moltissimi altri e per ogni occasione, per quanto quelli dedicati ai bambini sono forse quelli che mi piacciono di più. Come questa ninnananna melodiosa, probabilmente la prima che viene cantata al nascituro subito dopo essere venuto al mondo:
‘Ninnananna’ – Indiani Zuni (v.d.)
'Nonie-hi-e-nonie-he-e/Hey-lun-coo-hey-len-coo/Nonie-hi-e'.
(Vai a dormire, piccolo mio, mentre io lavoro. Tuo padre porterà subito dentro le pecore).
‘Del Lupo’ – Indiani Apache (v.d.)
'I lupi stanno ululando/(segue verso)/tutti dicono ‘buta, buta’./Sta mangiando qualcosa di buono'. (‘buta’ traduzione non reperita).
‘Della tartaruga” – Indiani Apache (v.d.)
'La tartaruga corre sul fianco/corre nella polvere./Ogni sua parte corre nella polvere'.
‘Del tacchino’ – Indiani Apache (v.d.)
'Il piccolo del tacchino avanza impettito/(segue imitazione)/io sto preparando un bel fuoco/raspando il terreno'.
Entriamo quindi in un accampamento e subito notiamo come la disposizione delle cappane tutt’attorno a una più grande formano un grande cerchio, anche se non proprio perfetto, in cui i ‘tepee’ a disegni geometrici, colgono lo sguardo per i colori vivaci, dando all’intero villaggio un tono gaio e armonioso per le scene artistiche sopra raffigurate, come animali stilizzati e scene di caccia. Le terre colorate che più spesso venivano utilizzate erano il rosso-ossido e il blu-cobalto, mentre le tinture spaziavano dal giallo-forte al verde-erba ricavate da vegetali. Il ‘tepee’, parola Sioux che sta per ‘abitazione’, originariamente costruita secondo regole ben precise, assumeva forme diverse a secondo dell’importanza di chi vi dimorava. In alcuni casi, dipendeva dal numero di cavalli in possesso o detenuti dall’intero gruppo famigliare, che serviva poi a trasportare le attrezzerie nei lunghi spostamenti. Ogni capanna, a forma conica, era composta da pali ricavati da arbusti di legno solido, un numero variante secondo la grandezza, legati in cima tra loro con corde e ricoperti di pelli di bufalo conciate, cucite tutt’attorno che la riparavano dal freddo pungente. All’interno di ogni capanna veniva acceso un fuoco, affinché durante l’inverno la tenda restasse asciutta, oltre che a mantenere la sua funzione primaria di focolare domestico.
Oltre alla costruzione meticolosa delle canoe agevoli e leggere alle quali dedicavano molta cura, e che i pellerossa utilizzavano come mezzo di trasporto e di pesca nei laghi e nei fiumi, molte tribù dedicavano il loro tempo al lavoro di intaglio del legno, di cui gli esemplari più noti a noi rimasti sono i grandi To-tem, interi tronchi d’albero intagliati e scolpiti con stilizzazioni di mascheroni, figure di animali antropomorfi, esseri superiori, entrati nel simbolismo tribale e facenti parte di una mitologia ancestrale, certamente di origine ‘sciamanica' e 'animistica' originaria della popolazione Tungus della Siberia, stanziata tradizionalmente nei pressi dell'estremo confine sttentrionale cinese. Scrive Martin Palmer in "Le origini del Taoismo":
"Iniziato 8000 anni fa in Siberia, lo sciamanesimo si diffuse in Cina, attraversando il Giappone e il Sudest asiatico e giungendo, tramite l'istmo che unisce Siberia e Alaska, fino all'America settentrionale e centrale. (..) Da antiche fonti pervenute la tradizione si avvale di un precetto fondamentale per cui esistono due mondi paralleli, talvolta sovrapposti, ma distinti l'uno dall'altro: il mondo fisico, cioè quello in cui viviamo e il mondo spirituale, abitato da forze che guidano e controllano il mondo fisico. (..) Il mondo spirituale è parallelo a ogni forma di vita del piano fisico per cui ogni albero, fiume, animale o roccia possiede un proprio spirito. Danneggiarli o offenderli (tabù) non può che suscitare sventure, per cui è estremanente importante prendersi cura di loro. Il modo per collegarsi al mondo spirituale è ricoperto dallo 'sciamano', egli penetra nel mondo spirituale e comunica con le sue forze tramite lo stato di 'trance' nel quale parla con gli spiriti e ne diventa il portavoce. Il suo potere è talmente considerevole che non s'intraprende alcuna decisione senza consultarlo. In caso di malattia o di disgrazia lo sciamano penetra nel mondo degli spiriti per ricercarne la causa e comunica poi alla comunità l'offesa che ha portato tale punizione. la convinzione che tutti i gli elementi del mondo fisico sono rispecchiati nel mondo spirituale induce ad assumere un atteggiamento cauto e rispettoso verso la natura, assoggettandosi ai suoi poteri e diritti. Il modello stesso dei due mondi paralleli, pose le basi per il concetto di 'via naturale', ovvero il cammino da seguire nel mondo materiale se si vogliono evitare disgrazie e catastrofi".
Si conoscono infatti molti canti e danze riferite in questo senso ai diversi animali e idoli raffigurati sui To-tem. Uno di questi fa riferimento a un ‘essere supremo’ intessuto a una funzione religiosa immune da ulteriore senso morale o immorale, che era all’origine del bene e del male. La sua potenza suprema non si mescolava mai agli individui, ma gli spiriti animali che erano in lui, avevano il potere soprannaturale di entrare ed uscire dai corpi degli stregoni (sciamani), oltre che dei danzatori che prendevano parte all’attività cerimoniale e detti Hamatsa ‘uomini selvaggi dei boschi’. L’Hamatsa era una sorta di ‘società segreta’ formata da soli uomini posti sotto la protezione di spiriti erroneamente indicati come ‘danzatori cannibali’ in ragione del fatto che nelle loro cerimonie le danze avevano un ruolo importante. Vi si accedeva per diritto ereditario ma era inoltre necessario essere stati prescelti e iniziati. Ogni capo doveva essere anche un Hamatsa e per diventarlo doveva sottoporsi a prove ardue e rigorose. Benché i membri della società fossero per lo più maschi, a volte, poiché il grado era ereditario, una donna, qualora fosse figlia unica di un Hamatsa, poteva entrare a far parte della società segreta. Come riferisce Ida Halpern (*), curatrice della ricerca qui trattata:
«Da sempre sono molto diffuse presso gli Indiani le società segrete che costituiscono dei raggruppamenti di individui che si creano in base a fattori ‘divini’, che nulla hanno a che vedere con la parentela. Regola generale è che a tali società non possono mai appartenere i bambini, ed altra regola, che ammette rare eccezioni, esclude l’appartenenza delle donne. Presso i Kwakiutl an un certo momento operarono tre diverse società segrete (fra cui appunto quella degli Hamatsa), ognuna delle quali aveva elaborato un suo ciclo di riti segreti dei quali potevano essere a conoscenza solamente i componenti della rispettiva società. Uno stesso individuo non poteva far parte di più di una società e, in seno alla società di appartenenza ognuno occupava un suo posto preciso, gerarchicamente stabilito. Nel corso delle cerimonie rituali delle società Kwakiutl si svolgevano vere e proprie ‘recite teatrali’, con numerose finzioni sceniche di grande effetto. Queste si svolgevano soprattutto di notte, quando l’incerta luce dei fuochi rendeva più facili gli inganni. Ad esempio, alcuni ‘attori’ portavano sotto i vestiti degli otri pieni del sangue di animali uccisi: in tal modo quando venivano ‘colpiti a morte’ il sangue scorreva abbondante per terra. Era così che gli Hamatsa fingevano il loro cannibalismo, a quanto si dice con impressionante evidenza. I danzatori erano posseduti dallo spirito cannibale e dovevano assolutamente dare sfogo al loro istinto e così, per evitare che assalissero davvero i loro compagni, si doveva fingere di dar loro da mangiare carne umana. Veniva appositamente preparato un piccolo orso bruno o un altro animale di dimensioni e forma adatte allo scopo, che era poi cotto e affumicato per bene. Il danzatore (invasato) si avventava su questo corpo che la penombra contribuiva a rendere sufficientemente ‘umano’ e lo divorava con ostentata ferocia».
‘Canti Hamatsa’ – Indiani Kwakiutl-Nootka (v.d.)
'Kin kawa ya/Sun km wm so mut ta sus/Sus glaw la a sus'.
(Perché stupirsi/Le cose che pensi troppo piccole/A causa del tuo tocco magico).
Questo canto in apertura di una danza che si svolge di notte, appartiene a Cho Sam Tas, che era un Hamatsa della tribù Quiquam, ora defunto. Ogni Hamatsa aveva almeno quattro canti di riferimento e questo, detto Hamam, era il primo della serie, noto anche come ‘canto della corteccia di cedro’ per essere eseguito con un abbigliamento ricavato appunto dalla corteccia dell’albero. E l’albero del cedro era l’elemento naturale con cui erano costruiti molti To-tem, selezionato tra moltissimi altri perché abitato dagli spiriti della natura. Simbolo e oggetto di culto il To-tem veniva posto davanti l’ingresso di alcune ‘tepee’ a raffigurare il suo proprietario o la sua professione; o come pure avveniva, era eretto alla memoria dei defunti che si erano distinti durante una particolare occasione, come la caccia o la guerra; per aver svolto singolari azioni che avevano dato lustro alla comunità tribale; per essere stato un capo saggio e giusto, e che per questo doveva essere ricordato e venerato; altri ancora.
«La religiosità indiana – scrive Charles Hamilton (*) autore di una preziosa raccolta di “Scritti e testimonianze degli Indiani d’America” – si proponeva di essere portatrice di felicità in questo mondo. E quando egli pregava o faceva offerte sacrificali al To-tem, era per ottenere risultati immediati. Se, per qualche ragione, non li otteneva ecco si rivolgeva a un qualche altro più disponibile, poiché nel To-tem tribale, solitamente alzato al centro dell’accampamento molti erano gli spiriti del bene o del male che vi erano rappresentati. Per lo più gli essi credevano che il mondo fosse pervaso dalla peculiare “forza” della magia, posseduta da ogni singolo spirito e che, per loro intercessione, questa potesse entrare a far parte delle doti dell’essere umano, che avendone acquisito il controllo, avrebbe finito col renderlo invulnerabile in battaglia alle armi del nemico, oppure fortunato in una battuta di caccia o irresistibile alle donne. Ogni tribù dava un nome diverso a questa forza misteriosa alfine di averla in esclusiva o ottenerne il favore. Gli Algonquini la chiamavano ‘Manitou’, i Sioux ‘Wakan-Tanka’, mentre i primi missionari qui giunti, confondendola con la loro idea di Dio, chiamarono ‘Grande Spirito’».
Ma i cieli del tempo nascondevano loro ancora molte verità: gli Ojibway, ad esempio, credevano in un doppio Spirito che era Buono o Cattivo e che governava sugli altri ‘della guerra’, ‘della caccia’, ‘degli uccelli dell’aria’ e ‘della medicina’ ritenuto forse tra i più importanti perché era ben rappresentato sulla terra nella figura dello sciamano e che presieda alla nascita e alla crescita delle piante. Uomini e donne apprendevano da lui le virtù delle radici e delle erbe mediche, e che spesso per guadagnarsi il suo favore, si sottoponevano a digiuno per giorni. Fermamente credenti nei poteri benefici o malefici dello sciamano, i guerrieri Ojibway, nei periodi di ostilità, portavano al collo certe erbe che, secondo loro, li avrebbero preservati dalla morte. Ma non erano solo le erbe curatrici delle ferite riportare a caccia o negli scontri con i nemici, i morsi delle tarantole o degli scorpioni, le febbre portate dai parassiti e altro, c’erano inoltre il succo di scorse di alcuni alberi, le radici allucinogene come il peyote e, soprattutto, le argille renose di alcuni luoghi o dei greti di alcuni fiumi, le quali, posate sulle ferite, permettevano loro di guarirle. Una conoscenza profonda dei doni della natura, oggi venuta meno, e che testimonia della simbiosi trovata un tempo dall’uomo con il territorio circostante.
Ancor più i pellerossa, avevano in uso di emettere certi suoni, derivati da alcuni strumenti d’origine magica come tamburi, sonagli, fischietti, zucche essiccate, ed altri; e canti onomatopeici, fonosimbolici e imitativi che servivano a lenire ma anche a curare lo spirito del malato, come ad esempio quella qui riportata:
‘Canto/Inno’ – Indiani Baraga-Ojibwa (v.d.)
'Manitou abisso neta’batadidjig,/Wasswnemaw gaie tebikadisidjig/Miwi tawi shinam anotch maianadak/Bidawishinam anotch maianadak/Bidawi shinam dash mojag weni jishing/Wabanaishinam eji-ogimik/Kinki ginigia, tchi widagwishinged'.
(Manitou, salvaci /Scaccia le potenze delle tenebre/Aiutaci contro il male/Donaci sempre la virtù/Proteggici,/Tu che nascesti perché/Io potessi giungere fino a te/Nei cieli).
L’esempio qui riportato serve soprattutto a dichiarare una certa approssimazione alla traduzione dei testi dei canti in una delle tante espressioni ‘linguistiche’ che distinguono gli Indiani d’America ancora oggi. Si consideri che essi non conoscevano alcuna sorta di alfabeto, tuttavia erano giunti a formalizzare mnemonicamente un linguaggio comune che serviva loro per comunicare, in realtà fra le tribù ci si esprimeva a gesti, con un linguaggio simbolico del tipo usato fra i sordomuti. Un modo di comunicare tuttavia immediato e scorrevole, preciso quasi quanto un discorso fatto di parole. Una sorta di scrittura ideografica tradotta in gesti, interpolato da un simbolismo che ripeteva nei movimenti quello che può essere la modulazione della voce nella poesia. Chi sapeva esprimersi a segni con abilità, era in grado di comunicare anche una storia complicata e, perfino in concetti astratti o fantasiosi. Pur tuttavia, non conoscendo la scrittura come la si intende ufficialmente nei paesi occidentali, la esprimevano per mezzo di ideogrammi sulla tela delle capanne e delle amache, sulla sabbia nei racconti della tradizione, e nelle incisioni su rame, nella corteccia di betulla come fosse una piccola lavagna per messaggi brevi, o dipinta sulle pelli interne ricavate dallo scuoiare degli animali.
Come ci ricorda Raffaele Pettazzoni (*) nella prefazione alla “Enciclopedia della Leggenda” del lontano 1957, e ben per questo ritenuta attendibile più di tanti altri scritti successivi di altri autori:
«La prima scrittura alfabetica usata dagli Indiani dell’America settentrionale fu quella creata per loro da Sequoia nella prima metà del XIX secolo come adattamento dell’alfabeto europeo alla lingua irokese dei Cheroki. Fuori di questa ‘invenzione’, il mondo indigeno nord-americano conobbe e usò soltanto scritture pittografiche, dipinte a colori oppure incise, come quella adoperata per il ‘Walam Olum’, a fissare mnemonicamente le tradizioni sacre dei Lenape. Alcuni ‘testi’ pittografici di contenuto rituale, come canti sacri e simboli iniziatici, relativi alle celebrazioni, comprendono una varietà di mitologie culturalmente differenziate, dovute alla configurazione etnologica del continente nor-americano. Questo, consta schematicamente di un grosso nucleo centrale di civiltà arcaica e uniforme – la massa dei popoli raccoglitori e cacciatori delle grandi foreste e degli aridi altipiani dell’interno (Proto-Algonkini, Proto-Athapaski, Proto-Californiani, ecc.) -, variamente lambito ai due margini costieri del Pacifico e dell’Atlantico, da correnti culturali provenienti dal sud, portatrici di forme più varie e più ricche. Su questo schema si articolano i singoli complessi culturali diversi, e la diversità si riflette anche nelle mitologie».
Seppure nel più lontano passato alcune tribù avessero elaborato forme di scrittura ‘ideografica’, il ‘Walam Olum’ dei Delaware, il cui nome sta a significare “riquadro dipinto”, è il primo e il più antico ‘testo’ (1789 circa) in cui è riportata la storia di un’intera tribù, graffita e colorata su tavolette di legno. Un altro famoso ‘manoscritto’ è il così detto “computo invernale di Cane Solitario” della tribù Sioux, redatto all’incirca tra il 1800 e il 1871. Si tratta di una ‘resoconto’ degli avvenimenti più salienti e degli spostamenti avvenuti sul territorio, trascritta su pelle di bufalo, in cui ogni singolo inverno tra quelle date trova corrispondenza in un dipinto. Altre tribù costiere, quindi più vicine al mare, si servivano per i loro scritti ideografici, dei ‘wam-pum’, frammenti di conchiglie colorate, che forati e uniti assieme, formavano una cintura sulla quale il messaggio poteva essere letto in modo continuativo.
Altre forme di comunicazione che possiamo qui considerare ‘uniche’ nel loro genere, per lo più utilizzate dai guerrieri delle praterie che per ragioni di lontananza avevano qualcosa da comunicare alla propria tribù o ad altre realtà tribali che si trovavano sullo stesso territorio: i così detti “messaggi di fumo”, quello detto “dello specchio” e il “suono dei tamburi parlanti”. Il metodo del ‘fumo’, se il cielo era libero dalle nuvole, permetteva in pochi minuti, di trasmettere un messaggio a cento e più miglia di distanza quasi con la stessa velocità dei ‘fili parlanti’, come i pellerossa in seguito chiamarono il telegrafo. Il metodo era semplice, si accendeva un grande falò facendo in modo che producesse fumo, poi a tratti vi si stendeva sopra una coperta possibilmente umida e subito si risollevava. Il messaggio vero e proprio era contenuto nel numero di piccole nuvole che si levavano alte nel cielo. Un’altra forma, prevedeva l’uso dello specchio, o di una piccola parte di esso, era utilizzata principalmente durante gli appostamenti nella caccia, vuoi per non essere uditi dall’animale, vuoi durante i combattimenti che prevedevano una qualche sortita ad effetto. Il metodo prevedeva alcuni lampeggiamenti, riflessi del sole catturati nello specchio, che in pratica comunicavano la presenza di qualcosa o qualcuno nei paraggi, e che poteva arrivare a distanze imprevedibili fra gli otto e i diciassette chilometri.
C’era poi il “linguaggio dei tamburi” che, utilizzato in diversi modi, era pregno di significato rituale. Va detto che il suono del tamburo era di primaria importanza nella vita comunitaria e culturale dei pellerossa, la cui esistenza, dalla nascita alla morte, era contrassegnata dalla danza e scandita dal suono martellante e arcano del tamburo. Una manifestazione questa che serviva a sottolineare le festività ed altre occasioni particolare di carattere comunitario, come il ritorno di un gruppo dopo un lungo soggiorno lontano dalla tribù, o l’arrivo di ospiti di particolare riguardo. Solitamente la danza iniziava la sera e durava spesso tutta la notte. Scopo primario era appunto ‘la danza’, ma dato che era anche la sola occasione in cui si supponeva che tutti i membri della tribù fossero presenti, essa forniva nello stesso tempo, un ottimo pretesto per rinsaldare i vincoli sociali e per lo scambio reciproco dei doni. Aveva inizio con un canto religioso in cui venivano ringraziati gli déi (spiriti del bene) per aver concesso la salute e contemporaneamente si chiedeva loro di proteggere i partecipanti ad eventuali effetti negativi conseguenti alla esecuzione della danza. Subito dopo il canto di apertura aveva inizio la danza vera e propria suddivisa in tre generi: la ‘danza del the’, ‘del tamburo’, e la ‘Danza Cree’ tipica di questa tribù. In particolare quella detta ‘del tamburo’ vedeva i partecipanti disporsi in un’unica fila e girando in tondo danzare con passo saltellante, chiamato ‘passo del coniglio’.
Diversi erano i tipi di tamburi e le percussioni in genere utilizzate: il ‘tom-tom’ piccolo tamburo a una sola faccia e l’unico percosso con le dita; il ‘nail keg’ a due membrane che si percuote con la bacchetta di legno; e l’ ‘hollow-log’ un tamburo ad acqua con una sola faccia percussiva. La pelle usata era per lo più di cervo o di daino per la sua elasticità e impermeabilità, la stessa che era anche usata per le calzature, i famosi ‘mocassini’ e le sacche. Di particolare interesse era anche una cerimonia religiosa che si svolgeva presso i Chippewa attorno a un grande tamburo decorato detto: ‘dream drum’, tamburo dei sogni, ritenuto sacro e possessore del Grande Spirito, che solo si sprigiona nel suo suono, alla cui costruzione sopravvede lo sciamano della tribù con un rituale dedicato al corso del sole attraverso l’arco del giorno.
‘Canto del tamburo’ – Indiani Navaho (v.d.)
“Haiya ha haya haya ha-a!/Ora ti incontro e sono con te. Haiya ha!/Quando il sole s’affonda a occidente/cominciamo a cantare i canti dell’aquila./La casa del Mago sorge,/drizzata dinanzi a me sul terreno./Noi cominciamo a cantare i anti dell’aquila./Il Mago terrestre ora viene qui./Il Mago terrestre ora viene qui;/dagli abissi sorgono i canti,/e da lui son qui fissati./Poiché ora la terra è fertile/il fratello anziano viene dall’oriente;/egli viene qui come potrebbe un fanciullo,/la terra prospera con la sua venuta./Era nelle montagne a occidente/che dimorava la Donna divoratrice di bianchi./Era nelle montagne a occidente/che dimorava la Donna divoratrice di bianchi./La sera splende rossa all’occidente,/e qui gli uccelli si radunano intorno a me./Ora io odo le grida dell’aquila:/Haiya ha haya haya ha-a!/Ora ti incontro e sono con te. Haiya ha!».
‘Canto del tamburo’ (recitativo) – Indiani Navaho (v.d.)
'Rullate da orlo di rupe ad orlo di rupe,/rullate, venti, dai ripidi muri dei casa./Ecos’ il crescente entusiasmo/aumenta come i venti che soffiano/dalla casa del Mago del Vento./All’oriente, miei giovani fratelli,/noi siamo preceduti dai portatori/delle sacre penne d’aquila./All’oriente, miei giovani fratelli,/noi siamo preceduti dai portatori/delle sacre penne d’aquila./Nella lontana terra dell’aquila,/nella lontana terra dell’aquila/risuona l’armonioso rullio/del tuono riecheggiante./Ora la rondine comincia il suo canto;/ora la rondine comincia il suo canto./E le donne che sono con me,/le povere donne, cominciano a cantare./Le rondini s’incontrano sulle rupi che si ergono;/le rondini s’incontrano sulle rupi che si ergono,/e gli arcobaleni curvati sopra di me,/là gli azzurri archi degli arcobaleni s’incontrano./Le nere rondini qui correndo;/ le nere rondini qui correndo,/correndo qui, vengono per condurmi,/per condurmi laggiù, laggiù./Haiya! Lontano nel distante oriente/giacciono le nubi nascoste dietro le montagne;/lontano verso oriente/alle nubi celate io corro./Noi battiamo i tamburi,/noi battiamo i tamburi/io canto, io ascolto,/dalle mie penne si scuotono le nubi./Io volteggio come l’avvoltoio,/soffermandomi, volando vicino all’azzurro,/io volteggio come l’avvoltoio,/vivo e volo vicino all’azzurro./Ora il rossiccio pipistrello si rallegra/dei canti che noi stiamo cantando;/si rallegra per l’aureola di penne d’aquila/con cui i nostri capi orniamo./Disorientato corsi alla palude/là udii le rane cantare;/disorientato corsi alla palude,/dove le rane coperte di croste cantavano./All’ovest il moscone d’oro vaga,/sfiorando la superficie degli stagni,/toccandoli con la coda rapidamente,/sbattendo le ali fruscianti, passa./Di là io fuggo mentre l’oscurità si raccoglie/portando fiori di cactus nei capelli;/di là io fuggo mentre l’oscurità si raccoglie:/oscurità vibrante verso il luogo del canto'.
‘In a sacred manner I live’ – tradizionale, rielaborata da Frank Fields (v.d.)
'Il sole cocente sulla roccia arsa/lontano una nube di polvere avanza/gli spiriti degli antichi antenati si allontanano./Nella valle verde e rocciosa contornata da alberi/i Sioux stanno facendo una danza/per placare gli spiriti del male./Un’aquila d’oro fa la sua apparizione in cielo/il loro canto dice:/’in maniera sacra noi viviamo/guardando fisso il cielo./In maniera sacra noi viviamo/i nostri cavalli sono molti’.
Se esaminiamo i canti sopra riportati fin da subito notiamo una certa ripetitività delle frasi, un’ostentazione quasi a rimarcare alcune parti del canto stesso. La ragione di ciò sta nell’adeguare la voce (le voci) del cantare alla ripetitività dei passi nella danza eseguita, la cui scansione ritmica equivale ad aumentare la forza che dai suoni emessi arriva ai danzatori. Altro elemento è senz’altro quello animale evocato, in questo caso l’aquila, che tutto sovrasta e la cui regalità domina sul territorio e nello spirito (psiche) umano. Tenuta in grande considerazione da tutte le tribù indiane, l’aquila incarna ‘l’uccello del tuono’ (thunderbird), la cui apparizione improvvisa in cielo faceva sussultare gli animi per il suo coraggio e la forza che da questo scaturiva. Particolarmente ammirata e venerata dai guerrieri, che amavano fregiarsi delle sue penne, era allo stesso tempo altrettanto temuta. Infatti era pensiero comune che con il solo muovere le ali l’aquila producesse il tuono, e il lampo con il solo battito di ciglia; il suo grido era udito dall’una all’altra parte del continente americano. Gli Indiani la catturavano, per farne i caratteristici copricapo, simbolo di potere e regalità. Le sue piume inoltre venivano utilizzate come motivo d’ornamento che apponevano tra i capelli e nel vestiario, come decorazione d’arte e in raffinati oggetti manifatturieri come tamburi, vasellame e coperte, o presa a simbolo decorativo sulle capanne, la cui immagine - si supponeva- proteggeva gli abitanti e la comunità dagli spiriti del male.
L’aquila era largamente presente presso i Pueblo del Sud-Ovest che la veneravano per i suoi poteri soprannaturali. Ad essa dedicarono una danza mimetica detta appunto ‘dell’aquila’ che si svolgeva nel villaggio in attesa della pioggia e nel tempo precendente al raccolto. Era solitamente eseguita dagli uomini che con i loro movimenti imitavano il suo andamento, i passi, i salti, il volo, l’accoppiamento. Prevedeva il canto di un coro accompagnato dal suono di un grosso tamburo che iniziava su un tempo lento per permettere ai danzatori di fare il loro ingresso nello spiazzo battuto; quindi si dava inizio alla danza vera e propria, dapprima lentamente, poi in modo accelerato, per tornare infine sul tempo iniziale. Il costume indossato prevedeva due ampie ali che scendevano dal collo alle braccia e si univano al corpo opportunamente dipinto, sovrastata dal ricchissimo copricapo a imitazione della testa dell’uccello e che conferiva ai danzatori un aspetto non solo bello da vedersi, ma anche perfettamente mimetico:
‘Danza dell’aquila’ – Indiani San Idelfonso (v.d.)
'Laggiù al limite della terra/ho posto/la mia meta./Dentro al tuo corpo/infondo lo spirito …'.
‘Terzo canto Hako’ – Indiani Hako (v.d.)
'Guizza sulla prateria/ment’io cammino/l’ombra di un uccello,/in cerchi sempre più vasti, attorno a me;/volgo i miei occhi all’alto,/Kawas mi guarda,/si volge con un battito d’ali/e vola via lontano.
Intorno ad un albero,/in cerchi sempre più vasti/un’aquila vola,/vegliando attenta sul nido;/forte ella grida,/gettando una sfida lontano,/là sulla terra ampia/riecheggia sfidando i nemici'.
Racconta una leggenda dei Pueblo che l’aquila li salvò da una pestilenza scoppiata dopo un lungo periodo di siccità, la quale, sopraggiunse ad ali spiegate e trasformò la brezza del mattino in nubi cariche di pioggia che lavarono la terra e spazzarono via il morbo dalla terra.
L’importanza di queste danze stava nella preparazione che sottendeva ad esse: nella preparazione del trucco facciale e corporale (body-art), nell’indossare le maschere o mascheramenti che talvolta prendevano tutto il corpo, e nel dedicarle a questo o quello spirito cui erano dirette, che fosse un elemento della natura o un animale. Ve ne sono, infatti, di dedicate al ‘bufalo’, al ‘cavallo’, al ‘serpente’, al ‘cane pazzo’, alla ‘farfalla’, alla ‘strolaga’ e altre dedicate allo ‘spettro’ (ghost dance), e al ‘diavolo’, alla ‘nascita’ e alla ‘rinascita’, alla ‘felicità’ e, ovviamente ‘all’amore’ di cui parleremo in altra occasione. Quella descritta qui di seguito, è conosciuta come ‘Danza del Sole’ tipica dei Sioux e trovava la sua espressione più completa nella cerimonia, piuttosto complicata, che ogni anno si svolgeva durante il plenilunio di mezza estate quando, da ogni località, lontana e vicina, i gruppi e le famiglie di varie tribù si riunivano per assistere all’adempimento dei voti dei loro membri, svolti in onore di ‘Wakan-tanka’, il Grande Misterioso, e farsi così partecipi della vita sociale che era parte del rito annuale.
La descrizione qui riportata appare all’interno dell’antologia “Indiani dell’America del Nord” a cura di Michael I. Asch (*):
"Narra Capo Lunga Lancia Figlio di Bufalo della tribù Sioux-Croatan, che circa mezz’ora prima di mezzogiorno si udiva un gran trambusto di grida e strepiti per l’arrivo nell’accampamento di dodici giovani guerrieri a cavallo, i quali, si trascinavano dietro rami di sempreverde appena tagliati, che dovevano essere gettati sull’impalcatura della capanna, costruita appositamente per la ‘Danza del Sole’. Al segnale dato dall’uomo di medicina, sciamano e stregone, due uomini in abito cerimoniale, entravano al galoppo nello spiazzo portando un nido d’aquila che veniva posto in cima al palo To-tem. Allo scoccare del mezzogiorno, con il sole a picco sul To-tem lo sciamano dava il segnale d’inizio della cerimonia. Il canto che l’accompagnava era eseguito da un coro maschile e da un tamburo e un fischietto di osso ricavato da un’ala di aquila e terminava nel mezzo del tumulto che si levava dal battimento dei piedi sul suolo, sonagli, campanelle, fischietti, grida, canti e zoccoli di cavalli lanciati in corsa pazza nella polvere. Alla fine, la ‘Donna della Danza del Sole’ che, per cinque giorni era stata tenuta a digiuno reclusa in una apposita ‘tepee’, prendeva posto accanto allo sciamano. I giovani guerrieri scelti tra i più coraggiosi, che dovevano affrontare le torture predisposte per loro, si inchinavano davanti alla Donna per farsi dipingere sul viso e i polsi i rituali disegni neri e quindi ricevevano dallo sciamano l’investitura che li avrebbe accompagnati.
Questa consisteva da parte dello stregone munito di un affilato coltello e alcune strisce di pelle cruda lunghe all’incirca un metro, nel praticare profonde ferite a circa quattro centimetri l’una dall’altra sotto una mammella del giovane e far scorrere la lama sotto la carne viva in modo da passarvi la striscia di pelle e legarla, e che poi ripeteva nell’altra. Terminata questa operazione, durante la quale il giovane non doveva essersi lasciato sfuggire neppure un lamento, lo sciamano prendeva una cinghia robusta lunga alcuni metri e ne legava l’estremità alla striscia di pelle attaccata al petto del giovane e legandola al palo To-tem. A questo punto l’aspirante guerriero iniziava la sua vera e propria ‘Danza del Sole’ al ritmo scandito dai tamburi. Avveniva così che il giovane durante la danza dava forti strattoni alle cinghie nel tentativo di liberarsi. Se resisteva a lungo allora lo sciamava ordinava a un guerriero a cavallo affinché lo trascinasse nel tentativo di strappargli la cinghia dalla carne. Spesso la partenza a strappo del cavallo provocava la liberazione. Dopo di ché lo sciamano si prendeva cura di lui medicandolo con erbe selvatiche appositamente preparate. Solo allora il giovane poteva dirsi un ‘guerriero’ forte e coraggioso che avendo egli dato prova del suo valore poteva essere accolto fra i guerrieri più maturi.
Tale procedura aveva anche un significato di qualificazione sociale. Da questo momento in poi egli poteva quindi indossare il copricapo di penne e portarlo fieramente nei combattimenti contro il nemico. Chiunque non avesse superato questa prova non era ritenuto degno di schierarsi tra i ‘prodi’ che prendevano parte alle cerimonie comunitarie, né di combattere al fianco degli altri guerrieri. Presso i Sioux-Oglaga, ad esempio, un uomo non poteva vantare le primarie virtù di coraggio, generosità e integrità se non presentava sul corpo le tracce delle ferite che si era procurato nel corso della 'Danza del Sole'".
Approfondiamo qui un altro tema di carattere religioso: il ‘Culto del Peyote’, curiosa mescolanza di simbolismo religioso (anche cristiano) e di riti e pratiche indiane originarie, in cui confluivano fede e atti di culto, il cui punto centrale consisteva nell’atto di mangiare il ‘peyote’, un cactus privo di spine i cui baccelli si sviluppano per la maggior parte sotto terra, e che gli Indiani identificavano con l’Essere Supremo. Lo stato eccitante ed ipnotico prodotto dal frutto era ulteriormente rafforzato dalla musica incessante che per l’occasione s’accompagnava allo stordimento che la radice procurava. La sua origine, per quanto riguarda gli Indiani nord-americani, ha il suo centro di diffusione in Athabasca ma alcuni studiosi, andando più indietro nel tempo, ne fissano in Messico, con riti simili nella civiltà Azteca. Ha scritto a proposito di questo culto Roberto Leydi (*) in “La musica dei Primitivi”:
"È molto probabile che il ponte attraverso il quale questa ‘religione’ messicana ha potuto giungere nel cuore degli Stati Uniti sia stato il popolo Apache. Il ‘Peyote Cult’ offre infatti, ovunque esso venga praticato, una notevole omogeneità cerimoniale ed espressiva, tanto da costituire quasi un’aria stilistica indipendente sovrapposta ad altre di definizione, oltre che culturale, anche etnica e linguistica. Le canzoni che si cantano durante i meeting notturni (..) hanno infatti carattere ibrido e partecipano al tempo stesso dei modi dell’area Athabasca e di quella della prateria e del gruppo dei Pueblo. Questi canti presentano sempre una struttura incompleta come quelli della prateria che dimostrano una spiccata tendenza ripetitiva, propria della musica Athabasca".
Antonin Artaud (*), in “Viaggio al Paese dei Tarahumara” (1936), a proposito della ‘Danza del Peyotl’, scrive:
"Lassù, sulle pendici dell’enorme montagna che scendeva a scaglioni verso il villaggio, era stato tracciato un cerchio di terra. E già le donne , in ginocchio davanti ai ‘metales’ (mortai di pietra), pestavano il peyote con una sorta di scrupolosa brutalità. Gli assistenti si misero a calpestare il cerchio.Lo calpestarono accuratamente e in tutti i sensi; e in mezzo al cerchio accesero un rogo che il vento aspirò vorticosamente dall’alto. (..) Mi avvicinai per scoprire la natura di quel fuoco e scorsi un groviglio incredibile di campanelli, alcuni d’argento, altri di corno, attaccati a corregge di cuoio, anch’essi nell’attesa del momento per officiare. (..) Intorno a quel cerchio, una zona dove nessun indio si avventurerebbe: si racconta che gli uccelli che vi si smarriscono precipitano, e le donne gravide sentono l’embrione decomporsi. Vi è una storia del mondo nel cerchio di quella danza, racchiusa tra due soli, quello che declina e quello che sorge. E quando il sole declina gli stregoni entrano nel cerchio, e il danzatore dai seicento campanelli lancia il grido di coiote, nella foresta. Il danzatore entra ed esce, tuttavia non lascia il cerchio. Deliberatamente avanza nel male. E vi si getta con una sorta d’orrendo coraggio, a un ritmo che, al di sopra della Danza, sembra disegni la Malattia. E si crede di vederlo volta a volta emergere e scomparire in un movimento che evoca non si sa quali oscure tantalizzazioni. (..) Salta con la sua schiera di campanelli, simile a un’agglomerazioni d’api impazzite, agglutinate le une alle altre, alla rinfusa, in un crepitante e tempestoso disordine. (..) Tra i due soli, dodici tempi in dodici fasi. E il cammino in tondo di tutto quel che brulica intorno al rogo, nei limiti sacri del cerchio: il danzatore, le raspe, gli stregoni. Ai piedi di ogni stregone, una buca sul cui fondo il Maschio e la Femmina della Natura, raffigurati dalle radici ermafrodite del peyote (si sa che il Peyotl rappresenta l’immagine d’un sesso d’uomo e di donna uniti), dormono nella Materia, cioè nel Concreto".
Chi di noi non conosce la ‘Danza della Pioggia’? L’abbiamo vista eseguire in tanti di quei film che disconoscerla significherebbe non essere mai andati al cinema e, forse, non essere mai stati ragazzi, per cui l’intento di provocare la pioggia era di primaria importanza nel gioco ‘degli Indiani’, quasi quanto lo era per gli Zuni o per i Pueblo che, nelle loro cerimonie avevano questo preciso scopo. In proposito Ruth Benedict (*) scrive:
"La danza, come la loro poesia rituale, è una monotona compressione di forze naturali che si ottiene con l’iterazione. L’infaticabile battito dei loro piedi riunisce l’umidità del cielo e l’accumula in grandi nuvole di pioggia. Costringe la pioggia a cadere sulla terra. I danzatori Zuni non si piegano affatto a un’esperienza estatica, ma raggiungano l’identificazione con la natura per piegare le sue stesse forze al loro volere".
L’importanza di questa danza, come di tutte le altre cerimonie aventi lo stesso scopo di provocare la pioggia, può essere compresa in tutto il suo valore se si considera che la regione abitata dagli Zuni – cioè quella dei Pueblo sud-occidentali – va soggetta a ricorrenti siccità. Alla danza prendevano parte numerosi danzatori e ad essa, essendo essa d’interesse comunitario, assistevano tutti i componenti della tribù. Per la stessa ragione lo sciamano che era ritenuto in grado di prevedere con particolare precisione il tempo, e quindi pronosticare l’avvicinarsi della pioggia, era tenuto in grandissima considerazione. Ma chi era davvero lo ‘sciamano’ o ‘stregone’ che dir si voglia? Un individuo ‘iniziato’ che praticava speciali attività rituali magico - religiose, assai diffuse in molte regioni della terra, tra cui l’America settentrionale e meridionale. Dotato di particolari facoltà conosciute a livello etnologico come applicative di tecniche dell’estasi che, secondo la mentalità del primitivo, permetteva a chi le possedeva, di comunicare direttamente con potenze superiori (divinità, esseri supremi e soprattutto spiriti), e di volgere la loro opera in favore degli individui e della comunità d’appartenenza. È però il carattere estatico del suo operare che distingue nettamente lo sciamano da altri tipi di stregoni, indovini e guaritori.
Una delle funzioni più diffuse dello sciamano era di guarire l’ammalato dagli spiriti con cui entra in contatto, egli viene a sapere così la causa della malattia che lo indispone e il modo di curarla e possibilmente di eliminarla. Particolarmente lo sciamano s’impegna nel raggiungere e ricondurre l’anima che ha abbandonato o sta abbandonando l’ammalato. Condizioni indispensabili per uno sciamano sono infatti (o almeno lo erano), il possesso di certe qualità psichiche che gli permettono di comunicare con le potenze superiori e di raggiungere uno stato ‘di possessione’ semi-divina, per cui egli finirà col parlare con la voce degli spiriti invocati e agire per essi. Ciò che gli permette inoltre tutta una serie di attività ‘altre’ come, ad esempio, la funzione di sacerdote cerimoniere duranti i riti tribali, con notevoli capacità ipnotiche e illusionistiche. Ovunque, ma specialmente nelle regioni nord-occidentali lo sciamano è un abile ventriloquo e un profondo conoscitore della fauna e della flora del proprio territorio, nonché dei miti e dei riti inerenti alla tradizione e alla religione.
È pressoché convinzione universale dello sciamanismo che certe malattie siano causate da un turbamento interiore dell’uomo, da uno smarrimento dell’anima. In quel caso solo lo sciamano, colui che attraverso l’estasi varca la soglia dell’invisibile ed è in grado di ‘vedere l’anima, può ricondurla all’uomo e ripristinare l’equilibrio perduto. Ma quella dello sciamano in estasi, equivale a una morte temporanea, grazie alla quale egli ristabilisce il contatto originario che pure in un tempo remoto doveva essere esistito tra il Cielo e la Terra, tra la Terra e l’Uomo. In tal modo, come per molti sciamani, il canto (lento e profondo), materializza la visione del potere che gli è dato, nel cui segreto si nasconde la causa della malattia, solo a quel punto la musica del tamburo incombe come chiave che spalanca le porte dell’immateriale. Molto conosciuto e praticato da tutti gli sciamani era una forma di canto di tipo ‘gutturale’ mantenuta segreta, risalente all’origine ancestrale della voce umana, al suo distinguersi dai suoni animali, ai primi passi verso una lingua articolata. L’emissione di suoni animali, richiama infatti un elemento tipico della ‘trance’ sciamanica, arte che per gli Inuit – ad esempio – rappresenta la quint’essenza della via interiore.
Esistono tuttavia alcune registrazioni di detti suoni ed emissioni vocali chiamate di speciali ‘inni notturni’ detti ‘katajak’, quanto di più estraneo all’orecchio europeo si possa immaginare, e canti specifici ‘per la cura di gravi malattie’, o ‘per la profezia’, in ragione della quale il suono di un tamburo in sottofondo non è solo il suono di un tamburo intorno al fuoco, ma un modo per liberare da stereotipi e preconcetti. Con ciò possiamo dire che è attraverso l’esperienza religiosa vissuta nell’osservanza e nella accurata pratica dei riti e delle cerimonie ad essi connesse che queste popolazioni hanno potuto mantenere viva l’armoniosa relazione con le forze misteriose che governano l’universo che si nasconde nei così detti ‘inni notturni’. Un complesso elaborato e molto sviluppato di queste cerimonie è stato riscontrato presso i Navajo. Vi figurano almeno trentacinque principali, generalmente indicate come ‘Inni’, la maggior parte delle quali hanno lo scopo di curare le malattie. Queste cerimonie, che possono durare da due a nove giorni, sono sempre guidate da uno sciamano ‘stregone’, che è anche il cantore. Si crede che la dottrina cerimoniale ed esoterica del cantore gli sia stata trasmessa attraverso una ininterrotta catena di cantanti dagli stessi déi che conferirono tale potere al primo Navajo.
"'L’inno notturno’ – scrive Willard Rhodes (*) – comunemente noto come ‘Yeibichai’ era parte di una cerimonia che non poteva avere luogo se non dopo la prima gelata. È nel corso di essa che i giovani di entrambi i sessi erano iniziati alla vita cerimoniale della tribù da due danzatori mascherati che impersonavano il ‘Nonno dei Morti’ e la ‘Divinità Femminile’. Durante l’ultima notte ‘Yeibichai’, fa la sua apparizione in compagnia di altre divinità mascherate e di danzatori. Dopo un’invocazione soprannaturale degli déi, i danzatori scuotono i loro sonagli con movimenti violenti, da terra all’altezza del capo, poi si girano nella direzione opposta e ripetono il medesimo gesto. Dopo questa introduzione canonica, i danzatori danno inizio alla danza ritmica e al canto, accompagnandosi con i sonagli. La potenza ipnotica di questa musica si accresce con l’ininterrotto susseguirsi, per tutta la notte, di canti. Gruppi di danzatori che hanno passato settimane e mesi preparandosi per questa cerimonia, gareggiano non solo nella danza e nel canto, ma anche nel proporre nuove melodie in onore di ‘Yeibichai’'.
(continua)
Bibliografia:
Franz Boas, “Anthropology” – Columbia University Press – New York 1908.
Carleton S. Coon, “I popoli cacciatori” – Bompiani 1973.
Aldo Celli, “Canti Indiani del Nord-America” - Firenze 1959.
Martin Palmer, "Il Taoismo", Xenia 1991.
Jaime De Angulo, “Indian Tales” – New York 1940. “Racconti Indiani” – Adelphi 1973.
Claude Lévi-Strauss, “Il pensiero selvaggio” – Il Saggiatore – Milano 1964.
Eckart v. Sydow, “Poesia dei popoli primitivi” - Parma, 1951.
Joyce Sequichie Hifler, “Diario Pellerossa: L’eredità spirituale degli Indiani d’America” - ….
AA.VV. a cura di Franco Meli, “Canti e Narrazioni degli Indiani d’America” – Guanda 1978.
Alfonso M. di Nola, “Canti dei Primitivi” – Garzanti 1961.
Blog: frank.dakota “Indiani d’America” –
Wikipedia: George Catlin (dalla parte degli Indiani) /dipinti.
Note:
(*)Charles Hoffman (vedi discografia)
(*)Ida Halpern (v.d.)
(*)Charles Hamilton, "Scritti e etstimonianze degli Indiani d'America" - Feltrinelli 2007. (v.d.)
(*)Raffaele Pettazzoni, Prefaz. a “Enciclopedia della Leggenda”- UTET 1957.
(*)Michael I. Asch, a cura di, “Indiani dell’America del Nord” -
(*)Roberto Leydi, etnomusicologo italiano. Dal 1973 è stato docente di etnomusicologia al DAMS di Bologna, da cui ha potuto coordinare numerose campagne di ricerca sulle tradizioni musicali di tutte le regioni italiane (ricerca sul campo). Sue opere: “L' altra musica. Etnomusicologia”, Lucca, LIM, 2008; “L' influenza turco-ottomana e zingara nella musica dei Balcani”, Nico Staiti, Nicola Scaldaferri (a cura di), Udine, Nota, 2004. “Gli strumenti musicali e l'etnografia italiana” (1881-1911) /Roberto Leydi, Febo Guizzi, Lucca, LIM, 1996;“L'altra musica”, Giunti-Ricordi, 1991; “I canti popolari italiani, Mondadori, 1973”; “Musica popolare e musica primitiva” , Torino-Eri, 1959.
(*)Antonin Artaud, “Al Paese dei Tarahumara” – Adelphi – 1966.
(*)Ruth Benedict, “Modelli di cultura”, Milano, 1960, antropologa statunitense, studiò antropologia con Franz Boas e dove si laureò nel 1923 ottenendo in seguito una cattedra. Per lungo tempo fu sua assistente Margaret Mead con la quale fece diversi viaggi di studi e sviluppò un legame accademico e di amicizia molto stretto. Nei movimenti studenteschi degli anni sessanta i risultati degli studi effettuati dalla Benedict e dalla Mead furono utilizzati - e a volte interpretati secondo tendenza - per mettere in discussione le strutture e tradizioni patriarcali. Fu una delle prime donne a occuparsi di antropologia ed ebbe difficoltà a farsi accettare dall'establishment accademico, diversi suoi scritti non furono mai pubblicati.
(*)Willard Rhodes, (v.d.)
Discografia:
Michael I. Asch, “Musica degli Indiani e degli Eschimesi dell’America del Nord” – Antologia di musiche e canti a cura di Alberto Paleari. 2LP Albatros – Folkways Records – 1974.
Willard Rhodes c/o The United State Office of Indian Affairs, “Musica delle tribù Indiane d’America Sioux & Navajo” – LP Albatros – VPA 8441.
(*)Charles Hoffman, in “Musica degli Indiani e degli Eschimesi dell’America del Nord” – op. cit.
(*)Ida Halpern, in “Musica degli Indiani e degli Eschimesi dell’America del Nord” – op. cit.
(*)Charles Hamilton, in “Musica degli Indiani e degli Eschimesi dell'America del Nord” – op. cit.
(*) R. Carlos Nakai, “Desert Dance” – Celestial Harmony 13711 30332.
(*) “Sacred Spirit” (Canti degli Indiani d’America) – 2CD Virgin 841245.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etn. 8: Romania ’Il canto della terra’
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGIA 8: Romania “Il Canto della Terra”.
(Dal testo omonimo redatto per RSI Radio della Svizzera Italiana a cura di Pietro Bianchi. Articoli stampa per Audio Review n.36 – 1985 e l’Annuario Discografico 1985).
Il nostro Gran Tour ha inizio lì dove il tempo, in un certo momento storico, sembrava essersi fermato e con esso la storia. Si chiamava così il viaggio intrapreso dai grandi viaggiatori del passato, quando viaggiare significava qualcosa di diverso che andare per diporto, a meno che non fosse per il solitario piacere dell’avventura, o in cerca di qualcosa che comunque esulava dall’essere un inviato speciale o aver intrapreso la carriera diplomatica. In quel caso si era quantomeno Console o Ambasciatore incaricato presso un regno o uno stato. Fatto questo che non ha mai riguardato un ricercatore etnico o il musicologo tout-court che si spingeva addentro in luoghi e ambienti sconosciuti. Solitamente era sempre attratto da una cultura pre-esistente che andava a scandagliare con viscerale bramosia di conoscenza più che a salvaguardarla dalla possibile estinzione. Più spesso era qualche acculturato locale che si accollava questa preoccupazione, con l’andare a cercare quelle che erano le “radici della propria terra”, per dire che risaliva alle origini del proprio passato, e non solo quello più vicino a lui, quanto quello dei propri avi; di quelle che erano le tradizioni popolari entro le quali erano vissuti i padri, i nonni, i bisnonni, e che fino a quel momento nessuno aveva mai pensato di dover abbandonare.
Così come accade per la memoria degli uomini, che hanno scritto nel DNA un termine, anche per il tempo che passa e la storia c’è una fine segnata, e questa è contenuta nel superamento del millennio, che, per la Romania è stato l’anno 2000, in cui, finita la dittatura che la teneva schiacciata al suolo, ha trovato una sua rinascenza sociale e culturale, sebbene in modi differenti da regione a regione, inevitabile dal punto di vista geografico e delle diverse realtà etniche che la popolano. Questo perché la Romania è un puzzle di realtà diverse, formato di minoranze, di usi e costumi, di contrasti tra città che guardano al futuro e villaggi sperduti tra le montagne, rappresentativo di un mondo alla ricerca di se stesso, per molti di noi ancora sconosciuto. Oggi, la Romania è parte integrante dell’Unione Europea (Gennaio 2007), ed anche se le cronache dei diversi paesi comunitari si riempiono di talune malefatte, forse dovremmo ricordarci che ciò non riguarda tutta la popolazione, bensì un numero esiguo di sbandati e disadattati frutto di decenni di dura repressione. Ciò non vuol dire che sono scusati per quello che fanno, ma va comunque riconosciuto loro di non aver goduto di quella libertà che concerne alla dignità umana e che permette la crescita della civiltà.
Quello che affronteremo quest’oggi è dunque un viaggio che ha del “turistico”, seppure lo scopo recondito che mi ha spinto in questa ricerca è comunque “musicale”, per quanto non sia svolta, come si dovrebbe “sul campo”, bensì in ambito letterario e discografico, di materiali recuperati sul mercato. Ciononostante essa è frutto di “immagini” raccolte dal vivo, dall’esperienza diretta, tra passato e presente che la Romania che verrà, offre a chi è interessato a scoprirla nelle sue ricche testimonianze d’epoca romana, chiese bizantine, monasteri arroccati, solenni fortezze e chiese affrescate nascoste nella cupa esistenza dei suoi villaggi e il luminoso “capriccio” delle sue città. Un susseguirsi di scenari in cui perdersi come in una “isola” dalla natura bizzarra, ricca di colori: il verde delle foreste, il blu dei suoi cieli, il rosso e il giallo dei costumi, il nero delle gole buie, il cristallo delle acque dei suoi fiumi e dei suoi laghi sparsi come tanti gioielli incastonati nella corona delle sue montagne, forse un tantino kitsch e comunque come in un diadema, a formare un itinerario insolito e travolgente. Un avvincente percorso che va dalla multiforme Bucarest, anche detta “La Parigi dell’Est”, coi suoi spaziosi e frequentati boulevard, alle terre della mitica Transilvania del conte Dracula, al delta del Danubio, fino alla costa bagnata, per un breve tratto, dal Mar Nero. Pur avendo una propria fisionomia storica, culturale ed etnica che la distingue nettamente dagli stati vicini, la Romania non costituisce una unità geografica ben definita a causa della mancanza per larghi tratti di confini naturali, dell’incertezza di quelli linguistici ed etnici, del loro frequente variare nei secoli.
Conoscere la storia di un territorio, la morfologia della sua natura, il clima, la flora delle sue pianure e la fauna dei suoi boschi, le condizioni di vita della sua gente, certo aiuta a comprendere la pur “semplice” vena creativa delle sue tradizioni popolari, a conoscere l’origine dei racconti di fiaba, la derivazione mitologica delle sue leggende. Così come conoscere le “sorgenti” della musica e del canto, permettono di comprendere la creatività dei “Lautari” quei virtuosi tzigani che riscossero molto successo nelle corti europee e presso musicisti colti e studiosi del folklore. L’etnomusicologia si è occupata poco di questa regione che ho appena definito “isola”, perché in effetti di isola si tratta: una stravagante quanto eccentrica isola “narrata e vissuta” in musica dal popolo che l’ha formalizzata, pur dentro schemi originali irripetibili, perché virtuosa. Qui ogni forma musicale è concepita nel virtuosismo: dall’uso che si fa degli strumenti musicali, alla loro fabbricazione; dalle voci naturali tipiche del canto dell’Oltenia, alle danze vorticose della Valacchia e della Transilvania, fino ai ritmi infuocati della Moldavia e del Banato. In ognuna delle regioni che oggi compongono la Romania, le tradizioni sono molto radicate e rispecchiano la popolazione diversa che le abita, seppure è possibile affermare che una linea musicale comune le abbracci tutte, secondo una sorta di reciprocità e interscambiabilità che conferisce ad essa una sorta di uniformità e, in qualche modo, di unicità, riscontrabile e riferibile come ad un'unica entità popolare.
Ma è giunto il tempo di metterci in viaggio, e riprendere il discorso iniziale da dove il tempo storico, in un certo momento, sembra essersi fermato e con esso la storia. Nelle diverse epoche che si sono succedute, la creatività popolare ha svolto un ruolo incontestabile nello sviluppo della cultura romena. Gli storici hanno tuttavia evidenziato come, sotto il segno delle influenze folkloristiche, si collochino due vertici dell’espressività romena moderna: la musica di George Enescu e la scultura di Constantin Brancusi. In questo periodo si incontrano alcuni fra i più alti ingegni delle lettere romene, prosatori e poeti, come: Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Tudor Arghezi, Jon Creanga e Mihail Sadoveanu, che hanno tratto ispirazione da motivi e canti di ballate della tradizione orale, nonché dalle fiabe e dalle leggende popolari”. Tuttavia va qui necessariamente tenuto conto dello sviluppo relativamente tardivo dei generi letterari più colti, soprattutto la prosa, principale fonte dell’educazione estetica, della cultura spirituale e della formazione della personalità morale riguardo alle arti. Per secoli, in un’epoca in cui non si componevano ancora testi scritti, l’immenso patrimonio della creazione artistica popolare fu affidato alla trasmissione orale: canzoni, ballate, fiabe e brevi storielle allegre sono state tramandate di padre in figlio, da una parte all’altra del paese, adempiendo, in maniera eccellente, alla funzione di guida spirituale di intere generazioni di ascoltatori.
Scrive Sadoveanu (*), uno dei grandi ammiratori e studiosi della letteratura popolare romena:
«Nelle sue pagine mai scritte, fra dolci rime piene di malinconia o di risate burlesche, questa letteratura racchiude in sé tutta la storia di un popolo, con il suo destino di vittorie e di sconfitte, di gioie e di dolori. La nostra storia più antica (..) ci è quasi sconosciuta. Il solo documento antico che in questo modo ci illumina è il canto popolare. (..) Nel dolore e nelle tempeste del nostro nebuloso passato i canti, la ‘dojna’, sono stati fonti di vita e di energia. Finché questo popolo, soffrendo, ha cantato, esso ha dimostrato la volontà di vivere r di vincere (..). Da queste sorgenti di “acqua viva” devono attingere tutti coloro che scrivono e sentono di appartenere a questo popolo e a questa terra».
Avevo prenotato il viaggio per tempo, un viaggio di una settimana appena all’inizio della primavera, sufficiente – mi avevano detto – per vedere quanto sarebbe bastato. Al mio arrivo in aeroporto trovai un giovane accompagnatore, un certo Luca, ben educato e gentile, che mi ha portato fino all’Hotel Central. Lì sono stato accolto con cortesia da Nicolai Farcas, originario di Bucarest, con il quale, insieme ad altri ospiti, mi sono intrattenuto a cena, giusto il tempo per illustrarci quello che sarebbe stato il nostro soggiorno nella capitale e quello che sarebbe stato il viaggio in pullman attraverso le regioni. L’indomani mattina convinco la guida locale (che parlava un buon italiano) a portarmi alla Biblioteca Nazionale dove cercare una qualche pubblicazione sulla ‘dojna’ romena: il bibliotecario (un anziano signore di nome Petri Vargas) ci dice che il materiale da consultare è tantissimo perché, in effetti, un solo trattato non esiste e nessuno dei presenti potrebbe tirare fuori dalla molteplicità delle pubblicazioni ciò che può definire il significato intrinseco e oscuro di una tradizione millenaria. Aggiungendo poi che forse un certo signore che si aggirava in fondo alla sala di sicuro avrebbe potuto darmi informazioni adeguate.
Dubitoso se disturbarlo o meno, decido di presentarmi (con la mia solita faccia tosta) e chiedo quello che avrei voluto sapere sulla ‘dojna’. Di tutto punto questi ci invita a sederci in uno dei tavoli a disposizione ed incomincia a parlare sottovoce in buon italiano:
«Si tratta della varietà di una stessa espressione musicale, anche abbinata al canto, la cui particolarità sta nel penetrare la moltitudine dei sentimenti che invadono lo stato d’animo dell’esecutore; e che, “intima della intimistica morte”, essa è struggente, ieratica, cedevole solo in presenza di una sofferenza incontenibile, capace di farsi amore davanti all’amore, poesia davanti allo spettacolo offerto dalla natura, la cui liricità, s’impone davanti al silenzio che qui tutto circonda».
Ho subito pensato a un prof di musica, anche se il suo nome Constantin sul momento non mi suggeriva gran che, pur avendo egli già dimostrato di avere parecchio da dire. Quindi lo incalzai a parlarmi più estesamente sulla diversità della ‘dojna’musicale da quella cantata.
«Il recitativo lirico innestato nella ‘dojna’ cantata, è per lo più libero e variabile, ciò permette all’interprete di tradurre nella giusta maniera il sentimento che al momento lo anima. Il canto assume allora una caratterizzazione espressamente rituale, che potrebbe dirsi, ieratica, mentre invece la ‘dojna’ puramente strumentale è caratterizzata da una così detta ornamentazione più ricercata di quella vocale. Soprattutto perché quanto si può ricavare da uno strumento, il questo caso il ‘nai’, non si riesce a ricavarlo dalla voce in egual misura. Una forma estremamente espressiva che si vuole scaturita dall’improvvisazione individuale, intuitiva, che favorisce, almeno nei brani strumentali più antichi che si conoscono, un’esecuzione in un certo senso virtuosistica. Non legata ad alcuna speciale occasione o funzione, la ‘dojna’ si presenta come un “canto lungo” che si vuole scaturito, almeno in origine, dai sentimenti che agitavano le pene d’amore della filatrice, come di un velo di consolazione e di bellezza; o forse, che il contadino gettava sulle sofferenze della vita in cui esprimeva, come forma di rivolta contro le dure condizioni della sua grama esistenza. Si tratta dello stesso canto, detto “hora lunga”, a suo tempo individuato da Bela Bartok (*) come melodia lirica pre-esistente sul territorio, certamente di remota origine orientale che, il musicista considerò come la più importante scoperta della sua vasta esperienza folkloristica».
Come primo impatto era niente male – mi dissi. Come del resto amava affermare Pablo Picasso: “Io sono colui che trova”, e quella volta mi sembrò di aver trovato alla grande. Constantin non era un prof qualsiasi, aveva studiato musicologia con il fondatore in Romania della Scuola di Musicologia, la prima riconosciuta ufficialmente, Constantin Brăiloiu, il noto musicologo romeno, curatore di raccolte di musica popolare romena, autore di numerose pubblicazioni e testi sul “folklore musicale” della Romania e dell’area dei Balcani che, a sua volta aspettava di tenere una conferenza sull’argomento, e che questa sarebbe stata in lingua romena, della quale, sono sincero, avevo ed ho tuttora zero conoscenza. Nonostante ciò, (che non era poco), non mi arresi e andai oltre, alla ricerca di materiali sonori da portare con me nel viaggio di ritorno a Milano. Quindi, chiesi a Nicolai di indicarmi un negozio di dischi dove continuare la mia ricerca. Inutile dire che malgrado la mia incredulità trovai alcuni LP straordinariamente interessanti per approfondire la mia conoscenza, pubblicati in Romania dalla House of Culture of Bucharest, con tanto di note in inglese, cosa che in quel tempo non capitava in nessun altro paese, vedi la Grecia o la Jugoslavia, fornite dalla Request Records, haimé senza alcuna data di riferimento. Nonché un secondo album contenente canti d’amore, lamenti pastorali, ballate epiche, ritmi a ballo e filastrocche per giochi, edito dalla Ethnic Folkways Library per il Folklore Institute of the Rumanian People’s Republic, risalente al 1959.
Lo sciogliersi nel canto della ‘dojna’ originaria del Maramures, è evidenziato in questo bell’esempio di ‘dojna’ che, superata una certa rigidità formale nel canto-piano, si presenta in tutta la sua nobiltà e ricchezza tipica delle canzoni più antiche. La canzone evoca il canto di un uccello (anonimo) al quale il cuculo (figura inquietante che appare di frequente), domanda:
«Perché vi lamentate madre mia?/ Piango, canto lamenti funebri/perché ho allevato molti uccellini/ed ora non sono più qui./ Quando le loro ali si sono formate,/se ne sono volati via per il mondo,/ed io, sono rimasta sola …».
Un bottino davvero sorprendente, quanto di meglio per poter approfondire una conoscenza molto vicina all’originale che, certamente in quegli anni corrispondeva alla tradizione, intendo prima dell’arrivo delle sofisticate tecniche successive all’elettrificazione dei suoni. In seguito, dovunque mi sono recato ho acquistato materiali sonori e cartacei per incrementare il mio già proficuo patrimonio musicale relativo a questa ricerca. È così che sono incappato in un altro musicista, questa volta francese, Maurice Cellier (*), ricercatore etnico, studioso del folklore romeno, egli stesso organista, che nelle sue attente note a commento della sua ampia produzione artistica aveva fornito una definizione credibile della ‘dojna’:
«Presa come base fondamentale di tutta la musica dell’area essa presenta una struttura sillabica e melodica dipendente dalle capacità interpretative e virtuosistiche del singolo strumentista che l’esegue o, in qualità di singolo interprete, presta la voce. Il carattere principale della ‘dojna’ sta nell’agibilità della melodia e nel ritmo che permette l’esatta espressione dei sentimenti, di quegli stati d’animo, talvolta favoriti dalla solitudine, vuoi perché l’esecutore (qui inteso come singolo individuo), è animato da un dispiacere d’amore, da una forma di gelosia, o da un amore improvviso, che sia indefinibile oppure ardente, obbedisce al proprio istinto ereditario, e che inconsciamente, si mette a creare, trasformando la sua espressione in opera creativa, vera arte virtuosistica».
Inutile dire che le ‘dojna’, strumentali o cantate che fossero e che una volta fiorivano su tutto il territorio, sono oggi limitate ad alcune zone rurali come la Muntenia e l’Oltenia, per lo più eseguite in forma recitativa improvvisata, con una funzione non dissimile dal ‘blues’afro-americano. La ‘dojna’ è l’unica forma melodica conosciuta dagli abitanti dei villaggi disseminati nelle valli più interne, colma di nostalgia e ansietà, di amarezza e anche di protesta. Le più antiche sono rintracciabili principalmente nella regione dell’Oas. Un tempo sottoposte a una certa rigidità formale, oggi hanno perso molto della nobiltà che le ispirava e, in certo qual senso, quella ricchezza di fondo che le rendeva appassionate e in qualche modo leggendarie. Ma come anche noi sappiamo (perché lo abbiamo appreso), ogni cultura deve le sue funzioni a un fondo mitico o mitologico che sia, e che quando questo viene a mancare, tutto si sgretola nelle fondamenta e si perde la cognizione di ciò che verosimilmente un tempo aveva funzionato da catarsi per la rigenerazione della tradizione che si voleva conservare e che era giusto conservare.
Può risultare altrettanto strano parlare qui di mitologia, quanto invece risulterà deduttivo nel parlare degli strumenti usati nell’esecuzione delle ‘dojna’ che ritroviamo in molte fiabe e leggende romene, nonché in molte testimonianze storiche e culturali trasmesse per lungo tempo solo nella forma orale, e in seguito trascritte ed entrate nella lingua e la letteratura ufficiali del paese. Si pensi che i primi prodotti letterari sono in paleoslavo o, per meglio dire, in una fase arcaica del medio-bulgaro. La prime opere scritte in romeno, risalenti agli albori del XVI sec., sono di carattere religioso, come è rivelato da un attento esame linguistico, per lo più traduzioni della Sacra Scrittura, e fanno la loro apparizione nella regione montuosa Maramures. In Transilvania invece, accanto alla lingua slava della Chiesa ortodossa, la convivenza con gli ungheresi cattolici romani, stanziali sul territorio, portò a suo tempo come lingua di cultura il latino, da cui i dialetti da esso derivati, rappresentano una continuazione nella sua versione parlata. Come si è detto la mancanza di confini fisici ben marcati hanno portato in Romania popolazioni etniche provenienti dai paesi limitrofi come la Bulgaria, l’Ungheria, l’Ucraina, la Jugoslavia; mentre gli ebrei e i Rom (zingari) sono sparsi un po’ dovunque nel paese ai quali non è fatto divieto di poter usare la propria lingua e la loro religione.
Come sempre mi capita, ogni volta mi perdo per la strada, tante sono le cose che rintraccio e di cui vorrei parlare, ed anche Nicolai a più riprese mi ha richiamato all’ordine perché facevo perdere tempo prezioso negli spostamenti da un luogo a un altro. In breve, dopo Arad ci siamo spostati a Timisoara nella regione del Banato, con visita della città a piedi come dopo cena e quindi pernottamento all’Hotel Continental. La notte al Café Europa ho assistito a un concerto Jazz dove la contaminazione con la musica locale era evidente, di una mistura a momenti contrastante, tuttavia interessante per valutare in che misura il passato interagisce col nuovo e quali sono i rapporti di interscambio, come lontana eco di un tempo che torna, ora a destare, ora a cullare, lo spirito lasso di un’antica deità mitologica: Pan. Va qui ricordato che il dio Pan era presente nei rituali arcaici di fertilità, come divinità riconosciuta dalle genti montane, dai pastori e dai cacciatori del passato. I suoi svaghi preferiti, oltre ad allevare api e capre, conosceva l’arte della profezia, e prendeva parte alle veglie delle Ninfe montane, con le quali si vantava di essersi accoppiato più volte. Ancor più vantava di aver sedotto le Menadi ubriache di Dioniso. In una certa occasione inoltre aveva inseguito la casta Siringa fuggente dal Monte Liceo fino al fiume Ladone, dov’ella nel frattempo si era trasformata in giunco lacustre. Pan non riuscendo a distinguerla tra i tanti che crescevano sulla riva, ne recise a caso e con essi fabbricò il suo famoso strumento: ‘sirinx’, con il quale prese a deliziarsi nelle lunghe ore d’ozio passate a pascolare gli armenti.
La leggenda vuole che alla ‘siringa’ costruita da Pan fossero attribuiti poteri magici che la sua natura aveva riposto nelle piccole canne col quale era fabbricato e il cui utilizzo, riversatosi poi nella tradizione di molti popoli, era definitivamente stato accolto nell’archeologia musicale in quanto di intima e seducente rispondenza al mito. Conservato nella forma e nell’uso più antico lo strumento prende il nome orientale di ‘nai’ o ‘flauto di Pan’ che si voglia, presso le genti dell’odierna Romania che, in debito all’oscuro mito, appellano l’inconfondibile melodia che da esso si ricava, con un termine intraducibile: ‘dojna’. Numerose sono le leggende fiorite e verosimilmente riprese di avvenimenti mitologici riconducibili alla mitologia greca e latina, scaturite dall’incontro di tradizioni autoctone con miti universali entrati nei racconti e nelle fiabe romene che hanno il fascino senza tempo delle vecchie storie narrate accanto al fuoco, che nelle sere più lunghe si popolavano di streghe cattive e di fate infinitamente buone, di re cialtroni e cavalieri senza timore, a che la voce flautata del narratore da una parvenza di beltà racchiudendole in un mondo di biechi incantesimi e folli amori, che non è soltanto espressione del talento creativo del popolo romeno e lontana testimonianza dei suoi costumi più antichi, ma specchio dell’eterno sogno di cui l’uomo insegue, instancabile, il filo. È così che troviamo “Il diavolo con la roccia in spalla” novello Prometeo; “Possàga” (*) che ricalca la storia di Orfeo ed Euridice così come altre ricalcano figure e avvenimenti biblici. Leggiamola qui di seguito, (solo le parti riferite al folklore musicale):
«Si racconta che in tempi molto lontani le fanciulle delle montagne non si lasciavano mai lusingare da canti ingannevoli. Ascoltavano solo la voce del loro cuore e tenevano conto dei consigli dei loro vecchi. (..) Possàga figlia del vecchio Vissalòm, era una pastorella, portava le pecorelle a pascolare nelle radure. Il suo ‘corno lungo’ (e la ‘buccina’) da pastora suonava dolcemente come il cinguettio degli usignoli e tanto a lungo da farsi sentire in tutti i pesi dei dintorni. (..) Possàga era bella e ci sapeva fare in casa. Molti la desideravano come moglie, ma fra questi ce n’era uno più bello, forte e ben fatto il suo nome era Vidru. (..) Era alto come un abete, snello e molto forte, ma non sapeva né suonare né cantare. Sapeva solo fischiare e fischiava tanto forte quando partiva per la caccia, da far risonare le montagne. Sapeva anche gridare bene i versi (1) quando ballava ‘la tzarina’ o ‘l’abrudeana’ (2). Ma cantare con voce dolce e intonata non sapeva proprio. E Possàga che era innamorata di lui aveva però fatto giuramento di voler sposare solo chi sapeva cantare come lei. Intanto arrivarono tempi sempre più duri per i motzi (montanari), che scendevano nelle miniere per guadagnarsi il pane estraendo l’oro dal cuore della montagna. Corbàn, il servo dell’Imperatore, s’impossessò di un numero sempre più grande di miniere e i montanari furono costretti a scavare l’oro solo per lui, sotto la minaccia delle armi imperiali. (..) Possàga allora diventò triste e le spuntarono le lacrime. Vagava per le montagne e cantava, cantava ricordando le sofferenze sempre più grandi dei minatori. Quando all’improvviso le venne incontro una donna coi capelli che sembravano di seta, lunghi fino a toccargli le caviglie, e con un bel vestito impreziosito da fiori freschi e foglie verdi. La Fata Buona delle Montagne le si avvicinò, posò la sua mano bianca e sottile sulla sua spalla e le chiese di suonare il ‘corno lungo’ per lei. Possàga portò lo strumento alle labbra e vi soffiò dentro una sola volta. Il suono che venne fuori era, all’inizio, come il mormorio del vento in mezzo all’erba quando sta per arrivare la pioggia in una giornata afosa d’estate. Poi il suono divenne più lungo e straziante, come il lamento delle madri che piangeva noci figli schiacciati sotto i sassi (della frana), che aveva colpito le miniere di Corbàn. La voce del corno lungo risuonava sempre più forte, come le rocce che rotolano giù dalla montagna in primavera o come le voci adirate dei montanari, quando, sulle cime, si accendono le fiaccole della rivolta. Il canto del corno lungo si alzava sempre più forte e più straziante e Possàga, che amava il canto più d’ogni altra cosa, era come scolpita nella pietra, mentre sulle guance della Fata Buona delle Montagne scendevano lacrime amare, e presa dalla commozione prestò a Possàga la sua bacchetta d’oro».
Questo è però solo l’antefatto, la fiaba si dilunga in sorprendenti accadimenti che parlano di un amore impossibile, di un anello fatato, di una ‘foglia’ di faggio che, poggiata sulle labbra emette suoni meravigliosi e tanto dolci da lenire ogni dolore; ed anche di una Megera cattiva e del suono di una ‘cetra’ stregata di cui s’innamorerà Possàga:
«Il suono delle note lontane diventò canzone e la cetra suonava così bene che la ragazza dovette riconoscere di non aver mai sentito prima di allora note tanto dolci, che il cuore le cominciò a battere così forte da sentirsi sciogliersi per amore …».
Il seguito è facilmente riconducibile alle antiche fiabe dove il bene vince sul male, ma questa volta il finale ha un risvolto amaro che vede Vidru affranto dal dolore vagare senza meta sulle rive del fiume dall’acqua limpida che piange la morte della sua adorata Possàga che la Megera cattiva ha trasformata in pietra:
«E Vidru, presa la ‘foglia’ fatata incominciò a suonare. E suonò, suonò … ».
Il cosiddetto ‘corno lungo’ che prende qui il nome di ‘trimbita’ è una varietà del ‘corno delle alpi’ ed è tipico della Transilvania, il cui suono è usato per emettere segnali diretti ai pastori: partenza, raduno o spostamento degli armenti; come richiamo per diversi animali e come segnale di pericolo. Altri segnali riguardano l’annuncio per i morti o per risvegliare la primavera, e sono detti di natura rituale. Un altro strumento è detto ‘caval’ tipico dell’area pastorale della Munténia, sorta di flauto a cinque fori il cui uso è simile al flauto greco di omerica memoria. L’altro strumento citato, la ‘foglia’ di faggio o anche di pero, è suonato tenendo la foglia con le mani tra le labbra, ed è entrato a far parte della tradizione popolare sulla scia delle leggende che lo legano a quel “canto della terra” che in ogni parte del mondo si leva a onorare i doni della natura.
Può sembrare incredibile tuttavia come, in questa breve ricostruzione, vi siano presenti tanti elementi musicali legati al folklore da restarne meravigliati: strumenti, danze, canti, le abitudini popolari romene di gridare versi durante i balli, inoltre a quelli che possono essere i riscontri economici di un territorio, la vita campestre, il duro lavoro della miniera, la possibilità di eventi catastrofici, la ribellione come simbolo di coraggio, ecc. Tutto questo però può non avere importanza, l’importante sta nel fatto che all’interno di esse, rimanipolate, adattate ad uso e consumo di qualcuno, ritroviamo le usanze e i costumi della gente: la povertà e la ricchezza, l’onestà e la rettitudine anteposte all’immoralità e alla slealtà, la giustizia e l’imparzialità, ma anche i sentimenti, le emozioni, gli amori, la gioia e il piacere che sono all’inizio e alla fine d’ognuna di queste brevi, forse piccole “storie”, che pure fanno grande un popolo ricco delle proprie tradizioni.
Nelle leggende, così come nelle credenze e nella letteratura (più tarda), si notano infatti sovrapposizioni e influssi romani, bizantini, slavi, cristiani, ecc. sull’antico patrimonio dei Daci, una popolazione indoeuropea storicamente stanziata nell'area a nord del basso corso del Danubio che da loro ha preso il nome (Dacia, corrispondente grossomodo alle odierne Romania e Moldavia). Ancora oggi molto sviluppata è qui la credenza nel diavolo, al tempo stesso antagonista e collaboratore di Dio, con potere notturno, capacità di incarnarsi in vari animali e di rendere gli esseri umani, ossessi; diffuso è pure il timore delle streghe e dei licantropi. Quella riportata qui di seguito è una delle tante versioni della leggenda conosciuta in tutta l’area dei Balcani, col titolo: “Come il Diavolo aiutò Dio a creare il mondo”, come fu narrata a Vladislav Kornel (*) da un narratore ignoto ungherese, sul finire dell’Ottocento:
«Quando sulla terra o nell’universo non c’era nient’altro che un’immensa quantità d’acqua, Dio decise di creare il mondo, ma non sapeva come fare. Seccato per la sua goffaggine, e in modo particolare dal fatto che non aveva neppure un fratello o un amico che gli potesse dare un buon consiglio, gettò nelle acque il bastone che utilizzava per pascolare le nuvole. Come il bastone cadde nell’acqua, immediatamente ne spuntò un albero gigantesco, le cui radici erano piantate in chissà quali profondità: su uno dei suoi rami sedeva il Diavolo, che allora era ancora bianco, come gli esseri umani creati da Dio. “Caro piccolo Dio! Mio caro fratello!” disse sorridendo il Diavolo. “Mi dispiace davvero per te. Non hai né fratelli né amici. Vuol dire che io sarò per te fratello e amico”. “OH, niente affatto” rispose Dio. “Non mi puoi essere fratello; nessuno può essere mio fratello. Ma sii mio amico”. Nove giorni dopo questo dialogo, quando Dio non aveva ancora creato il mondo, né sapeva ancora come procedere, si accorse, durante una passeggiata, che il Diavolo non nutriva sentimenti poi troppo amichevoli nei suoi confronti. Il Diavolo, che non era stupido, capiì che Dio non si fidava di lui e allora gli disse: “Caro fratello, ti sei accorto anche tu che noi due non siamo fatti proprio l’uno per l’altro? Allora, per favore, abbi la compiacenza di creare qualcun altro, così saremo in tre”. “È facile dire ‘Creane un altro’”, gli rispose Dio molto tristemente. “Crealo tu se la sai tanto lunga”. “Ma io non ne sono capace”, strillò il Diavolo. “Avrei creato un mondo bello e grande già molto tempo fa ma, caro fratello, a che cosa mi servono tutte queste buone intenzioni se non so come metterle in pratica?”. “Bene allora”, disse Dio sovrappensiero e grattandosi la testa come se cercasse di ricordarsi qualcosa. “Creerò questo mondo, e tu mi aiuterai. Presto dunque, e non perdiamo altro tempo: tuffati sott’acqua e portami una manciata di sabbia dal fondo, per farci la terra”. “Davvero?”, fece il Diavolo che sembrava sinceramente sorpreso. “E come farai? Non riesco davvero a capirlo”. “Quando pronuncerò il mio nome, la sabbia si trasformerà, diventando il globo”, gli spiegò Dio. “Ma ora fai presto: portami la sabbia”. Il Diavolo si tuffò dicendo a se stesso: “Oh, non sarò così stupido da permettere che il mondo sia creato da qualcun altro. Lo farò da solo pronunciando il mio nome”. Quando il Diavolo arrivò in fondo al mare, afferrò della sabbia con entrambe le mani: ma quando pronunciò il suo nome fu costretto a lasciarla cadere perché la sabbia gli bruciò le mani. Tornato su, il Diavolo disse a Dio che non aveva trovato la sabbia. “Vai di nuovo a cercarla e portami ciò che ti ho chiesto”. Per nove giorni il Diavolo insisté che non riusciva a trovare la sabbia, il che era una bugia bella e buona visto che proprio con quella sabbia del mare continuava a cercare di creare il mondo. ma, tutte le volte che prendeva la sabbia nelle sue mani e pronunciava il suo nome, si scottava. La sabbia, poi, diventava sempre più calda e lo bruciava tanto che un giorno tornò su nero come il carbone. Quando Dio lo vide conciato in quel modo gli disse: “Vedo che sei diventato tutto nero e che non sei stato un buon amico. Fai presto ora: portami della sabbia dal fondo e non pronunciare più il tuo nome, altrimenti la sabbia ti consumerà”. Il Diavolo si tuffò e finalmente obbedì all’ordine. Dio prese la sabbia, pronunciò il Suo nome, e creò il mondo, che piacque molto al Diavolo. “Bene”, disse sedendosi all’ombra di un grand’albero. “Io vivrò sotto quest’albero e tu, caro fratello, puoi andarti a cercare un altro alloggio”. Tutta questa impudenza, però, alla fine fece arrabbiare Dio che gli gridò: “Ah, furfante! Aspetta solo un attimo e te lo insegno a stare al mondo. vattene immediatamente!”.In quello stesso istante, uscì dal bosco un bue immenso, infilzò il Diavolo con le sue corna e se lo portò via per il mondo. la paura e il dolore fecero gridare il Diavolo così forte che tutte le foglie caddero dall’albero e si trasformarono in essere umani. E fu così che il Signore creò il mondo e gli uomini che lo abitano con l’aiuto del Diavolo» (*).
Crogiuolo di culture diverse che affrancano sostanzialmente due concetti ‘Oriente’ e ‘Occidente’ un tempo ben distinti, che hanno trovato nei Balcani e soprattutto in Romania, il loro punto focale, vuoi scaturito dall’incontro di genti provenienti da popolazioni diverse, vuoi per la concreta interazione avvenuta, come è stato detto, delle forme della cultura che le ha trasformate in un tutt’uno che rende difficile, oggi, distinguerle, e del tutto inutile. Se non per curiosità di conservazione di ciò che ogni singola cultura ha preso o lasciato all’interno dell’altra. Acciò l’uso degli strumenti in musica o della voce nel canto, fungono da testimoni, o meglio rappresentano le testimonianze di questa interazione. Come distinguere un Rom che canta una litania russo-ortodossa, o un Lautaro che suona il violino alla maniera zingara? In quale riquadro inserire nell’ambito della musicologia la ‘cetra’ o la ‘siringa’, o addirittura la ‘foglia di faggio’, in Oriente o in Occidente? Trovare certe risposte oggi non ha molto senso, perché seguire ogni singola traccia migratoria di uno strumento o di una forma di canto, sulla scia delle grandi migrazioni dei popoli, è arduo, anche se non impossibile. Ne è un resoconto il mio libro “Musica Zingara: testimonianze della cultura europea” (*), frutto di ben cinque anni di lavoro svolto con dura fatica per mettere insieme “i pezzi” di una cultura che ho dovuto ricostruire dalle fondamenta, nel quale ho cercato di dare corpo a una tradizione inesistente e tuttavia radicata sul territorio, basata sul coinvolgimento dei popoli, di cui però sfuggivano i termini e si conoscevano solo gli estremi opposti: l’Oriente e l’Occidente.
Era quindi necessario, per armonizzare gli opposti di due culture diverse arrivarea una loro integrazione, cioè a formulare un incontro, anche ipotetico, delle due diverse culture che infine si focalizzano in Romania appunto, in ragione della composizione variegata della popolazione. Esempio unico acculturante, di tanti generi musicali come parte di un insieme più vasto, erroneamente creduto all'inizio di appartenenza di questo o quel mondo diversificato come solitamente esso viene rappresentato sia per quanto riguarda la concezione culturale dell'Oriente, ha sempre prevalso un approccio globale che ne riconosce i diversi livelli di manifestazione, sia nel campo delle arti visive (oggettiva), sia nel campo della musica (poetico-lirica), che in letteraria (scrittura, verbalizzazione) che hanno assunto valore in ambito fisico, cioè emotivo, mentale e spirituale, come in quello dell'equilibrio e dell' “armonia” tra le diverse componenti che ne formano la cultura. La più antica cultura orientale, dedita soprattutto a conoscere le energie che compongono e pervadono la realtà, si è sviluppata a partire dal fruire nell’organismo umano dell’energia che lo pervade, studiando percorsi alternativi delle diverse filosofie rivolte ad un principio assoluto, per cui le diverse concezioni sono riconducibili a una intelligenza universale che riconosce alla vita, nella sua duplice manifestazione materiale e spirituale, di essere parte di un insieme più vasto che porta all’annullamento della individualità. Intelligenza che permette di attribuire un valore altissimo alla propria esistenza e di viverla quindi ancora più intensamente.
Così, se l’interesse “orientale” si è in particolar modo concentrato sulla dimensione interiore, riconoscendo la componente spirituale non solo come parte integrante dell’essere umano, addirittura come la sua vera natura, tanto più l’interesse “occidentale”, si è mosso sulle linee della materialità della vita nel viverla ancor più intensamente. Per così dire, la cultura occidentale ha approfondito la conoscenza della realtà, per cui le facoltà razionali sono state le principali strumentazioni di indagine e di conquista che hanno favorito lo sviluppo tecnologico e scientifico che ben conosciamo e che hanno permesso di raggiungere elevatissimi livelli di conoscenza delle leggi che regolano il mondo della materia. La tendenza all’analisi, alla frammentazione, alla classificazione, che caratterizzano lo spirito della cultura occidentale, hanno però favorito lo sviluppo di un atteggiamento fortemente dualistico in cui esiste una dicotomia tra mente e corpo, tra materia e spirito che si riflette in tutti i campi. Una volta riconosciuta questa bipolarità si può ben capire la ragione della fortissima attrazione reciproca che si è manifestata all’inizio della nuova era verso cui ci stiamo dirigendo con l’integrazione e l’armonizzazione degli opposti, che avviene parallelamente in Oriente quanto in Occidente. Ecco, tutto questo ad esempio, in Romania è già avvenuto da secoli, e tutto quello che noi oggi riscontriamo come facente parte di una unica cultura, trova la sua originalità nella commistione delle culture.
Tralasciamo quindi le filosofie e torniamo alla ricerca che da queste pagine prende l’avvio, sulla falsariga di un “diario di viaggio” anomalo per via delle divagazioni letterarie cui ogni volta mi spingo per diletto ed anche per una sorta di tendenza a rendere partecipi gli altri dei miei stessi interessi di ricercatore e delle mie emozioni di viaggiatore. L’itinerario prosegue verso Sibiu con visita al centro storico; un insieme di elementi gotici, bastioni e torri, case signorili e palazzi in stile barocco austro-ungarico. Molto interessante è la sosta al villaggio di Biertan, patrocinato dall’UNESCO con la visita della chiesa fortificata risalente al 1468. Il viaggio riprende in direzione di Sighisoara la cui Città Alta d’epoca feudale è la meglio conservata della Transilvania. Ma è a Bran che visitiamo il sinistro castello del conte Dracula (che brivido!), per poi fare ritorno a Bucarest. Torno a far visita alla Biblioteca Nazionale dove il signor Petri mi permette di scandagliare nei documenti sonori che occupano una parte davvero esigua.
La musica popolare, che di fatto qui appartiene alla tradizione orale trasmessa da generazioni, si presenta diversificata a più strati, il più antico dei quali trova il proprio corrispettivo in modelli dell’area turco-orientale d’epoca ottomana, sebbene sono riscontrabili alcuni arcaismi propri della musica occidentale, soprattutto nella struttura formale, nello stretto legame con le funzioni fondamentali della vita contadina, agricola e stagionale, di cui conserva una certa ritualità che stenta a scomparire. Ne è un tipico esempio “Foaie verde maghiran” (la foglia verde) la ‘dojna’ cantata, in uso ancora oggi in alcuni villaggi della Moldavia come esorcismo per liberare le forze nascoste della natura:
«Foglia verde sbocciata a Maggio/guardo al sole che nasce/e vedo arrivare la primavera./La riconosco dall’arrivo delle farfalle allegre/ e dalle api operose,/dalle giovani foglie verdi/e dal canto del cuculo,/ed anche dalle grida del contadino/intento al suo lavoro…».
L’interprete di questo brano è un’anziana donna (Maria Lataretu zingara del villaggio Negresti nella regione dell’Oas), la quale, di tanto in tanto, intervalla il canto rifacendo il verso del cuculo, che si dice appartenente a questa specifica canzone che occupa uno spazio preferenziale fra i canti più antichi per la sua liricità. Si tratta di un relitto dell’antica cultura pastorale improvvisato su un tema che fa da base, caratterizzato da una struttura libera e variabile che permette all’interprete di tradurre nella giusta maniera il sentimento espresso nel momento che lo anima. In un’altra versione sul finire del testo è detto:
«Cuculo dai modi sgraziati,/è forse in pena la tua voce?/ Perché canti al mio dolce cuore di morte?».
Quando la festa della primavera giunge alle porte, si fanno i preparativi per accoglierla, che, in alcune regioni, consiste in atti propiziatori per accattivarsi gli spiriti del bene e della fecondità con l’intrecciare ghirlande di fiori. Soprattutto, si da inizio ai festeggiamenti che in alcune regioni come la Valacchia e in Oltenia assumono l’aspetto di una spensierata sagra paesana coronata da almeno un banchetto di nozze. Fatto questo che nella vita comunitaria di un villaggio, ad esempio, occupa un posto di rilievo. È questa l’occasione per fare musica, cantare e ballare all’aria aperta nelle aie e nelle piazze, vera e propria occasione per rinverdire la tradizione. Interessante è la visione di un video (girato in Super8) di anonimo, che riprende una di queste feste in cui sono visibili alcuni strumenti tipici, quali: ‘taragot’, ‘cimbalum’, ‘nai’, ‘cetra’, ‘oboe’, ‘drimba’ (scacciapensieri), ‘vioara’ (violino), ‘tilinca’ (flauto della Moldavia senza becco né fori), e altri più conosciuti come i sassofoni, la cornetta, la viola da gamba, la fisarmonica, trombe e tromboni ecc. Straordinariamente, oltre al ‘cimbalo’ suonato con le bacchette, non si trova notizia di particolari percussioni. Tuttavia alcuni degli strumenti menzionati, hanno contribuito in modo determinante a far conoscere la musica romena oltre i suoi confini geografici, dovuto anche alle genti Rom che li hanno portati con sé nelle escursioni del loro essere nomadi. E dei Lautari che hanno dato forma alle così dette ‘bande musicali’ vere e proprie ensemble itineranti che abbiamo apprezzato in tante occasioni, più o meno famose, come quella del mitico Barbu Lautaru (in disc.), di Yoska Nemeth (in disc.), Fanfare Ciocarlia (in disc.), Taraf de Haidukus (in disc.), Ensemble Tulnicarese (in disc.) e, non in ultima, quella formata da Goran Bregovic (in disc.) apprezzata in Europa e nel resto del mondo.
Per tornare alla ripresa filmica, è l’arrivo di una di queste ‘ensemble’ a dare ad essa l’irrefrenabile vitalità che la distingue da tante altre che si possono vedere in Europa e che trasforma la comune allegria in una festa di colori (costumi, nastri, corpetti, acconciature e gioielli), e fornisce l’occasione per i giovani di mettersi in mostra con l’esibirsi, ad esempio, nelle danze o dare modo di apprezzarne la voce nei canti. Festa alla quale ognuno è invitato a intervenire (straniero o turista che sia), meglio ancora se conoscitore di qualche particolare canzone o in grado di suonare uno strumento. Ma chi sono questi Lautari? – ci si chiede sempre ad ogni loro apparizione. E solitamente il loro arrivo in un villaggio porta, per così dire, quel brio in più di felicità che segna poi il ‘ritmo’ della festosità comune. Con il nome di Lautari, anche detti Boemi, Tzigani, Magiari ed altro, rapprendano una genìa di suonatori, per lo più di origine tzigana, un tempo girovaghi, che vivono oggi perfettamente integrati non solo in Romania bensì in tutta l’area dei Balcani, dalla Jugoslavia alla Macedonia, dalla Bulgaria e dall’Ungheria. Di loro va considerato il fatto che non sono una razza, come potrebbe lasciar intendere l’uso che si fa del loro nome, bensì rapsodi che hanno raccolto la preziosa eredità di un passato mitico della musica, legato alla leggendaria figura del trovatore, poeta e musicista di medievale memoria, il cui patrimonio folkloristico è tale da superare in numero qualsiasi raccolta esistente.
Ai Lautari si deve l’introduzione nella musica popolare l’uso accelerato, alla maniera zingara, del ritmo e l’aver mantenuto in vita il gusto musicale abbinato all’uso degli strumenti; l’autenticità del loro repertorio, siano essi tzigani o no, va abbinata inoltre, la geniale versatilità, le fioriture strumentali, le singolari interpretazioni soliste e vocali. Musicisti nati, nel senso di doti naturali o acquisite senza studio della musica, sempre danno una interpretazione inconfondibile ai brani che eseguono, composto di ornamenti melodici su una base ritmica spesso indiavolata, che mai travisa il libero andare della melodia, anzi, dandole profondità sonora, eleganza e disinvoltura, calore e verve. Il loro stile esotico, anche detto “barbarico” dagli occidentali, è dovuto principalmente dal modo zingaro, assai vicino al sistema cromatico orientale del ‘bhairava’ indù, al quale le loro melodie sono istintivamente adattate; e, se mi si lascia passare l’accostamento, molto vicino al modo di “cantare” arabo andaluso (gitano), forse derivato dal loro leggendario passaggio attraverso l’Egitto, prima del loro stanziare nelle lande montagnose dell’Europa Centrale. Oggi non si conoscono le diversificazioni tra i gruppi “professionisti” e le più famose “bande tzigane” che un tempo erano erano di sola estrazione popolare, poiché entrambi si sono fusi a farmare una unica realtà musicale. In Transilvania, ad esempio, i contadini preferiscono cantare le loro canzoni tipiche e lasciare ai suonatori zingari di suonare i ritmi-a-ballo.
Ciò a conferma del profondo legame fra la musica prettamente etnica con quella probabilmente d’importazione che i gruppi zingari hanno trasferito sa altre aree di contaminazione e liberate dagli schemi più arcaici. Tuttavia, ad un osservatore attento non possono sfuggire, ad esempio, nelle danze, figurazioni e movenze orientali o nel canto, una certa frequentazione con la salmodia ebraica, qui traformata ad uso magico-contadino, con la quale pure sono venuti a contatto nell’ambito di una convivenza prolungata. In occasione della festa, fanno la loro apparizione folti gruppi in costume tradizionale, diversi per ogni regione, a far da cornice all’intrecciarsi delle danze, in attesa che venga approntato il banchetto degli sposi. È allora che i Lautari danno fiato agli ottoni, strusciano le corde dei violini, pigiano i tasti delle fisarmoniche e pigiano i piedi sulla terra battuta dell’aia o sul mattonato della piazza, mentre i partecipanti (tutti) impazzano nella ‘hora’ prevalentemente eseguita da suonatori zingari. Questa danza che - si dice – “chiama amore”. quello della ‘hora’ è un ballo che si diceva “galeotto” per via che forniva a circa la metà delle coppie romene della campagna, l’occasione di incontrarsi, conoscersi e frequentarsi.
È così che, ancora oggi, la danza collettiva continua a essere vivissima, e offre un pretesto d’incontro, e non sono fra i giovani. Oltre alla ‘hora’ si ballano la ‘sirba’ o la ‘facioreasca’ oppure il ‘joc’, ritenute tra le danze più piroettanti e allegre della Romania festosa. Famose per la loro bellezza e varietà, le danze romene vengono solitamente eseguite in colonna, quelle formate da soli uomini: i danzatori, disposti in una lunga fila, pongono le mani alla vita dell’altro che gli sta accanto, e insieme eseguono passi complicati, spostandosi ora da un lato, ora dall’altro, a ritmo incalzante, dal nome ‘briul’, anche detta “danza della cintura” per il modo di tenersi per la cintola dei danzatori. Altre sono la ‘hategana’, danzate in coppia o in circolo dalle donne, e la più conosciuta di tutte, la ‘czarda’, della quale ancora si disputa l’origine con l’Ungheria. Gioiosa e trascinante, fu introdotta nella musica colta 8dell’operetta) verso la fine dell’Ottocento da compositori di rilievi, fra i quali figurano Bartok, Lizst, Kodaly, Monti, spesso eseguita da vere e proprie orchestre.
Lo svolgersi di queste danze nell’antichità e dei riti che talvolta le accompagnavano, variava secondo le regioni, in alcune delle quali si faceva uso di maschere, cosiddette rituali, per la funzione che esse avevano, secondo la tipologia, di essere propedeutiche o iniziatiche. Alcune di esse, ad esempio, rappresentavano animali e verosimilmente (quasi in tutte le popolazioni dedite alla caccia), servivano a mimetizzarsi nell’animale da cacciare; oppure indossate a scopo benefico al fine di accogliere lo spirito e la forza dell’animale cacciato o da cacciare. Tipica della Transilvania è una danza mascherata detta “del cavallino” il cui significato magico è andato smarrito, tuttavia è ancora oggi in uso per il tipico accompagnamento che la distingue e detto “a strigaturi” per l’uso che hanno i danzatori di declamare versi, ai quali fanno eco le voci dell’assemblea. In altri casi, come nel gobbo, nella vecchia o nel fabbro, le maschere riproponevano i personaggi popolari le cui caratteristiche s’imponevano all’evidenza per essere tenutarie di influssi magico-rituali cui si doveva rispetto o anche, riverenziale timore.
L’interesse suscitato dai virtuosi romeni attorno alle antiche ‘dojna’, ha reso possibile il loro definitivo riconoscimento all’interno della grande musica. allo stesso tempo ha elevato alcuni strumenti tipici come il ‘nai’ (flauto di Pan), e il ‘cembalo’ all’altezza degli altri strumenti nell’orchestrazione musicale di molti compositori e strumentisti romeni, depositari delle antiche melopee e conoscitori virtuosi delle musiche che le accompagnano. L’estrema facilità di assimilazione e memorizzazione musicale, ha permesso alle popolazioni di quest’area geografica di estendere il dominio della cultura orale, ai più complessi canti epici sia mitici o storici, divenuti assai rari, erano un tempo narrati o cantati sulla falsariga della ballata su melodie proprie eseguite da contadini-menestrelli più o meno specializzati in un dato ciclo; mentre i poemi lirici, venivano per lo più cantati sulle forma melodica della ‘dojna’. Si rende qui necessario parlare anche di queste “ballate” più o meno epiche e leggendarie che pure sono parte integrante del patrimonio culturale dell’odierna Romania. In esse venivano messe in risalto le gesta eroiche o le peculiarità della vita di personaggi come, ad esempio, del bandito benvoluto dal popolo, che lotta contro i potenti e l’ingiustizia riservata solitamente ai poveri; oppure l’eroe popolare che affronta le cieche forze delle tenebre e fa la guerra ai nemici, invasori delle terre appartenute ai padri. Queste ballate normalmente, portano il nome dell’eroe come, ad esempio, “Porvitazo ardito cavaliere”, “Alexandru Tiberiu”, “Ilincuta Sandrului”, solo per citarne alcune tra le più conosciute. In quest’ultima si narra la storia di una ragazza coraggiosa la quale, catturata dai Turchi, si getta nel Danubio piuttosto che lasciarsi usurpare della propria giovinezza dagli invasori.
A proposito del Danubio, questo grande fiume che scende dai Balcani e che qui sfocia in un grande delta nel Mar Nero, una delle regioni più suggestive della Romania patrocinata dall’UNESCO che, richiede di diritto una narrazione particolareggiata. Arriviamo a Tulcea e guarda caso in un albergo che si chiama proprio Delta, bello e accogliente. Dopo cena Nicolai ci riserva una sorpresa: la narrazione accompagnata dalla visione di un filmato di quella che sarà la nostra escursione nell’area danubiana a partire dall’indomani mattina con piroscafo e annessa visita al locale Museo del Delta. «Qui vivono almeno 1200 specie di alberi e piante, colonie di pellicani, centinaia di specie di pesci, dislocati in un autentico labirinto acquatico e floreale in cui ci si può perdere se non si conoscono bene le molteplici vie d’acqua. La navigazione fluviale è sospesa soltanto durante i forti geli invernali e i primi disgeli» - ci rassicura Nicolai - aggiungendo poi, ovviamente scherzando, che essendo in primavera inoltrata, il rischio vero semmai lo affronteremo al confine con la Jugoslavia, lì dove il fiume s’infossa nelle note gole dette “Porte di Ferro”, ma che questa volta ci risparmierà, soprattutto e “solo” perché, non è previsto nel nostro itinerario.
Una beltà per gli occhi e talmente interessante che riflettendoci su, senza una presentazione adeguata, saremmo rimasti nell’ignoranza di chi intraprende il solito viaggio turistico beandosi solo in ciò che appare in superficie. Dopo la prima colazione in hotel, partenza attraverso il Danubio, per la zona della Moldavia in direzione Galati/Braila. All’arrivo visita panoramica della città con la Chiesa dei Tre Gerarchi, capolavoro dell’architettura ortodosso-romena, la Cattedrale Metropolitana dalle forme tardo-rinascimentali e il Palazzo della Cultura, cui fa seguito una discreta cena con piatti tipici e pesce del Danubio. Non so voi cosa pensiate ma una visita al Palazzo della Cultura da parte mia era doveroso farla. Qui trovo molti scaffali con tomi polverosi e tantissimo materiale riferito al folklore, pezzi manifatturieri come attrezzi fuori uso, cassapanche e madie, tessuti e merletti, oreficeria varia interessanti sotto l’aspetto della ripetizione di una tradizione artigianale mai venuta meno. Ciò nonostante, come si dice, chi cerca trova, tra le varie pubblicazioni in lingua, trovo un libretto di canzoni popolari che il buon Nicolai lesto traduce. «Si tratta – egli dice – di alcune ‘cintec’ popolari molto diffuse su tutto il territorio nazionale, d’appartenenza alla cultura zingara della Transilvania»:
«Lancio il mio cavallo all’alba/e il mio sudore sulla gualdrappa./ Passo i giunchi del fiume/credendo che sono spade./metto il bavaglio alla mia bocca/di discreto miele e grazia./Senza sapere che dimenticasti/di indicarmi la tua casa».
«Per i tuoi neri occhi/lasciai la dolce madre/perché erano dolci e neri/e mi sono piaciuti./Per la tua faccia bianca/ho sofferto assai,/perché era bianca e dolce/ e mi è piaciuta».
Come già detto in precedenza, affiancano queste canzoni popolari pezzi strumentali d’accompagnamento il cui virtuosismo è subordinato all’improvvisazione degli esecutori che, in alcuni esempi, raggiunge tale levatura musicale da non poter essere ripreso da alcun manuale d’insegnamento. Come scrive Vasile Tomescu (*) studioso e insegnante del folklore romeno:
«I Lautari romeni sono più virtuosi che creatori, assimilatori di tecniche intrinseche al loro operato di strumentisti di qualsiasi manuale, per il loro imporre allo strumento il loro gusto “virile” ricco di colorature. Non in ultimo, per certi “effetti” scaturiti dalla loro maestria e conoscenza del proprio strumento, al quale, indubbiamente hanno apportato alcune modifiche, come ad esempio, l’aggiunta di canne extra alle venti che solitamente formano lo strumento originale, così come potrebbero aver incrementato i registri bassi in parte carenti nello strumento arcaico, cioè il flauto di Pan. Del resto, la matrice etnica della musica romena presenta alcune rare influenze turco-arabe verosimilmente importate dalle tribù nomadi che hanno trovato stanziamento nella regione. Va considerato inoltre che qui la tradizione è fino ad oggi salvaguardata dalla condizione socio-culturale, alla quotidianità, come all’alternanza delle stagioni e della vita proletaria e contadina. Una fonte questa, alla quale Bela Bartok ha attinto più abbondantemente che altrove, poiché rappresentativa di tutta l’area carpato-danubiana e della quale il maestro parlava come di “ombelico musicale”», (l’isola da me ipotizzata fin dall’inizio).
È dunque nel clima tipico dell’orchestrazione ‘lautareasca’ che meglio si esprime la tradizione romena, abitualmente composta da uno o più violini, una o due ‘cobza’ (sorta di liuto arcaico ormai sostituito dalla chitarra), un ‘timbalo’ (tamburello), uno o due ‘nai’, un ‘cimpoi’ (piccola cornamusa dotata di un dispositivo per l’effetto “staccato”). Ma altri strumenti di fattura moderna, sono ormai entrati nell’ensemble della come il violoncello (bass e double bass, sassofono (alto e basso) e altri ottoni che solo in alcuni casi fanno la loro apparizione nella “banda lautereasca” formata da autentici lautari. Il ‘cymbalum’ di cui non si conosce l’epoca e il popolo che lo vide nascere, fece la sua prima apparizione in Europa al seguito delle Crociate del XII secolo. In uso prima in Italia e in Francia, passò in seguito in Germania poi in Inghilterra dove sembra abbia acquisito la tipica forma trapezoidale dalla primitiva forma triangolare. Si compone essenzialmente di una tavola armonica in forma di trapezio isoscele, sulla quale sono tese trasversalmente delle forti corde metalliche, da tre a cinque per ogni nota, tenute da caviglie analoghe a quelle del piano, che si fanno vibrare per mezzo di due percussori la cui estremità è circondata di stoppa che l’esecutore deve manovrare agilmente per ottenere i disegni più complicati e gli accordi smaltati. A questo strumento è legato il nome di Gheorghe Radulesco (in disc.), nativo della Valacchia, ed è solo nell’ascoltare la sua musica che è possibile farsi un’idea precisa della particolarità sonora di questo strumento uguale a nessun altro. Dotato di autentico talento musicale virtuosistico, Radulesco offre alla musica il carattere improvvisato della sua fantasia d’esecutore che, liberata da ogni scolastica intrusione, da forza e originalità all’esecuzione.
Tuttavia è il ‘nai’ ad essere ritenuto lo strumento romeno per eccellenza, dovuto anche all’utilizzo che se ne fa come strumento solista. Fànicà Lucà (in disc.) è indubbiamente il maestro assoluto di questo strumento, riconosciuto come il primo grande innovatore e maestro che portò lo strumento all’attenzione internazionale e colui che diede ad esso “il dono della parola”, un nuovo afflato di vita dopo un lungo silenzio dei secoli. Simon Stanciu (in disc.) e Gheorghe Zamfir (in disc.) sono oggi considerati i più rappresentativi interpreti del suo insegnamento. Il più istintivo Stanciu si distingue per il brio tzigano che da alle sue interpretazioni, le più complesse e le più rapide in assoluto, che riesce a ottenere in grazia delle sua tecnica personalissima data dal suono dovuto al posizionamento inusuale delle sue labbra. Autentico virtuoso dello strumento, Zamfir ha elevato il ‘nai’ al repertorio professionale, con l’adattamento di melodie secolari recuperate in aree dimenticate e rappresentative del paese. Custode geloso del segreto che Pan aveva nascosto nelle piccole canne, Gheorghe Zamfir esprime nel suono del ‘nai’ tutta la natura musicale dell’uomo e della terra che l’accoglie, le sue gioie, le sue aspirazioni, ma anche le sue sofferenze, le sue pene:
«Il ‘nai’ – ha egli detto – non è uno strumento del passato, né uno strumento del futuro, è lo strumento stesso del tempo, riferito cioè a quel tempo mitico che non si è mai arrestato, e che trova nella ‘dojna’ romena la propria diversità, una ricchezza unica nel suo genere, la ragione stessa di essere “vera musica”».
Gheorghe Zamfir insieme a Marcel Cellier inoltre hanno firmato le musiche di film di grande successo: "Picnic at Hanging Rock" (in disc.), e "The Light of Experience" (in disc.). Zanfir è anche autore di una "Messe pour la Paix" (in disc.) con la partecipazione de l'Orchestre Symponique de la Radio-Télévision Roumaine, diretta da Paul Popescu, e il Choeur Madrigal diretto da Marin Constantin, salutata quale evento mondiale del 1975, e che segnato l'ingresso del 'Flauto di Pan' nella grande orchestra.
Ma ecco che il suono del ‘nai’ si allontana da noi con l’allontanarsi della nostra imbarcazione di ritorno a Tulcea per poi a bordo del pullman, fare ritorno a Bucarest. Il nostro viaggio finisce qui, con Nicolai che raccoglie i nostri saluti e le speranze di rivederci un giorno. Il cielo già scolora nella sera. L’indomani la primavera sboccerà aprirà le porte all’estate. Per il viaggiatore che abbia la fortuna di assistere a una festa popolare e soprattutto a un corteo nuziale, segnerà un momento di piena gioia e felicità totale. Dopo ci penserà la vita a distrarci dalla felicità ritrovata, di quando bastava poco per sentirsi felici, una banda lautearasca, le danze della tradizione, i canti spontanei. La Romania vi aspetta per regalarvi un sorriso e un incontro veritiero con “il canto della terra” spontaneo e geloso dei propri tesori.
Note:
(*) Mihail Sadoveanu was a Romanian novelist, short story writer, journalist and political figure, One of the most prolific Romanian-language writers, he is remembered mostly for his historical and adventure novels, as well as for his nature writing. An author whose career spanned five decades, early associate of the traditionalist magazine Sămănătorul, before becoming known as a Realist writer and an adherent to the Poporanist current represented by Viaţa Românească journal. His books, critically acclaimed for their vision of age-old solitude and natural abundance, are generally set in the historical region of Moldavia, building on themes from Romania's medieval and early modern history. Among them are Neamul Şoimăreştilor ("The Şoimăreşti Family"), Fraţii Jderi ("The Jderi Brothers") and Zodia Cancerului ("Under the Sign of the Crab"). With Venea o moară pe Siret... ("A Mill Was Floating down the Siret..."), Baltagul ("The Hatchet") and some other works of fiction, Sadoveanu extends his fresco to contemporary history and adapts his style to the psychological novel, Naturalism and Social realism. A founding member of the Romanian Writers' Society and later President of the Romanian Writers' Union, Sadoveanu was also a member of the Romanian Academy since 1921 and a recipient of the Lenin Peace Prize for 1961. He was also Grand Master of the Romanian Freemasonry during the 1930s. The father of Profira and Paul-Mihu Sadoveanu, who also pursued careers as writers, he was the brother-in-law of literary critic Izabela Sadoveanu-Evan.
(*) Constantin Brăiloiu – Musicologo romeno, curatore di raccolte e studî sui canti natalizi (colinde), nuziali, e sui lamenti funebri (bocete). Noto per aver elaborato una moderna teoria del ritmo popolare e delle strutture musicali popolari e aver dotato l’etnomusicologia di una solida base metodologica, in cui i punti salienti sono il costante riferimento alle rivelazioni fonografiche dirette e l'impiego di strumenti d’indagine musicali, linguistici e sociologici. Il suo metodo consisteva nel prendere la prima versione ascoltata di un canto e nello scriverla su un rigo, mettendo, poi, sotto solo le varianti delle nuove versioni. A trascrizione ultimata notò che esistono “logiche di variazione” e concluse affermando che se ci sono variazioni negli stessi punti, c’è una libertà esecutiva regolamentata. Nel 1920 fondò, unitamente ad altri compositori rumeni, la Societatea Compozitorilor Român , (SCR, società dei compositori rumeni), della quale è stato il segretario generale dal 1926 al 1943. Nel 1928 fondò Arhiva de folklore (Archivio del folklore) divenuto presto uno degli archivi di musica etnica più importanti del mondo in quel periodo. Nel 1943 emigrò a Ginevra dove costituì Les Archives internationales de musique populaire, del quale è stato direttore dal 1944 fino alla sua morte.
Sotto l'egida dell'UNESCO, curò inoltre una collana universale di musica popolare, in dischi: “Sirba De La Cetate” Joue Tzigane! (LP, Comp) Fontana; “Bate Murgul Din Picior” con George Folescu - Recital (LP, Mono) - Electrecord; “Baietas Din Tirgu-Jiu” - Joue Tzigane! (LP, Comp) Fontana; “Cîntări Din Lada De Zestre” - (CD, Album) Jurnalul Naţional, Intercont Music; “The Traditional Folk Music Band: I. Oltenia” - Electrecord, Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice. Pubblicazioni:«Problèmes d'ethnomusicologie » - Genève: Minkoff Reprint (1973). «Children's rhythms» - In Lloyd, Problems of Ethnomusicology. Cambridge University Press (1984). «Musical folklore» - In: Lloyd, Problems of Ethnomusicology. Cambridge University Press (1984). «Opere 6. Prima Parte. Introducere, classificare» - note de Emilia Comişel. Bucureşti: Editura Muzicală (1998).
(*) Maurice Cellier, musicologo e organista è il curatore della collana “Universo del folklore” – ARION.
(*) Vladislav Kornel - “Possàga” in “Fiabe e leggende Romene” a cura di Petre Ispirescu e Alexandru Mitru – Edizioni Studio Tesi – Pordenone Italy 1986.
(*) Giorgio Mancinelli, ricercatore etnico e autore di articoli e libri sulla musica nel mondo - “Musica Zingara: testimonianze della cultura europea”– MEF Firenze Atheneum 2006.
(*) Vasile Tomescu, doctor în muzicologie al Universităţii Sorbona din Paris, doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, personalitate proeminentă a ştiinţei muzicale contemporane, 80 de ani de la naştere.
Bibliografia.
The Larousse Encyclopedia of Music – by Geoffrey Hindley – Hamlyn 1978.
“Ancient and Oriental Music” in The Hystory of Music in Sound – Oxford University Press – His master’s Voice – London 1957.
Dizionario Enciclopedico Treccani - vedi alla voce Romania.
“Romania” in Meridiani Anno XIX – Editoriale Domus n.147.
“Rumanian Songs and Dances” from Archive of the Folklore Institute of the Rumanian people’s Republic – Ethnic Folkways Library – NYC 1960.
“I miti greci” - Robert Graves – Longanesi 1979.
“Storie e Fiabe Zingare” a cura di Diane Tong – Guanda 1990.
“Fiabe e leggende Romene” a cura di Petre Ispirescu e Alexandru Mitru – Edizioni Studio Tesi – Pordenone Italy 1986.
“Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” – Giorgio Mancinelli - MEF Firenze Atheneum 2006. (Premio per la Saggistica Italiana l’Autore).
Discografia (consigliata).
“Rumania” – in Musical Atlas - UNESCO Collection/EMI Odeon by Alain Danielou - LP 064-18120.
“Cantati Romaneste-Dansati Romaneste” – Request records Inc. LP SRLP 8113.
“Rumanian Songs and Dances” – Ethnic Folkways Library – LP FE 4387.
“Flauti Rumeni” n.1, n.2 con Gheorghe Zamfir – ARION - LP FARN 1014.
“Flauto di Pan e organo” – Gheorghe Zamfir e Marcel Cellier – Ducale – LP FD332.
“La dojna rumena” – Gheorghe Zamfir – Ducale – LP FD333.
“Il cymbalum rumeno” – Gheorghe Radulesco – ARION LP FARN 1057.
“Musiche nuziali e di feste rumene” – ARION – LP FARN 1104.
“I virtuosi rumeni” – ARION – LP FARN FD335.
“Musiche tzigane” – ARION – LP FARN FD1061.
“Il flauto tzigano” – con Gheorghe Radulesco – ARION – LP FARN 1022.
“Toute la musique Tzigane” con Yoska nemeth – Musidisc 4LP – CCV2519.
“Gypsy Music from the Heart of Europe” – Bratsch – CD World Network.
“Wild sounds from Transylvania, Wallachia & Moldavia” – D. Farcas, T. Mociu, Taraf de haudikus, Fanfare Ciocarlia – CD World Network.
“Road of the Gypsies” – CD World Network.
“Flute de Pan et Reveries” - Gheorghe Zamfir – CD Electrecord – CD 12540.
“Pan Pipes” – Gheorghe Zamfir – CD Music Club 05803.
“Tales and Songs from Weddings and Funerals” – Goran Bregovic – CD Universal 063 079-2.
“Ederlezi” – Goran Bregovic – CD Mercury 558 350-2.
“Violons Tziganes” – (Hungary) – Sàndor Déki Lakatos – HMplus CD 3903027.
Colonne sonore:
Gheorghe Zamfir - "Picnic at Hanging Rock" - Epic - LP EPC 81780
Gheorghe Zamfir - "The Light of Experience" - Epic - LP EPC 81638
Gheorghe Zamfir - Messe pour la Paix" - Philips LP 9101069
Goran Bregovic - "Underground" - Polygram /Mercury CD 5289102
Goran Bregovic - "Les Temps des Gitans" - Mercury CD 842764-2
(*) Si ringrazia Boscolo Travels per l'organizzazione e la perfetta funzionalità del Tour e dei suoi Tour Operator.
*
.jpg) - Musica
- Musica
Etnomusica 7: Letteratura-Viaggio-Antropologia
ETNOMUSICOLOGIA 7 – “Letteratura di Viaggio come Antropologia del Vissuto”.
Titolato così, il connubio tra avventura letteraria e scienza ufficiale può sembrare azzardato, tuttavia non lo è affatto, in ragione che l’una contiene l’altra e, mentre la prima è suscettibile di varianti imprevedibili, l’altra ne trae le conseguenze confermando all’interno della propria esperienza ogni singola conoscenza rilevata, andando a posizionarla all’interno delle diverse discipline che la riguardano. È così che, ad esempio, in ambito musicologico vengono raccolte quelle che sono le esperienze più diverse nell’uso di strumenti, l’evoluzione della danza, la trasformazione di vecchie canzoni e di ritmi a ballo, in nuovi ritmi e nuove assonanze musicali. Come pure, in ambito del costume e delle maschere, un tempo simboli tribali, li ritroviamo trasferiti, lì dove è in atto una qualche trasformazione, e adattati alle esigenze della pubblicità, dei gadget, della moda, ecc..
Anche per questo il moderno ricercatore, oltre a studiare, attraverso la rivisitazione del passato le grandi trasformazioni dell’evoluzione, “deve” necessariamente valutare le progressive significazioni, inventariarle e disporle ad uso pratico e fruibile, e chiedersi in breve: dove sta andando l’umanità (?), per meglio affrontare le sfide che l’aspettano nell’immediato futuro. Da costituire così una sorta di “antropologia del vissuto” che intendo qui formulare quale unico e autentico sbocco possibile dell’antropologia accademica, in grado di catapultare le discipline che la sostengono, nella “nostra” attualità, senza comprometterne la sostanza. Il rischio per l’antropologia è, altrimenti, di chiudere la propria esperienza scientifica nei polverosi tomi delle scienze disconosciute perché antiquate, sorpassate in quanto obsolete.
È possibile che qualcuno gridi allo scandalo, ciò non di meno si rotolerà nella polvere dei vecchi costrutti inducendo qualcun altro (che la pensa come me) a ridere ogni qual volta udrà ripetersi la solita solfa di un possibile “ritorno alle origini” improbabile quanto inutile. Certo, le “origini” vanno comunque giustamente valutate, almeno per ciò che riguarda l’evoluzione umana di cui la scienza antropologica da sempre si fa carico e che ci permette di comprenderne il cammino, il grado di evoluzione sociale raggiunto, la conoscenza culturale cui ogni singolo popolo va riferito. Ovviamente l’antropologia non è solo questo, tuttavia per quanto concerne questa ricerca che, ricordo, disciplinata alla “letteratura di viaggio” e non alla “scoperta archeologica”, quindi nel campo piuttosto limitato ma che, in qualche modo contribuisce a delineare, quelli che chiameremo i “paesaggi antropologici”, da scandagliare quali nuovi possibili territori di conoscenza.
Introduzione necessaria alla scoperta del “fantastico” cui questa ricerca va incontro con il creare le aspettative del nostro viaggiare, a fornire cioè, alla nostra mente, la “straordinarietà” della nostra avventura umana, del nostro voler conoscere ciò che la natura, il mondo, il cosmo hanno in serbo per noi. Perché, se è vero che “sempre più spesso la realtà supera la fantasia” tuttavia non possiamo prescindere da questa. Cioè non possiamo affrontare di “metterci in viaggio” senza concedere alla fantasia una certa prerogativa, quella di essere il frutto della nostra “immaginazione”, perché in fondo perché, non in ultimo, è proprio questa che più alletta il nostro spirito, la volontà di avventurarci in luoghi e situazioni ignote, incontrare genti diverse, scoprire luoghi inesplorati, ascoltare suoni e musiche lontane, assaporare cibi e frutti esotici, estendere la nostra cognizione sessuale, o più verosimilmente, ampliare quella che è la nostra esigua concezione del mondo in cui viviamo.
Ovviamente non solo queste sono le ragioni. A voler cercare, ve ne sono tantissime altre e, molte ce ne suggeriscono i romanzi di avventura, i diari e i vademecum, i reportage di viaggio, le guide turistiche ecc. che, sulla scia dei grandi viaggiatori di un tempo, e ad essi vanno rapportati i condottieri, i navigatori, i sorvolatori degli oceani, gli avventurieri, i pirati e perché no certi poeti visionari (Blake, Rimbaud, ) e molti scrittori illuminati (Verne, Stevenson, Swift, Salgari), hanno lasciato ai posteri le loro attente e talvolta scrupolose “annotazioni” a commento dei viaggi intrapresi in questo o quel continente (Polo, Cook), fra questa o quella popolazione (Lévi-Strauss, Artaud, Guénon, Métraux, Chatwin), per aver scoperto un’antica civiltà (Schliemann, Pettinato), un magnifico tesoro (Carter), o una qualche peculiarità naturale (Darvin, Lorenz), ecc.
A tutti costoro va il nostro grazie più sincero, per aver spalancato l’orizzonte davanti a noi, fatto conoscere terre lontane e popoli diversi, svelato tabù e religioni, mostrato i segreti della scrittura e della musica, della poesia e dell’arte, le peculiarità delle forme, delle espressioni e del pensiero d’ogni popolo e paese. Non tutto ciò che ci è dato ci è stato rivelato anzitempo, tantomeno ciò che andiamo man mano scoprendo ancora in questa supertecnologica era, ci è del tutto spiegato. Pertanto, riconsiderare l’avventura del viaggio in ogni sua disciplina e nella sua raggiunta dimensione può essere considerata un’incognita, per quanto essa sia fattiva di nuovi apporti e concessioni che facciamo a noi stessi, quasi un approvvigionamento di consapevolezza che prepariamo per l’imperscrutabile futuro.
“Pur non potendosi fissare dei criteri certi che permettono di delimitare il genere in confini rigorosamente netti, la definizione "letteratura di viaggio" è di regola associata a opere il cui sviluppo corrisponde interamente a narrazioni di viaggio, tendendosi quindi ad escludere tale caratterizzazione in quelle creazioni la cui articolazione è solo parzialmente interessata da quelle particolari esperienze. Per essere classificabile come “letteratura” deve ovviamente avere il già citato spessore artistico di narrativa, al di là della semplice registrazione di date ed eventi, come possono essere altri generi come, ad esempio, il diario di bordo; può parlare di avventura, esplorazione o scoperta, ma anche essere a tema bucolico o paesaggistico, e in questo genere possono talvolta ricadere reportage turistici e giornalistici. La trattazione letteraria contiene descrizioni e notizie sugli aspetti sociali e storico-culturali dei luoghi visitati e delle genti incontrate, variamente selezionati, filtrati ed elaborati per mezzo della sensibilità culturale soggettiva, con considerazioni e osservazioni che possono spaziare fino ad aspetti di natura antropologica. Ma un elemento essenziale di tale genere letterario è la presenza della figura dell'autore, la cui esperienza diretta e soggettiva assume sempre un peso importante, più o meno preponderante, andandosi ad aggiungere o a sovrapporsi alla componente osservativa e descrittiva. Dal filo narrativo di tale esperienza possono scaturire intrecci e sviluppi dal sapore più marcatamente letterario e romanzesco” (*).
Racconti di terre lontane erano già comuni nella storiografia greca e latina, ma la loro origine erano i racconti di mercanti e marinai, che spesso "condivano" le loro storie con notizie bizzarre e poco realistiche; il primo vero e proprio reportage di viaggio è sicuramente il "Milione", che Marco Polo dettò a Rustichello da Pisa intorno al 1300, descrivendo il suo lungo viaggio e soggiorno nella Cina dei Mongoli, alla corte di Kublai Khan. Un altro esempio di reportage di viaggio scritto per amore del viaggio stesso è senza dubbio la lettera in cui Francesco Petrarca raccontò all'amico Francesco Dionigi della sua scalata del Monte Ventoso nel 1336, oggi considerato il primo esempio di alpinismo, in quanto la scalata non aveva fine pratico; anzi, Petrarca dichiara di averlo voluto scalare solo per ammirare il panorama dalla sua cima e accusa i suoi compagni che lo aspettano più in basso di frigida incuriositas ("fredda carenza di curiosità"): descrivendo l'ascesa questa diventa un'allegoria della sua elevazione morale.
A seguire, troviamo Michault Taillement, poeta presso il duca di Borgogna, viaggiò attraverso il Giura nel 1430 e lasciò scritti delle sue riflessioni personali, la sua reazione inorridita alla vista delle rocce aguzze e delle fragorose cascate dei ruscelli di montagna. Antoine de la Sale, autore di Petit Jehan de Saintre, scalò il cratere di Vulcano nelle Isole Eolie nel 1407, per "una follia di gioventù", e scrisse le sue impressioni. Nel 1589 Richard Hakluyt pubblicò "Voyages", un testo che segna il vero e proprio inizio del genere, seguito a ruota dal così detto Grand Tour, il viaggio in altri Paesi d'Europa (spesso in Italia) per vedere l'arte e l'architettura del passato, che tutti i nobili dovevano intraprendere per essere accolti nell'alta società. E' questo il caso straordinario di John Ruskin di "Le pietre di Venezia". Tra i grandi modelli troviamo "Il viaggio in Italia" di J. W. von Goethe, edito nel 1817. È del 1828 il vademecum "Guide a l’usage d’un Voyageur en Italie" redatto da Marie-Henri Beyle (pseudonimo di Stendhal). Ancora nel diciannovesimo secolo, Robert Louis Stevenson si distinse per i suoi numerosi resoconti di viaggi, descritti con ottimo spirito d'osservazione e arguto umorismo; in uno stile ancora più umoristico saranno alla fine del secolo i romanzi di Jerome Klapka Jerome "Tre uomini a zonzo", e "Tre uomini in barca" (per tacere del cane).
Tra gli altri autori anglosassoni va qui citato lo straordinario David Herbert Lawrence di "Twilight in Italy" (Viaggio in Italia) che meglio suonerebbe tradotto in 'Viaggio tra gli Italiani' per la sua introspezione psicologica, stampato nel 1916, e del quale va qui ricordato anche "Mare di Sardegna" sulla natura affascinante di un'isola che ha ammaliato l'autore. E inoltre, gli statunitensi Paul Theroux, William Least Heat-Moon, il gallese Jan Morris, gli inglesi Bruce Chatwin, Eric Newby, Wilfred Thesiger e Colin Thubron, anche se Morris è noto come storico e Theroux come narratore; ma colui che più di ogni altro ha posto il viaggio al centro della propria visibilità moderna è stato senza dubbio Jack Kerouac (Sulla strada) sempre di grande attualità.
Fra gli italiani citiamo l'umoristico Beppe Severgnini: “Italiani con la valigia”, “Un italiano in America”, “Manuale dell’imperfetto viaggiatore”; e i numerosi autori del genere che nascono dal giornalismo, come Tiziano Terzani: “La porta proibita”, “Un indovino mi disse”, “In Asia”, “Un altro giro di giostra”; Guido Piovene “De America”, “Viaggio in Italia” e Paolo Rumiz “L'Italia in seconda classe”, “La leggenda dei monti naviganti”, “È Oriente”; o le narrazioni di Giorgio Bettinelli, che ci ha raccontato a più riprese il giro del Mondo compiuto in Vespa e considerato da molti uno dei pochi veri viaggiatori degli ultimi decenni. Da non dimenticare l'infaticabile e straordinario Angelo Maria Ripellino di "Praga Magica", che fa la radiografia di una città attraverso la sua letteratura. E che dire allora di Umberto Eco, il più grande viaggiatore “fantastico” di tutti i tempi, se non sono “viaggi” in ogni senso e in ogni direzione i suoi romanzi, quali altri? – mi chiedo. A cominciare da “L’isola del giorno dopo” fino all’ultimo “Il Cimitero di Praga” il cui “viaggiare” è per il protagonista un labirinto oscuro e polveroso ('già, la polvere, ma quella è tutt’altra storia') in cui l’autore intrappola l’affaccendato lettore e lo costringe a perdersi nei rimandi di un passato fin troppo presente, a quella realtà quasi sconcertante che è il nostro “surrealismo” quotidiano. È allora che, catturati dall’enfasi scrittoria dell’autore, entriamo nella fiction letteraria (in cui egli ci trascina quasi prendendoci per i capelli), e ci fa dono di quella “meraviglia” che è il suo linguaggio: ora opaco di terracotta ruvida (degli errori e orrori della storia), ora di porcellana fine (personaggi e luoghi poco conosciuti), e pur sempre cristallino, di vetro soffiato (alchemico e misterioso), con un’eleganza verbale, una scioltezza tale da poter riscrivere tutto il dizionario della lingua italiana, dove perdersi, infine, nei meandri di quella realtà “immaginaria” che fa di Eco l’architetto della “storia”, sebbene traslitterata, proscritta e profuga che non conosciamo, solo perché abbiamo chiuso l’uditorio a ciò che è “altro”, o forse, a quell’“altrui” che rifiutiamo e che spesso si avvicina più d’ogni altra cosa, alla realtà in cui viviamo. Se, come scrive Teilhard de Chardin “Solo il fantastico ha qualche possibilità di essere reale”, allora l’immaginario mondo ricostruito per noi dall’infaticabile Eco, è l’unico dei mondi possibili, dove cercare noi stessi.
Ci sono poi i romanzi di Cormac McCarthy, Premio Pulitzer per “La Strada”, che pur nella sua esiguità letteraria, risulta fin troppo crudo, a tratti violento, eppure straordinario. Se davvero vogliamo formulare un giudizio sul romanzo, tornato ad affacciarsi alla ribalta grazie alla trasposizione cinematografica (mera traduzione filmata diretta dall’australiano John Hillcoat che lo ha presentato in concorso all'ultima Mostra di Venezia che, se non altro, è valsa a testimoniare al più ampio pubblico, certamente più ampio dei lettori che avranno letto il libro), l’altissimo messaggio d'amore tra padre-figlio, (di cui non si trova quasi traccia nella letteratura contemporanea). Una storia forse non nuova, ma di certo avvincente, “incentrata sui postumi di un Armageddon, in cui un padre e un figlio si trascinano attraverso scenari post-apocalittici, tra le rovine della civiltà, assediati da fame, disperazione e uomini regrediti che riscoprono gli istinti bestiali del cannibalismo”. Che è anche messaggio d’amore e di vita, per una consumata esistenza-sopravvivenza, che funge da trama portante in un mondo “di puro orrore” dove, il nuovo pericolo incombente della radioattività nucleare ci presenta uno scenario che riprende le atmosfere metafisiche da fantascienza apocalittica, confermandole. Non ci rimane che rileggere questo incredibile libro, per essere sicuri di ciò che la sconvolgente “realtà” dell’autore (quasi una profezia di quanto sta accadendo) ha portato alla ribalta in un momento come questo, in cui davvero serve tutta la nostra partecipata comprensione.
A testimoniare che il racconto di viaggio è sempre stato un argomento affascinante per autori di epoche molto diverse, potremmo citare come affini al genere anche resoconti di viaggi immaginari; l' “Odissea” di Omero, il viaggio allegorico di Dante Alighieri nella “Divina Commedia”, il “Viaggio in Occidente” di Wú Chéng'ēn, il “Candido” di Voltaire, “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift. Diffusi nel Medioevo, soprattutto in aree dove l'alfabetizzazione era già in stato avanzato (come a Firenze), erano i "libri di ricordanze", sorta di memorie, "ricordanze" appunto, registrate per sé o per i familiari o per i posteri immediati, scritti generalmente con brani che iniziano ciascuno con "Ricordo che...", a metà strada tra la cronaca e l'autobiografia. Spesso questi libri sono dei preziosi documenti sulla vita e i costumi del tempo. Tra questi il “Libro di ricordanze” di Giorgio Vasari o il “Libro di ricordi” di Bernardo Machiavelli, ma anche in qualche modo, sebbene in forma di dialogo, i “Libri di famiglia” di Leon Battista Alberti. Ne riprende la tradizione anche “Pomo pero” di Luigi Meneghello.
Altra forma narrativa e letteraria è il cosiddetto "diario", in cui il racconto, reale o di fantasia, è sviluppato cronologicamente, spesso scandito ad intervalli di tempo regolari, solitamente in giorni. Può essere la cronaca della vita o di un periodo di vita di una persona, ma anche la raccolta di annotazioni giornaliere in cui vengono descritti fatti di rilievo, avvenimenti politici, sociali, economici, osservazioni di carattere scientifico o altro. Dal punto di vista della tipologia testuale è la forma che di solito rivela la parte più intima dell'autore. Chi scrive lo fa per puntualizzare a se stesso ciò che gli sta accadendo in quel periodo, senza pensare troppo al passato ma ponendo l'attenzione sul presente. Solitamente all'inizio di una pagina viene scritta la data in cui si scrive; il destinatario può essere o il diario stesso o un amico immaginario. Il linguaggio è di solito semplice, esistono anche, oltre ai diari veri, quelli creati da un autore che si inventa un personaggio che parla di sé.
Con "diario" si indica anche il supporto materiale dove questo racconto viene realizzato; una moderna forma di diario, in questo senso, è quella affidata all'informatica attraverso la tenuta di blog personali. Solamente nel Rinascimento il diario si distinse dalla autobiografia e dalla cronaca, assumendo la funzione di annotatore di appunti da ricordare e di eventi spirituali dello scrivente, utili per un miglioramento ed un perfezionamento. In un secondo tempo questa tendenza passò anche nel mondo laico. Alla stregua del diario di viaggio, il diario di bordo ha da sempre aiutato esploratori di ogni specie ad appuntare le varie fasi delle proprie imprese. Si riferisce nel particolare a viaggi effettuati su imbarcazioni e che riportano quanto accade a bordo della stessa. Diversi diari di bordo e di navigazione sono stati raccolti da Giovanni Battista Ramusio nel suo “Navigazioni e viaggi” (pubblicato intorno al 1550).
Tra i più famosi “Diari di bordo”, quelli della prima navigazione verso l'America di Cristoforo Colombo (dal 3 agosto 1492 al 15 marzo 1493). James Cook “I diari di bordo dell'Endeavour”, “I diari del primo viaggio di Cook, 1768-1771”, “Diario di Cook durante il suo primo viaggio intorno al mondo”. L'espressione è diventata parte del linguaggio comune, tanto da essere spesso ripresa anche da personaggi famosi per indicare annotazioni personali: John Steinbeck, William Least Heat-Moon, Robert M. Pirsig, che da Melville di “Moby Dick” portano fino a Hugo Pratt. Quest’ultimo, autore delle avventure ormai famose di “Corto Maltese”, va ricordato per il suo narrare storie di mare come fossero “tentativi di raccontare la vita”, attraverso le quali, il solitario giramondo Corto Maltese da una svolta moderna al racconto d’avventura, affrontando temi inusuali come l’amore e l’amicizia, la giustizia e la morte.
D’altro genere è il “Diario di Guerra”, tenuto sia da ufficiali nella propria funzione sia da soldati. Anche il diario di Resistenza e di prigionia dovuta a guerra possono rientrare in questa categoria. Qualcuno considera diari anche il “De bello Gallico” o il “De bello civili” di Gaio Giulio Cesare. Tra i diari di prigionia, quelli di Giovanni Ansaldo, Carlo Emilio Gadda o “Un soldato racconta” (1960) di Ruggero Y. Quintavalle. Anche “Se questo è un uomo” o “La ricerca delle radici” di Primo Levi (benché non abbia forma di diario, con le date), come poteva essere “Le mie prigioni” di Silvio Pellico o il racconto dell'esilio di Teresina Bontempi, oppure il romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi.
Nel “diario intimo”, viceversa, il diarista si misura con una sorta d'amico immaginario che si rispecchia nel suo mondo interiore, in una forma di scrittura che assomiglia di più a una presa di coscienza. Al diario non si nasconde nulla e si possono avere più modi per scrivere questo diario. Si può raccontare della giornata, oppure dei sentimenti che si ha e che si ha paura di dire agli altri. Il diario è comunque un racconto personale, che, può essere scritto in modo fantasioso, oppure si scrive la realtà. Dall'Ottocento in poi, il diario prende sempre di più la forma del cosiddetto journal intime che mostra spesso emozioni, sensazioni e sentimenti allo stato nascente o latente, non ancora ben compresi dalla persona, come nel caso del celebre “Diario” di Anna Frank, dove la narratrice, immaginando di scrivere lettere a un'amica inesistente, ovvero un alter ego, racconta gli avvenimenti del giorno per esteso, scegliendo la forma della lettera. Altrettanto celebre è il precedente “Diario intimo” di Henri-Frédéric Amiel. In forma di diario è anche la narrazione di “Quaderno proibito”, di Alba de Céspedes , che inizia con il piccolo atto di trasgressione che da il titolo al romanzo.
Hanno scritto diari intimi anche Niccolò Tommaseo, Vittorio Imbriani, Sully Prudhomme, Miguel de Unamuno e John Henry Newman. Come romanzi si possono ricordare il “Le Journal d'une femme de chambre” (1900) di Octave Mirbeau o il “Diario intimo di un cattivo” (1989) di Giorgio Saviane. In questo ambito sono state anche raccolte memorie erotiche, più o meno storicamente interessanti come le “Memorie di una maîtresse americana” di Nell Kimball o “Memorie di una cameriera” di O. Mierbeau, così come i vari libretti anonimi che periodicamente affollano librerie ed edicole. In fondo anche “L’amante di Lady Chatterly” di D. H. Lawrence è una forma di diario e, ancor più lo è tutta “A la recherche du temps perdu” di Marcel Proust, un lungo, sottile filo conduttore di un’intimità vissuta in modo edonistico.
Nella letteratura propriamente detta è un esempio di “diario per appunti” quello scritto da Cesare Pavese in “Il mestiere di vivere”. Si tratta di un diario che non racconta mai episodi interi, ma vi allude senza rendere espliciti i riferimenti a fatti e persone. In esso vi è un minimo di forma dialogica, ma il "tu" che a volte appare è in realtà un "io". Il diario di Pavese è fatto di sensazioni e di istanti che vengono espressi in forma sintetica e lapidaria, spesso senza verbo o costruite su un verbo all'infinito o al participio passato. Mentre nella pratica psicoanalitica alcune scuole mediche stabiliscono che il paziente debba tenere un diario di sogni, scritto ogni mattino al risveglio. Anche per i disordini del sonno, come le parasonnie e le dissonnie possono richiedere la tenuta di un diario del sonno. Anche le diete e in generale qualsiasi terapia possono prendere la forma dell'appunto di diario, ma questo va sotto il nome di diario medico.
Un’altra forma letteraria è il resoconto del “viaggio di scoperta”. Spesso negli atlanti, il planisfero che illustra le scoperte geografiche e i progressi nella conoscenza del mondo mostra i cinque paesi per conto dei quali le scoperte geografiche sono state fatte: Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda. Una superficie minima nel planisfero. Lo squilibrio della prospettiva eurocentrica è ancora più forte dal punto di vista letterario: sono quasi ignoti in Occidente gli scritti del cinese Zang Qian, che nel sec. II spingendosi verso ovest toccò i limiti dell'impero romano; o gli scritti dell'arabo Ibn Battuta che nel sec. XIV visitò il mondo musulmano dall'Africa settentrionale all'India e toccò la Russia meridionale, la Malesia, la Cina. Così come lo sono “La scoperta di Troia” di Schilieman, i molti libri sull’Egitto di P. Vandenberg, “La valle”; o la ricerca de “Le sorgenti del Nilo” di …., C. W. Ceram “I detective dell’Archeologia”, e tantissimi altri che riprendono dalla letteratura di viaggio là dov’è cominciata nella tradizione occidentale con la letteratura greca. L' “Odissea” di Omero è una storia di viaggi in parte probabilmente fantastici, ma è testimonianza autentica di un amore per l'avventura e le esplorazioni che caratterizzerà tutte le culture occidentali nei secoli successivi. Nel sec. V a.C., con le “Storie” di Erodoto, all'amore per la conoscenza si accompagna una strategia di dominio. Nel sec. IV a.C. l' “Anabasi” di Senofonte è la cronaca di un'impresa militare; quest'ultimo filone continua nella letteratura latina con i “Commentari” di Giulio Cesare (sec. I a.C.). Nel sec. II d.C., con Pausania si delinea un atteggiamento precursore di quello che si chiamerà turismo circa venti secoli dopo.
Nel medioevo i viaggiatori sono missionari o ambasciatori e mercanti. Tra i primi, i francescani Giovanni da Pian del Carpine e Odorico da Pordenone si spingono nell'Asia centrale e orientale rispettivamente nel 1247 e nel 1331. Tra i secondi, il veneziano Marco Polo soggioma in Cina dal 1275 al 1291, e non scrive un libro sui suoi viaggi bensì fornisce oralmente i dati per scriverlo a Rustichello da Pisa, mentre sono entrambi in prigione a Genova nel 1298. Rustichello, professionalmente rifacitore di romanzi arturiani, scrive in «francese di Lombardia», quel che gli racconta Marco Polo. Questo libro di due autori, titolato “Il Milione” nella traduzione fiorentina anteriore al 1309, suscita la diffidenza di alcuni letterati per la sua genesi giornalistica e ancor oggi vengono sollevati dubbi sulla veridicità del racconto; ma nonostante ciò, o forse proprio per questo, resta il più bello tra tutti i libri di viaggio e uno dei più bei libri che siano stati mai scritti. Il viaggio d'andata di Marco Polo è per terra, come quelli di Giovanni da Pian del Carpine e di Odorico da Pordenone; il ritorno è per mare.
E per mare la maggioranza dei più importanti viaggi successivi, a cominciare da quello di Alvise Cadamosto (che nel 1456 al servizio del Portogallo scopre le Isole di Capo Verde) per culminare con quello di Antonio Pigafetta (che nel 1519-22 partecipa alla spedizione di Magellano). Le relazioni di questi viaggi, e di una sessantina d'altri, sono raccolte nei tre volumi delle Navigazioni e viaggi curati da Giambattista Ramusio tra il 1550 e il 1559. Ramusio traduce, annota, manipola brani derivati da codici oggi perduti; che non fà invece con il “Diario” di Cristoforo Colombo perché, consegnato ai sovrani di Castiglia, resterà coperto dal segreto di stato fino al 1825. Successivi alla «summa» di Ramusio sono altri libri di viaggio che, come quelli di Filippo Sassetti e di Francesco Carletti, interessano quasi solo la storia della letteratura italiana. Daniello Bartoli scrive su India, Giappone, Cina senza mai muoversi di casa. Sia per la storia delle scoperte, sia per le storie letterarie, hanno peso ormai viaggiatori e scrittori di paesi diversi dall'Italia. Le più importanti raccolte di libri di viaggio, dopo Ramusio, sono quelle dell'inglese Richard Hakluyt (dal 1589) e del francese Antoine Frangois Prévost (dal 1746), ma con il Settecento il numero dei libri di viaggio si accresce vertiginosamente. Tra i capolavori indiscussi si possono ricordare i libri dei coetanei James Cook (n. 1728), L. A. Bougainville (n. 1729), J. H. Bemardin de Saint Pierre (n. 1737). I primi due sono testi sacri per gli illuministi, il terzo è uno tra i primi esempi di letteratura romantica.
Il “viaggio di formazione” prende spunto dai resoconti di esploratori e diplomatici nei quali prevale l'osservazione geografica, naturalistica o etnografica, che servirà da traccia alle conquiste coloniali. Tra il sec. XVI e il XVII l'interesse dei giovani aristocratici e degli artisti si orienta piuttosto verso il viaggio di formazione intellettuale e, soprattutto, verso il viaggio in Italia, ispirato al culto dell'antichità. Da Montaigne a Goethe, il viaggio assume per l'intellettuale il valore di esperienza conoscitiva e di scoperta interiore, nella relazione tra individualità del soggetto e singolarità del luogo. L'Italia, insieme con la Grecia e il Vicino Oriente, diventa così tappa obbligata del «Grand Tour» che si impone tra le classi colte d'Europa per tutto il sec. XVIII. Cento anni dopo un nuovo flusso di viaggiatori, questa volta provenienti da oltreoceano (N. Hawthome, H. James), rinnova i fasti del viaggiare. Nell'era dell'imperialismo, agli albori della cultura di massa, si diffondono le suggestioni dell'esotismo: il miraggio di una fuga dalla mediocrità è al fondo di gran parte della letteratura di viaggio fra i secoli XIX e XX, mentre nel Baedeker (inventato da K. Baedeker a metà del sec. XIX) si va delineando il modello di un nuovo modo di «consumare» il viaggio: il turismo. Nel frattempo si completa la conquista europea del globo che giunge in molti casi ad assumere le forme dell'etnocidio e dell'ecocidio. C. Lévi Strauss apre il suo “Tristi tropici” (1955) con la frase: «Odio i viaggi e gli esploratori», deprecando la mistificazione operata dagli innumerevoli libri di viaggio di mestieranti dell'«avventura» che sostituiscono il convenzionale al vissuto per poter essere consumati da un pubblico sempre più vasto.
Nella produzione del nostro secolo, nonostante la concorrenza dei giornalisti, i romanzieri restano i soggetti maggiormente accreditati alla narrazione di viaggio di carattere documentario e di riflessione culturale. Il genere «travel writing» si sviluppa soprattutto in ambito anglosassone. Tra gli autori più noti come D.H. Lawrence, G. Greene, E. Waugh, P. Bowels sono affiancati da una nuova generazione di scrittori-viaggiatori come B. Chatwin, P. Theroux, K. White, R. O'Hanlon, J.M. Le Clézio, i cui resoconti tendono ad applicare alla restituzione del reale le tecniche del romanzo, in una dimensione narrativa che ha il suo grande precedente in T.E. Lawrence (da non confondere con l'altro) autore de "I Sette Pilastri della Saggezza". Ma anche in Francia con Alfred Métraux “Meravigliosa Isola di Pasqua”, Bernard Pierre “Storia del Nilo”, Paolo Matthiae “Gli archivi reali di Ebla”, ed alcuni scrittori latinoamericani, come L. Sepúlveda “Il mondo alla fine del mondo” (Mundo del fin del mundo), J. M. Arguedas “I fiumi profondi”, J. Amado “Terre del finimondo”, P. Coelho "Il Cammino di Santiago", "L'Alchimista", J. Saramago "Viaggio in Portogallo", in cui il resoconto di viaggio tende a configurarsi come interpretazione intimistica o storico-critica della condizione dei diversi paesi visitati.
In Italia hanno scritto libri di viaggio, tra gli altri, A. Moravia, G. Parise, A. Arbasino, P. P. Pasolini del quale tengo qui a ricordare e suggerire lo straordinario “Odore dell’India”,
Cino Boccazzi “Pagine di Pietra”, Massimo Baistrocchi “Antiche civiltà del Sahara”, lo storico Giovanni Pettinato "Ebla", e Stefano Malatesta “Il grande mare di sabbia”, e moltissimi altri che, nell’impossibilità di citarli tutti, vorranno scusare la momentanea dismissione. Ciò non vuol dire che ci si è dimenticati di loro, bensì che ci sarà occasione di conoscerli più a fondo in altre occasioni.
Colgo l’occasione per segnalare una importante quanto interessantissima manifestazione a quanti trovano nel piacere di viaggiare la peculiarità di tenere un diario oppure di scrivere note a riguardo, di “approfittare” di questo spazio per far conoscere le proprie emozioni e le proprie avventure, nonché di partecipare numerosi al prossimo “Festival della letteratura di viaggio” del 2012. Il “Festival della letteratura di viaggio” tenutosi a Roma in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, dal 29 settembre al 2 ottobre 2011 al Palazzo delle Esposizioni, è stato dedicato al "Viaggio in Italia, viaggi degli italiani", che ha ospitato più di trenta eventi, e promossa dalla Società Geografica Italiana e da Federculture, diretta da Stefano Malatesta e Antonio Politano. Tanti gli eventi in cantiere: dai racconti del classico “Grand Tour” ai viaggi degli esploratori italiani, e incontri con gli scrittori italiani della nuova generazione agli inviati speciali delle grandi riviste. Il Festival della Letteratura di viaggio nasce per esplorare e raccontare tutte le forme di narrazione del viaggio: letteratura, giornalismo, cinema, televisione, fotografia senza dimenticare storia e geografia. Per quattro giorni incontri, lezioni e laboratori didattici di fotografia e scrittura sono stati tenuti da docenti, giornalisti e fotografi fra cui molti nomi eccellenti.
Il Festival di quest'anno inoltre ha dedicato la sua mostra principale: "Nell’Impero di mezzo e sul tetto del mondo", a due grandi viaggiatori marchigiani in Asia, il gesuita Matteo Ricci e l’orientalista Giuseppe Tucci. La mostra, a cura di Nadia Fusco, documenta con foto, carte geografiche d’archivio, planisferi, i viaggi in Asia dei due marchigiani. Ricci arrivò per la prima volta in Cina nel 1582, durante il suo soggiorno imparò il cinese, scrisse diversi libri e introdusse innovazioni importanti in campo cartografico, e ontribuì in maniera fondamentale, con il suo mappamondo - una copia è esposta nella mostra - alla conoscenza del mondo occidentale da parte delle dinastie Ming e Qing, rivoluzionando la concezione sinocentrica allora dominante in Cina. Giuseppe Tucci, esploratore del ventesimo secolo, è considerato uno dei più grandi orientalisti di tutti i tempi. Dal 1928 si recò diverse volte nelle regioni himalayane e nel 1948, durante il suo ultimo viaggio in Tibet incontrò il Dalai Lama, allora quattordicenne. Profondo conoscitore della cultura tibetana e indiana, ha fondato il Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma. La mostra, visitabile dal 30 settembre al 20 ottobre al Palazzetto Mattei di Villa Celimontana.
Bibliografia: (oltre a tutti quelli citati nel testo)
Matteo Ricci, “Opere complete di Padre Matteo Ricci” - Sette volumi, Edizioni critiche in lingua italiana con testo cinese a fronte a cura di Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l'Oriente.
Giuseppe Tucci, “Cronaca della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933) (con Eugenio Ghersi), Roma, Reale Accademia d'Italia, 1934. E inoltre:
Attilio Brilli, “Quando viaggiare era un’arte: il romanzo del Grand Tour”, Il Mulino, 1995.
Antonio Gnoli, “La nostalgia dello spazio”, Bompiani, 2000.
Claudio Magris, “L'infinito viaggiare”, Mondadori, 2005.
Luigi Marfè, “Oltre la fine dei viaggi. I resoconti dell'altrove nella letteratura contemporanea”, Olschki, 2009.
Elvio Guagnini, “Il viaggio, lo sguardo, la scrittura”, EUT Edizioni Università di Trieste, 2010.
Discografia essenziale: (musica di viaggio per viaggiare e conoscere)
“The History of Music in Sound”, (LP) – His Master’s Voice – Collana LP improntata all’evoluzione della musica nel mondo, a partire dale primitive forma di suono fino all’Opera lirica.
“An Anthology of Music from all over the World”, (LP) – UNESCO - Collection Barenreiter- Musicaphon – collana distinta per gruppi etnici riferita a tutto il mondo.
“Musical Sources”, (LP) – Musica cerimoniale e rituale da tutto il mondo. UNESCO - Collection – Philips.
“Universo Folklore”, (LP) - Collana diretta da Ariane Ségal per la Arion-Ducale.
“Musical Atlas”, (LP) – UNESCO Collection, Atlante musicale del mondo edito da International Music Council e da Institute for Comparative Music Studies (Berlin- Venice)- General Editor Alain Danielou – Collaborazione alla diffusione Giorgio Mancinelli.
“Albatros”, (LP) Collana edita in Italia dalla Editoriale Sciascia che abbraccia molti aspetti della musica etnica e la sua diffusione nel mondo, ricca di note e illustrazioni, riferiti menti a strumenti e tipo di vocalità usate nelle registrazioni.
“Meridiani Musicali”, (CD) – Collana limitata a soli 12 “virtual travel” realizzata da Editoriale Domus e distribuita con la rivista “Meridiani”, utile alla conoscenza di alcuni aspetti musicali dei paesi di riferimento.
“A World of Music”, (CD) - Collana di musiche da tutto il mondo realizzata da Azzurra Music e che presenta la musica di molti paesi e popoli.
“Anthologies de Reference”, (CD) - Collana che raccoglie: canti, danze, strumenti della musica del mondo - World Network Zweitausendeind Versand – Frankfurt.
“Real World”, (CD)- Collana realizzata da Peter Gabriel edita da Virgin Records che accoglie molti artisti di provenienza etnica viventi.
“Musiche dal Mondo”, (CD) - Collana realizzata da Fabbri Editori con booklet di note esplicative e illustrazioni, riferita alle diverse aree musicali del mondo.
“Musique d’abord”, (CD) – Collana di musica tradizionale di diversi paesi, impostata su particolari strumenti del Medio Oriente e i suoi virtuosi esecutori. Edita da Harmonia Mundi.
E inoltre: Stephan Micus, compositore e strumentista di eccezionali capacità musicali che nell’arco di almeno 20 anni ha condotto una ricerca sul campo nella musica etnica/tradizionale in tutto il mondo, ha studiato le forme vocali in uso tra i popoli più diversi, traendone forme di musica innovative che riportano all’ancestrale origine del suono e del canto, nonché autore di innumerevoli brani, molto piacevoli all’ascolto perché ricche di poesia (anche in senso vocale), dedicati a deserti e oceani, foreste sotto la pioggia, al volo degli uccelli, al vento che smuove le nuvole, alla neve e alle pietre ecc.. I suoi dischi sono tutti editi da ECM Records: “Ocean”, “Desert Poems”, “The Music of the Stones”, “Towards the Wind”. “Listen to the rain”.
NB: Attenzione non trattasi di easy – listening music, bensì di musica a lungo meditata e ricreata sulla scia di emozioni calibrate al fine di ricavarne sonorità armoniose, di grande impatto intimistico, fino a farci partecipi d’una musicalità primordiale che doveva essere all’inizio dei tempi.
*
 - Musica
- Musica
Etnomusica 6: Letteratura - Musica - Antropologia
“Letteratura, musica e antropologia”, di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Il Canto della Terra”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RSI (Radio della Svizzera Italiana) e apparsi in numerosi articoli sulle riviste: Nuova Scienza, L’Annuario Discografico, Hi-FI, Audio Review).
Oggi l’antropologia non si dedica più (se mai l’ha fatto) a descrivere le bizzarre costumanze di popoli esotici, ma studia aspetti delle culture ampi e complessi, come i processi mediante i quali creatività, volontà umana e costrizioni materiali e ambientali plasmano le tradizioni culturali. Pur ammettendo l’importanza di tutti questi fattori, non riduciamo la cultura a nessuno di essi e riconosciamo che l’esperienza umana del mondo è essenzialmente variegata, che quindi necessita di un esame comparativo, atto a ricercare nelle singole esperienze, quel o quei comuni denominatori che ne formano l’essenza, o i fattori che le diversificano, e che determinano l’espressione culturale complessiva dell’umanità. La costruzione e la ricostruzione delle pratiche culturali sono pertanto inevitabili e incessanti, cui attingere nelle proprie scelte di ricerca, che vanno modellate sulle relazioni e interazioni dettate dall’ “ecologia”, dall’”economia” e dalla “razionalità”. Il risultato è la straordinaria varietà dei modi di vita culturali, nessuno dei quali si spiega come effetto inevitabile di un’unica forza modellatrice, bensì dell’insieme delle forze che spingono a plasmare il nucleo “esplosivo” del concetto di “cultura”, così come esso è maturato nel corso millenario dello sviluppo umano.
L’Etnomusicologia è solo una delle forze che contribuiscono allo sviluppo culturale e, come tante volte ripetuto, è senza ombra di dubbio una tra le più importanti, poiché contribuisce, o almeno ha contribuito senza mai essere venuta meno, a sviluppare il senso estetico delle diverse forme dell’arte, entrando in ogni forma dell’espressività umana: a cominciare dalla gestualità primitiva, alla forma della danza, alla modulazione della parola e del canto, fino alle forme più sofisticate e spettacolari del teatro e della rappresentazione. E non solo, anche delle arti plastiche come la pittura, la scultura e l’architettura, forme queste che prendono l’avvio dalla scansione musicale presente in natura, nei colori (pittura), nella luce e delle ombre (scultura), o derivanti dalla "lettura" metrica dello spazio (architettura), onde una lettura o rilettura dell’arte sotto questo aspetto, apre a nuove e inusitate rivalutazioni, che dobbiamo considerare alla stregua delle più alte espressioni dell’umanità, poiché in esse si mostra come noi, esseri umani, utilizziamo la creatività culturale per fronteggiare le costrizioni materiali e ambientali che costellano la nostra vita.
Scrive sapientemente Oliver Sachs nella prefazione del suo libro “Musicofilia” (*) di recente ristampa: “Eppure la musica non ha concetti, non formula proposizioni; manca di immagini e di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di rappresentazione, né alcuna relazione necessaria con il mondo reale. (..) Ciò nondimeno, è così profondamente radicata nella nostra natura che siamo tentati di considerarla innata, proprio come Edward O. Wilson considera innata la “biofilia”, il nostro sentimento verso gli altri esseri viventi”. E aggiunge: “Forse la stessa musicofilia è una forma di biofilia, giacché noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva” (?).
L’interrogativo è ovviamente il mio, allorché mi sono chiesto come noi, questi esseri antropologicamente umani che siamo, ci rapportiamo con il mondo sonoro che ci circonda e con la musica che, malgrado tutto, siamo capaci di accalappiare e di trasformare in qualcosa di concreto e che, in quanto a concretezza, tolto il supporto (CD, Vinile, Radio TV, i-Pad ecc.) che la contiene, essa ci sfugge e si dissolve nell’aria, per entrare a far parte di quell’aura effimera e invisibile che pure ci circonda, e ci assolve dal divenire contenitori zeppi di insolvenze. Come se non bastasse il debito che abbiamo col linguaggio parlato, la scrittura, la sintassi delle diverse lingue che cerchiamo di apprendere, degli apparati tecnologici di cui ci serviamo e che non comprendiamo appieno, ecc. ecc. Immagino che qualcuno dica: “Ci mancava pure la musica, adesso!”. Tanto che viene da chiedersi se effettivamente non sia la musica a condizionare, in qualche modo, la nostra capacità intellettiva o, al contrario, la nostra incapacità di ascoltatori (?).
L’interrogativo è ancora mio, ma stavolta la risposta ce l’ho bella e pronta, e guarda caso, sembra darmi ragione, offerta a scatola chiusa, niente meno che da Charles Darwin, il quale, nel suo “L’origine dell’uomo” (*) scrive:
“Giacché né il piacere legato alla produzione di note musicali, né la capacità (di produrle) sono facoltà che abbiano il benché minimo utile diretto per l’uomo (..) devono essere collocate fra le più misteriose di cui egli è dotato”.
In verità ammetto di essermi illuso che mi si desse ragione. Dal momento che tutto rientra nel “mistero dell’esistenza” colgo la mia incapacità di dare qui una risposta e accetto quanto affermato dallo stesso Sacks, che: “L’origine della musica umana è molto meno facile da comprendere”. Allora rispondo: all’infuori di quando è il nostro corpo a produrla, perché in quel caso la capiamo perfettamente. Ma scusate la digressione, tuttavia ritengo plausibile ciò che gli studiosi hanno affermato, che le nostre capacità musicali – per lo meno alcune di esse – siano rese possibili attraverso l’uso, il reclutamento o la cooptazione di sistemi cerebrali già sviluppati per altre funzioni. Dunque, per parlare di qualcosa che esuli dalla musica tout-court, prendo qui ad esempio quel certo aspetto della letteratura, che mi permette, in certo qual modo, di staccarmi dalle linee conformi alla ricerca musicologica.
Va qui detto che la letteratura è entrata a buon diritto a far parte di tutti gli ambiti della ricerca antropologica, sia puramente teorici che come fonte di studi in campo etnografico, socioculturale o etnologico. Essendo la letteratura formata da parole e non solo, occorre che prima si individui un qualche rapporto tra la tradizione orale e la parola scritta, quindi valutarne le interazioni (influenze reciproche), gli scambi formativi, la ricezione da parte del gruppo (popolo) che ha dato forma alla cultura specifica di cui si vuole trattare. Ed ecco che subito sorge la prima domanda a cui è doveroso dare una risposta:
“Che cosa avviene quando alla formazione di una data cultura ha contribuito più di un popolo, più di una singola tradizione che verosimilmente ne ha forgiato l’anima multiforme?”
E di conseguenza: “Quale impronta musicale, più o meno originale che sia, comunque tipica del territorio preso in considerazione, risulta accresciuta nella sua dimensione socio-antropologica?”
La prima risposta è inclusiva nella domanda stessa, lì dove si determina un contributo comunitario o in qualche modo accomunante, la cultura può dirsi tipica del territorio in cui prende forma. Tuttavia è possibile incontrare sul nostro cammino di ricercatori, taluni accorti studiosi che usano le rispettive tradizioni per imporre e sostenere un certo ordine di costumi, all’interno delle gerarchie socio-culturali e religiose, di riferimento etnico. Ciò da luogo però a un sminuzzamento della cultura, una certa particolarità che talvolta non influente nella formazione della cultura stessa. Nell'etnomusicologia comparata è importante accomunare le similitudini, le sinonimie e, per contrasto tener conto delle divergenze contrarie, in modo da ricondurre gli effetti nel comune "accordo" specifico.
La seconda risposta prende avvio nello studio specifico del territorio oggetto di ricerca e ne valuta la tipicità, basandosi sulla morfologia e l'economia del medesimo, alfine di rintracciare quegli elementi materiali presenti in natura che hanno permesso all'umano antropologico di sviluppare il suo utilizzo musicale e la propria creatività, per quanto primitiva essa possa risultare. A fronte di quanto affermato, va inoltre detto che l’immagine di un mondo costituito soltanto dalle culture ufficiali e dalle confessioni riconosciute, per la maggior parte, sono prive di curiosità o di particolare interesse per la nostra ricerca etnomusicologica, in quanto il nostro coinvolgimento coincide più con ciò che è involontario e accidentale, e che “viaggia” fuori delle righe della uniformità culturale ufficiale e della escatologia precostituita.
L’incompatibilità fra le due visioni non è però così totale o incommensurabile, in realtà un risvolto va necessariamente trovato per aprire la nostra ricerca e, isolare quelle che sono le parti integranti di un discorso culturale, sia orale che letterario, che sia di transizione o definitivo, verso quella che è la meta che ci siamo prefissati. Fatto importante, da tenere in considerazione è che l’obiettivo può anche cambiare durante il percorso, così come ampliare la visione iniziale, percorrere strade inusitate che talvolta, pur non assomigliando a quelle dell’antropologia di vecchia impostazione, sono però indirizzate verso lo “strutturalismo antropologico”, comprensivo di tutti quegli aspetti che concorrono a determinare una certa cultura di fondo, ivi inclusa la musica, come disciplina indicativa dell’esperienza socio-culturale universale.
Il che equivale ad ammettere la legittimità di una funzione, quella della etnomusicologia, di vitale importanza per coprire ogni distanza tra “le silenziose pianure del passato” e la “sovranità e il predominio del futuro”, quello stesso futuro in cui in verità non riponiamo alcuna aspettativa, perché, al contrario, non fa che allontanare gli uni dagli altri. Del resto, vivere il mondo della musica oggi, significa vivere il mondo nella sua totalità, in una condizione sperimentale costante che non conosce precedenti. Questo implica, tra l’altro, che nulla in linea di principio, può impedire di agire secondo modalità che in passato sono state ritenute valide solo dalla cultura e dalla religiosità ufficiale, mentre oggi, in ultima analisi, si presentano a noi come un mezzo utile per riappropriarci dell’identità smarrita del mondo, di questo mondo che, per un’infinità di motivazioni, sembra crollarci addosso o, espandersi a dismisura, ma questo dipende dai punti di vista.
Se è vero che la musica ha il potere di mantenere vivi certi suoi caratteri a distanza di millenni, che continua a essere suonata e intonata negli stessi luoghi dove si è formata, ciò vale altresì per la parola orale e scritta, per la letteratura come per la poesia, per i gesti rituali così come per il canto e la danza, che troviamo, pur con migliaia differenziazioni in ogni parte del mondo e presso tutte le popolazioni conosciute. Gli esempi potrebbero essere infiniti, sebbene a tutti va dedicata, da parte del ricercatore, una particolare attenzione. Soprattutto perché, ogni singolo momento nell’ambito della vita e della cultura di ogni singolo popolo, rappresenta una condizione sperimentale evolutiva, e la musica è sempre stata la più attaccabile dai bacilli delle mode e della modernità, e non sempre in maniera eccepibile.
A questo proposito sottopongo alla vostra attenzione un passaggio, solo apparentemente complesso di Roberto Calasso esposto in “L’Ardore” (*) che, nell’ambito di una ricerca che vuole indagare nei perché della concatenazione e scambievolezza reciproca, ritengo appropriato ed esaustivo. Aspettatevi dunque una lezione, fondamentale, di cui tenere conto nell’affrontare una qualsiasi ricerca scientifica o storica che sia:
“L’umanità non dispone di una sovrabbondanza di “modi del pensiero”, e due si distaccano come fratelli nemici: connettivo e sostitutivo. (..) Non c’è forma del pensiero che non possa essere sussunta nell’uno o nell’altro di questi due enunciati. I quali si trovano fra loro in rapporto di successione cronologica, perché il connettivo ha sempre e ovunque preceduto il sostitutivo, se si intende il connettivo come riferito a quei vincoli e nessi che collegano i fenomeni più disparati per affinità, somiglianza e analogia. Quanto più maturo – nel senso di molteplice, avvolgente, preciso – è il pensiero, tanto più praticherà sino in fondo, sino all’estremo delle loro possibilità, entrambi i suoi modi.(..) Indispensabile è distinguere i rispettivi compi di applicazione. Né il connettivo né il sostitutivo hanno la capacità di estendersi a tutto. In certi ambiti, diventano vacui e inerti. Tanto più sottile ed efficace diventa l’attività di uno dei modi del pensiero, quanto più sa riconoscere e delineare con esattezza le zone cui applicarsi.”.
“Connettivo e sostitutivo: i due modi della mente possono essere così definiti riferendosi al loro carattere dominante. Ma, se ci si riferisce alla messa in atto delle loro operazioni, potrebbero anche definirsi analogico e digitale, in quanto mezzo principale della sostituzione è la codifica – e il numero è ciò che le permette di agire con la massima facilità ed efficacia. E il modo digitale si applica innanzitutto al regno della quantità, dove il risultato di un’operazione è un numero che si sostituisce a un numero iniziale. Mentre il modo analogico si fonda sulla somiglianza, quindi sulla connessione fra entità di qualsiasi specie. Convenzione e affinità sono altri termini utili per definire i due poli della mente. Convenzione significa che, qualsiasi cosa sia a, si può decidere che “stia per b”, quindi che lo sostituisca. Principio impositivo, non fondato su un ragionamento – e immensamente efficace. Affinità significa che, per motivi non necessariamente chiari o evidenti, in a vi è qualcosa che lo accomuna a b, perciò qualsiasi cosa si dica di b per qualche via coinvolgerà a. È un terreno in larga parte oscuro, all’inizio – e destinato a rimanere in qualche misura tale anche alla fine di ogni indagine”.
“La percezione delle affinità è interminabile. Si può dire dove il processo ha inizio, ma non dove si può arrestarlo. La convenzione, all’opposto, ha origine e si conclude nell’atto con cui si instaura. Di questo siamo fatti. Come la numerazione binaria, nella sua elementarità, permette inesauribili applicazioni, così le due modalità della mente si prestano a sostenere le più diverse costruzioni, combinandosi, mescolandosi o respingendosi. E perennemente richiamandosi l’una all’altra. Ogni decisione che pretenda di scinderle o dichiari il predominio dell’una sull’altra è vana, perché entrambe continuano a operare, consapevolmente o no, in ogni istante, per chiunque e in chiunque”.
“Il modo connettivo e il modo sostitutivo corrispondono a due elementi irriducibili della natura – e della mente che la osserva: il continuo e il discreto. Il continuo è il mare; il discreto, la sabbia. Il modo connettivo si assimila al continuo, in quanto incessantemente produce un amalgama, una striscia ininterrotta di figure che entrano una nell’altra. Il modo sostitutivo moltiplica indefinitamente i granelli che, visti a una certa distanza, compongono una sola figura (d’insieme) ben distinta, così come il retino permette alle cose fotografate di lasciarsi riconoscere. Più che categorie, il continuo e il discreto sono dimensioni con le quali la mente opera senza tregua. E con essa opera il mondo. Sono “i poli di una fondamentale complementarità del pensiero di tutti i tempi”. A quel fondo oscuro, inesauribile, attingono la mente e il mondo, come artigiani nella stessa officina”.
Lasciatemelo dire, una bella lezione sulla di metodo sulla “osservazione” da adottare, una condizione implicita valida sempre e comunque, che s’inquadra nel tessuto scientifico, restituendo la complessità di un'opera interpretante la natura e la cultura quali in realtà esse sono, cioè espressione unica dell'universo simbolico che vive dentro tutti noi.
Nello specifico propongo quanto redatto da Renata Gambino (*) in “Antropologia Letteraria”:
“Gli studi di antropologia letteraria, nella loro forma attuale, si occupano dell’analisi del testo letterario, inteso come specifico strumento di ricerca antropologica. Il ritrovato collegamento tra studi antropologici e letteratura si fonda sulla scoperta della dimensione autonoma della scrittura, intesa come strumento d’interpretazione della realtà e non solo come mera descrizione di essa. Il testo diviene il luogo in cui la ricerca scientifica e il media letterario si uniscono creativamente, poiché il mezzo letterario, grazie alla sua capacità rappresentativa, si presta in maniera esemplare ad un’analisi delle caratteristiche umane e ad una riflessione sulla natura umana e sui cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, trasponendo il risultato della ricerca antropologica entro quella che è stata definita la metafora viva del testo (Ricoeur 1975)”.
“Pur essendo un campo di studi recente, l’idea originale va rintracciata nel XVIII secolo, agli esordi degli studi antropologici. Contrariamente alla tendenza illuminista, intenta a separare la parte animale dell’uomo da quella spirituale, l’antropologia si proponeva di studiare l’humanum, nella sua originale unione di mente e corpo. L’antropologia si trovò subito assai vicina ad un altro settore della ricerca, che durante la seconda metà del Settecento prese rapidamente piede in Europa, l’estetica. Entrambe infatti incentravano la loro analisi sullo studio delle manifestazioni del soggetto. Non sorprende dunque che il fiorire di questi studi abbia influenzato la produzione letteraria dell’epoca e che questa a sua volta sia stata considerata una forma d’antropologia sui generis. Obbiettivo di questa nuova corrente di studi era, e resta in linea generale a tutt’oggi, quello di individuare la natura dell’uomo, l’humanum o, usando un’espressione nietzschiana, la homo natura rappresentata nell’opera poetica".
“L’uso del termine antropologia letteraria, riferito ad una precisa corrente interpretativa autonoma, inserita nel contesto degli studi culturali, si deve a Fernando Poyatos, il quale lo propose per la prima volta, in occasione di un convegno, nel 1977 ed in seguito lo adoperò come titolo della pubblicazione degli atti, da lui curata nel 1988. Con questo termine egli indicava quel campo di studi interdisciplinare caratterizzato da un uso antropologico della letteratura, quale fonte di dati per un’analisi intertestuale sulle caratteristiche e lo sviluppo delle idee e degli usi di una cultura” (..)“L’idea di F. Poyatos, che la letteratura costituisca un ricchissimo archivio di dati antropologici, si fonda sull’idea che la scrittura letteraria esprima a pieno la cultura d’origine dell’autore, e di conseguenza si proponga come fonte per l’antropologo. La sua posizione, pur avendo dato il via ad un nuovo settore di studi, non fu subito accolta con grande fervore; furono infatti molte le critiche rivoltegli anche da coloro che firmarono gli interventi raccolti nel volume da lui curato. In particolare, fu posta in evidenza l’impossibilità, all’interno del testo poetico, di distinguere tra fatti oggettivi e immaginario poetico, condizione che renderebbe impossibile condurre un’indagine di tipo scientifico. Fu invece accolta con maggior entusiasmo l’idea che propone di analizzare il testo letterario non soltanto come fonte di dati, bensì quale oggetto o strumento d’indagine antropologica in sé. Non sono più i fatti contenuti all’interno del testo a costituire argomento di studio, ma i suoi procedimenti interni, le sue caratteristiche fondamentali”.
“Questa nuova impostazione teorica della questione, ha dato vita a due principali linee di sviluppo dell’indagine, assai diverse tra loro. L’una, basata sul testo di Wolfgang Iser, individua, quale tratto precipuamente umano della letteratura, la capacità immaginativa d’invenzione del singolo (Iser 1991), mentre l’altra, condotta sulla linea di ricerca adottata da Helmut Pfotenhauer (1987), indaga concretamente sul ruolo giocato dalla letteratura quale strumento di rappresentazione di uno specifico argomento d’interesse antropologico. La prima è caratterizzata da una chiara tensione filosofica trascendente, la seconda da un orientamento più concretamente storico ed immanente. La questione su cui si fonda l’indagine di Iser deriva dall’osservazione che tutte le culture dotate di una tradizione scritta hanno creato una letteratura d’immaginazione, che a suo parere costituisce lo specchio delle sue caratteristiche antropologiche fondamentali. La duttilità della scrittura, come mezzo espressivo, e la sua plasticità ne fanno lo strumento ottimale per la rappresentazione e la descrizione delle differenze e dei mutamenti propri della natura e della cultura umana. Questo permette nuove ed assai più ampie prospettive di studio, di quanto non abbiano fatto indagini puramente filosofiche, sociologiche o psicologiche”.
“L’immaginazione e la fantasia diventano quindi gli elementi cardine della ricerca antropologica. Secondo Iser, la finzione letteraria, das Fiktive, rifletterebbe una caratteristica antropologica fondamentale: l’irrefrenabile tensione dell’individuo a superare se stesso e i confini del mondo reale, ovvero la spinta alla creazione di immagini fittizie. La letteratura rappresenterebbe, dunque, una forma d’antropologia estensiva, in quanto fornisce all’uomo, attraverso la creazione di un mondo virtuale (Phantasmatische Figurationen) uno strumento utile a verificare i possibili rapporti, che di volta in volta si vengono a creare tra l’uomo e il mondo circostante. La finzione letteraria crea estensioni dell’umano, superamenti di sé, grazie alla sua libertà da limiti pragmatici”.
“Questo processo metterebbe in luce la condizione umana e contemporaneamente indurrebbe ad una variazione nella percezione del reale da parte del soggetto, con conseguenze dirette sulla vita del singolo. La capacità immaginativa sarebbe, sempre secondo Iser, non soltanto in grado di creare mondi alternativi, sia in senso sincronico che diacronico, ma permetterebbe di canalizzare nel quotidiano la quantità di fantasia necessaria, affinché abbia luogo lo sviluppo culturale. La letteratura non rappresenterebbe soltanto un utile strumento d’indagine antropologica, ma anche un elemento attivo di sviluppo culturale, in quanto mezzo di comunicazione in uso”.
“Nel volume pubblicato nel 1987 da Pfotenhauer, Literarische Anthropologie, la questione dei testi letterari quale fonte della ricerca antropologica viene impostata più su di un piano storico-letterario, ponendo al centro della ricerca il genere dell’autobiografia, inteso quale luogo in cui l’unione tra l’indagine scientifica e lo strumento letterario trova ideale realizzazione. Si fa esplicito riferimento agli esordi degli studi antropologici e viene tracciata una breve storia dei primi testi letterari che si rifanno agli studi sull’uomo (die Menschenkunde), condotti durante la seconda metà del XVIII secolo in Germania, quando già la letteratura era considerata utile strumento di ricerca per la comprensione della natura umana”. (..) “L’efficacia di questa strategia diventa evidente quando si esaminano quei testi in cui l’autore riesce a ricostruire la realtà che lo circonda in modo tale da essere rappresentativa dell’intero contesto socio-culturale, come avviene ad esempio nei romanzi di Jane Austen, o nella letteratura d’emigrazione, etc. Ma è anche il caso di opere dal carattere, per così dire, ibrido, in cui il saggio scientifico assume dimensione poetica, adottando i mezzi espressivi e le strutture tipiche della scrittura letteraria. È questo il caso delle lettere di Schiller sull’educazione estetica (Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795), o del saggio di Herder sulla storia della cultura (Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774).
“L’indagine condotta da Pfotenhauer, rimane centrata sull’autobiografia letteraria, quale strumento di comprensione dell’interiorità umana, in grado di fornire una Innenansicht des Anthopologischen (1987). Questa natura umana interiorizzata, testimonianza di un’esperienza vissuta in prima persona, risulta essere rivelatrice, nella dialettica instauratasi al suo interno tra soggetto narrante e mondo circostante, della trasformazione subita in generale dal concetto di individualità e soggettività. L’io diviene in questo contesto, come già auspicato da Goethe, totalità estetica dell’individuale. L’impostazione dello studio di Pfotenhauer rimanda, anche in linea teorica, ad un genere di studi precedenti, finora considerato appartenente all’ambito letterario, in cui l’indagine condotta sui testi letterari mirava a mettere in evidenza elementi stilistici o storico-letterari, ma che rivelano già delle caratteristiche tipiche dell’indagine antropologica, come, per fare solo qualche esempio, nel caso dello studio condotto da Hans-Jürgen Schings sulla melanconia nel periodo illuminista (Melancholie und Aufklärung, 1977), o del volume di Philippe Ariès dedicato alla storia del confronto tra l’uomo e l’idea della morte (Geschichte des Todes, 1975)”.
“Il modello d’indagine adottato da Pfotenhauer è stato ripreso ed ampliato da Wolfgang Riedel (1996)in un volume dedicato ad un esame di alcuni testi letterari significativi per l’analisi di quel profondo cambiamento intervenuto nell’uomo durante il XX secolo. L’indagine di Riedel parte dal presupposto che la modernità sia contrassegnata da un radicale cambiamento di prospettiva nel rapporto esistente tra l’uomo e la natura, e da un profondo mutamento subito dal concetto di natura come ideale. L’espressione letteraria diventa testimone delle trasformazioni del rapporto soggetto-oggetto, e delle mutazioni subite dal concetto di natura umana in quella che viene definita l’era della modernità o das technische Zeitalter. Il testo letterario diventa rappresentativo della profonda antitesi instauratasi tra tecnologia e natura, scienza e religione, ecc. e del cambiamento subito nel corso del tempo dal concetto stesso di humanum”.
“La letteratura in quanto natura umana esperita, secondo la prospettiva individuata da Pfotenhauer, è diventata la base su cui si è sviluppato questo nuovo settore di ricerca interdisciplinare, che, dal 1996 in poi ha visto nascere numerosi testi, riviste e convegni dedicati a quest’argomento. Uno dei primi e più importanti progetti di ricerca dedicati a quest’ambito di studi, che riunisce in sé tutte le varie correnti prese fin qui in esame, è quello fondato nel 1996 dalla Facoltà di filosofia dell’Università di Costanza. Il progetto è articolato su tre quesiti fondamentali riguardanti il perché l’uomo produca letteratura, i contenuti dei testi letterari riguardanti l’uomo ed il rapporto instaurato dalla rappresentazione letteraria con gli altri strumenti espressivi. Il progetto ha dato vita ad un vasto numero di contributi, che affrontano molteplici aspetti della ricerca, e individua proprio nell’intertestualità e nell’interdisciplinarietà il futuro sia in ambito antropologico che letterario”.
“La ricerca italiana ha dimostrato di partecipare al crescente interesse rivolto all’antropologia letteraria, dedicando all’argomento alcuni convegni (Trento, 1991 e Torino, 1996) e adottando questa prospettiva interdisciplinare all’interno di alcuni studi specifici (cfr. Crescenzi 1996). L’argomento è stato accolto anche all’interno di alcuni importanti progetti di ricerca come quello dedicato all’antropologia filosofica dell’Università di Pisa o dal CRIER (Centre de Recherches sur l’Italie dans l’Europe Romantique) della Facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università di Verona. Va infine notato che l’interesse rivolto al collegamento tra antropologia e letteratura ha assunto proporzioni rilevanti a livello mondiale negli ultimi cinque anni, coinvolgendo molti centri di ricerca (per es. Asociaciòn Espagnola de Semiotica y modernidad dell’Università della Coruña) e ha dato luogo ad importanti studi sui più svariati aspetti assunti da questo nuovo ambito della ricerca, come dimostra, solo per fare alcuni esempi, l’indagine condotta dall’antropologo sociale Miguel Alvarado Borgoño, dell’Università Cattolica Cilena di Temuco, consultabile in rete, sulla consistente produzione di testi di letteratura antropologica cileni, o il saggio di Clifford Geertz che prende in esame la figura dell’antropologo, quale autore di testi letterari (1988)”.
Bibliografia:
Oliver Sachs. "Musicofilia", Adelphi 2010.
Renata Gambino, “Letteratura d’immaginazione”, Menschenkunde, “Metafora viva”, Sinnlichkeit.
L. Crescenzi, “Antropologia e poetica della fantasia”. “Per una genealogia della narrativa fantastica nel romanticismo berlinese”, Fasano, Schena.
P. Ricoeur, 1975, “La métaphore vive”, Paris, Seuil; trad. it. 1984, “La metafora viva”, Milano, Jaka Book.
R. Calasso, “L’Ardore” – Adelphi 2009.
In “Tra l’antropologia e la letteratura di Claude Lévi-Strauss”, Marilena Cavallo (*) introduce l’estetica dei linguaggi, attraverso la metafora dell’attraversamento del viaggiatore - scrittore, tra i modelli antropologici e filosofici e quelli strettamente letterari, che ha trovato nell’opera di Lévi-Strauss, uno dei maggiori interpreti (se non il maggiore, di un Novecento che culturalmente non è finito e tanto meno si è smarrito tra le onde del secolo nuovo), che ha inciso un solco straordinario in un rapporto tra civiltà e linguaggio: “Nell’opera del famoso antropologo ci sono modelli epistemologici che si aprono a ventaglio intorno ad una fenomenologia che parte chiaramente da “Tristi tropici” che risale al 1955 e percorre saggi come “Il pensiero selvaggio” del 1962 e ancora “Il crudo e il cotto” del 1964, ma che trova la sua “attualità” di pensiero in un intreccio sistematico che è lo studio dedicato a “Guardare, ascoltare, leggere” insieme a “Le vie delle maschere”."
In “Tristi tropici”, tradotto in Italia nel 1965 da Bianca Garufi che ne ha curata l’Introduzione, leggiamo: “Viene qui affrontato un tema significativo, quello del fuoco, che è stato centrale nella ricerca di Lévi-Strauss perché ha rappresentato il “diario” intimo di una antropologia profondamente esistenziale giocata costantemente intorno a riferimenti mitico - simbolici e strettamente alchemici. Da antropologo puro, che ha scavato all’interno delle civiltà, dei popoli, degli uomini con le maschere e senza caverne, ha penetrato quel tessuto fatto di linguaggi: i linguaggi delle parole, i linguaggi dei colori, i linguaggi delle vocali molto cari al Rimbaud, appunto, di “Vocali”."
Certo, il punto di riferimento rimane la scientificità rigorosa e applicata sul campo culturale e umano che emerge in “Tristi tropici”, nel quale si racconta delle spedizioni di natura etnologica nei popoli indigeni sia del Brasile che del Mato Grosso sino a toccare le terre dell’Amazzonia durante gli anni Trenta”:
“Un riferimento questo che è rimasto tale ma che si è esteso grazie ad una analisi comparata sia dal punto di vista letterario che pedagogico in una visione in cui miti, credenze e riti non sono elementi “sovrastrutturali” delle culture ma sono la vera espressione di processi dentro le identità delle civiltà. Catturare il senso del selvaggio dei popoli è un andare oltre la storia definita come apparenza meramente storiografica. Proprio per questo i linguaggi non sono soltanto motivazioni di una comunicazione diretta e indiretta ma costituiscono delle suggestioni dentro le espressioni dello spirito dell’uomo. D’altronde Lévi-Strauss ha collaborato con uno studioso dei linguaggi come Roman Jakobson grazie al quale ha potuto analizzare i testi di un poeta come Baudelaire e prendere come esempio una poesia che si presta ad una apertura interpretativa meta – letteraria in una non consuetudine, per quei tempi, fortemente ancorata al tessuto antropologico. Mi riferisco a “Le chat”, un poesia sulla quale Lévi-Strauss ha orientato la sua esperienza e la sua testimonianza di antropologo dentro il guardare le parole”.
“Il dato di fondo è che nel progetto dell’antropologia applicata alla letteratura in Lévi-Strauss (capovolgendo i termini il processo culturale non cambierebbe) l’analisi dei linguaggi è dentro la capacità di leggere i popoli non come modelli legati ad un determinato territorio ma come espressione di civiltà e quindi di un portato di eredità che è possibile definire risistemando la griglia simbolica offerta dagli archetipi.
I popoli continuano a vivere lungo la dimensione culturale degli archetipi. La letteratura resiste all’urto della storia soltanto grazie ai simboli. Già in “Tristi tropici” questa versione si enuclea considerando il fatto che i popoli durano nel racconto. Infatti è recente l’affermazione di Bernard-Henri Lévy: «“Tristi tropici” è letteratura magnifica (..) un pensatore che era pure un maestro di stile letterario» (Corriere della Sera - del 4 novembre 2009). Una piccola ma importante osservazione che ricontestualizza la funzione che ha avuto Lévi-Strauss”.
“Il linguaggio, in fondo, resta una motivazione nella caratterizzazione della comprensione dei popoli. Un linguaggio che nasce sia dalla oralità sia dalla gestualità sia dallo sguardo. Un atto di vera creatività che si inserisce nel quadro delle ricerche e delle attività speculative che Lévi-Strauss ha condotto partendo da un presupposto di fondo: gli uomini fanno i popoli e i popoli si leggono in una visione complessiva che è quella della civiltà che per durare non deve assentarsi dalle eredità. Ecco perché la lettura antropologica si presenta con un mosaico la cui interpretazione passa inevitabilmente lungo i tracciati della letteratura. “La via delle maschere” sviluppa proprio un percorso ad intreccio tra antropologia e opportunità letterarie il cui significante è dato dalla presenza dell’estetica che si confronta con il mito. Leggere e interpretare i segni di una maschera nella cultura del mondo primitivo è dare una dimensione all’onirico che si trova tra gli spazi dei popoli antichi attraverso la misura delle distanze che è data dal tempo”.
“Il tempo è una istanza anche antropologica e rimane tale soltanto se è l’estetica a farsi voce. È questo un concetto che rimanda alla letteratura. Ma Lévi-Strauss sapeva bene che l’antropologia, pur nella sua scientificità dei dati e dei fatti, diventa strumento interpretativo grazie alla capacità del linguaggio. Ma il linguaggio è una estetica della letteratura che si presta a qualsiasi rottura di schemi. L’antropologia è dentro la letteratura. Ma la letteratura ormai non può assolutamente assentarsi da una motivazione e da emozioni che nascono o derivano da intagli antropologici”.
Coscienti che, per porsi da un punto di vista assolutamente oggettivo, bisogna studiare l'uomo dal di fuori - "come se fossimo osservatori di un altro pianeta" - scrive Lévi-Strauss e il rifiuto dei cosiddetti "dati immediati della coscienza" come via di accesso alla verità, contro l'empirismo e il soggettivismo, quegli stessi che lo strutturalismo va a riconsiderare. Lo strutturalismo sostiene che fare scienza significa procedere al di là dell'empirico e del vissuto, contro ogni forma di atomismo logico e di sostanzialismo. Per cui lo strutturalismo afferma che la realtà è un sistema di relazioni i cui termini costituenti non esistono di per sé, ma solo in connessione tra loro. Contro l'umanismo e il coscienzialismo gli strutturalisti difendono il primato della struttura sull'uomo, sostenendo che l'individuo non è libero e attore autentico delle proprie scelte e azioni, ma il risultato di strutture che agiscono per lo più a livello inconscio, negando così ogni possibilità di libero arbitrio.
Permettetemi qui di aprire una parentesi sul “libero arbitrio” perché materia di nuove e influenti considerazioni che arrivano da ogni parte e che, in qualche modo, impegnano la nostra ricerca, più di quanto ci si aspetti. Il libero arbitrio è il concetto filosofico e teologico secondo il quale ogni persona è libera di fare le sue scelte. Ciò si contrappone alle varie concezioni deterministiche secondo le quali la realtà è in qualche modo predeterminata (destino), per cui gli individui non possono compiere scelte perché ogni loro azione è predeterminata prima della loro nascita (predestinazione o servo arbitrio).Il concetto di libero arbitrio ha implicazioni in campo religioso, etico e scientifico. In campo religioso il libero arbitrio implica che la divinità, per quanto onnipotente, scelga di non utilizzare il proprio potere per condizionare le scelte degli individui. Nell'etica questo concetto è alla base della responsabilità di un individuo per le sue azioni. In ambito scientifico l'idea di libero arbitrio determina un'indipendenza del pensiero inteso come attività della mente e della mente stessa dalla pura causalità scientifica. Qui di seguito riporto alcune “teorie” relative all’argomento:
“Il determinismo è l'idea che tutte le cose che accadono nel presente e nel futuro sono una conseguenza causata necessaria dagli eventi precedenti. Il compatibilismo (anche detto determinismo morbido) crede che l'esistenza di libero arbitro sia compatibile con il fatto che l'universo sia deterministico, all'opposto l'incompatibilismo nega questa possibilità. Il determinismo forte è una versione dell'incompatibilismo che accetta che tutto sia determinato anche le azioni e la volontà umane. Il libertarismo si accorda con il determinismo forte solo nel rifiutare il compatibilismo; ma i libertari accettano l'esistenza di un certo libero arbitrio insieme con l'idea che esistano alcune cose indeterminate. L'argomento standard contro l'esistenza del libero arbitrio è molto semplice. O il determinismo è vero o l'indeterminismo è vero. Queste due posizioni esauriscono le possibilità logiche da contemplare. Se il determinismo è vero noi non siamo liberi. Se l'indeterminismo è vero, le nostre azioni sono casuali e la nostra volontà manca di controllo per essere comunque moralmente responsabili”.
Il concetto di libero arbitrio è oggi molto dibattuto in ambito religioso in relazione all'onniscienza attribuita alla divinità nelle religioni monoteistiche. Esso è alla base della religione cattolica mentre risulta uno dei punti di contrasto con la religione luterana per la quale l'uomo non può in alcun modo agire per liberare la propria anima, mentre il cattolicesimo considera fondamentali le opere quanto le preghiere. Alla stessa idea del luteranesimo aderiva anche il calvinismo per il quale l'uomo era predestinato e per questo a niente servivano le proprie opere e le proprie azioni, poiché l'elemento decisivo è solo la fede. Dunque, non rimangono che due possibilità: l'interpretazione deterministica della natura, secondo la quale sono solo le leggi fisiche a dettare i comportamenti umani; e l'interpretazione indeterministica, per cui ogni evento è dettato dal caso e le scelte individuali sono la naturale conseguenza di questi processi casuali. Una persona è quello che è in base alle proprie azioni, un uomo viene giudicato colpevole o innocente secondo le proprie scelte, dunque il problema del libero arbitrio continua a presentarsi e a porre delle domande:
"Possiamo prevedere i comportamenti umani?",
"Le scelte sono solo il frutto di leggi fisiche deterministiche o di leggi quantistiche e in definitiva regolate dal caso?"
Troppo complicato, a voi la scelta, il dibattito è ancora aperto. In entrambi i casi la risposta è sospesa a mezz’aria, non rimane molto spazio per il libero arbitrio, se non tramite una teoria del “tutto” che apre la via per differenti interpretazioni. Potete sempre intervenire sull’argomento, su questo stesso sito, nella sezione “commenti”.
Bibliografia:
Marilena Cavallo, "Tra l'Antropologia e la Letteratura di C. Lévi-Strauss" (in Web)
Erasmo da Rotterdam, “Il libero arbitrio” a cura di Roberto Jouvenal, Claudiana, Torino 1969. Terza edizione a cura di Fiorella De Michelis Pintacuda, 2004.
Martin Lutero, "Il servo arbitrio" (1525), a cura di Fiorella De Michelis Pintacuda, Claudiana, Torino 1993.
Mario De Caro, "Il libero arbitrio: una introduzione", Roma-Bari, Laterza, 2004.
Claud Lévi-Strauss “Le vie delle maschere” –Einaudi, Torino 1966.
J. Lebacqz, « Libre arbitre et jugement », Louvain 1960.
C. Mazzantini, “Il libero arbitrio in San Tommaso e Duns Scoto”, Torino 1966.
Y. Simon, “Trattato del Libero Arbitrio”, Roma 1963.
P. Siwek, « La conscience du libre arbitre », Roma 1976.
Agostino d'Ippona, "De libero arbitrio"...
Le figure più rappresentative dell'atmosfera filosofica dello strutturalismo vedono inoltre a Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Lacan, Louis Althusser, Roman Jacobson e Marcel Mauss. Su questi pensatori hanno agito soprattutto le tesi della linguistica strutturale (da De Saussure agli esponenti delle scuole di Praga e di Copenaghen), ma anche, in modo non meno rilevante, suggestioni provenienti dalla filosofia della scienza di Gaston Bachelard e dagli scritti di Nietzsche, Heidegger, Marx e Freud. Tuttavia siamo già oltre, siamo passati al post-strutturalismo e al decostruzionismo, nonché agli studi di eziologia e genealogia che hanno portato al postmodernismo filosofico, in cui viene analizzato il linguaggio, e le scoperte vi assicuro non mancano.
In “Eziologia e genealogia del postmodernismo filosofico” Mimmo Pesarese ad esempio scrive (*):
“Anche il linguaggio, infine, è considerato, in quanto struttura, un elemento di neutralizzazione e canalizzazione delle energie; la rivoluzione e la liberazione del desiderio deve allora giocarsi anche sul piano linguistico: questa la tesi che costituisce l'essenza stessa del pensiero e dell'opera filosofica di Jacques Derrida, dai cui scritti ha preso vita una corrente, il decostruzionismo, che prende appunto il nome dalla pratica della «decostruzione», possibile traduzione del termine heideggeriano Destruktion, ovvero la doverosa distruzione della storia della metafisica e del sistema concettuale da cui, per secoli, è stata dominata. Come gli altri pensatori francesi della sua generazione, Derrida avversa il «logocentrismo della stuttura», ovvero la proiezione del Soggetto della metafisica classica che, nello strumento eristico per eccellenza degli strutturalisti, ha messo radici e detta legge. Il progetto filosofico di Derrida, quindi, si identifica in una programmatica decostruzione della «metafisica della presenza» che ha caratterizzato la tradizione filosofica occidentale. La metafisica europea, infatti, avrebbe considerato l'Essere come un ente attingibile e reso «presente» attraverso la parola -- il logos- e la voce (da cui il termine logocentrismo), cui Derrida contrappone un Essere che, proprio in quanto definibile solo per differenza e irriducibile a ogni tipo di identità originaria, detiene, invece, gli attributi dell'assenza, di cui non si danno rappresentazioni, ma esclusivamente tracce. In quest'ottica, all'idea metafisica del primato della voce/logos sulla scrittura, ovvero del primato della presenza dell'Essere sull'assenza dell'Essere, viene sostituito il primato della scrittura sulla voce”.
“Dall'idea della scrittura come fenomeno risultante dall'oralità, si passa all'idea secondo la quale è il linguaggio a essere anticipato dalla scrittura, poiché, come argomenta Derrida, si parla riferendosi a testi, ovvero a un nodo di tracce che rimandano a un'assenza: quella dell'autore, che nella rappresentazione del testo attua il proprio autodisfacimento. Ecco che in quest'opera di «rovesciamento» dei fondamenti del linguaggio, indicativa risulta la pregnanza della nozione derridiana di testualità, una concezione del testo scritto non come sistema definito e dato in maniera ultima, ma come circolarità aperta, continuamente ri-definibile e non riconducibile a un'unità, nella quale non è mai possibile pervenire a un'origine, né a un originario referente. Si ha sempre e solo a che fare con una catena di rinvii senza soluzione di continuità che viene a essere definita esclusivamente mediante il meccanismo della differance: per negazione, cioè, di ogni composizione unitaria, di ogni telos, di ogni razionalità onnicomprensiva, scardinando l'egemonia del «centro»".
Appare chiaro, dunque, come l'eredità di questo approccio sia fondamentale per comprendere la pluralità dei codici e dei linguaggi, centrale nella teoria postmoderna, nonché sia applicabile ante litteram alla situazione contemporanea della multimedialità, dell'ipertestualità e della contaminazione «in rete», che della teoria postmoderna sono l'esito ultimo e più complesso. Orientamento teorico e metodologico risalente, con diramazioni successive, all'opera del linguista svizzero Ferdinand de Saussure, che considera la lingua come un insieme strutturato di elementi interagenti e interdipendenti; successivamente la definizione è stata adottata anche per indicare gli indirizzi di pensiero che hanno esteso alle scienze umane i principi dello strutturalismo linguistico, per cui i fenomeni culturali sono visti come insiemi organici tra i cui componenti vigono relazioni costanti e sistematiche: l'antropologia (con Claude Lévi-Strauss), la critica letteraria (con Roland Barthes), la psicanalisi (con Jacques Lacan), l'esegesi marxista (con Louis Althusser), la filosofia della cultura (con Michel Foucault) e la neo-liguistica (con Roland Jakobson). Per una comprensione analitica del fenomeno cfr. G. Fornero e F. Restaino, Nicola Abbagnano – “Storia della Filosofia”, volume X in “La filosofia contemporanea”.
Bibliografia:
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero - “Filosofi e filosofie nella storia”,
vol. III, Paravia, Torino, 1992.
Mimmo Pesare - “Eziologia e genealogia del postmodernismo filosofico” Bulzoni Editore - a cura dell’AISEA.
Dottore di Ricerca in Etica e Antropologia e Assegnista di Ricerca in Pedagogia Sociale della Comunicazione presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell'Università del Salento, collabora alla didattica nel Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. È redattore della rivista internazionale Quaderno di Comunicazione (Meltemi, Roma) e autore di numerosi saggi nel campo delle scienze umane. Si è occupato, tra l'altro, del concetto di «abitare» in filosofia e psicoanalisi. Tra le sue pubblicazioni, la cura del libro “Rifrazioni. Luoghi superstiti della postmodernità” (Manni, Lecce), il recente “La dimora dei luoghi. Saggi sull'abitare tra filosofia e scienze sociali” (Icaro, Lecce) e, in corso di stampa, “Antropologia filosofica dell'abitare” (Mimesis, Milano).
In merito, va qui ricordato che la sezione tematica "Antropologia e letteratura" si è costituita, con approvazione del Consiglio Direttivo dell'AISEA, Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche, il 10 giugno 1996, le cui linee programmatiche, valide per il nostro interesse specifico di ricercatori, si possono così riassumere:
•promuovere l'approfondimento dell'indagine sulla scrittura etnografica, in linea con alcune recenti domande della riflessione antropologica;
•studiare la possibilità di elaborare un quadro teorico che metta in comunicazione questo settore di ricerca con le problematiche afferenti agli studi di antropologia della scrittura;
•riprendere parallelamente la riflessione sulle implicazioni antropologiche dell'oralità, con particolare riferimento all'oralità letteraria, rivisitando in questa prospettiva tradizioni di studi e di ricerche quali la letteratura popolare a stampa, la scrittura popolare, la letteratura di tradizione orale, con riferimenti ad aspetti quali la poetica comparata, l'antropologia della voce, del gesto e, più ampiamente, della performance;
•riflettere problematicamente sull'uso che la ricerca antropologica può fare di testi letterari, nonché, tenendo fermi limiti e distinzioni, definire i rapporti tra antropologia e letteratura all'interno del quadro teorico che si propone di elaborare.
Oltre a promuovere ricerche su temi e problemi di volta in volta individuati, la sezione sta lavorando per effettuare una ricognizione bibliografica degli studi e delle attività concernenti le tematiche proprie della sezione;
•curare i rapporti con centri e gruppi di ricerca che si occupano di queste tematiche, in Italia e all'estero;
•organizzare periodicamente momenti di confronto, soprattutto in forma di seminari e convegni.
Riguardo a quest'ultimo punto la sezione ha già tenuto due incontri seminariali propedeutici ai convegni a Roma e a Salerno e nel 2001 in Calabria a Cosenza, presso l’università della Calabria e a Cassano Ionio, in collaborazione con il Centro Studi Demologici e Dialettologici Cesare Pavese. In questi anni, la sezione, in collaborazione con l’Università di Salerno, ha organizzato i seguenti Convegni:
•“Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici”, Fisciano- Ravello 21-23/11/97 (di cui sono stati pubblicati gli Atti).
•“Antropologia e romanzo”, Fisciano-Ravello 8-10/10/1999.
•“Altrove immaginari. Modelli di società tra etnografie inventate e costruzioni utopiche”, Fisciano-Amalfi 22-24/9/2000.
•“Antropologia e poesia”, Fisciano- Ravello, 2-4 maggio 2002.
•“La vita in gioco. Antropologia, letteratura, filosofia dell’azzardo”, Fisciano-Amalfi 1-3 ottobre 2004; convegni che hanno visto una notevole partecipazione e hanno promosso confronti anche tra studiosi italiani e stranieri.
La sezione di “Antropologia Storica” ufficialmente costituita in seno all'Aisea nel 1992, pone come suo obiettivo prioritario di occuparsi delle problematiche relative ai rapporti tra discipline antropologiche e quelle storiche; tra l'hic et nunc dei primi antropologi fautori della contemporaneità storica dell'evento da analizzare come unico "tempo" osservabile, e la più moderna ed obiettiva analisi dei cambianti per cui gli eventi stessi risultano inscritti, oltre che nel presente, in un passato in grado di restituire ai fenomeni la loro originale ed originaria tridimensionalità. Da sempre interessata alle metodiche connesse alla verifica e alla decodificazione delle fonti documentarie (epistolari, archivistiche, visuali, orali, ecc.) nella convinzione della loro irrinunciabile vitalità quale strumento di indagine e di conoscenza, la sezione cura inoltre e da diversi anni la pubblicazione di una collana editoriale, sotto i tipi della Bulzoni, che prevede "incursioni" nei più diversi ambiti culturali, sollecitando il lettore mediante una gamma di occasioni e di spunti di riflessione acquisiti grazie al metodo storico-comparativo. La collana è diretta da Gilberto Mazzoleni e da ciascun coordinatore di sezione in carica.
Ospite della Facoltà di Lingue e Letterature straniere, si è costituita in seno all'AISEA una Sezione di Antropologia Applicata, che si propone di raccogliere documentazione, di promuovere la ricerca e di creare occasioni di incontro, collaborazione e dibattito non solo tra gli antropologi ma con altri specialisti e con gli operatori rilevati. La Sezione intende promuovere attività e attenzione per gli snodi di maggiore importanza della società e delle dinamiche produttive, culturali e comunicative attuali, come pure per i principali aspetti istituzionali. Ci si riferisce, in primo luogo, alle attività economiche, ai servizi, allo sviluppo e alla riqualificazione territoriale, ai movimenti demografici, al tempo libero, al turismo e, infine, anche all’università e alla ricerca. Nel corso della prima riunione sono stati eletti il coordinatore, Gian Luigi Bravo, il segretario, Lia Zola, e l’incaricato delle comunicazioni e dei rapporti con l’esterno, Mara Francese, mentre Dipak Pant cura i rapporti con l'American Association for Applied Anthropology.
Bibliografia e pubblicazioni:
“Il Bollettino”, la cui redazione è affidata alla dott.ssa Floriana Ciccodicola, è una pubblicazione semestrale concepita come organo di discussione, di informazione e di coordinamento delle attività svolte all'interno della sezione medesima. In esso vengono esposte e dibattute le diverse iniziative didattiche e di ricerca effettuate dai soci nel quadro dei loro impegni sia universitari che extra-universitari; inoltre vengono segnalate e recensite tutte le novità editoriali attinenti i soggetti dell'Antropologia Storica. Contatti: Floriana Ciccodicola (E-Mail: flo.cicco@libero.it).
Silvestrini E., (a cura di), Fare antropologia storica. Le fonti, Roma, Bulzoni, 1999.
Pirani A. M., (a cura di), ”L’abbaglio dell'occidente per il diritto alla differenza culturale”, Roma. Bulzoni, 2000.
Di Renzo E., (a cura di), “Si fa il cammino con l'andare: note di antropologia del viaggio”., Roma. Bulzoni, 2002.
È in questo modo, stimolando la curiosità verso quelle esperienze, umane e sociali, ma del tutto ragionevoli se comprese all’interno del loro particolare contenuto culturale, che l’Etnomusicologia ha saputo forzare i confini di ciò che era da ritenere umano, culturale, artistico, razionale. Concetti come “cultura”, “relativismo”, “etnocentrismo”, “etnografia” sono divenuti parole chiave anche in altre discipline e, più in generale, per il pensiero contemporaneo. Va ricordato che la devozione antropologica per lo studio di tutti i popoli, nei luoghi e nei modi in cui vivono, è ormai riconosciuta come un’irrinunciabile conquista della sensibilità contemporanea. Popoli diversi e distanti tra di loro hanno così potuto per la prima volta contribuire, grazie alle testimonianze raccolte dagli antropologi e dagli etnomusicologi, a una discussione sulle potenzialità e i limiti tra le forme di vita e i modi di pensare dell’umanità.
Grazie a questa lezione, volta a decostruire molte tra le idealizzate nozioni della nostra civiltà, l’etnomusicologia si è affermata come una delle discipline umane che più hanno contribuito a caratterizzare il Novecento. Ed è proprio grazie a questa disciplina così effervescente di studi e di applicazioni, così impegnata a rinnovare sia il proprio mandato sociale, sia l’attenzione della comunità scientifica più in generale, che si configura come programma di ricerca e di formazione istruttivo quanto avvincente; un saper fare assai ben radicato in una tradizione scientifica di indagini etnografiche e dibattiti teorici, ma anche in grado di interpretare in modo simpatetico e autorevole l’esperienza postmoderna. Pertanto va qui ribadito che quando si parla di etnomusicologia comparativa, si parla di una disciplina da pensare come dimensione centrale della conoscenza antropologica, di una radicale opzione antipositivistica che contrasta ogni illusione di oggettività, di ingenuo empirismo, di descrizione realistica.
Come pure scrivono E. Schultz e R. Lavenda, autori di “Antropologia Culturale” (*):
“Il sapere etnografico risulta sempre mediato da sguardi orientati, da contesti storici e relazionali, da prospettive ideologiche e biografie situate. Ma si farebbe un grave errore pensare di dover depurare o cancellare questa mediazione: si perderebbe la possibilità stessa di riconoscere le fonti e le modalità del processo conoscitivo che si è attuato; verrebbe meno la possibilità di ricostruire e di dar senso alle energie e alle risorse della trasformazione avvenuta. La comprensione dell’altro culturale scrivono gli autori echeggiando posizioni vicine all’ermeneutica contemporanea, e in Italia per molti versi anticipate dall’antropologia di Ernesto de Martino – è costruita intersoggettivamente, utilizzando elementi tratti dal sistema culturale sia dell’antropologo che dell’informatore. Afferrando il significato del sé culturale dell’altro, scopriremo in parte il significato della nostra identità”.
C’è da augurarsi che il lettore possa qui ritrovare quella sensazione vitale avvertita da Claude Lévi-Strauss,il quale leggendo nel 1933-34 uno dei primi manuali della disciplina, “Primitive Sociology” di Robert Lowie, che decise la sua vocazione di ricercatore:
“Qui, invece di nozioni tratte da altre letture e immediatamente trasformate in concetti filosofici, trovai esperienze vissute da società indigene, il significato delle quali era stato rispettato dall’attenta cura dell’osservatore. Il mio pensiero sfuggiva alla soffocazione che la pratica della riflessione filosofica gli causava. All’aperto, l’aria nuova lo rinvigoriva. Come un cittadino fra i monti, mi inebriavo di spazio mentre i miei occhi abbagliati misuravano la ricchezza e la varietà degli oggetti”.
Ne emerge che l’etnomusicologia ma ancor prima l’antropologia non è un sistema teorico dotato di una gerarchia di livelli analitici e rapporti casuali, ma può configurarsi più efficacemente come un’istanza euristica di rappresentazione e connessione delle differenze culturali prodotto delle tante etnografie; prospettiva duttile e sempre in fieri, che continuamente si rimodella per costruire una storia che invita a condividere storie nostre e altrui. E che, per approssimazione al limite, può anche far pensare a mondi comuni a tutti i popoli, almeno finché la cultura rende possibile la sopravvivenza dell’umanità.
Bibliografia:
Claude Lévi Stauss “Tristi Tropici” – Il Saggiatore, 1960.
E. Schultz e R. Lavenda “Antropologia Culturale” – Zanichelli, 1999.
Robert Lowie, “Primitive Sociology” …
*
 - Musica
- Musica
Ecce Advenit Dominus
“ECCE ADVENIT DOMINUS”
Tratta dal Laudario di Cortona il cui manoscritto risale al XIII sec., la “Lauda della Natività” di Girolamo da Cremona, rinvenuta nel libro di preghiera di una confraternita mista laico-religiosa, è il primo documento noto in volgare italiano posto in musica:
“Da ciel venne messo novello
ciò fo l’angel Gabriello.
Nella città di galilea
là ve’ era la gente Judea,
favellavano en lengua ebrea
in città et in castello,
ch’è chiamata Nazareth
là u’ la vergene nacque e stette;
sponsata era a Josefe,
secondo la legge coll’anello.
Stella nuova ‘n fra la gente
c’aparuisti novamente,
Stella c’apparist’ al mundo
quanto nacque ‘l re iocondo,
stette ‘n mezzo a tutto ‘l mondo
per aluminar la gente”.
Di là dall’apparente semplicità questa Lauda della Natività si rivela patrimonio di testimonianze originali in cui l’avvicendarsi esultante del canto, invita all’esultanza corale per una celebrazione che dal lontano passato ci conduce al quotidiano essere della tradizione italiana, in quella cadenza rituale e celebrativa che è la festa più rappresentativa della cristianità. Il Natale infatti è nella ricorrenza cristiana, la manifestazione gaudiosa dell’avvenuta rivelazione del sacro, in cui il segreto nascere alla vita conferma un’antica promessa d’eternità nell’atto celebrativo della festa, il ringraziamento per il dono ricevuto. La testimonianza di un sentimento comune che va oltre la veridicità della 'storia' narrata, che supera la dimensione temporale per raggiungere nella coscienza cristiana, la propria grande affermazione di fede.
Una rivisitazione del Natale attraverso il canto delle laudi, il rileggere i racconti o i semplici testi delle canzoni dedicate alla natività, così come prendere parte alle manifestazioni popolari a qualsiasi titolo, comunque equivale a riscoprire l’infanzia del mondo, quel sentimento mistico che ad esso si ispira. Equivale cioè a ridestare nell’uomo il fanciullo che è stato, quando per gioco rincorreva gli astri nel cielo, nella speranza di afferrare il vago incedere dei sogni, in cui si perpetua la conciliazione della natura con la divina trascendenza e si rinnova la magica rinascenza alla vita; punti di discernimento che sono all’origine di questa festa entrata con il suo alone di leggenda nella storia dell’umanità.
Presente nella memoria di molti popoli che l’hanno tramandata attraverso leggende e racconti, cantici e rappresentazioni, la sua ricorrenza ha assunto nel tempo simboli e significati diversi, rispettivamente della solennità religiosa e della celebrazione festosa, ricche di un apparato scenografico prezioso e variegato, e da una simbologia funzionale insostituibile, che ha influenzato grandemente la creatività popolare nell’arte come nel canto e nella musica. Intesa come riunione conviviale la festa del Natale ha assunto nel tempo il significato di messaggio, di scambio, di presenza; di invito alla diretta e attiva partecipazione all’unione familiare. Quella stessa festa che i primi cristiani salutarono come il giorno della nascita del Bambino in Betlemme, data di partenza di una nuova era.
Il genere musicale della Laude è prevalentemente quello liturgico ufficiale in cui non mancano elementi di canto popolare vicini alla melica di Giuliano da Spira (1250 circa). La prima trascrizione completa della parte letteraria del Laudario di Cortona si deve invece a Guido Mazzoni (1889) e più recentemente a Gianfranco Contini (1960) che ne ha proposta un'edizione critica con un’ampia scelta di laudi. Per la parte musicale, la trascrizione completa è stata curata per la prima volta da Ferdinando Liuzzi (1935), mentre la più recente è quella adottata dal Quartetto Polifonico Italiano diretto da Clemente Terni e da questi condotta secondo i criteri di modifica della innodia liturgica del gregoriano a una vocalità popolare e moderna, fondata sul senso della tonalità lineare e conchiusa in coerente architettura formale.
La 'Laude della Natività' ripresa dal Laudario Codice 91 dell’Accademia Etrusca di Cortona e qui riprodotta, è da considerarsi una rarità musicologica il cui canto ci permette di recuperare il passato e di riscoprire una dimensione forse sconosciuta della festa a noi più cara, nella commemorazione della quale, in certo qual senso, ritroviamo in noi stessi quel sentimento di lietezza che ci conduce ad una nuova speranza di pace.
Buon Natale.
Giorgio Mancinelli - da “Anno Domini: usanze e costumi di una tradizione” – Grafica e Arte Bergamo – 1989.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomus. 7: Grecia - terza parte
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGIA – 7 GRECIA (terza parte)
“GRECIA: Terra di suoni, di antichi miti, di amori lontani ritrovati” – di Giorgio Mancinelli.
Frammenti di un diario di viaggio:
“Faccio la conoscenza di Zorba al Pireo, la mattina che mi reco al porto. (..) Un uomo alto, massiccio, il volto scavato dalle intemperie, ma giovanile; gli occhi verde-azzurri, con un’espressione intelligente e fiera …”. (1)
Kalimera! – dice, mentre mi viene incontro e mi chiede di dove vengo e dove sono diretto. Parla correttamente greco, francese, inglese e si arrangia con l’italiano. Sa tutto sul teatro e la letteratura greci, conosce i testi delle canzoni più famose, il nome dei compositori in voga, gli strumenti, le danze popolari, i cibi e i vini, le taverne che è uso frequentare, e chissà quante altre cose. Decide lui di farmi da accompagnatore in questo viaggio itinerante che intendo fare nelle isole greche alla ricerca delle antiche tradizioni.
Strano – mi dico – come i greci siano tutti un po’ Zorba, come tutti sanno suonare almeno uno strumento, sanno cantare e ballare almeno una danza della loro terra d’origine, conoscono le tradizioni della regione che li ha allevati, e tutti si rallegrano al primo bicchiere di vino, quasi Dioniso in persona scenda tra loro per invitarli alla sua millenaria festa che si tiene un po’ dovunque, dall’Attica fino a toccare ogni Isola, anche la più lontana. Dioniso stesso è chiamato ad assistere ai banchetti, nell’euforia generale, alla pigiatura, al piacere del canto, alla gioia della danza, mentre Nikos Kazantzachis, autore del romanzo omonimo fa dire al suo Zorba:
“Basta bere un bicchiere di vino e subito il mondo cambia aspetto. La vita è davvero buffa. Sul vostro onore, sono grappoli quelli che ci pendono sulla testa, o sono angeli?”. (2)
È allora che Zorba corre a prendere il suo santouri e siede al suolo con le gambe incrociate, poi tolta la fodera allo strumento se lo pone in grembo e incomincia a suonare:
“E appena egli comincia a suonare, ècco si stende davanti agli occhi l’intera Macedonia, con le sue montagne, le sue foreste, i suoi torrenti, le donne atte alla dura fatica e uomini dalla corporatura possente, il monte Athos coi suoi ventuno monasteri e i suoi pigri abitanti … (..) A volte suona una melodia selvaggia, è allora che ci si sente soffocare, si comprende all’improvviso come la nostra vita sia incolore, triste, meschina, indegna. (..) Altre volte, quando suona egli suona un’aria malinconica si capisce come invece la vita trascorra, fuggendo come sabbia dalle dita dischiuse, senza possibilità di salvezza, ma forse di speranza”. (3)
Sembra quasi di sentirlo, non è vero? Ma chi è Zorba se non quell’Orfeo innamorato di Euridice al tempo stesso felice e affranto che vive il paradosso della sua esistenza/assenza destinato a toccare il suo apice solo (divinamente parlando) nella musica, e forse (umanamente parlando) nel canto, sì da lasciarci esterrefatti nell’accostamento, dinanzi all’unità e alla strettissima somiglianza delle idee che si sviluppano intorno ai pensieri fondamentali che si avviluppano nella nostra mente pur secondo misurate concezioni fin troppo umane.
Scrive Marius Schneider nel suo insuperato “Il significato della musica” (4):
“Quanto più antico è il passato a cui risaliamo nella storia dell’umanità, tanto più vediamo la musica comparire non in forma di divertimento o di manifestazione artistica, ma come elemento legato ai particolari più umili della vita quotidiana o connesso agli sforzi ostinati tesi a stabilire il contatto con un mondo che possiamo chiamare metafisico”.
E metafisico è l’accostamento che stiamo cercando di fare in questo contesto di ricerca, onde catturare la polisemia del simbolo che ci ha fin qui accompagnati, cioè la musica e il canto, tenuti insieme da entrambi i protagonisti della nostra storia “surreale”, lì dove Zorba è riconducibile a Orfeo o, al limite massimo della sua esperienza umana, di unione e separazione degli elementi che compongono l’incontro delle due entità. Lì dove Orfeo rinuncia a vivere per andare incontro a Euridice, mentre Zorba chiede di vivere per andare incontro al tempo “il regno del mutamento, della discontinuità, dell’alternanza” e, non importa che il tempo sia concepito secondo un modello ciclico, quanto è l’idea stessa del cambiamento che rende concepibile la coesistenza degli eventi in un eterno presente. Se per Orfeo l’assenza di Euridice simboleggia il vuoto di un sentimento, per Zorba è l’assenza in se stessa a essere significativa, nella separazione di luce e ombra che include la sua esistenza, è il nulla che lo circonda, il tutto che lo avvolge è luce e tenebra, vita e morte affrancate dalla sua voglia di vivere. Due estremità di una fune che corrode il tempo in cui, se il ritorno ciclico è garanzia di immortalità, l’avanzare del tempo verso una fine è non più la sofferenza di vivere (Orfeo) ma è liberazione (Zorba).
Verosimilmente sia Orfeo che Zorba ci seducono attraverso la musica, come scrive Augusto Romano (5):
“In questa impresa orfeo si mostra grande incantatore, anestetizza il male: infatti Tantalo dimentica la sua sete, Sisifo si siede sulla sua pietra, gli avvoltoi smettono di lacerare il fegato di Tizio e così via. Si tocca qui un terreno che inquieta: la funzione civilizzatrice della musica (..) che già in Platone aveva trovato un’efficace formulazione che si propone un mondo di affetti stabili e incorruttibili. Il male come rottura viene eufemistizzato attraverso la possibilità della ricomposizione. (..) Questa reversibilità del tempo si estende sin oltre il punto in cui esso ha avuto origine e sfocia nel gran mare della comunione universale, in cui Orfeo ed Euridice sono una cosa sola”.
Lo stesso che vede Zorba essere tutt’uno con la terra che lo ha visto nascere e che un giorno lo riavrà tra le sue braccia amorevoli:
“Che cosa significa allora la Grecia, la patria, il dolore?” – fa chiedere ancora a Zorba l’autore del romanzo, dandosi poi anche la risposta:
“La verità è qui!, racchiusa in queste parole, che forse non significano nulla. Eppure per questo nulla (noi greci) siamo disposti a corteggiare la morte!” (6) – ed è forse questa la riproposizione del dramma antico che si porta dietro la Grecia, il tentativo di riappropriazione del proprio passato, e lo fa attraverso l’anima della Tragedia, il corpus “musicale” del suo canto, delle sue danze arcaiche come per un viaggio iniziatico significativo che dal lontano passato giunge fino ai nostri giorni. E se è vero che l’occasione fa il lettore ladro, colgo l’occasione per un’introduzione nel vasto panorama della danza che qui si balla con gioia per le strade e nelle piazze, come forse lo si faceva ieri, oggi, sempre:
“Chi non danza, ignora quel che accade” (Cristo in un Inno gnostico del II sec.). (7)
Scrive Curt Sacks (8): “La danza è la madre delle arti. Musica e poesia si determinano nel tempo, le arti figurative e l’architettura nello spazio: la danza vive ugualmente nel tempo e nello spazio. In essa creatore e creazione, opera e artista, fanno tutt’uno. Movimento ritmico in una successione spazio-temporale, senso plastico dello spazio, viva rappresentazione di una realtà visiva e fantastica (del mondo). Danzando, l’uomo ricrea queste cose con il suo stesso corpo, ancor prima di affidare alla materia, alla pietra, alla parola, il risultato della sua esperienza. (..) Infatti, nella danza i confini tra corpo e anima, tra espressione libera dei sentimenti e finalità utilitarie, tra socialità e individualismo, tra gioco, culto, lotta e rappresentazione scenica, tutti i confini che l’umanità ha costruito nel corso della sua evoluzione, si annullano. (..) La danza è vita a un grado più elevato e intenso: tale affermazione sottolinea il carattere universale della danza con il suo significato definitivo e potrebbe dare profondità e ampiezza a considerazioni di ordine scientifico, ma non è una definizione che per tali considerazioni possa servire da punto di partenza”.
Al carattere gioioso della danza fa riferimento l’origine della parola stessa, almeno per i greci la parola “chóros”, cioè “danza”, seppure erroneamente era derivata da “chará”, ovvero gioia. Gli studiosi del folklore vedono nella danza di “gioia” un modo catartico della morte e della resurrezione, come nel più antico mito della morte e del risveglio della natura, in senso propiziatorio. I vari elementi della danza che sono dispersi nello spazio e nel tempo e che devono essere laboriosamente riuniti in un quadro corrente, vivono insieme in un mirabile organismo nell’Europa antica (9). A mio avviso, nessuno degli aspetti del mondo antico può essere studiato isolatamente perché ognuno costituisce una parte interdipendente di un tutto. L’Egeo, fino a un certo periodo si trova a un livello di cultura non superiore a quello del resto dell’Europa. Le tradizioni coreutiche, quelle dei più lontani antenati, che le civiltà mature amano riportare indietro in un oscuro passato, hanno conservato qui tutto il loro originario vigore e sono oggetto dello stesso amore e della stessa fedeltà che a loro testimonia l’umanità primitiva; inoltre qui tutto ciò che hanno creato i millenni successivi fiorisce liberamente accanto alle tradizioni di questa prima età. Alla successione si è sostituita la coesistenza delle forme coreutiche di cui la narrazione fattaci da Omero dei tempi eroici descrive le danze gioiose dei giovani, soli o con fanciulle per festeggiare le nozze, la vendemmia o semplicemente per dar sfogo alla loro esuberanza giovanile:
Dall’Iliade canto.XVIII, leggiamo un passo nella traduzione di Vincenzo Monti: (10)
“Facevi ancora il mastro ignipotente
In amena convalle una pastura
Tutta di greggi biancheggiante, e sparsa
Di capanne, di chiusi e pecorilli.
Poi vi sculse una danza, a quella eguale
Che ad Arianna dalle belle trecce
Nell’ampia Creta Dèdalo compose.
V’erano garzoncelli e verginette
Di bellissimo corpo, che saltando
Teneansi al carpo delle palme avvinti.
Queste un velo sottil, quelli un farsetto
Ben tessuto vestìa, soavemente
Lustro qual bacca di palladia fronda.
Portano queste al crin belle ghirlande,
Quelli aurato trafiere al fianco appeso
Da cintola d’argento. Ed or leggieri
Danzano in tondo con maestri passi,
Come rapida ruota che, seduto
Al mobil torno, il vasellier rivolve;
Or si spiegano in file. Numerosa
Stava la turba a riguardar le belle
Caròle, e in cor godea. Finian la danza
Tre saltator, che in vari caracolli
Rotavansi intonando una canzona”.
Scrive ancora Curt Sachs (11): “Sono gli stessi uomini che, immersi in una profonda meditazione, girano intorno agli oggetti sacri alla maniera dei loro antenati; che imitano l’animale nei suoi tratti caratteristici e nei suoi gesti; che sotto la maschera perdono la loro individualità e vengono posseduti, seguendo il potere degli spiriti e delle divinità, danzando nel rapimento dell’estasi. E sono ancora gli stessi uomini che, ispirati da un sogno, rivivono il destino dei loro avi e ne fanno un dramma del popolo, un dramma universale con il riconoscimento della socialità nella danza collettiva e l’affermazione individualistica nella danza solistica, con umile devozione e ridente saggezza, solennemente e grottescamente, seriamente e scherzosamente, trascorrendo sempre dall’umano al sovrumano”.
È così che ogni regione e ogni isola ha la sua varietà di strumenti – dice ancora Zorba – come pure i suoi canti e le sue danze. È allora, come adesso, che torna a farsi sentire la voce di Zorba che col bicchiere di vino in mano, comincia a cantare una canzone antica, pur sempre nuova, e a poco a poco attorno si forma un coro accompagnato dal tamburellare delle dita sul tavolo e dal battere ritmico delle mani, di quanti s’immedesimano in cantori:
Dall’Iliade canto.IX, leggiamo un passo nella traduzione di Vincenzo Monti: (12)
“Alle tende venuti ed alle navi
de’ Mirmidoni ritrovar l’eroe
che ricreava colla cetra il core
cetra arguta e gentil che la traversa
avea d’argento e spoglia era del sacco
de la città d’Eezion distrutta”.
Ed anche danzatori provetti, se non altro perché ognuno improvvisa un passo di danza, benché nel chiuso della taverna. Oltre a quelle già elencate nell’excursus di questa ricerca, troviamo il “pentozali” l’antica danza nazionale dei guerrieri di Creta; il tradizionale “chassapiko” (del macellaio); lo “zeibétiko” del popolo Zeibèko dell’Asia Minore; insieme alla più diffusa “kalamantianós” originaria del Peloponneso; la “sousta” tipica del Dodecanneso; la “pella” forse la più antica danza conosciuta nell’antica Macedonia; il “lambiatiko” di Kèdras in Tessalonia, e il “sirtaki” sui passi del tradizionale “syrtòs” di più lontana memoria.
Come allora ci si avvale per l’accompagnamento degli strumenti tipici, o di una piccola orchestra che prende nome Zilyà, composta da clarino, violino, liuto, sandouri e dai tamburelli daouli che, nello spettacolo tenuto dalla coreografa Dora Stratou nell’omonimo Teatro sotto l’Acropoli fanno di ogni singola esecuzione, un momento di autentico virtuosismo, dal forte impatto tradizionale. Ogni strumentista dice di saper suonare oltre al già citato santouri, il bouzouki, un mandolino dal manico lungo a sei corde che deriva dal saz turco o dal bizantino tambourás; e ancora il klarino, la pipiza e la zournas appartenenti alla grande tradizione dei flauti greci e quell’antico aulos il cui suono è ancora oggi capace di incantare il mondo; la zampogna o askomadoùra, la gaida, e, non ultima la lyra o kithára. Dopo l’aulos, la lyra è infatti lo strumento che più interessa la nostra ricerca: già rinvenuta nelle stanze funerarie egizie del Nuovo Regno, è formata da una cassa quadrata e poco profonda, da due bracci divergenti e asimmetrici e una traversa obliqua; le sue corde sono fissate a una cordiera sulla fronte della cassa, in alto invece avvolte attorno alla traversa e possono essere spostate fino a raggiungere l’altezza desiderata:
“Dalla conoscenza della lyra classica greca si può dedurre che l’accordatura fosse pentatonica pure per quella egizia., anche quando il numero delle corde era superiore a cinque. In questo caso le corde aggiunte probabilmente continuavano la scala pentatonica verso l’acuto o verso il grave. Un numero più elevato di corde, come dieci o quattordici, va interpretato quale semplice raddoppio di corde, sull’esempio della moderna lyra abissina. La mano destra faceva scorrere il plettro sull’intera superficie delle corde, mentre le dita della sinistra provvedevano a impedire la vibrazione di quelle che non dovevano risonare. Lo strumento veniva tenuto nella posizione più conveniente per questo genere di esecuzione, con le corde inclinate in avanti”(13).
La lyra o cetra o kithára costituiva il principale strumento della Grecia antica, quello attribuito agli déi. Febo o Apollo era il dio citaredo (armato di cetra) che della lyra gli era attribuita l’invenzione. Resta famoso il mito della disputa tra Apollo e Marsya di cui si è già parlato. In quanto attributo di Apollo, la lyra rappresentava e dava voce a quell’aspetto della vita e dell’anima greche che si dice solitamente apollineo: “una miracolosa alchimia di saggia moderazione, armonioso controllo ed equilibrio della mente, laddove l’aulos incarnava l’aspetto dionisiaco (satiresco), l’ebbrezza sfrenata, l’estasi”.
Dagli Inni Omerici (14), leggiamo il XIX dedicato “A Pan” e alla danza:
“O Musa, celebra il figlio diletto di Ermes,
dal piede caprino, bicorne, amante del clamore, che per le valli
folte di alberi si aggira insieme con le ninfe avvezze alla danza:
esse amano calcare le cime delle impervie rupi
invocando Pan, il dio dei pascoli, dall’abbondante chioma,
irsuto, che regna su tutte le alture nevose
e sulle vette dei monti, e sugli aspri sentieri.
Si aggira da ogni parte tra le folte macchie:
ora è attirato dai lenti ruscelli,
ora invece s’inerpica fra rupi inaccessibili
salendo alla vetta più alta da cui scorgono le greggi.
Spesso corre attraverso le grandi montagne biancheggianti,
spesso muove fra le colline, e fa strage di fiere,
scorgendole col suo sguardo acuto; talora, al tramonto,
solitario tornando dalla caccia,
suona modulando con la siringa una
musica serena: non riuscirebbe a superarlo nella melodia
l’uccello che tra il fogliame della primavera ricca di fiori
effonde il suo lamento, e intona un canto dolce come il miele.
Con lui allora le ninfe montana dalla limpida voce
girando con rapido batter di piedi
presso la sorgente dalle acque cupe cantano, e l’eco geme
intorno alla vetta del monte.
Il dio, muovendo da una parte all’altra,
e talora al centro della danza, la guida
con rapido batter di piedi – sul dorso ha una fulva
pelle di lince, esaltandosi nell’animo al limpido canto,
sul molle prato dove il croco, e il giacinto
odoroso, fioriscono mescolandosi innumerevoli all’erba …”.
Per una divinità legata soprattutto alla pastorizia, “cantare Pan” significa dedicarsi alla poesia pastorale, o almeno, secondo i poeti bucolici, invocare il suo nome è invocare la natura selvaggia che fa da sfondo alla vita pastorale. Com’è noto, la sua figura è popolare soprattutto in Arcadia, la terra “ricca di greggi” dove il suo culto è attestato fin dal VI secolo, ma doveva essere molto più antico da poter supporre precedente alle feste di Zeus Liceo (Pausania). Secondo Erodoto il culto di Pan fu introdotto in Atene dopo la battaglia di Maratona, nel 490, a causa dell’aiuto ch’egli diede agli Ateniesi. La sua presenza è attestata qua e là dal V sec. in poi, in tutto il mondo greco. Colgo qui l’occasione per parlare del syrinx o flauto di Pan dimenticata dai prototipi strumentali forse perché non trova posto nell’arte musicale.
In Grecia lo strumento fu esclusivamente pastorale pertanto relegato a fatto mitico che lo legava alla natura. Questo spiega facilmente perché soggiorna in luoghi più frequentati da animali cha da uomini, tant’è che Omero dice dei pastori che: “seguivano il gregge su la siringa / lor zufolando …”; lo strumento consiste d’una serie di canne ordinate secondo la lunghezza e generalmente in numero di sette, delle quali ognuna rassomiglia a un semplice flauto diritto, chiuso all’estremità inferiore e privo di fori per le dita, capace di emettere una nota della scala. Le canne sono unite insieme a formare una fila solidale pareggiata in alto e digradante alla base sagomata ad ala, su cui l’esecutore fa scivolare la bocca per giungere alla nota voluta dando luogo a un passaggio di note più o meno alte fino a formare una sorta di melodioso insieme.
I pochi esemplari esistenti, reperti negli scavi archeologici, sono fatti di legno, bronzo, terracotta, o in una specie di resina; può ben darsi che siano state usate anche delle canne ma si tratta di un materiale troppo facilmente deperibile perché si sia potuto conservare. Dovunque sia presente nella Grecia classica come in regioni primitive, la syrinx è legata a incantesimi e magie amorose. Riferisce la leggenda che Pan innamoratosi di una leggiadra ninfa dell’Arcadia, la inseguì finché ella non fu fermata nella sua fuga dal fiume Ladon: sarebbe stata certo raggiunta dal dio coi piedi caprini se un dio che la proteggeva non l’avesse subito trasmutata in canna. Fu precisamente da questa canna che Pan ricavò la sua sarin, per suonarla quando la passione e il desiderio si fossero impadroniti di lui.
Si vuole che una sarin conservata nella caverna di Artemide presso Efeso, fosse capace di provare la verginità di una fanciulla col suo suono. Lo sfondo crepuscolare dell’inno sopra riportato, nonostante le sue dimensioni, probabilmente non è un proemio integro, ma solo un ampio esordio seguito da un breve congedo, possibilmente eseguito in Arcadia, tuttavia non è escluso del tutto che fosse recitato durante un agone in onore della divinità o addirittura di altre se, come qui di seguito riportato, esso si apre a un’esaltazione più ampia, rivolgendosi agli déi dell’Olimpo: (15)
“Cantano gli déi beati e il vasto Olimpo;
per esempio, del rapido Ermes, eminente fra gli altri,
narravano: come egli sia messaggero veloce per tutti gli déi,
e come venne all’Arcadia ricca di fonti, madre di greggi,
là dove ha il suo santuario cillenio.
Colà, pur essendo un dio, (Pan) pascolava le greggi dal ruvido vello
presso un mortale: poiché lo aveva preso, e fioriva in lui, un
desiderio struggente
di unirsi in amore con la fanciulla dalle belle trecce, figlia di
Driope.
E ottenne il florido amplesso; ed ella, nelle sue stanze, generò
Ermes un figlio diletto, già allora mostruoso a vedersi,
dal piede caprino, bicorne, vociante, dal dolce sorriso.
Diede un balzo e fuggì la nutrice, e abbandonò il fanciullo:
si spaventò, infatti, come vide quel volto ferino e barbuto.
Ma subito il rapido Ermes lo prese fra le braccia,
accogliendoloi: grandemente il dio gioiva nell’animo.
Senza indugio salì alle dimore degl’immortali, dopo aver
Avvolto il fanciullo
Nella folta pelliccia di una lepre montana;
lo depose al cospetto di Zeus e degli altri immortali,
e presentò suo figlio: si rallegrarono nell’animo tutti
gli immortali, ma più d’ogni altro il baccheggiante Dioniso;
e lo chiamarono Pan, poiché a tutti l’animo aveva rallegrato.
Così io ti saluto, signore, e ti rendo propizio col mio canto:
ed io mi ricorderò di te, e di un altro canto ancora”.
“Solleva il piede spingi nell’etere la danza, evoè, evoè … La danza è santa”, incita Euripide in un antistrofe di “Le Troiane”, che risuona come un diretto invito a ogni coreografo/a che si rispetti, di misurarsi con la tragedia greca. Interamente alla danza è dedicato il Festival Internazionale che si tiene a Kalamàta in Luglio con la direzione artistica di Victoria Marangopoulou il cui prestigio è riconosciuto a livello internazionale, e diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del genere e un’importante ribalta per le compagnie di ogni nazionalità. Altro evento culturale di punta dell’estate è indubbiamente il Festival di Atene con un cartellone che spazia dall’Opera lirica, alla Commedia greca, alla danza contemporanea, che si alternano sull’antico palcoscenico dell’Odeon Erode-Attico, costruito nel 161 d.C., e che ha come sfondo d’eccezione l’Acropoli.
Nello stesso periodo estivo si svolge anche il Festival di Epidauro, considerato una vera istituzione per gli appassionati del dramma antico. il più celebre teatro del Peloponneso, costruito nel 4 a.C. da Policlito il Giovane e tutt’oggi rinomato per l’eccellente acustica, ospita le più acclamate tragedie di Eschilo, Euripide e Sofocle, nonché alcune commedie di Aristofane.
Colgo qui l’occasione per citare uno stuolo di grandi e di più giovani coreografi e musicisti che si sono adoperati per una internazionalizzazione della musica e della tragedia greche. Il ricordo va senz’altro a Pina Bausch (16) che della danza antica e in particolare di quella greca ha fatto la sua stilizzazione di base, rapportandosi spesso con la tragedia, creando coreografie per balletti e ispirazioni che l’hanno portata alla fusione di “teatrodanza”. La novità del suo lavoro non consiste tanto nell'invenzione di nuove forme e nuovi gesti, da riprodurre uguali a se stessi, quanto nell'interpretazione personale della forma che si vuole rappresentare. Un altro elemento di novità è costituito dall'interazione tra i danzatori e la molteplicità di materiali scenici di derivazione strettamente teatrale - come le sedie del Café Müller - che la Bausch inserisce nelle sue coreografie.
Solo alcune figure, che oggi definiamo “rappresentative”, di un percorso artistico, avevano (coraggio o altro) portato in scena la propria fisicità in questo modo, per così dire avevano espresso con il proprio corpo quella “tensione” muscolare e nervosa, specchio di umana forza e fragilità, e che in seguito, abbiamo eletti ad “eroi” di un passato a latere della nostra epoca e della storia della danza artistica. Nel 1974 Pina Bausch crea e porta in scena l'opera-ballo Iphigenia in Tauride (riallestito nel 1991 all'Opéra di Parigi); il 1975 è l'anno della realizzazione scenico-coreografica di Orpheo e Euridice di Gluck, ricomposto nel 1992 e ammirato anche in Italia (Teatro Carlo Felice, 1994). Nel suo irrinunciabile avvicinamento alla vita la Bausch coreografa rompe continuamente la prigionia dei codici o vi fa ritorno per paradosso, in episodi, spesso ironici, di riflessione sulla danza stessa e sulla fatica di danzare, che costituiscono uno dei leitmotiv non secondari della sua coreografia 'totale'.
Ma ècco che, incapaci come noi siamo, di sostenere l’assenza di peso dei nostri corpi alati (di Icaro memoria), nel tentativo di levaci altissimi fin dove la Bausch ci vede immersi nella luce, fatti di luce e di splendore, nella divinità infinita dei nostri corpi, veniamo presi dai soliti dubbi che ci portiamo dietro e ci torna infine la paura di non farcela a sostenere il calore infuocato del sole e torniamo miserevolmente a essere umani e precipitiamo irrimediabilmente verso il basso per ricongiungersi alla terra da cui veniamo, ragione per cui, forse, non saremo mai déi. Tuttavia alcuni importanti compositori hanno sottolineato la preponderante presenza della musica appositamente composta per lo spettacolo teatrale che vede la tragedia greca porsi in primo piano nello scenario internazionale. È il caso di Michalis Christodoulides (17) per le “Supplici” di Euripide, portata in scena dal Teatro di Cipro, proponendo una nuova prospettiva funzionale, cioè integrata col movimento scenico. Abbiamo già citato Mikis Teodorakis nella scrupolosa trasposizione del testo di Euripide “Ifigenia” e de “Le Troiane” portate al cinema e sulle scene di Broadway da Michael Cacoyannis; Vangelis Papatanassiou che compone le musiche per il colossal “O Megalexandros” su Alessandro il Macedone la pellicola di Theo Anghelopulos, solo per citarne alcuni, che hanno affondato le proprie mani nella tradizione popolare della Grecia antica e moderna.
Ma, se non rientra nel nostro precipuo interesse divagare troppo da quella che è la ricerca cui ci stiamo dedicando, tornare a parlare della musica etnica propriamente detta con l’ascolto (la presentazione) di un album di registrazioni sistematiche di una delle aree più interessanti della cultura europea è senz’altro corretto. Si tratta di un ricercatore tedesco, Wolf Dietrich, impegnato a fornire una integra documentazione della musica greca di tradizione orale, che ci propone in due album registrati sul-campo: “Musica popolare del Dodecanneso” (18) che fa eco a “Musica popolare di Creta”. I materiali raccolti in questi album interamente dedicati al Dodecanneso e all’isola di Creta, provengono da un programma assai ampio e approfondito di ricerca avviato da Roberto Leydi e Tullia Magrini, con la collaborazione di Stélios Lainàkis, a testimonianza della grande presenza di violinisti che hanno il loro territorio d’elezione nella parte occidentale dell’isola, ma attivi in tutta l’isola, con più o meno evidenti differenziazioni provinciali.
Come ha lasciato scritto Domna Samiou (19), la più nota etnomusicologa greca:
“La chiave della cultura di un popolo è nel linguaggio musicale e canora, nell’analisi delle sue componenti folkloristiche, nella incontaminazione etnica”.
E, sebbene noi abbiamo più volte constatato, come la contaminazione tra stili e forme musicali diversi ha permesso di scoprire e di rinverdire gioielli di una cultura, restituendoli alla sua originalità creativa il cui valore era di per sé universale. Ciò nonostante la pur grande Domna Samiou con la sua frase ha cristallizzato una verità sacrosanta: che bisogna risalire all’origine delle cose, a quando la contaminazione non aveva ancora sfiorato l’opera originale, per poter infine conoscere lo sviluppo che la stessa ha raggiunto successivamente. All’etnomusicologa greca dobbiamo tuttavia un ringraziamento, onde riconoscerle di aver scoperto virtuosi di alcuni strumenti originali della sua terra, personaggi quasi mitici che hanno lasciato impronta di sé nella musica greca di ieri. È il caso di Tassos Calkias (20), d’appartenenza alla dinastia dei clarinettisti dell’Epiro; la sua arte è raccolta in alcuni album di grande pregio artistico.
Non trascurabile la ricerca all’interno della tradizione di Creta realizzata a suo tempo dal poeta-compositore Nikos Xilouris (21) che ha raccolto una copiosa serie di canti della tradizione del “rizitika”, sul genere del blues negro-americano e come quello entrato nell’anima profonda della Grecia di oggi. Nato ad Anoghia, Creta, Nikos Xylouris è un membro di una vecchia famiglia cretese la cui storia è profusa di menestrelli e bardi, che gli permise di imparare a suonare la lyra. Divenuto egli stesso un menestrello della musica tradizionale, iniziò a fare da intrattenitore di feste di matrimonio e celebrazioni religiose e occasioni speciali. Compositore e poeta Xylouris ha arricchito la musica tradizionale cretese con molte creazioni di profondo acume musicale ed istintivo, inoltre la sua voce, così fondamentalmente greca, riflette della tradizione datata in più di 500 anni.
Tra i migliori esponenti della musica greca incontriamo Yannis Markòpoulos (22), passato attraverso l’esperienza folkloristica raccogliendo antiche melodie klefte, canzoni cretesi, litanie della forma liturgica bizantina, per poi avvicendarsi nella musica più avanzata, è riuscito a trovare un indirizzo musicale di rilievo che lo ha portato a musicare una tragedia moderna del poeta Dionissos Solomos “Eleftheri Poliorkimeni”(23). Insieme a Xylouris ha collaborato al recupero dell’antica tradizione del “rizitika” di Creta, nome dato ad un ramo della vecchia canzone popolare in uso fino ai nostri giorni. Ogni canzone rizitika può rispondere a molte versioni e ad ogni melodia corrisponde una lirica poetica. Creta, un tempo crocevia di culture diverse tra Europa, Africa e Asia, influenzata dalla musica cerimoniale bizantina e del Medio Oriente, abbracciando le culture Achea e Dorica e, più tardi, Pelasgie e di Kidones. Tutti hanno lasciato il loro marchio sulla canzone popolare rizitika che, ciononostante, ha preservato il suo carattere originale. Yannis Markopoulos, a sua volta cretese ha così definito il genere rizitika:
"È una forma di arte greca che ha prevalso sempre, è musica di luce, libera e umana, leggera e sensibile come il piumaggio di un uccello”.
Benché il termine Dodecanneso indichi solamente dodici isole, in realtà sono parecchie di più ed ancora oggi molte fra quelle minori sono disabitate. Come caratteristiche generali, ed anche per quanto riguarda gli stili musicali, le isole presentano evidenti differenze che le contraddistingue, e ciò, benché l’area Dodecanneso (24) non sia poi così lontane dalla Turchia, l’influenza musicale turca è praticamente nulla. Comunque un esiguo numero di danze turche sono conosciute anche dai musicisti greci. Oggi l’organico più diffuso per la musica strumentale popolare è il duo, formato da violino e dal liuto. Nelle isole di carattere più conservatore, come Scarpanto, i musicisti suonano ancora il violino tradizionale a tre corde, la lyra, invece dello strumento moderno a quattro corde. In alcuni casi il liuto viene sostituito da una chitarra o dal santouri. La maggior parte dei musicisti è formata da suonatori semi-professionisti, contadini od artigiani dei villaggi. Per loro fare musica vuole dire procurarsi un guadagno extra, e così occasionalmente suonano ai matrimoni o ai “panegyri”, feste locali in onore del patrono del villaggio.
Ancestrali riti di possessione, danze e musiche dionisiache, tra sacro e profano la Grecia è uno straordinario teatro di celebrazioni popolari:
“Due millenni di prediche cristiane non sono valsi a esorcizzare superstizioni e retaggi dell’antica religione: contadini e pastori sono infatti sempre convinti dell’esistenza di un cosmo parallelo, affollato di creature extraumane e in quanto tali pericolose, da ammansire oppure allontanare con complessi rituali. Sicché Zeus continua a dominare le vette sotto le spoglie del profeta Elia, come il predecessore padrone di tuoni e fulmini, ossequiato ovunque vi sia un’altura e quindi una cappella a lui intitolata. Alla fine anche pope e archimandriti hanno dovuto fare buon viso alla trasposizione di dèi ed eroi in un numero esorbitante di santi e sante, ognuno con un suo corteo di adepti e una propria specializzazione, le cui quantità ribadisce lo straordinario ruolo di ponte che la Grecia ha sempre avuto tra il mistico Est e l’Occidente”(25).
La Pasqua è la festa più attesa per antonomasia, una grande settimana di passione, vissuta come un’apoteosi del creato, quando la terra ritorna fertile dopo i rigori invernali, ed è questo il periodo in cui si rispolverano le antiche tradizioni rituali dello spirito della terra e quelle più sacre legate al cristianesimo greco-ortodosso e che poi fu bizantino e cristiano. I riti sono ossequiosi nel rispetto dovuto alla religione fino alla mezzanotte del Grande Sabato, in cui l’atmosfera si fa davvero incandescente, quando, a mezzanotte, il sacerdote spezzato il buio con la luce accesa di una candela, annuncia il Christòs Anésti, ovvero l’Anastasi, la resurrezione. Il dopo è tutta un’esplosione di festa che percorre ogni angolo della Grecia:
“Ovunque i più giovani nell’Arcadia hanno preparato la pira per cremare il pupazzo raffigurante Giuda, che a Monemvassia sembra esplodere sul sagrato la domenica pomeriggio, quando tutti sono satolli dopo aver mangiato l’agnello sacrificale” (26).
Ma se d’altronde come si dice nessuno campa di sola ascesi e penitenza, men che meno i greci, nel cui profondo, accanto al solare Apollo, alberga pur sempre l’orgiastico e tenebroso Dioniso, il quale viene onorato con un oltraggioso carnevale da parte dei “Babogeri”, strafottenti maschere coperte di pelliccie di montone, con campanacci legate intorno al basso ventre. Li rafforzano nelle loro bravate alcuni canti sconci che evocano i phallica delle dionisiache “antesterie”. Del resto, come scriveva il poeta Costantino Kavafis, che: “se anche li abbiamo scacciati dai loro templi, non per questo gli dèi sono morti”.
A parte i canti per la danza esistono pure motivi particolari a ritmo libero. Uno è l’amanés, uno stile di canto di origine turca con elaborate ornamentazioni melodiche. Gli altri sono canti di donne: il lamento “miroloi”, la nina-nanna “nanoùrisma” o ancora canti legati a funzioni strettamente specifiche, come ad esempio il canto accompagnato dalla casseruola di rame detto appunto tapsì. I canti femminili non sono mai accompagnati da strumenti e le donne stesse non suonano mai la lyra o la zampogna o il liuto, né i loro canti si eseguono in pubblico.
È noto che a Rodi sussiste una ricca tradizione di danze e canti di nozze. Tra queste il canto “Piccola Irene” (27) è un tipico esempio di tale tradizione e per lo più si esegue nella seconda parte della cerimonia nuziale, il quarto e il quinto giorno dei festeggiamenti. Questa canzone solitamente si inserisce al centro di un’esecuzione di musica per la danza durante un intervallo degli strumenti:
“Ah,eh,le chiavi del Paradiso
Per la mia piccola Irene
Le tengono gli Apostoli.
Ah, eh lunga vita alla sposa e allo sposo!
Irene, mia sola, tu che sei greca
E voi, tutti voi alla festa
Venite e parliamone
Facciamo diventare questo giorno notte …”.
Dal mio personale diario di viaggio:
E come si addice alla festa non può mancare il brindisi il che, dopo parecchi bicchieri di oùzo bevuti, tutto diventa più leggero (se non si finisce stesi a terra), allora ognuno è libero di cantare quello che vuole. Non manca chi solleva i piedi nella soùsta o nel pentozàlis, e chi a gruppi di due o tre eseguono per proprio conto alcune figurazioni tradizionali. Il tutto accompagnato con abilità dal suonatore di zampogna Emmanouil Hakiàs che (all’epoca) aveva già 72 anni e col quale avevo bevuto insieme e che mi aveva spiegato che, a differenza delle cornamuse scozzesi, la tsamboùna, questo il nome originale greco, era molto primitiva. E così che imparai a conoscere uno strumento antico, certamente più antico di Emmanouil che me lo illustrava e che trovavo fosse davvero concio dall’uso. In breve la tsamboùna è formata da un sacco di pelle bisunta, da una canna per l’immissione dell’aria e da due canne per la melodia, riunite in un unico tubo. Mentre le canne per la melodia e le ance sono in giunco, il tubo è di legno. Le due canne sono tenute insieme con della cera colata all’interno del tubo ed ognuna ha cinque fori per le dita, mancando però quello per il pollice. Il sacco è ricavato da una pelle di capra rivoltata in modo che tenga meglio all’aria che Emma (per brevità) dice essere stata trattata con una mistura di miele e olio d’oliva che ne affretta la stagionatura e l’impermeabilità e che di tanto in tanto viene ripetuta. A parte rare e trascurabili eccezioni, questo tipo di zampogna a doppia canna è diffusa in molte zone del Mediterraneo, si chiama infatti “talum” nel Ponto turco e nel Caucaso occidentale, “mezwìd” in Tunisia e “diple” nel Montenegro e in Dalmazia, mentre in Italia più semplicemente “la capra che suona”.
Dopo il lungo excursus nella musica tradizionale, quella più autentica, ci ritroviamo qui ad affrontare il discorso appena accennato delle interazioni musicali che nel corso dei secoli hanno interessato ogni forma d’arte, non esclusa la musica popolare e tradizionale per la sua costante reiterazione e le influenze reciproche derivate dall’incontro con le altre culture. Che cioè accentua le contaminazioni, ove queste presentino caratteristiche regionali pronunciate, asseconda il linguaggio classico, in senso introspettivo, ove la musica procede per linee interne, svincolata da riferimenti stilistici esplicitamente etnici. Il tutto comunque entro gli ambiti di un linguaggio attuale, contemporaneo.
Così come abbiamo avuto modo di confrontarci con la creatività di Eleni Karaindrou, questa volta affrontiamo una delle personalità della musica mondiale più complesse in assoluto: Vangelis Papathanassiou (28), un artista a tutto tondo formatosi sull’attenta combinazione di suoni presi dalla musica etnica del proprio paese, quella Grecia di cui si è fin qui parlato, e alla quale conoscenza egli ha speso tutta la vita di musicista-compositore-interprete straordinario. Pur tuttavia, prima di tentare una qualsivoglia definizione della musica di Vangelis, si rende necessario non tanto conoscere l’uomo da vicino, per quello in internet c’è un’ampia biografia, quanto avvicinarsi alla sua concezione in fatto di musica. Tutto nasce al Nemo Studio di Londra che Vangelis confidenzialmente chiama “il mio laboratorio”:
“È lì che tento di costruire la musica del nostro tempo, riprodurre suoni, toni, modalità, successioni, effetti spaziali e temporali che poi adopero nel costruire i miei brani musicali. Quello che mi interessa in modo particolare è il rapporto che corre fra l’uomo e la musica, o meglio quegli effetti psichici e psicologici che la musica riflette sul comportamento umano”.
Ha egli detto durante una breve intervista rilasciata prima dello spettacolo avvenuto in illo tempore alle Terme di Caracalla in Roma. Ripercorro qui solo alcune tappe (discografiche) per comprendere al meglio quali materiali etnici ha egli utilizzati e che compongono i suoi brani migliori. Rinato sulle ceneri del successo internazionale ottenuto con gli Aphrodite’s Child con Demis Roussou, dopo lo scioglimento di questi si avvia alla carriera solistica con un album in parte strumentale in parte di canzoni in inglese, dal titolo “Heart” significativo del suo rivolgersi al cuore della Terra, in cui sono contenuti due brani: “Ritual” e “Sunny earth” che dimostrano tutta la forza musicale che entrerà nelle sue composizioni future.
Risale al 1971 un suo primo album sperimentale “Hypothesis” (vedi d.) a cui fanno seguito nel ’75 due colonne sonore per i documentari del francese Frederic Rossif “L’apocalypse des animaux” e “La fête sauvage”, e ancora le musiche per la serie televisiva “Cosmos” inclusa più tardi nell’album “Heaven and Hell” con il quale l’autore spazza via ogni reticenza o riserva possibile sulla natura della sua musica. Se consideriamo gli anni in cui lavora e la tecnologia messa in campo, ci accorgiamo che l’album suddetto è già un’opera compiuta, Vangelis si ripresenta infatti al pubblico della scena internazionale nella doppia veste di musicista-alchimista conoscitore degli oscuri segreti della musica elettronica da cui la capacità di fusione che scaturisce in nuove atmosfere, crea situazioni sonore inusitate prima, in cui nulla rimane di intentato.
La grande capacità creativa di Vangelis rivela fin da subito una profonda conoscenza del panorama etnomusicologico mondiale, i suoni da lui creati o ricreati non hanno talvolta nulla a che fare con la musica che avevamo fino allora ascoltato, si rivolgevano oltre, a un cosmo musicale ignorato o forse davvero sconosciuto che Vangelis catturava per noi. Infatti – come egli stesso ha poi rivelato, essere fondamentale la riscoperta di materiali appartenenti alla tradizione, per affrontare un serio recupero di quel messaggio ancestrale che la musica conteneva in sé:
“Per me la musica non è solo in trattenimento edonistico, ma qualcosa di più. È una forma di vita a sé stante, vecchia di milioni di anni, vecchia come la permanenza dell’uomo sulla terra”.
Ne sono una riprova i bellissimi brani “Dervish D”, ispirata alle danze derviscio della Turchia il cui mistico girare trova la sua realizzazione nella spirale dell’universo; e la lirica “To the Unknown Man”, un inno elevato al mondo sconosciuto dell’uomo, entrambe incluse nell’album “Spiral”.
Ma è un’altra colonna sonora, quella per il film di Francois Reichenbach, in cui Vangelis ripropone un’antica danza greca per bouzouchi che possiamo pensare a un ritorno alle sue origini. Confermato poi dalla produzione di due fantastici album, entrambi del 1987, di canti e melodie greche elaborati per l’occasione sulle sonorità di strumenti autentici e dalla voce di Irene Papas: “Odes” (vedi d.) dai contenuti, musicologicamente parlando, interessanti per la commistione del vecchio e il nuovo proporsi della musica nell’arco dei secoli che separano l’antico e l’attuale, la voce ieratica di Irene qui utilizzata in modo tradizionale e l’avanguardia musicale di Vangelis a dare forma non a un contrasto, bensì a un amalgama intenso di forti emozioni.
Altrettanto dicasi per “Rapsodies” (vedi d.) in cui la mistura elettronica addirittura rivela insieme ai suoni il grande afflato artistico che ha permesso ai due interpreti di stabilire un continuum con la tradizione, qui valorizzata e innalzata alla sua massima espressione canora e musicale. Lo rivelano soprattutto alcuni brani strumentali e canti in essi contenuti: “I rizes” (Le radici), “Miroloi” (Lamento), “Choros tis fotias” (Danza del Fuoco), e “Kolokotronei” (I guerrieri), “Ti ipermacho stratigo” (Al Generale che vince tutte le battaglie) e i brani “Christos anesti” (Cristo è risorto) e “Asma asmaton” (Cantico dei cantici) ripreso dalla tradizione bizantina, semplicemente un capolavoro in versi interpretato da Irene Papas in modo sublime.
L’esperienza di Vangelis non si è ovviamente fermata qui, a cominciare da “China” in cui si è avvalso dell’esperienza musicale dell’oriente e della filosofia Tao, egli è tornato più volte a spingersi nei meandri inconsueti della ricerca a tutto tondo. Noti sono i suoi excursus nella musica bulgara e nella “doina” rumena, nel rock con due album cui ha prestato la voce Jon Anderson, nella musica italiana con Milva ed altri. Ma non è certo questa la sua unica passione (e più vera professione), lo abbiamo spesso visto alle prese di colonne sonore di successo, si ricordi “Blade Runner” di Spilberg, “Chariot of Fire” di Hugh Hudson, premio Oscar per il miglior soundtrack, “1492, discovering of America” e le tante altre, incluso quel “Mythodea” per la Missione Nasa del 2001 titolata Mars Odyssey, con la partecipazione di Kathleen Battle e Jessye Norman, solo per citarne alcune della sua vastissima produzione che lo vede impegnato non nel semplice commento sonoro alle immagini che scorrono, bensì a quella che un tempo si diceva essere la “colonna sonora” capace di creare veri e propri momenti di autentica bellezza musicale.
Qui, nell’economia dei film la musica assume il ruolo che sembrava aver perduto più recentemente in altre pellicole, cioè scandisce il ritmo delle azioni, dei momenti di psicologica tensione, di riflessione e progressiva emozione dei protagonisti, restituendo ad essi quella vivificante bellezza uditiva che asseconda il discorso fotografico, che altrimenti risulterebbe senza emozione, vuoto di sentimento. Considerato il più sensibile e originale creatore di straordinari “impatti musicali” l’uomo Vangelis, pensate, non fa sfoggio di sé e raramente fa la sua apparizione in pubblico. Non si lascia fotografare e non appare neppure sulle copertine dei suoi dischi. Suo malgrado è ancor più oggi, a conferma della sua grande creatività artistica, e dei tantissimi anni passati sulla scena internazionale, Vangelis è un probabile profeta della contemporaneità e della musica del futuro.
E già si affacciano sulla scena della musica greca altri nomi di artisti quotati che meritano il nostro plauso. Padre fondatore del genere rebetiko che, come abbiamo avuto modi di dire, durante il periodo della dittatura, assunse una connotazione di protesta alla quale contribuirono tutti gli artisti e nomi noti della scena greca, troviamo Markos Vamvarakis, mentre di recente ha contribuito al suo revival la “pasionaria” Eleftheria Arvanitaki, affascinante interprete di brani celebri della tradizione greca con particolare riferimento al questa forma di blues ellenico. Tuttavia l’influsso bizantino e ottomano, la vicinanza con la Turchia e persino gli strumenti danno al folklore ellenico un inconfondibile retrogusto orientaleggiante che non è scomparso del tutto nei generi cosiddetti contemporanei, come l’entekhno, rappresentato da da artisti quali Theodorakis e Hatzidakis; e il laiko, tra i cui massimi esponenti troviamo Stelios Kazantzidhis e Akis Pannou. Inoltre Haris Alexiou oggi il personaggio più affascinante ed eclettico della scena ellenica George Dalaras originario del Pireo, considerato un’istituzione nazionale; come bene ha scritto Ivo Franchi: “Un cantante e compositore raffinatissimo che ha saputo creare un efficace trait d’union tra la musica etnica tradizionale e il pop d’autore di qualità”.
Il suono dunque – e mi ripeto – scaturisce immagini che, nel processo graduale di crescita ed esplorazione della realtà, la composizione musicale trasforma in straordinaria visibilità. Tuttavia il processo di comprensione di questa musica da parte di un così vasto pubblico ha avuto una gradualità lentissima e non culturale, forse in parte spontanea e immediata. Perché? - ci si chiede. E la risposta non può che essere tra le più semplici ci si possa aspettare. Benché malgrado sia di gran lunga entrata nelle forme di comunicazione come la pubblicità ecc. ciò non trova corrispondenza nella cultura musicale che solo l’insegnamento scolastico, in sostituzione della tradizione degli anziani detentori, può dare. Così come si insegnano le altre arti ritengo che l’insegnamento delle tradizioni canoro-musicali e perché no anche della danza, vadano insegnate o almeno fatte conoscere, alfine di salvarle da ogni possibile dimenticanza.
Ciò, non perché in questo modo vogliamo conservare un distinguo che sa di razziale, quanto invece di avviare quello scambio culturale più che mai necessario a conoscere meglio la nostra e l’altrui provenienza culturale, avvalerci dello scibile comunitario per l’avanzamento culturale dell’umanità tutta, scopo precipuo di questa ricerca da non considerarsi fine a se stessa, o espressione intellettualistica o celebrativa di una moda che ritorna.
Tantomeno legata a un periodo storico e politico ancora non ben definito come quello in cui ci troviamo, altresì la musica così come la poesia devono ritrovare, insieme o separatamente non importa, il linguaggio delle forze naturali che l’hanno sostenuta fin qui, l’assieme delle emozioni e delle sensazioni che infine è in grado di affermare, seppure in contrasto col macrocosmo sonoro in cui si dibattono. Seppure in contrasto con quanto una volta affermato da Walter Marchetti che: “la musica, macerie di tutte le idee, fa da sfondo a un incendio che non rischiara ancora il mondo”.
Dal diario di viaggio:
Per quanto mi concerne, e poiché, come si dice, non bisogna trascurare il lato ironico delle cose, faccio girare attorno al dito indice, nell’uso greco, il mio komboloi di pietra blu mentre il piroscafo si stacca dal molo del Pireo con il sole che arrossa il tardo pomeriggio: Zorba è là, seduto sulle gambe incrociate che suona il suo santouri. No, a lui non piacciono gli addii, con le note che si propagano nell’aria mi saluta a suo modo, con l’eco del tempo che riporta nel modo antico e nella lingua il verso: “se perimeno” e che vuol dire ti aspetterò, è solo un arrivederci!
Note:
1)2)3) Nikos Kazantzakis - “Zorba il Greco” – Mondadori 19….
4) Marius Schneider – “Il significato della musica” – Rusconi 1979.
5) Augusto Romano – “Musica e psiche” – Bollati Boringhieri 1999.
6) Nikos Kazantzakis, op. cit.
7) cit. in Curt Sachs “Storia della danza” – Il Saggiatore 1985.
8) Curt Sacks, op. cit.
9) Stuart Piggott - “Europa Antica” – Einaudi1976.
10) Omero – “Iliade” - Einaudi …
11) Curt Sacks, “Storia della danza” op. cit.
12) Omero – “Iliade”, op. cit.
13) Curt Sacks “Storia degli strumenti musicali” – Mondadori 1996.
14) Inni Omerici – “A Pan” – Mondadori 1994
15) Ibidem (seconda parte)
16) Pina Bausch (vedi articolo in questo stesso sito).
17) Michalis Christodoulides (le musiche del compositore non sono state a tutt’oggi incise su disco).
18) Wolf Dietrich (vedi discografia)
19) Domna Samiou (vedi d.)
20) Tassos Halkias (vedi d.)
21) Nikos Xilouris (vedi d.)
22) Yannis Markòpoulos (vedi d.)
23) Dionissos Solomos - “Eleftheri Poliorkimeni” (vedi d.)
24) R. Leydi – T. Magrini - “Musica Popolare del Dodecanneso”(vedi d.)
25) Melissa Corbidge – in Meridiani “Grecia” Anno XIV n.101. Editoriale Domus-
26) Ibidem
27) R. Leydi – T. Magrini – op. cit.
28) Vangelis Papathanassiou
Discografia: (essenziale)
Meridiani Musicali – “I suoni di Orfeo” – Editoriale Domus – red edizioni.
Wolf Dietrich – “Musica popolare del Dodecanneso” – Albatros LP - VPA 8295.
Wolf Dietrich – “Musica popolare di Creta” Vol. I – II – Albatros LP – VPA 8397/8.
Domna Samiou – “Souravli” – Emi Columbia 14c 054-70816.
Domna Samiou - “Il flauto greco” – Arion Farn 1051.
Domna Samiou – “Travelling in Greece” – Lyra 1972.
Tassos Chalkias – “Clarino Soloist” – Emi Columbia 14c 054-70823.
Tassos Chalkias – “The sound of the clarinet” – Lyra 3231.
Nikos Xilouris - “Rizitika” – EMI REGAL 14c 034-70335.
Yannis Markopoulous / Nikos Xylouris – «Rizitika » - Emi Columbia 14c 064-70069.
Yannis Markòpoulos - “Pireo” – Emi Columbia 2LP MT 8858.
Yannis Markopoulous / Dionissos Solomos / Irene Papas / Halkias / Xilouris
“Eleftheri Poliorkimeni” – 2LP EMI – 14c 154- 70837/8.
Vangelis O. Papathanassiou – “Earth” – Vertigo - LP PG200 – 6499693.
Vangelis O. Papathanassiou – “Mythodea” – Sony CD – Sk 891891.
Vangelis O. Papathanassiou / Irene Papas – “Odes” – Polygram 1987.
Vangelis O. Papathanassiou / Irene Papas – “Rapsodies” - Polygram 1987.
Impossibile e anche superfluo elencare qui la sterminata discografia di Vangelis mi limito a far presente che in ogni suo disco (CD o LP) è presente almeno un brano, un suono, un’assonanza strumentale, un richiamo alla musica greca o altre contaminazioni come quelle riportate nel testo
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomus. 7: Grecia - seconda parte
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGIA – 7 GRECIA (seconda parte)
“GRECIA: Terra di suoni, di antichi miti, di amori lontani ritrovati” – di Giorgio Mancinelli.
Frammenti di un diario di viaggio:
Dell'intimo mio sogno ricordo i passi d'una allegra danza che un bouzouki stridulo rinnova, che porta alla stagione amica l'oro dell'uve novelle, l'aspro del cedro e dei limoni pregni sotto il cocente sole. E il sopraggiungere di un’eco malinconica che il melodioso suonar di un aulos rimanda, una canzone antica che parla d'un disperato amore, o forse di un inganno e che lieve talvolta si diffonde lungo i pendii e per le valli intorno. E ancor ricordo il maestrale vento, ansante e sospiroso come un lamento, che dagli abissi si leva sopra le cime dei monti e che dà voce ai Cori che della Tragedia antica perseguono gli affanni, e che infine si placa dacché giunto è davanti alle dimore degli avversi dèi. E quell'immenso mare, che a navigar la vela invita, che spumoso s'infrange sulle irte scogliere, dentro gli anfratti, i porti nascosti, sulle spiagge dorate, e bianche e nere delle tante isole sparse, che come Ninfe ora brama e ora insidia. Quel vasto mare caro alla memoria, colmo di passati ricordi, ove la mente vaga e mai s'appaga: che come la vita l'eroe rifugge e che il mortale anela – che della vita ognor porta la vita, dopo la morte.
È quì, che un giorno assai lontano fui di ritorno, a ritrovar qualcosa di me ch'avevo forse dimenticato. E che cos'è, chiede a se stesso l'uomo ritrovato, la riscoperta della Grecia antica? Se non un fuoco che ancor divampa e brucia, se non il riscatto della scontata pena, in cui si erge e placa un'ultima speranza, se non il viaggio di ritorno verso la Grande Madre pria. Cos'è? Se non l'idea vagheggiata d'una giustizia suprema: se non un inno che al sole si leva, quando istantaneo abbaglia. Cos’è se non l'anelito al sublime, che agli dei rimena ciò che all'eterno attaglia . . . ?
Scrive il poeta Dionysios Solomos: (1)
“L'ultima stella del mattino risplendente
ha annunciato l'arrivo del sole su in alto.
Nessuna nebbia od ombra osarono danneggiare
la perfezione pura e semplice del cielo senza nubi
da dove una brezza gentile soffia
carezzando le facce al disotto di esso
come se mormorasse nelle interruzioni del cuore.
La vita è dolce e...
La vita è dolce
la musica va alla deriva nel vento
qualcuno ha toccato i colori e i ritmi
ricordi e sogni
la nostalgia nei bisbigli dell'anima
uniti in un viaggio
verso il domani, verso la luce”.
Ed è sui versi del poeta che mi accingo a riprendere il discorso di questa lunga esperienza musicologica, solo apparentemente trascurato, col presentarvi alcuni grandi musicisti e ricercatori greci di rilevanza internazionale che a fronte di approfonditi studi hanno dato luogo a straordinarie manifestazioni della musica tradizionale di tutta l’area, con l’attivare una ricerca sistematica su basi scientifiche che tocca profondamente la Grecia, riscoperta non soltanto nella sua più facile tradizione “rebetika” (oggi retrocessa a produzione commerciale), ma anche nella sua più pura tradizione demotica. I documenti qui riportati si propongono appunto di dare ampia testimonianza della varietà delle situazioni geografiche, dai monti dell’Epiro alle isole dell’Egeo, nonché delle vicende mitologiche e culturali che hanno segnato gli aspetti differenti che tutt’oggi convivono nell’animo greco. A iniziare da Gregorio Paniagua, monaco spagnolo, fondatore nel 1964, dell'ensemble Atrio Musicae di Madrid, un insieme specializzato in musica antica, greca e romana.
Dopo gli studi di violoncello alla Serra Reale con Don Ricardo Vivó, il giovane Gregorio Paniagua intraprese lo studio del liuto e della viola da gamba con Agosto Wenzinger, nonché la conduzione orchestrale con Sergiu Celibidache; si pensi che il suo esordio come concertista, è avvenuto a soli 15 anni sul palcoscenico del Metropolitan Museum of Art di New York, e lo consacrò definitivamente alla carriera musicale.
Successivamente il suo operato come ricercatore si concentrò soprattutto nella formazione del suo gruppo di strumenti antichi Atrium Musicae de Madrtid e nella incisione ormai famosa: “Musique de la Grèce Antique”(2) del 1978. All’esito positivo di questa incisione, ne seguirono delle altre, tra le quali vanno citate: “Musique Arabo-Andalouse” (vedi disc.) precedentemente registrato nel 1976, nel quale Paniagua scava nel repertorio ispanico-musulmano suscitando nuovo interesse per questo genere musicale della Spagna meridionale; “Villancicos” del 1980; “Tarantule e tarantelle” del 1982; “La Spagna” del 1983 e “La Folia” 1983, autentici gioielli di archeologia della musica, straordinariamente interessanti per la nostra ricerca. Attraverso di essi, oltre a conoscere quelle composizioni più antiche, per lo più smarrite, ci rendiamo partecipi dell’immenso lavoro sostenuto nella ricostruzione di un arsenale culturale musicale tra i meno esplorati e ci rende edotti nell’uso di strumenti antichi andati perduti e da Paniagua recuperati.
È questo certamente l’aspetto più affascinante della produzione cui ha dato vita il gruppo, formato tra l’altro da tre suoi fratelli, Luis, Eduardo e Carlos Paniagua, da Pablo Cano e Maximo Predera. Nei tardi anni settanta fino agli anni ottanta, il gruppo intraprese la serie di incisioni sopra elencata, che ripeterono con successo quanto riportato nei concerti, ed anche se alcuni studiosi di storia greci e spagnoli accusarono i fratelli Panigua di aver esagerato con la brillantezza dei suoni, rimangono le uniche incisioni di un certo livello presenti nel mercato discografico, se non altro le prime e le più originali. La decisione successiva a quegli anni, avvenuta senza dubbio da parte dei fratelli più giovani, presi dall'interesse di carriere soliste, li portò alla dispersione del gruppo.
Gregorio Paniagua inoltre, è considerato l’iniziatore di una nuova stagione della musica antica per l’aver egli mescolato strumenti antichi e moderni insieme ed essere un abile suonatore di sitar indiano e altri strumenti orientali; una delle sue collaborazioni più interessanti fu quella con Rita Marley, moglie del leggendario Bob Marley nel 1995. Luis Paniagua ha stabilito una presenza di successo come compositore e leader di altre ensemble creando progetti per balletti, teatro, e film. Allo stesso modo Eduardo Paniagua nel 1994 diede vita a un nuovo gruppo, Música Antigua, e a un coro, Pneuma, che tutt’oggi sono fondamentali nello sviluppo di molti suoi progetti. Ma leggiamo insieme quello che può essere considerato il testamento musicale del gruppo nella sua prima formazione, così come ce lo descrive il suo fondatore e che rappresenta, per noi, un documento della massima importanza etnologica e musicale dell’antica Grecia: (3)
“Uniti qui per la prima volta sono i rari frammenti di musica giunta fino a noi dalla Grecia Antica. Vi abbiamo aggiunto l'unico frammento musicale che sopravvive della Roma Imperiale, in parte mutuato da un lavoro di Terenzio. È come se nulla fosse andato via dell'Acropoli ma alcuni pezzi sparsi di colonne ed un paio di capitelli rovinati. In effetti, sebbene testimonianze ammirabili della cultura Ellenica sopravvivono nell'architettura e nella letteratura, nulla rimane della sua musica, né dello spettacolo musicale che era una vera istituzione in Grecia, tuttavia questi frammenti sparsi preservati miracolosamente in alcuni papiri, marmi e in altri documenti copiati nei secoli, dal Medio Evo, al Rinascimento all'era Barocca, inclusi in questa incisione, rendono loro l'importanza che meritano, nonostante il fatto che certi musicologi li screditino come apocrifi".
Fortunatamente altri lavori di teoria musicale non soffrirono lo stesso destino, numerosi sono infatti i trattati in greco, latino e arabo che sono sopravvissuti e che mescolati con lo studio di altro materiale furono integrati nelle culture dei popoli che li hanno custoditi come fossero gli eredi testimoniali della cultura Ellenica. Al dunque la musica greca presenta due sistemi di notazione: uno strumentale, comprensivo di 15 segni distinti probabilmente dedotti da un alfabeto arcaico, e l'altro vocale basato sulle 24 lettere dell'alfabeto Ionico. I due tipi di notazione furono usati indiscriminatamente come è supportato fuori dagli Inni Delfici e nell'Ode a Pythian di Pindaro.
Il secondo è dovuto ad Atanasius Kircher che lo studiò, e ne fece una copia nel XVI secolo. In un documento raro, unico nel suo genere, si fa riferimento al ritmo con annesse indicazioni grafiche, è il caso dell'Epitaffio di Seikilos e in altre delle molte iscrizioni raccolte da Bellermann, che noi, con il nostro lavoro di ricercatori, li abbiamo infine districati dai loro testi, tuttavia senza neppure tentare di sezionare un documento archeologico che poteva sembrare freddo e distante, per lo più affidandoci alla natura dell'espressione personale di un sentire assolutamente dispiaciuto di fronte a una perdita così irrimediabile.
"Inoltre, abbiano tentato, e devo dire con successo, di ricostruire alcuni strumenti greci più antichi, come la lira e l’aulos (presente in almeno dieci tipi diversi), per non dire di un organo idraulico, riprodotti da almeno un centinaio di vasi , bassorilievi e dipinti, e da un’ampia varietà di documenti, ridisegnando in certi casi le fasi diverse della vita di essi. Lo studio relativo alla teoria musicale del tutto concernente l'arte musicale greca ci ha infine portati alla conclusione che ripristinare il suo valore intrinseco, non stava nel trattarla come un elemento di archeologia che potrebbe essere ricostituito più o meno fedelmente, ma che noi avremmo dovuto infondere ad essa una nuova vita attraverso il nostro sentire e i nostri propri spiriti. Prima di sondare la prima nota del papiro di Euripide, ad esempio, noi cominciamo il record con un'esplosione sonora che, nella maniera dei "Anakrousis" o preludi, ricreava il silenzio necessario per entrare in contatto con una musica remota e ignota, come del resto era il pezzo che stavamo interpretando.
Solo in seguito abbiamo trattato il problema delle lacune innumerevoli che pure esistevano nei frammenti di papiro e nei pezzi di marmo, e li abbiamo trattati in vari modi: o nel silenzio totale, come l'uso di un cemento neutrale nella restaurazione di un dipinto o una scultura; oppure come se la linea melodica fosse stata congiunta al prossimo frammento, ripristinando, in modo "anti-archeologico" il metodo di ricolorare con una piccola toppa (ma non troppo) il colore, un po’ come si fa per riempire il vuoto con l'immaginazione; altrimenti colmando il vuoto irreparabile con suoni, rumori e corde sconnesse, doloroso e totalmente dissonante, come nel caso del papiro di Oslo. In conclusione, è stato come ripetere un ritmo in un tempo progressivamente accelerato, che ci ha condotti infine all'Epilogo-catastrofe, dell’ultimo brano, mentre riflettevamo sul significato duplice della parola "Katastrophe": tra caos e disastro, come noi usiamo attualmente chiamare “ut”, e che ha una connotazione musicale i.e. e che segna il ritorno ad un punto di equilibrio assiale di una sequenza di lira dopo che ha cessato di vibrare”.
Una delle opere presenti in questa esecuzione risale al 522/466 a.C., la “Prima Ode Pitica” (4) di Pindaro, con la quale si celebra la vittoria nella corsa delle quadrighe ot¬tenuta da Ierone, tiranno di Siracusa, a Delfí nel 470 a.C. . L'ode è stata collocata in testa alla raccolta delle Pitiche nell'edizione alessandrina probabilmente per analogia con le Olimpiche, aperte da un epinicio sempre per Ierone, al quale sono dedicate anche le Pitiche 2 e 3. Alla vittoria del sovrano volle dare la mas¬sima risonanza, anche Bacchilide il quale ricevette l'inca¬rico di comporre un epinicio (Epinicio 4) e un encomio (fr. 20c).
Originate quindi dalla medesima occasione, le tre odi differiscono per dimensione e per contenuto e sembrano aver assolto funzioni complementari, richieste dalla diversa destinazione: il breve epinicio bacchilideo, che si risolve nell'elenco dei numerosi successi agonali di Ierone, fu verosimilmente composto ed eseguito a Delfi nell'immediatezza della vittoria. Mentre la Pitica I venne eseguita a Etna nel corso di una solenne cerimonia pubblica che insieme ai successi militari e agonali di Ierone celebrava la recente fondazione della città e la reggenza del figlio Dinomene, a un'occasione simposiale più ristretta, sempre nella medesima località, sembra fosse destinato l'encomio di Bacchilide.
Con il successo in quella che era considerata, per fasto e spet¬tacolarità, la gara più prestigiosa, Ierone incrementava un numero già considerevole di vittorie nei grandi giochi Panellenici. Il sovrano siracusano aveva vinto due volte ai giochi Pitici nella corsa con il cavallo montato, nel 481 e nel 478 a.C. e nella medesima specialità aveva trionfato due volte anche ai giochi Olimpici, nel 476 e nel 472, in cui la prima vittoria olimpica fu cantata da Pindaro (Olimpica I) e da Bacchilide (Epinicio 5), mentre mancano indizi di carmi composti appositamente per le altre vittorie.
Leggiamone alcuni brani insieme:
(inserire la Prima Ode Pitica). (*)
Come si è detto, e la tradizione vuole, che le manifestazioni festivaliere che accompagnavano i Giochi Olimpici fin dal loro inizio nel 776 a.C. e di conseguenza anche tutti gli altri, tra i quali vanno citati gli Istmici, risalenti al 586 a.C.; i Nemei al 573 a.C., e appunto i Pitici, risalenti al 581 a.C. Per l’occasione, e la cosa è stata mantenuta fino ai nostri giorni, si dava luogo a competizioni canore e musicali di grande rilievo culturale per essere crogiuolo di tradizioni e usanze di forme arcaiche trasmesse oralmente (forme e modalità di canto), e insegnate da padre in figlio (danze e strumentazione musicale), che offrono al tempo stesso un profilo di grande creatività e virtuosismo.
Agli aedi era lasciato il compito di addestrare i giovani Cori ai quali erano affidati i canti riferiti alle vicende mitiche degli dei, e che servivano a onorare il dio preposto ai Giochi. La vicenda mitica versificata, raccoglieva in sé tutte le forme innodiche in uso: dalla lode a scopo votivo, all'inno vero e proprio usato come preludio, al canto epico; dall'imeneo, sorta di nenia di accompagnamento alla gestualità rituale, al peana canoro che conteneva la supplica al dio, al ditirambo in lode, solitamente dedicato a Dioniso, e con il quale si chiudeva festosamente la sacralità dei Giochi. La ripetizione rituale degli avvenimenti storici che in qualche modo avevano dato lustro alla stirpe regnante e alla dignità patria, dava allo svolgimento dei Giochi un'alta valenza drammatica, poiché drammatica era l'essenza mitica in essi evocata, che di per sé, raggiungeva la compiutezza d'una vera e propria forma di rappresentazione, non già ed esclusivamente immaginata attraverso il canto dei poeti, bensì, resa visiva dall'azione processionale e coreutica di quanti vi prendevano parte.
La particolare occasione dell'agone pitica permetteva inoltre ai poeti invitati, di cimentarsi nel repertorio più legato al dio, come nel caso dell'Oracolo di Apollo a Delfi, nel cui vaticinio sacerdotale, si voleva, il dio deponesse la sua saggezza divina. L'ufficialità dei Giochi, concepiti come strumento di addottrinamento culturale e insieme repertorio di comportamenti esemplari, inoltre, imponeva il rispetto della testimonianza storica e la trasmissione fedele dei miti più antichi, contribuendo all'educazione delle classi subalterne e alla loro integrazione sociale. Di pari passo con lo scopo di indottrinamento delle masse in tutto ciò che contemplava il bello e il giusto, i Giochi servivano soprattutto a inculcare e consolidare la supremazia ufficiale, nel rispetto e nel timore dei Sacri Numi, che una stretta analogia accomunava all'iniziazione suprema:
". . celebrerò la Notte, madre degli dei e
degli uomini. .
e la Notte, origine di tutto.
Ascolta, o dea beata. .
che nella notte conduci i tuoi brillanti cavalli,
o incompiuta, che sei terrena e pur anche
celeste e danzando di nuovo ritorni alle
tue aeree sedi
tu mandi sotterra la luce e risplendi
a fuggire dall'Ade, ché la terribile necessità
tutto governa.
Ora, o Notte beata e felice, da tutti bramata,
o generosa, che dalle nostre preghiere
il sonno supplice ascolti,
benevola vieni e i nostri terrori allontana”. (5)
Il luogo, Delfi (racconto di viaggio):
". . Musa, lascia le guerre e canta tu con me le nozze degli dei,
canta i conviti degli uomini, le feste dei beati" (6)
La prima volta sulla strada per Delfi, e il ricordo ancora oggi mi accompagna, fui colto da una folata odorosa di fragranze e dal levarsi di un richiamo che subitaneo mi condusse nel pieno dello svolgersi di un rito: una prima voce, poi un'altra e un'altra ancora, fino a dar forma a un coro, la cui alternanza raggiungeva una drammaticità arcana e tesa, di segreta memoria, che un intimo rapporto con l'immaginario riconduceva al presente – quasi che reminiscenze di un tempo trascorso, rendessero compiuto il tempo del mio ritorno, trasfigurato entro la realtà del momento. I tori, asserviti al giogo ornato di fiori per l'occasione, tracciavano un ampio cerchio nella terra, entro il quale, i contadini del luogo, tenendosi per mano, eseguivano una danza di origine lontana, che si riallacciava, oltre che compositamente anche empaticamente, ai riti agresti del sopraggiungere delle stagioni. Uno di loro, forse un capo designato, affondate le mani nella nuda terra, prese a rivoltarla, e come il vomere prese a frantumarla, poi la sollevò ed a manciate la disperse al vento, una, due, tre volte.
Il sole, giunto al tramonto in quel momento, arrossava quella polvere come la fiamma che divampa improvvisa, il che – dissero – preannunciava il sopraggiungere epifanico del mito. E nel rimescolio di quelle polverose danze e umane fatiche, di orazioni e di canti, la terra riaffermava la propria identità trascorsa, entro una metafora che sostituiva all'evento una sorta di rappresentazione enfatica, tuttavia compiuta entro l'illusorietà del tempo. Al ricordo, un lontano presentimento ancor oggi mi coglie, come un qualcosa che preme contro le pareti del vissuto – quasi che l'anima antica, risvegliata per non so quale esigenza, sopraggiunga ad affermare il presente astratto d'un sogno che s'avvera.
Ancora oggi, sospesa sopra il folto bosco degli ulivi che dalla piana si spinge fino al monte, Delfi mi appare di lontano, immersa nelle nebbie del mattino, nel pieno dominio del paesaggio sottostante, immobile e trapassata sotto l'etereo cielo – un sovrapporsi di terrazze aeree che si staccano dalla roccia come aste di giavellotto lanciate da un possente Iddio, proprio lì, dove la montagna alta si leva, brumosa e superba, e l'occhio s’arresta timoroso prima di giungere alla meta. . .
". . lì, dove le vette del Parnaso senza via, luminose accolgono
il disco del giorno ai mortali". (7)
Ai canti d'invocazione intonati al suono degli strumenti tradizionali, facevano seguito le danze, eseguite a scopo celebrativo e processionale all'interno del tèmènos, il primitivo recinto sacro dedicato al dio, e in seguito svolte intorno all'ara nel tempio. Non si conosce con assoluta certezza quale danza, fra le molte che scandivano l'alternanza dei Cori, fosse quella più in uso, sebbene si sia pensato al syrtòs, per la diversificazione ritmica e le figurazioni "in cerchio", che appaiono spesso rappresentate nell’iconografia classica. Si pensa che potrebbe essere quella stessa danza che, in epoca più tarda, fu poi eseguita attorno al thymele, l'ara eretta al centro dell'orchestra, nel complesso architettonico del theatron, considerato un momento di pura elevazione spirituale, che permetteva all'animo umano di ricondursi alla sua origine arcaica, all'aria e al volo degli uccelli. I Giochi Delfici, si svolgevano secondo un rituale specifico che li legava alla sacralità del luogo, e trovavano il proprio culmine nel vaticinio della Pizia, la riconosciuta sacerdotessa di Apollo . . .
". . la Donna di Delfi siede al tripode santo colei ch'è profetessa,
e nel suo alto canto sono le voci del dio" (8)
Lo spettro silente della Pizia sembra aggirarsi talvolta sopra i ruderi arsi, come una gorgone che ostenta dall'alto d'un architrave solenne e austero il suo sguardo ostile, che nulla ormai possiede del carattere d'un tempo, ma che, come un tempo, sembra reggere le sorti degli uomini, in nome del dio Apollo dispensatore di vita, colui che nella morte infine ha la sua iniziazione suprema. Il mio sguardo vaga disorientato fra le architetture abbattute, sulle pietre sconnesse, in cerca di quel mitico afflato che fece di Delfi uno degli oracoli più frequentati dell'antichità. E come per un possesso ambito, mi scopro ad attingere nella concretezza del suo glorioso passato, quella sacralità obliata che lo restituisce integro all’eternità.
Ed ecco, in codesto presente artato e nel fulcro del loro splendore, sfilano davanti a me, uno dopo l'altro, i Thesauroi in cui erano custodite le offerte recate dalle ambascerie delle città greche in visita al santuario, ricolmi di rostri di navi e trofei d'armi tolti ai vinti, statue in marmo e bronzo, sculture votive e oggetti di culto; gli edifici templari ornati di belle metope, che un tempo costeggiavano la Via Sacra, la Tholos arcaica e l'antro roccioso che la tradizione attribuisce all'antico oracolo di Gea. Ecco la Marmarià, luogo dove i pellegrini diretti al Tempio assolvevano all'atto di purificazione necessaria; il Ginnasio, in cui si allenavano gli atleti prima delle gare ginniche; l'Ippodromo, per le sfilate e le corse dei carri; lo Stadio, in cui si svolgeva l'agone atletica; il Bouleuterion per le riunioni consigliari; e, più in alto, una volta superato l'ultimo terrazzamento, i resti della Tholos dedicata ad Athena Pronaia, un raffinato esempio dell'arte ellenistica; e il monumentale Theatron, vanto della città antica, in cui avevano luogo le rappresentazioni drammatiche e le gare musicali . . .
“. . Ora voi (..) andate alle correnti argentee di Castalia, innovatevi come di pura
rugiada, poi ancora, incamminatevi al Tempio”.(9)
Nulla ormai resta del grande Tempio dorico periptero costruito in bianco marmo di Paros, un tempo fulcro della magnificenza e della potenza divine di Apollo. Solo alcuni gradoni, sgretolati ed arsi, salgono oggi verso l'aperto cielo, che la luce azzurrata dell'alba, fredda entro l'entità obliata, allontanano il guardo dall'opprimente squilibrio d'ogni architettonica misura . . .
“. . guarda, là sulle mura di pietra
la lotta confusa dei Giganti.
Eracle tronca il mostro di lerna
con una falce d'oro!. .
Iolao con lo scudo vince altre prove.
. . e il cavaliere dal cavallo alato
che tronca la forza della Chimera
che respira fuoco.
. . la scorgi, che vibra su Encelado
lo scudo con la faccia di Gorgone.
E' Pallade.
E poi? Il fulmine fiammeggiante
fortissimo, nella mano di Zeus
che colpisce lontano.
. . e col fuoco Mimante mortale
muta in cenere. .
E Dioniso, creatura della terra
che uccide un altro Gigante col tirso
d'edera, segno di duratura pace”. (10)
Talvolta uno splendore opaco, di pietrosa memoria, illumina il sacro luogo, quasi che la volontà suprema del dio, occulti la magnificenza del Tempio allo sguardo profano, e come una sorta di mistica riverenza e di timore, prende, di fronte alla presenza percettibile del sacro. Il cui afflato, adduce alla caducità umana una qualche possibilità di riscatto, per la quale, forse, diviene lecito credere, o almeno sperare. Ma una indubbia fatuità conduce l'umano anelito entro un unico e fallace destino, accettato come dato dall'esperienza della vita, e che solo la sublimazione della morte rende più prossimo all'eternità . . .
". . rispetto a tutte le altre, una sola cosa preferiscono i migliori;
la gloria eterna rispetto alle cose caduche” (11)
Che tutto ciò sconfini nel supremo raggiungimento d'una possibile eternità, non è dato sapere. Ma, per una sorta di illusione in cui mi conduco, credo che la negazione dell'idea della morte come atto conclusivo dell'esistenza, porti a una più ampia estensione della vita, o quantomeno, s'avvicini all'umana concezione dell'immortalità – quasi che per un rovesciamento di valori, la vita acquisti la sostanza mitica dell'eterno. .
". . per natura la nostra anima viene come
esaltata dal vero sublime, e nel toccare
un'entusiasmante altezza si riempie
di gioia e di orgoglio, come se lei stessa
avesse generato ciò che ha concepito” (12)
Ma dall'oscuro viluppo delle illusioni e delle analogie affiorano, senza retoriche declamazioni, quelle che sono le reali necessità umane, la nostalgia d'una purezza interiore, il riscatto dalle impurità della vita, e non in ultimo, il desiderio di dare un senso al ritmo impetuoso dell'esistenza:
"Non vi è senso alcuno già consegnato nel cosmo, possiamo solo industriarci a inventarlo, provvisoriamente (..) poiché senza senso, non si dà esistenza". (13)
E se ciò non fosse che un miserevole inganno? Se avere accesso all'eterno significasse soltanto rinunciare infine alla propria vita terrena? Come sopprimere quel che è dato d'essere in vita e soggiacere paghi all'annientamento della morte? Queste e altre domande s'affollano ancor oggi improvvise nella mia mente, tesa nel momento di affrontare l’oracolo, senza tuttavia aspettarmi alcuna risposta. E al dunque, tutto finisce per sembrare un futile gioco di parole, e più che il sacro transito del vissuto – come momento del destino individuale che supera di per sé i confini della vita e va oltre la vita stessa. No, l'esasperato passaggio attraverso la morte non sembra bastare a ricondurre la precarietà dell'esistenza umana alla purezza onirica della memoria ancestrale.
Tuttavia, è proprio la morte, quella aulica e mitologizzata dell'eroe a consegnare la vita a un al di là aureo e raggiante, in cui si configura la memoria cultuale e filosofica della civiltà greca, con la quale costantemente tutta l'umanità si confronta. Ed è proprio lì, in quel suo anelito all'immortalità, così emotivamente sentito, che si pone l'eterna ragione del contendere fra l’uomo e la divinità. Ma mentre da un lato scopriamo la valenza edonistica della concezione umana, dall'altro, mai ci abbandona la consapevolezza dell'ineluttabilità della fine. E quale che sia la domanda, la risposta si protrae dal profondo sconforto di un'attesa intristita dall'inevitabile:
Allora la "posizione dell'uomo oscilla, pare fragile cosa rispetto alla forza divina; (..) a volte pare invece ch'egli abbia una sua energia di decisione, per cui devia dalla retta strada e si costruisce da sé il male" (14), nel quale infine si ritrova coinvolto.
Cos'è dunque la vita? Mi chiedo, se non transito, prepotenza, sbaraglio, desolazione, paura, sofferenza, balzo nel vuoto, precipizio, schianto, agonizzo, orrore, se non corsa affannosa verso l'ignoto, verso l'invisibile astratto? Cos'è mai la morte? Se non azione, godimento, viaggio estremo, sacro anelito, urlo trionfante, luce assoluta d'un tutto sfolgorante. Cos'è al dunque la morte, se non il culmine dell'esperienza, spogliata dalle cose sensibili, che diventa interiore e che più s'avvicina all'indicibile idea del divino? Cos'è? Se non un ultimo esultante anelito che si fa supplica, preghiera, certezza di legalità, di giustizia, speranza di pace:
"… che pone le sue radici nei sentimenti di inquietudine e di orrore dell'infinito; che prende le sue mosse da quel senso di misto sgomento e piacere determinato dall'assolutamente grande e da ciò che suscita nell'uomo il senso della sua fragilità". (15)
Ma l'Oracolo resta muto alla mia interrogazione, al sorgere in me spontaneo della preghiera, a formulare una domanda che non trova risposta alcuna. Quantunque, una risposta mi sia già stata data, la più semplice e la più emblematica di tutte, e che scolpita nella dura pietra stanzia ancor oggi nell'aria come un epitaffio, per sempre rivolta al visitatore di ieri e a quello di domani: "Conosci te stesso, evita l'eccesso”. Una strana sensazione di stasi trattiene la mente dell’adepto in un desiderio di luce che un sacro anelito riconduce all'eterno. Ed è come se una potenza astratta, volta a stabilire un qualche ordine supremo, si frapponga fra quelle arcane parole – quasi che la loro essenza, tesa a stabilire un sostanziale dominio delle parti, tenti di contendere all'umano ciò ch'è solo del capriccio degli dei.
Mi chiedo quale forza occulta osteggi talvolta l'esile volontà umana? Quale oscuro disegno affranca il geniale edificio della tirannide divina? Se non la segreta speranza d'una imprescindibile superiore giustizia. Non so. Forse non arriverò mai a conoscere, a quale fonte attinga l'esperienza umana, quando facendo leva sulla propria sovrabbondanza di senso, si libera dalle forze ambigue e incontrollabili del fato. A quale occulto potere essa s'appella, quando nell'affermare la propria capacità d'astrazione, finisce per dar consenso alla divina Nèmèsis, tutrice e conservatrice dell'ordine e dell'equilibrio dell'universo intero, la cui potenza restituisce a ognuno l'illusione effimera del destino? . . .
"Invoco il celeste Nomos, santo signore degli
immortali e dei mortali,
rettore degli astri, giusto sigillo
dell'equoreo mare e della terra,
che in eterno conserva il saldo sostegno
della natura
con irrevocabili leggi con cui dall'alto
sostiene l'immenso cielo e avanza
e l'impotente invidia via come un soffio
disperde;
che anche ai mortali assegna il nobile fine
della vita, poiché egli solo ha in pugno il
governo degli esseri viventi" (16)
Quale che sia, il potere intrinseco della divina Nèmèsis, poco o nulla aggiunge al mistero che avvolge il sacro istituto dell'esistenza. Eppure, la consapevolezza di ciò, è più che mai coinvolgente, mi cattura emotivamente, e non posso fare a meno di appellarmi al divino custode, e chiedere al Dio dell'Oracolo di svelarmi la struttura emotiva dei miei dubbi, la natura delle mie incertezze, la perseguibilità della mia avventura umana. Ma all'insondabile interrogazione, manca forse la condizione di smarrimento che accompagna l'evento emozionale del sacro; quel qualcosa di estremamente umano che sempre emerge dalle profondità della psiche e che trova accesso nel vuoto onirico dell'inconscio, quel desiderio di luce che pure risplende dell'aura luminosissima del sublime. E se lontana è in me la capacità di un corretto pregare, nulla o quasi è la possibilità di avvicinarmi sottomesso alla sacralità degli antichi altari:
"È solo sogno il disincanto, e chimere le sue attese:" (17).
Neppure la sottintesa promessa di fare offerte votive, mi dà diritto a una qualche risposta. Non posso che ammettere il mio disconoscere la purezza che s'impone all'orante, il modo di rendere vigorosa la mia preghiera, né la mia adesione al culto mi suggerisce oggi il modo di dar valore al rito che s'impone . . .
"Il rito, santo in sé, può farsi empio se impura è la volontà che lo detta" (18)
La mia riflessione sulle qualità del sacro, sulla sua potenza, sulla sua unicità, fa della mia preghiera un'indagine non consentita, e infine ogni mia domanda ruota attorno a qualcosa che forse non mi è dato sapere. Che senso ha, mi chiedo, la mia ostinazione di voler scrutare l'impossibile? Il continuo volermi spingere nella ricerca di qualcosa che mai conseguo, ma che pure sento di dover cercare? Il sacro Oracolo tace, la sua voce è riposta nei meandri di un passato occulto che lo rende incapace di promulgare concessione alcuna, ne di amministrare gli altrui interessi, poiché esente ormai da ogni dovere di sovranità.
Al dunque: "il destino dell'uomo è di meteora accesa, astro esploso in cielo, a cui si fissano, quasi per culto, gli sguardi di tutti (..) e il disincanto costituisce la risposta alla millenaria domanda sul senso"; così che, l'esistenza risulta essere quasi “apprendistato di morte", e solo "chi ha raggiunto la chiarezza solare della verità; la condizione della purezza, dopo il passo, che non è più varco da esorcizzare, ma scioglimento da attendere con fiducia e amore" può "vivere la morte come liberazione estrema." (19)
È forse in questo la nostra umana inesprimibile inferiorità:
"… che non sappiamo il senso della nostra vita. E non possiamo saperlo. Ma che dobbiamo inventarlo, se ne siamo capaci." (20)
Quel senso "altro" e "supremo", che fa da ponte tra la nostra piccola vita e la "vita" più grande che si spinge al di sopra di noi tutti, e che dà valore al nostro operato. Quel senso che ci restituisce, nella consapevolezza dell’umana grandezza, la certezza della nostra esistenza . . .
"O Natura, madre divina di tutte le cose
industre genitrice. . fine infinito gioiosa e infinita
che l'aere proteggi e la terra e il vasto mare,
dell'universo provvida regina,
che generosa nutri e poi dissolvi i maturati
frutti, di tutte le cose. . nutrice ed alimento
artefice perfetta, plasmatrice feconda, augusto
nume, che in eterno produci movimento,
e con giro incessante il mobile flutto incalzi,
tu che tutto ti effondi, ciclica, e mutando forme
ti rinnovi,
o fra i numi superni nume supremo e rombante,
o intrepida sovrana del mondo, immutabile Fato,
o fiammeggiante, vita immortale,
o provvidenza eterna, tu sei tutte le cose,
ché tu sola tutte le cose produci:
ti prego, o dea: nelle felici stagioni
portaci la pace. .” (21)
Così, come mi chiedo la vita cos'è? – “Se non una maschera arcana scaturita da chissà quale abisso della mente che si ripropone come metafora d'un immaginario lontano, fatto di paura e di morte, che proprio nel momento in cui si annulla, fa ritorno al presente e si unisce al principio della vita che continua, substrato entro il quale si sgretola e si dissolve ogni sua forma mortale”. (22)
Cos’è, dunque, se non maschera iniziatica, simbolo della vita che si attua attraverso l'interpretazione luminosa dell'eterno, ma in cui si compie una sorta di deplorevole inganno – quasi che fosse una maschera tragica lasciata cadere nel mezzo dello svolgersi d'un dramma, entro il quale si celebra dell'eroe, libero per un istante dalla suprema concezione annientatrice della morte, la suprema vittoria . . .
“. . . che solo agli dei ed agli eroi del mito l'eterno afflato s'adduce”.
E già l'immediata successione dei pensieri si rivela, al dunque, carica di energie vitali, la cui connessione col reale, attribuibile al presente immaginario del mio vivere nel sogno, diviene in me coscienza dell'inconscio, si fa azione di un dramma personale visualizzato all'interno di un possibile inconscio collettivo che, visto in divenire, si rivela enigma irrisolto d'un passato ormai perduto, entro cui mi osservo, attore e spettatore d'un qualche evento mitico, partecipe ed estraneo al tempo stesso, della tragedia in cui si riversa il mondo. Quasi agiscano in me innumerevoli altri personaggi che entrano ed escono di scena senza prerogativa alcuna, se non quella di condursi all'inevitabile conclusione del dramma, liberi, per un istante, dalle rigide trame di un copione che li costringe nella condizione annientatrice della fine, in un susseguirsi rutilante d'intenti, per dare un'ulteriore prova di sé, nel tentativo di riappropriarsi dei desideri nascosti, delle segrete ambizioni, e dar vita così a quel gioco che si vuol dire teatro: quella catarsi in cui l'anima libera spesso s'invola, e nell'adempimento della quale, infine si bea …
Ma più profondamente penetro la materia dei miei pensieri e più persistente si fa in me l'idea d'una qualche connessione fra due elementi cognitivi: l'immaginazione mitica, percezione di un'esigenza antropologica; e la mente estatica, stadio emozionale di un'enfatizzazione individuale. Connessione che rivela, pur nella sua duplicità cognitiva, la molteplicità insita nell'esistenza stessa quale momento individualizzante dell'archetipo che è all'origine dell'esistenza manifesta. Risultato di un segreto rapporto intercorso dall'esistenza in sé, e per il suo divenire, nella cui dinamica si evince sempre più l'enfatizzazione di un effimero individuale imperscrutabile, e tuttavia irrisolto all'origine, proiettato verso la realizzazione di una compiutezza formale, nella molteplicità degli aspetti a esso connessi, e nelle innumerevoli facce segrete, proprie dell'essere e dell'esistere. Quand'ecco, un ultimo innocente anelito, sopraggiunto inavvertitamente dentro una folata di vento improvvisa, mi restituisce ignaro al presente, entro la calma estrema d'un tempo infinito, con il quale, a misurarmi, ben misera cosa mi sento, eppur grande. Ed ebbro, al dunque, d'una comprensione nuova, m'avvio silenzioso sulla strada del ritorno, e da lontano volgo lo sguardo a Delfi, sospesa nel vagar d'un sogno che scompare.
Altro luogo, Micene: (racconto di viaggio)
“Mi sono svegliato con questa
testa di marmo tra le mani e non so dove posarla”: (canta Giorgio Seferis)
La tomba a tholòs quasi si disconosce immersa com'è nel paesaggio, coperta di secche sterpaglie e qualche insolito fiore di campo. Un solco netto nella terra e le pietre verticalmente esposte formano l'entrata: una barriera invisibile che s'oppone al passo con un brusco arresto della luce, che si posa, per un ultimo istante sulla soglia, oltre la quale, il buio, il baratro. Come una cecità che improvvisa colpisce agli occhi chi entra, ché, nel ricordo e nel rammarico di essa, s'arresta, in bilico a poter cadere nel vuoto. Filigrane d'argento e d'oro, come bave di ragni ascosi, tengono i blocchi di pietra, sporgenza sopra sporgenza, a formare gli anelli concentrici della volta, che espandono lo spazio, sì, da farlo sembrare un emisfero in moto che ruota vorticosamente, sottratto all'incessante mutare della luce, per rivendicare al buio l'utopia di ciò ch'è per sempre. Nel pietroso spazio della tomba una cieca presenza s'aggira, e lo sguardo vaga in cerca d'un ombra, o forse di un'anima che in sé prenda forma, per identificarsi col vissuto. Come di una potenza ignara che si manifesta al compimento d'una vicenda che si colora della luce empirica del mito, corpo, nel corpo stesso del buio, quasi parvenza dell'oscura vaghezza che si leva precaria entro la realtà vana . . .
______epos
Micene tutta, restava muta, come lo è ora, chiusa nel cerchio di pietra delle sue possenti mura. Sconvolta e inorridita, davanti al fatto di sangue che avrebbe segnato la sua rovinosa caduta. S'apprestava a celebrare, senza sfarzo, le esequie del proprio re Agamennone di ritorno da Ilio con la vittoria in pugno. Vivo e tenace nel suo giungere lieto. Sfigurato e trafitto sul suo letto di morte. Non in battaglia ucciso, ma per mano di Clitennestra, sua sposa e madre dei suoi figli, che aveva diviso con lui il regale talamo di Atreo. Il rito funebre, celebrato davanti alla folla attonita, avvolta nei lugubri panni, si svolgeva in un giorno sferzato dal vento, e grida e lamenti striavano il plumbeo cielo. Colonne di fumo si levavano dai bracieri accesi, e il mirto e l'incenso bruciati, appesantivano l'aria d’un acre inesprimibile odore di morte. . .
Agl’inni invocanti gli dei di placare l'ombra vagante dell'ucciso, affinché fosse accolta nell'Ade, si aggiunse il compianto dei figli e degli amici, e di quanti avevano combattuto al suo fianco. Quando, atterrita, al di sopra di tutti, si levò la voce delle donne in accorato pianto: “Ecco colui che torna, quel poderoso Atreo, acclamato e tenace, che gli Atridi condusse alla vittoria”; colui che or dunque giace sotto il cumulo delle macerie, dei massi sconnessi, delle porte abbattute. Il cui inquieto silenzio fa riaffiorare all'evidenza del presente, la mostruosità d'un perpetrato inganno: Agamennone!
Alla stregua d’un cadavere violato, sconvolto dalla mano sacrilega che ne ha turbato il sonno, carico delle ferite che ancora sanguinano del sangue versato, Agamennone avanza con la spada in pugno, lentamente, attraverso l'oscurità della tomba. I suoi occhi sembrano fuoco che splende dietro la maschera d'oro che gli ricopre il viso. .
"A imitazione del re scarnificato, donne e
guerrieri e sacerdoti (..) si levano dalle
lontane tombe e vengono a lui incontro (..);
hanno immutabili visi d'argento, di ferro,
di rame, di legno, di stoffa; la fiamma rosea e porpora
che irraggia dalla bronzea grata (..) del braciere
acceso, fa brillare le maschere dei volti (..)
e solo la maschera d'oro del re è maestosa,
e veramente regale". (23)
Improvviso, s'ode un calpestio di piedi, un fragore di spade; qualcuno grida nelle segrete stanze ricche a oltranza d'agili scarabei. Poi, tutto tace, e come per l'addensarsi d'una ambiguità palpabile, s'accende di tonalità drammatiche la finzione della messinscena . .
_______parodos
Funesto presagio, quando Borèa sferzante e impetuoso ammassa le nubi nel cielo e le sospinge, le aggroviglia, le dipana; quando solleva le navi nel golfo e le scuote, e le sbatte con violenza contro la scogliera. Acciò, la sconfitta dopo la vittoria, lo scoramento che segue alla pena, al prevalere precario che spetta all'eroe dall'oltraggiosa morte che all'Antica Madre rimena. Or dunque, una tragica sorte t'aspetta o Micene, il pianto dei tuoi figli e il tumulto delle anime in pena: ché il sangue versato non altri germogli a te condurrà, ma ortica e gramigna, sulle tue terre spoglie. Che già s'ode un fragore di legni alla deriva, e il frastuono delle tue poderose mura. Ieratiche nell'ombra si stagliano le figure delle Coefore pronte ad agitar le mani, e degli umani il biasimo annunciano per quegli eroi che degli dei or hanno il favore inviso . . .
______stasimo I
". . Tale non fu quel prode dall'altero petto
di cui narraron i padri. . .
Mai non ebbe a dolersi del suo coraggio
asprigno Pallade Atena, quando in prima fila
s'agitava fra mischie di guerra cruenta sotto
i pungenti strali dei nemici.
Di lui non vi fu mai soldato più valente
ad agire nel vivo della lotta, fino a che
visse nell'abbaglio celere del sole” (24)
Egli dunque s'avanza, protagonista e sovrano, entro le spoglie austere, ma un segreto tormento lo insidia, il timore ispido e incessante: di dover perdere davanti all'ipostasi suprema, la sua ineludibile finitezza d'uomo – “Un peccato d'orgoglio nel tentativo di sottrarsi al proprio destino, di impadronirsene e produrlo (..) all'unico esperibile Tutto che è la propria vita individuale, l'esistenza concreta e irripetibile che a ciascuno è data nella incerta durata di una certa finitezza" (25); "quella promessa di autentica libertà e di potere, che avrebbe consegnato alla storia l'eco della sua umana avventura" (26) . . .
". . Poiché la libertà è capace di nutrire
il pensiero di chi ha un animo grande,
e di dare speranze, e insieme, di suscitare l'ardore
di una reciproca contesa, e l'ambizione
per il primato" (27)
Ma Agamennone non chiede di tornare a vivere. Una siffatta richiesta sarebbe vile per un eroe. Avvolto nella tenebra egli rivela una doppia natura: due aspetti contrastanti di un medesimo sé, segreto a quell’io che talvolta s'infiamma e grida dal profondo. Oscuro all’essere che cela, dietro l'apparente mutismo d'una maschera, i limiti della propria condizione umana:
"In virtù della quale egli rinuncia alla sua identità più propria, e al disagio della finitezza che l'accompagna, nell'illusione di poter accedere all'onnipotenza divina, integrandosi e annullandosi nel genere, sanzionandosi come mera replica di una presunta essenza umana" (28)... "..non tutti gli uomini hanno la consapevolezza innata di ciò che è giusto”. (29)
Una sorta d'orgoglioso sgomento traspare dai suoi occhi socchiusi, il cui inesorabile sguardo, vuoto nella terribile fissità dell'oro, conduce al di là d'ogni umano intendimento, oltre il quale, la verità degli uomini non ha più ragione d'essere. La sua maschera d’oro si leva in splendida solitudine al di sopra d'ogni altra, su tutte le altre, configurazione di un io idealizzato, imprigionato dentro l'essenza stessa della morte, sublimazione e trasfigurazione d'una dannazione eterna, o forse, dell'estasi divina.
Sotto la maschera regale, riflesso dorato di quell'essere impetuoso che mai si è arreso alla divina sorte, si cela un volto sfigurato, che si raccapriccia all'idea di dover "considerare l'incomprensibile, la mancanza di senso, come condizione preliminare di tutto ciò che può avere valore" (30) e "in cui ciascuno attinge valore in sé, invece di scoprirsi irrimediabilmente gettato in un ruolo che vale come destino naturale, come articolazione organica di una cosmica volontà fisica". (31)
Sì, egli s'avanza, nella recuperata memoria del presente dentro la morte, come un'ombra senza sembiante, che non un vero castigo opprime, ma a cui, la mancanza di una vera fede toglie il conforto d'ogni possibile speranza. Agamennone:
Sì beffarda è la notte, quando chetati gli spiriti inquieti, s'affacciano le ombre dei vissuti a reclamare il bronzo del riscatto. Perché, mi chiedo, di questa morte oltraggiosa, che non reca vanto ad alcuno? Perché sì tanta crudeltà e il dispregio degli dei, per questo figlio d'Atreo che ad essi non rifiutò il sacrificio estremo? Di chi, per voler loro, condusse la propria spada in Ilio? Perché? Perché di sì orrendo delitto s'è macchiata la mano di Clitennestra? Oh! quali e inquietanti istanze affollano i miei pensieri, quanti angosciosi perché, premono alla mia mente, quale sorta di rabbia mi logora dentro e mi spinge all'astio, alla vendetta estrema”.
E già la parola accresce il suo furore, l'incita alla vendetta, e un brivido percorre la sua mano . . .
_______stasimo II
Di che ti lagni Tu, che ingiustamente uccidesti Tantalo, e che il suo giovane figlio strappasti dalle braccia di colei che poi prendesti in sposa? Di lui t’insegue la maledizione estrema, che mai lavò il subìto affronto. Tu, che d'Artemide l'ira placasti con l'immolare la tua diletta figlia Ifigenia, sappi che il sangue dei propri figli giammai può essere lavato. Tu, che coi nemici mai fosti pietoso, dell'empietà dei molti rispondere or devi, e della suprema vendetta dei giusti, la pena eterna paghi. Quand'ecco la voce ferma del re erompe sotto la volta e fa tremare per un attimo la fiamma che nel braciere improvvisa divampa . . .
Agamennone:
Triste è il tempo di chi non s'aspetta pietà. O si, questo son io, queste le colpe, ma ben più è il castigo divino che mi danna a questa sopravvivenza di larva, morto alla vita, nella consapevolezza angosciosa di ciò che accadrà. O Ipnos, o Thanatos, o Ermete fraterno, giungete vi prego. O vaghe parvenze dell'invisibile, venite a colmare l'incolmabile attesa. Conducete, v’imploro, la mia anima inquieta verso quell'ultima silenziosa meta, dove io possa infine posar le stanche membra da sì cotanto affanno che mi strema. Meschina è l'esistenza di chi è oltraggiato, ignorato dalle amicizie d'un tempo, deluso dall'affetto dei cari, inviso agli impietosi dei, obliato nella memoria dei posteri. Ognuno di me conosce le colpe di cui mi macchiai un tempo, or dunque nessuno sa, invece di quale precipizio io sono sull'orlo, ché questo mio volto d'oro s'infrange contro lo specchio gretto dell'invisibile sorte. O, perché dunque, mi chiedo, perché l'autore di sì funesto dramma non reclama per sé il riscatto della pena e di un sì cotal destino? E già si levano le fosche dee ctonie, regolatrici dell'umane sorti, a ravvisare Eschilo di non dare ascolto al reo, ché un deplorevole inganno egli trama:
______stasimo III
A Te, o Eschilo, che d'Agamennone scrivesti l'epitaffio, egli chiede mercé. Ma attento! l'ira in cuor suo consuma, e con l'inganno egli viene a Te. E non già per estirpare il malanimo suo, bensì, a chiedere della vita l'aggio, che non d'appartenere al mito egli si lagna, ma per la vita che quest'oscurità gli nega. Ed ancor più attento sii dell'orda malvagia che l'accompagna, che attende miserevole in questa notte parca, di carpire sì degna sua presenza. Non confidare in loro, sono le ombre dei dannati che il Tartaro attende, pronte a sbranar chiunque la sua dimessa spoglia tenti. E Tuo infine sia l'onore oppur il dispregio di riaverlo in Te qual figlio spurio del Tuo più sommo dramma. Le anime dei trapassati si fanno in disparte e indietreggiano lentamente verso il fondo, nel mentre l’autore del dramma, invocato, incede attraverso il buio nella piena luce della fiamma . . .
Eschilo:
Caro agli dei già fui e ai mortali che della tragedia danno a me la palma. Qui giungo che Eolo mi chiama e riconduce a me il pianto d'uno dei miei eroi sì nobile e sovrano, che giammai mi dolgo di riaprire il canto. O Melpomene, o Musa alla memoria cara, ascolta questo prode figlio d'Atreo, che d'Agamennone oggi qui discute il vanto. Per la sua morte il pianto leva tutta Micene, colpita da sì grave lutto, e del re ucciso declama or già l'orrore, ma non dimentica le subite offese, e del figlio suo, per i colpevoli, degli dei sovrani, la vendetta estrema chiede. E tu, prode Agamennone, riponi orsù la spada, che di sì tale fardello ancor la terra lagna. Io non così ti volli. Nella memoria dei molti or tu riposi da quel grande che fosti, come colui che alla sacra Ilio vincitor condusse gli Achei. Parlami, dunque, che chiedi? Quale verità nascondi dietro la maschera d'oro ch'io non ti diedi? Quale enigma? O, quale inganno? Che . . .
"… rispetto a tutte le altre, una sola cosa preferiscono i migliori: la gloria eterna rispetto alle cose caduche" (32)
Allorché Agamennone, con gesto remissivo, ripone la spada sua levata . . .
______stasimo IV
Qui, sotto il cumulo delle macerie sparse, che il tempo sembra aver dimenticate, si dispiega l'irreale realtà del mito, e sì coinvolge, che sorprende una temuta gioia, che al dunque appaga e sazia, fin dentro la tensione strenua dell'umano. E un brivido scorre nel presagio della fine, o, forse, un lugubre silenzio, di vaticinio. Sicché piangiamo l'eroe ancor vivo, per l'imminenza della sciagura che lo coglie. Una sorta di pietà concorde che lo enfatizza in vita, che lo esalta, e che lo spinge inevitabilmente nella profonda morte. Non qui, certo, si decide la sua sorte. Il Fato si è già compiuto altrove, quando al suo volgere dall'alto d'Ilio sacra in fiamme, egli impietoso, la spada impugnò contro i nemici suoi, e mercé egli non chiese agli dèi dell'Olimpo, dei suoi passati errori e delle innocenti morti. Ed ecco, li, in quel momento, si compiva il Fato, il suo volgere alla fine. Nessuno mai cambiare potrà il corso del destino che incombe, poiché volgendo in bene quel che male è stato, si compiono gli inganni dell'umana sorte. Ne potrà il malvagio attendersi da noi pietà, poiché noi siamo il Fato, la voce intermediaria del tempo che si conduce, che ognuno dentro sé al dunque ode, ma che nessuno ascolta.
_______esodo
. . . Micene tutta restava muta, come lo è ora, chiusa nel cerchio di pietra delle sue possenti mura.
Luogo degli finiti inganni, Epidauro (racconto di viaggio):
“Da masse di silenzio sorgi corpo vegliante,
leva il capo dal cavo delle mani” - (canta Giorgio Seferis)
Il sole arrossa il tardo meriggio e un ultimo stormo d'uccelli, neri in controluce, attraversa stanco i salutari colli che di Epidauro formano la chiusa, per gettarsi poi, con un battito d'ali vorticoso, nei profondi valloni alle falde dei monti Eubea – come di un'ombra che cerchi nell'ombra un castigo, o un premio, o forse, un luogo dove trovare l'agognata pace. Volgendo lo sguardo d'intorno, s'ode il gorgogliar dell'acque fra il verde d'una natura quieta, che si ripete, dentro il silenzio dei millenni, sempre uguale, sempre medesima, accolta fra i misteri che sono all'origine del mondo. Qui, nel santuario che d'Asklepios cinse il vanto, giungono i pellegrini assorti e stanchi, che si conducono, come un tempo, a ricercar nell'arte la cosmica armonia e il vigore d'una sanità preclusa.
Adagiato sul declivio naturale del colle, il Theatron di Epidauro sorge improvviso come una valle che si spalanca verso l'aperto cielo, sì da sembrare la trasposizione della cosmica armonia. Chi a piedi vi giunge attraverso la via ascosa dalla fiorente verzura si sente avvolgere dal protettivo abbraccio della pietra: una gradinata maestosa che si dispiega con rapido slancio verso l'infinito, e che la luce dorata del tramonto, per la beltà, rende prossima alla dimora degli dei. Dall'alto, il disegno concentrico dei gradoni traccia una spirale che all'assoluto tende, quasi che il primigenio sole posatosi sul nascere un momento, abbia qui posto la sua impronta, prima di spingersi dentro la pacata illusione dell'eterno.
Costruito in osservanza delle esigenze d'una visibilità ideale e della migliore percezione acustica delle sorgenti sonore, il Theatron è l'incomparabile testimonianza d'una evoluzione architettonica giunta all'apice della sua grandezza, e si colloca in primissimo piano nella vita sociale e culturale dell’antichità classica. La sua struttura, insieme di elementi pressoché costanti dell'architettura arcaica, legata alla sacralizzazione mitica degli spazi, ripete nell'orchestra il primitivo recinto sacro, nel mezzo del quale era posta l'ara, o thymele, destinata ai sacrifici liturgici. La scena, o skene, che faceva da sfondo alla struttura portante, era in origine costruita con materiale ligneo dipinto e riproduceva con linee essenziali una natura piuttosto spoglia che si rifaceva solo vagamente al tessuto verbale del dramma rappresentato. All'occorrenza non mancò di originalità e vi fecero la loro apparizione strutture mobili e tendaggi per gli interni, rappresentate talvolta con cura d'arredi, prima di divenire struttura portante in muratura con porte e arcate aperte sullo sfondo della natura.
Luogo deputato per le rappresentazioni tragiche, il Theatron segnava l'apice delle feste pubbliche ed ospitava ogni anno insieme con le compagnie attiche, quei drammi che più si erano distinti e che più d'ogni altri contrassegnavano una qualche evoluzione nella formazione dell'uomo interiore e del soggetto responsabile. Temi questi, che ripresi dal patrimonio culturale e letterario classico, si rivelarono costruiti sull'intima osservanza della ritualità liturgica dei primordi, delle istituzioni sociali e delle psicologie umane. Ma, ed anche, per la capacità estrinseca di trascinare al di dentro di una sorta di smarrimento sacro il desiderio umano, e dare così un senso all'ineluttabilità della vita. Quel desiderio che tanto avvicinava l'umano al sublime, per quel po’ che il suo nobile slancio recuperava alla memoria dei posteri – come di una realtà mitica che si fa storia e leggenda insieme, partecipe dell'entusiasmo che la esalta. Talvolta era l'abilità dell'invenzione o la costruzione di una trama, o più sovente la scaltrezza di un intreccio rivelatore a condurre le parti in gioco, e finiva col travolgere sulla scena uomini ed eroi dentro una passione distruttrice che opponeva alla colpa, un ferreo destino di morte. Quest'atteggiamento indubbiamente emotivo, permetteva all'autore del dramma di formulare lo scambio simbolico delle entità contrapposte: da una parte l'immaginazione mitica nel suo divenire simulazione della vita reale; dall'altra, la realtà umana miticizzata e trasferita, per così dire, sull'Olimpo degli dèi.
Per un bizzarro quanto ambiguo ribaltamento delle parti, l'operato del dio oracolare investito nel dramma rappresentato, si trovava ad operare su una sua immediata umanizzazione, mentre l'essere umano, eroicizzato, assumeva un'indiscutibile dimensione mitologica. Ciò, rendeva possibile una lettura simultanea del dramma da due diverse angolazioni: quella determinante del Coro e quindi del giudizio umano; e quella pregiudiziale della giustizia divina, regolatrice della vita religiosa e politica della comunità che dava slancio al nobile orgoglio della stirpe. In questo modo gli dèi e gli eroi si trovavano ad incarnare quelle qualità superiori che tutti potevano affermare e che come spettatori e cittadini di uno stato erano chiamati a rappresentare in prima persona, o comunque, in cui potevano riconoscersi, o quanto meno aspirare. Messaggero straordinario dell'autorità precostituita era il Choros, elemento portante della struttura tragica. La sua funzione era l'osservanza indiscussa della giustizia sancita dalle leggi dello stato e l'ordinamento delle ideologie sociali e religiose: quella familiare, cosiddetta anche rituale, puramente privata e centrata sul focolare domestico, sugli affetti e sul culto dei morti; e quella prettamente sacra, Olimpica, riconosciuta dall'ortodossia religiosa che l’aveva finalizzata e ufficializzata nello Stato.
È forse questo un aspetto apparentemente incomprensibile al nostro spirito moderno, all’epoca capace di costituire sul piano dell'azione drammatica un forte e insormontabile contrasto tra due forze opposte: da un lato l'eroe tragico, mitizzazione di una realtà individuale il cui destino era ancorato all'azione del dramma, sempre più spesso figura d'altra età e d'altro spessore, più o meno estranea alla condizione ordinaria del comune cittadino. Dall'altro, il Coro, espressione d'un sentimento collettivo, il cui ruolo consisteva nell'esprimere assieme ai sentimenti e alle speranze degli spettatori, il giudizio ultimo, in rapporto con la comunità sociale che rappresentava e che, nell'azione scenica, conduceva le sorti del dramma.
Nella tecnica della tragedia, ciò rappresentava una sorta di bipolarità tra due elementi contrapposti: sul piano emotivo, tipicamente umano, il crimine si poneva a fronte della paura; l'ordine costituito di contro al disfattismo dirompente; la luce "illuminante" della vita in opposizione al buio dell'al di là. Mentre sul piano strettamente psichico della "suggestione" venivano suggellati il timore reverenziale a fronte dell'intimo desiderio; la turbolenza della ragione a fronte della casualità del Fato. Ma era al dunque la ricerca affannosa della giustizia suprema a dominare la scena, quasi che la materia della tragedia altro non fosse che la tragedia stessa, legata per un verso alle esperienze umane e psicologiche d'una esistenza sofferta che ancora doveva compiersi. D'altro verso, somigliava ad una sorta di regolamento di conti fra la terra e il cielo, fra gli uomini e gli dèi.
La particolare corrispondenza estetica e filosofica dei drammi, la visualizzazione dei miti narrati, la tragodia che accompagnava i destini degli umani, doveva guidare la mente del malato verso una comprensione più ampia della vita, mediante un’immagine di sana pienezza che avrebbe reso possibile il recupero dell'identità individuale, restituendo così agli accoliti del dio, la dimessa fiducia in se stessi e la forza necessaria per affrontare le difficoltà più esplicitamente esistenziali. Quelle stesse difficoltà che, in certi casi, sommate le une alle altre, avevano dato forma a problematiche sociali. Reso quindi visivo sulla scena, l'evento narrato, diveniva per così dire attuale, permetteva cioè ai personaggi che in esso agivano, un facile riscontro entro la realtà immaginaria dell'azione, tramite la quale, si rendeva possibile il divenire mitico di ciò ch'era prettamente umano e, per contro, l'umanizzazione di ciò ch'era esclusivamente divino.
Una sorta di contestualità rituale conferiva al dramma scenico sue regole e caratterizzazioni specifiche, rivelatrici di aspetti inusitati in fatto di esperienza individuale e collettiva. L'esplicarsi dei ruoli sulla scena, ad esempio, agiva sull'inconscio al pari d'una rivelazione che il soggetto umano si trovava a vivere dentro un dibattito che lo costringeva a prendere posizioni, a fare scelte. Così come ad orientare le proprie azioni, a districarsi in un universo di valori ambigui, dove nulla era mai stabile e univoco, o soltanto imprescindibilmente umano o divino; ma dove entrambe le parti, in costante tensione tra loro, rendevano possibile la continuità temporale dell'azione entro una precipua funzione catartica. E ciò, nel solo intento di scandagliare nelle umane passioni e nei moti dell'anima che gli sono propri.
In questo gioco delle parti entrava anche l'autore della tragedia che finiva così per sostenere il ruolo giocato dallo spettatore, entrando in prima persona nel tessuto psicologico del dramma. Il drammaturgo non si limitava quindi a mostrare le sole imprevedibili e turbolente avventure dell'anima, ma asserviva quelle ch'erano da considerarsi primarie esigenze educative, necessarie a formare in seno alla giustizia e al potere costituito, una solida dignità patria. A fronte quindi dell'opposizione transitoria delle parti in azione, e nell'asserzione o nella negazione delle passioni umane coinvolte, la tragedia rivelava un suo precipuo dominio dello spazio, autonomo e originale, momento acculturante che attraverso lo spettacolo e l'intrattenimento, intesseva insegnamenti di etica e di equità.
Legata all'origine sacrale della rappresentazione tragica, la maschera teatrale a cui gli antichi adducevano un'intrinseca dualità espressiva che la imponeva e al tempo stesso la metteva in causa sulla scena, era la vera protagonista del dramma. E se per un verso essa esaltava il lirismo poetico dei personaggi, sempre tesi tra la realtà antica e la coscienza dei moderni, fra mitologia e realtà storica; in altro verso, occultava le vere sembianze del volto che la sosteneva, seppure per rivelarlo poi, entro un divenire metafisico posto a metà strada tra l'umano e il divino. Il riferimento è puramente di carattere antropologico e va relegato in un tempo più arcaico, forse tribale e probabilmente religioso, che non permetteva all'accolito di avvicinarsi alla divinità a viso scoperto, pena lo straniamento e la pazzia; quando addirittura la colpa attribuitagli non sfociava nella definitiva condanna a morte, inflitta dagli stessi membri componenti la comunità tribale, per l'avvenuta violazione del tabù originario.
Riti di trans, cerimonie iniziatiche, feste e rappresentazioni di carattere teatrale hanno visto fin dalla più remota antichità l'utilizzo della maschera. La sua funzione era in origine legata all'educazione e all'istruzione spirituale e non mancava di valenza psicologica, di intenzione psicoterapeutica. L'identità della maschera non risiedeva quindi nella maschera in sé, bensì si stabiliva per rapporto tra elementi astratti e forme oggettive trasposte in simboli iniziatici dell'arte figurativa. Ad un'analisi speculativa degli elementi che la compongono, la maschera si rivela di natura metafisica, chiave di lettura di quei simboli attivi che, posti in connessione, danno forma alla sintassi razionale di un concetto irrazionale. Simboli la cui conoscenza si rende necessaria per l'interpretazione di quanto andiamo scorrendo e che sono strettamente inerenti a una concezione onirica del mondo e della vita a cui la collettività ha attribuito importanza psicologica, e che ha esternato, quasi ad esorcizzare se stessa, per mezzo della rappresentazione visiva.
Tuttavia un'indagine del ruolo specifico dei simboli tesa a conferire alla maschera identità culturale può risultare vana o quanto mai generalizzante, non connessa con la natura accidentale e mutevole della maschera, alla quale meglio si addice il gioco intelligibile e sottile della mimesi. La maschera visualizzata nella sua integrità di simbolo ci rende partecipi del suo pulsare interiore insito della materia plasmata e lascia trasparire in superficie, sia essa realizzata nel metallo prezioso, nel legno, nel cuoio o nella terra grezza, quei sentimenti più intimi che come macchie di colore si accendono e si dissolvono sulla superficie dell'anima. “E poiché l'anima non pensa mai senza un'immagine”, la maschera non può che esistere nella misura della sua essenza metafisica, alla cui visualizzazione contribuiscono molteplici atti di formazione mutuamente interconnessi, selettivi, astrattivi e finanche creativi. Come tale, la maschera, è quindi la complessa visione di una astrazione che attraverso l'esperienza della forma, s'impone quale immagine collettiva della memoria e il suo posto è tra le immagini archetipiche fondamentali. Pertanto la sua scomposizione dei singoli elementi porterebbe inevitabilmente alla distruzione dell'archetipo che essa costituisce. .
“Se l’immagine agisce come simbolo nella misura in cui raffigura cose ad un livello di astrazione più alto di quello cui si trova il simbolo stesso” (33) Allora “l’astrazione è il mezzo mediante il quale la rappresentazione interpreta ciò che raffigura” (34).
Ecco quindi che la conoscenza dei simboli naturali, cioè di quei simboli entrati nella concezione popolare e in seguito divenuti culturali, si rende necessaria per una lettura significativa dell’origine della maschera da attribuirsi allo stato inconscio della parola (35). Lettura questa, che consente di entrare in stretto rapporto con l'immagine che essa rappresenta e penetrare nella sua arcana bellezza, sia anche di restare prigionieri del potere che la sua immagine esercita sugli uomini e sulle cose. Subirne il fascino può significare entrare nell'entità incommensurabile dell'assoluto in cui la vita e la morte terrene si eguagliano, l'una compenetrata nell'altra. Allo stesso modo di come la maschera compenetra il volto, facendosi al tempo stesso simbolo visuale e rappresentativo della continuità della vita. Per questo la maschera funeraria, ampiamente visualizzata nell'oggettistica di molti popoli, si pone per la complessa simbologia e la stupenda capacità di sintesi raggiunta, intesa a valorizzare quella che è forse la sua più affermata raffigurazione.
Molto diverso è il ruolo che la maschera ha assunto in seguito all'interno della scena teatrale odierna, dove la sua funzione primaria appare del tutto diversa dal travestimento rituale in favore di un ruolo prettamente estetico svolto sul piano dell'arte, ruolo che in qualche modo contribuisce a sottolineare la differenziazione che intercorre tra gli elementi antitetici che occupano la scena tragica. Nelle sue molteplici applicazioni la maschera scenica antica proponeva l'interpretazione simbolica di valori presi in assoluto: non l'emozione del singolo in un definito momento, né il risultato dell'uomo che teme, che combatte o che muore; bensì, il timore, la guerra, la morte, resi presenti sulla scena e chiamati in causa nella loro assolutezza sotto gli occhi attoniti degli spettatori. In tal senso la maschera prendeva se stessa a soggetto della rappresentazione e si reinterpretava davanti a un giudizio trasposto che poteva anche risultare arbitrario alla storia, ma che permetteva il rovesciamento dei valori su cui era incentrato il dramma, causando talvolta un qualche contrasto nello spessore del mito "idealizzato" e il personaggio portato sulla scena. Ma per lo più la maschera nell'impossibilità di aggiungere qualcosa a quanto già stabilito dal Fato, permetteva al personaggio preso a soggetto una più concreta fusione col testo dando al personaggio stesso una precisa identificazione e universalità di significato.
La maschera, rivestita di significato simbolico, svolgeva un ruolo apotropaico che permetteva all'attore di non rivelare la sua identità nascosta se non e soltanto sulla scena senza tuttavia rimanerne contagiato in alcun modo. Ruolo, in cui non già l'attore ma il personaggio che egli rappresentava diveniva oggetto dello straniamento in atto, nel momento in cui il personaggio più s'avvicinava alla sacralità o veniva a contatto con la divinità. La necessaria catarsi agiva sull’identità, all'interno della specifica azione del personaggio sulla scena, lasciando posto a un “io” più universale e al trascendimento all'autocoscienza, indicata come meta da conquistare attraverso lo sforzo, il rischio di morte e di prova. (36) La funzione rituale della maschera, la sua visualizzazione e utilizzazione, risultavano quindi determinanti allo straniamento delle parti in lotta sulla scena, le quali si contrastavano e si completavano a vicenda, alfine di creare quella situazione drammatica che doveva portarsi a compimento. Situazione che l'immaginazione mitica poneva come modello, allo scopo di giungere a percepire nel suo fulcro, la sublimità del messaggio dell'autore. Modello che pur guardando ai posteri come a un pubblico ideale, vedeva nei grandi del passato un esempio con cui gareggiare. Come infatti ancora oggi avviene, ma …
". .solo quando l'anima dell'ascoltatore vibra all'unisono con quella dell'autore; solo quando egli si trova in uno stato psicologico di tesa sospensione, in cui i limiti della propria personalità si annullano, si può giungere a percepire la sublimità, che associa alla stessa esperienza il poeta che crea e il pubblico a cui si rivolge" (37)
La maschera di solito copriva il volto e la testa e assolveva ad un compito pratico di amplificazione della voce rendendola più sonora e percepibile fino alle ultime gradinate della cavea. Altresì dava maggiore espressività al volto, mettendo in risalto i tratti caratterizzanti il personaggio, come ad esempio: le orbite degli occhi appositamente accentuate con colori vistosi, servivano a mettere in rilievo lo sbigottimento o la tristezza dello sguardo, e allo stesso scopo venivano accentuati i tratti della bocca o la magrezza delle gote. Poiché la maschera non consentiva all'attore di erompere in lacrime in modo visibile e limitava le manifestazioni espansive non permettendo improvvisi cambiamenti di stato d'animo, ben presto si giunse a fornire spiegazioni verbali sull'impassibilità di un personaggio davanti a situazioni per lui sconvolgenti. In altro modo, un momento di abbandono allo sconforto o di pianto improvviso, trovava una soluzione nella gestualità, anche se questa non poteva rimediare sempre a tutto.
Se sul piano della scena mutamenti di fondali potevano essere indispensabili, l'intervallo tra una scena e l'altra consentiva agli attori il cambio della maschera che diveniva di volta in volta sempre più confacente ai diversi stati d'animo che essi si trovavano a recitare. Così, ad esempio, v'era una maschera per il dolore, una per l'ira o il furore, una per la tristezza ed una per l'astuzia, una per la maestà regale e numerose altre, fissate in pochi tratti stilizzati e mutate da accessori diversi, come: copricapo e parrucche, che permettevano agli stessi attori in un'ampia gamma di personaggi secondari. Gli attori tragici erano soliti indossare il chitone ionico, una veste ricca di drappeggi che scendeva sino alle caviglie con lunghe maniche che tendevano a coprire la virilità dei muscoli maschili, interpreti unici di tutte le parti, anche di quelle femminili, ma per le quali essi indossavano invece il peplo di lana, squadrato e ad ampie pieghe. La calzatura abituale era il coturno, un calzare a mezza gamba, morbido, largo e basso, sovente con la punta all'insù, e solo in epoca tarda venne fornito di robuste suole che rialzavano la statura a scapito della scioltezza dei movimenti.
I primi attori e i coreuti a loro volta componenti il Coro, venivano scelti e istruiti dagli autori stessi del dramma e pagati in principio dai Coreghi, quei cittadini benestanti che si autotassavano per finanziare la rappresentazione. In un secondo momento però si arrivò al coinvolgimento diretto dello Stato che finanziò gli attori con premi alle migliori interpretazioni. A tale riguardo gli autori non mancarono di apporre didascalie interne al testo con le quali suggerivano i comportamenti da assumere in scena. Ma se scarsa era la messe delle istruzioni, il lessico, la struttura della frase o dell’intero periodo costituivano già da soli una guida per gli attori più stimati che, oltre ad avvalersi della voce, conoscevano un proprio modo di porgersi e di esibirsi. Cosicché la maschera per la sua natura e per la funzione affidatale, finì per sottolineare, rimarcandola, la distanza e la differenza tra due inusitate tensioni: quella estetica e rituale, e quella inconscia e soprannaturale, decisamente antitetiche l’una all’all’altra, ma al tempo stesso strettamente solidali, dal cui scontro l’ordito della “tragedia” si consumava (sulla scena) come l'unica verità subliminale . . .
“. .Chi può sapere se vera (luce) o se inganno di dei?”
Or qui, in questo luogo dedito allo spirito, si vuole avesse luogo un'importante agone che i poeti tragici dedicavano ai miti degli antichi e le cui passioni, agitavano non poco quegli animi provati, che nei drammi prendevano coscienza del proprio sé e dei rispettivi affanni. E tale era la sospensione dell'anima nel ritrovato equilibrio della scena, che il pensiero talvolta s'involava e la parola si permeava d'una segreta grandezza, rivelatrice di ciò che di meraviglioso l'umano detiene con gli dèi: quel sublime anelito che l’animo accende, capace d'illuminare finanche il regno delle ombre, nell'ora in cui la "verità" varca i limiti del possibile . . .
". . Poiché solo la morte porta la vera conoscenza alla purezza dell'anima finalmente staccata dall'elemento materiale" (38)
Qui, come un tempo, in questo immenso Theatron che d'Epidauro prende il nome, si fa un gran parlare di quando, nel fervore delle prove che precedono l'andata in scena, giungono della tragedia i narratori supremi: – quasi ch'egli, per una sua intima decisione, voglia rivendicare, all'intenzione più che all'azione, il supremo giudizio degli dei . . .
". . Poter dimenticare o Dèi, la colpa che va crescendo e sempre più ci grava fuori dalla saggezza e dalla fame". (39)
Giunti al dunque, tutto tace, ogni umano fermento trova qui una battuta d'arresto. E in questa pausa, non più lunga di un istante, accade un ché d'inaspettato, che dal presente si spinge a ritroso nel passato più remoto – quasi il propagarsi della lontana menoria che ritorna improvvisa, e mi ritrovo fra gli spettatori di un tempo, nel presente immaginario che alla mente talvolta si conviene. Ma nell'astratta sospensione del momento, assisto incredulo al materializzarsi sulla scena dello svolgersi d'un dramma che non conoscevo appieno, e che forse trascinavo con me, attraverso quegli stessi luoghi che passo dopo passo vado visitando, come un ultimo confuso accolito di un autore segretamente amato: Euripide.
Quand'ecco, all’improvviso, fra il repentino accendersi e spegnersi dei riflettori e il via vai affrettato dei tecnici e delle maestranze, s'ode il frastuono delle assi gettate in terra per preparare la scena.
Epidauro, 30 Agosto 2001, palcoscenico del teatro antico, prova generale di “Le Troiane” di Euripide, dove incontriamo Eleni Karaindrou, impegnata in un adattamento moderno di “Le Troiane” messo in musica e che ci racconta la sua importante esperienza di creatività musicale:
“Ode di Lacrime”, o di ferite lacere (?).(40)
“Il mio vero incontro con le Troiane ebbe luogo in una mattina nebbiosa, dieci anni fa nella mia casa paterna in Teichion, un piccolo villaggio di montagna della Grecia, menzionato da Tucidide nel suo Guerra del Peloponneso (431-404 b. C.). Trattavasi di una semplice lettura fattami da Antonis Antypas, lo stesso che diresse le Troiane l'estate precedente per la Festa di Epidauro. Quando mi sono chiesta qual fosse l’elemento che rende veritiero un lavoro, che s’introduce tra il pensiero e la sofferenza di un poeta? Io avevo visto prima le Troiane, molte volte, ancora il mio incontro con questo dramma non era avvenuto fino a quella mattina. C'è qualche cosa che va oltre la ricerca e l'analisi, dietro l'accumulazione di conoscenza e informazione a riguardo, quel qualcosa che va oltre e che permette la comprensione di un testo poetico. E questo elemento non può essere spiegato, può essere illuminato solamente.
Probabilmente quella mattina, la voce di Antonys Antypas deve aver portato qualche cosa con lui, quella comunicazione inesplicabile che va oltre parole. Concerne avvenimenti storici, ricordi nascosti, incerti. In quel momento egli illuminò la storia attraverso il dolore umano nei secoli, mentre portava ai miei orecchi il suono dell'uggiolare del poeta che attraverso il suo lavoro trascendeva il tempo, mentre annichilendolo così, in un momento. Di quell’avvenimento io riposi poi i primi suoni, dieci anni fa, al pianoforte nella mia casa paterna. Fu così che m’immersi nel "leit-motiv" che mi guidò più tardi al completamento del “concetto” del mio lavoro musicale per le Troiane, cosa questa che è poi avvenuta durante i primi mesi dell'anno 2001.
Io ero fortunata a poter leggere in greco antico il testo originale, e quando l'adattamento poetico che ne aveva fatto K. X. Myris in greco moderno, arrivò nelle mie mani, le prime canzoni cominciarono a venirmi fuori insieme ai suoni degli strumenti che avrei utilizzati. E gli strumenti apparvero da soli, saltarono fuori al bisogno dal subconscio, addebitando con la loro presenza il dolore dell’avventura umana in questa particolare terra, la terra che io chiamo casa: lyra turca, kanonaki, ney, santouri, liuto, arpa, daires e daouli, suoni che accarezzano le spiagge dell'Asia Minore, viaggiano fino al Mar Nero fanno il nido nelle cupole di Costantinopoli; suoni che legano nel gemito di Smirne non solo i suoni della Grecia ma anche dei Balcani ed in ogni paese del Mediterraneo.
Ero sicura che solamente questi suoni potessero dipingere i panorami interni di le Troiane che, mentre sono in prigione, tengono lezioni sui valori morali e la grandiosità interiore, ai conquistatori greci. Nella sua definizione della tragedia greca, Aristotele parla del “logotipo" di Idismeno, una lingua ricca di ritmo, armonia e melos che, nel loro canto liturgico, le donne di Troia piangendo, fanno appello e rivangano il passato. Io fui condotta istintivamente a qualche genere di scrittura polifonica, o anche semplicemente monofonica. Per lunghi mesi di lavoro costrinsi le attrici a svolgere la parte musicale dei loro ruoli, ma quando lo spettacolo si dispiegò sotto il cielo stellato di Epidauro, la musica ebbe il suo luogo, le voci delle donne il loro ruolo, congiunti in un’Ode in cui tutto era suono.
E mentre suoni, voci, colori, parole, movimento, luce, occuparono tutta l'area sacra di Epidauro, la voce del poeta, di pura trascendenza, tornò al lontano 415 A. C., a quando le donne Troiane, volendo distrarre gli uomini dall'alienazione mentale della guerra, volendo insegnare al mondo intero, che nelle guerre non ci sono vincitori o perdenti, solamente orrore e pazzia. Quella sera del 30 Agosto del 2001, in Epidauro io vidi eserciti di persone sradicate, traversare lentamente il palcoscenico del teatro antico, silenziosamente: Armeni, persone di Pontico, greci di Smirne, ebrei Curdi, Cossovari e Afgani... vidi il corteo funebre per il piccolo Astianatte, e piansi per il genocidio di tanta gente ... E, improvvisamente, mi sentii grata d’essere capace di aver fatto certe esperienze, di tali momenti dolorosi al tempo stesso di conoscenza. Passarono mesi dopo la “prima”, tuttavia lo spettacolo ristette nella memoria ed nel mio cuore. Una volta presa fiducia e inspirazione per stendere la musica, cercai di disgiungerla dal guscio dello spettacolo, di farla respirare in una dimensione più ampia, distaccata dal repertorio scenico, per ricomporla con tocchi magici in un lavoro integrante che porta il sigillo prezioso di Manfred Eicher”.
Siamo qui di fronte a una reale esperienza di creatività musicale, costruita sulla consapevolezza artistica e culturale della Tragedia, da parte di un’artista che ha voluto misurarsi in quello che è lo spazio teatrale per eccellenza, l’antico Teatro di Epidauro, in occasione dell’ Hellenic Festival 2001, nel quale concorrono oltre alla recitazione e alla musica e al canto, la gestualità teatrale e il movimento scenico alla base dell’arte coreografica. Come allora, la tragedia è nell’aria, chiama, grida mentre canta e danza. Ma se la Grecia antica appartiene ad Omero, agli déi dell’Iliade e agli eroi dell’Odissea, quella di oggi appartiene di fatto ai suoi poeti e scrittori del secolo appena ultimato, e che rispondono ai nomi di Kavafis, Seferis, Ritsos, Kazantzachis; agli attori di prestigio come Irene Papas, Vassililikòs, Melina Mercouri; alla coreografa Dora Stratou, ai cantanti Domna Samiou, Bithikotsis, Nanà Mouscouri, Maria Farandouri, a compositori e musicisti del calibro di Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Yannis Markopoulos, Vangelis Papathanassiou, Iannis Xenakis, Eleni Karaindrou, ed ai registi famosi dello spessore di Michael Cacojannis, Costa Gravas, Theo Angelopoulos, che l’hanno internazionalizzata, riscattandola dopo lunghi anni di forzato silenzio. Voi direte nient’altro che nomi, la solita lista di volti del cinema e dello spettacolo, dell’arte e della musica, pur sempre e soltanto nomi, volti.
Volti, ma che pure nel momento del bisogno, quando la Grecia tutta si è sollevata per il riscatto dei diritti umani, contro l’oppressione e la tirannia dei Generali, hanno esposto i loro volti e hanno fatto sentire le loro grida forte contro la persecuzione politica, nel fermento della lotta per la libertà, quasi che le loro voci sembravano non voler smettere mai. Ed ècco che gli antichi eroi del mito si levano, i loro volti hanno tutti un nome, le loro voci sono tutte la stessa voce, quella del poeta, da Omero in poi:
“Voci” di Costantino Kavafis (42)
“Ideali amate voci
di coloro che sono morti e come i morti
non sono per noi perduti.
A volte ci parlano in sogno
altre volte vibrano dentro di noi.
E con il suono, per un istante
l’eco fa ritorno nel nostro canto
la prima poesia della nostra vita.
Come lontana nella notte
Una musica che dilegua”.
(continua)
Note:
(*) I versi in apertura dei capitoli sono di George Seferis, tratti da “Poesie”, Arnoldo Mondadori Editore - Milano 1989.
1) Dionysios Solomos - “Easter Sunday” – in “Eternity and a Day”- (vedi discografia)
2) 3)Gregorio Paniagua e Atrium Musicae De Madrid – “Musique de la Grèce Antique” - (vedi d.)
4) Pindaro - “Prima Ode Pitica” ……..
5) Inni Orfici - “Alla notte”, ASRAM VIDYA - Roma 1986.
6) M. Schwob – “Il re dalla maschera d’oro”, …..
7) E.Savino - “Preghiera e rito nella Grecia Antica”, Mondadori - Milano 1986.
8) 9) 10) 11) 12) Euripide - “Ione”, in “Il Teatro Greco”, Sansoni 1970.
13) P.Flores D’Arcais “Etica senza fede”, Einaudi - Torino 1992.
14) 15) E.Savino – op. cit.
16) Inni Orfici - “Inno a Nomos”, op. cit.
17) 18) 19) 20) P.Flores D’Arcais, op. cit.
21) Inni Orfici - “Alla natura”, op. cit.
22) J.Campbell “L’eroe dai mille volti”, Feltrinelli - Milano 1984.
23) M.Schwob – op. cit.
24) Minnermo “L’eroe”, in “I Lirici Greci”………
25) P.Flores D’Arcais, op. cit.
26) J.Campbell, op. cit.
27) Anonimo “Il Sublime” ………..
28) P.Flores D’Arcais, op. cit.
29) Anonimo “Il Sublime”, op. cit.
30) H.Hesse “Religione e Mito”, Mondadori - Milano 1989.
31) P.Flores D’Arcais, op. cit.
32) Anonimo “Il Sublime”, op. cit.
33) Aristotele
34) Karl G. Jung “L’uomo e i suoi simboli”, Longanesi ………..
35) R.Harneim “Il Pensiero Visivo”, Einaudi – Torino ………….
36) Karl G. Jung, op. cit.
37) A.M.Di Nola “Enigma”, in “Enciclopedia”, Einaudi – Torino ….
38) Anonimo - “Il Sublime”, op. cit.
39) Eschilo “Agamennone”, in “Il Teatro Greco”, op. cit.
40) E. Karaindrou – “Le Troiane” (vedi discografia)
41) Dora Stratou
42) Costantino Kavafis - “Poesie nascoste” – A. Mondadori Ed. – 1974.
Bibliografia / Letture:
Filippo Càssola - “Inni Omerici” a cura di – Mondadori 1994.
Salvatore Quasimodo - “Antologia Palatina” a cura di – Mondadori 1992.
E.Wellesz “Ancient and Oriental Music”, in “The History of Music in Sound” Vol.I,Oxford University Press - London 1957.
K.Kerenyi “Miti e Misteri”, Boringhieri - Torino 1979.
Karl G.Jung “Opere” Vol.IX, Boringhieri - Torino 1980.
F.Nietzsche “La nascita della Tragedia”, Adelphi - Milano 1982.
Felice Ramorino “Mitologia Classica” - Hoepli Milano 1984.
Stephen Larsen “L’immaginazione mitica” - Interno Giallo Ed. Milano 1992.
Angelo Brelich “Gli eroi greci” - Ed. Dell’Ateneo & Bizzarri Roma 1078.
Mario Vegetti- “Oralità, scrittura, spettacolo”, a cura di - Boringhieri Torino 1983.
Vernant e Vidal Naquet “Mito e tragedia nell’antica Grecia” - Einaudi Torino 1976.
R.B.Bandinelli - “Storia e civiltà dei greci: La crisi della Polis” a cura di - Bompiani 1979.
Marie Delcourt - “L’oracolo di Delfi” - ECIG Genova 1990.
Filippo Maria Pontani - “La morte degli eroi” - Sansoni Firenze 1975.
F.H.Sandbach - “Il teatro comico in Grecia e a Roma” - Laterza bari 1979.
Marion Milne - “L’alba dell’eternità” - Borla Roma 1990.
Otto Rank - “Il mito della nascita dell’eroe” - Sugarco Ed. 1987.
Henry Frankfort - “Il dio che muore” - La Nuova Italia Firenze 1992.
Edmond Burke . “Inchiesta sul bello e il sublime” - Aesthetica edizioni, Palermo 1995.
<br
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomus. 7: Grecia - Terra di suoni...
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGIA – 7 (prima parte)
“GRECIA: Terra di suoni, di antichi miti, di amori lontani ritrovati” – di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, un programma di Etnomusicologia a cura di Pierluigi Tabasso, trasmesso da RAI 3 – “Itinerari Folkloristici” a cura di Sanzio Chiesa per RSI, e apparsi in articoli sulle riviste: Nuovo Sound, Musica & Dischi, Banchetto Musicale n.66 Feb.1986 , Hi-FI, Audio Review n.33 – Nov.1984).
Abbandonato in un insolito viaggio della memoria, mi sorprendo qui a rievocare, non senza esitazione, i passi di una letteratura appresa sui banchi di scuola, il cui ricordo partecipa talvolta di esperienze successivamente acquisite, di luoghi visitati, di persone incontrate, di intimi segreti amori che il tempo sembrava aver del tutto cancellato e che invece ho ritrovati quasi intatti nell’averli rivisitati. Ed è un cospicuo riaffiorare di eventi lontani, di situazioni fuggevoli, di personaggi appartenuti per lo più a una mitologia corrosa, forse mai compresa appieno, che ancora oggi mi delizia e mi affanna insieme, come allora. E che riscopro, improvvisa, nella liricità di un verso, o di un passo narrativo, nelle pagine di libri che trovano posto nella mente, e che riassaporo assieme ai ricordi, nel rivisitare oggi i luoghi classici della Grecia: Atene, Delfi, Epidauro, impedendo così al passato d'impallidire.
È questo il racconto di un viaggio nei siti che hanno visto nascere gli eroi del mito, riesaminati attraverso la lente d’ingrandimento dell’invenzione letteraria, intesa a sottolineare i risvolti inusitati di un linguaggio enfatico, quello della memoria, l’unico capace di scaturire in emozioni, di ridestare quelli che un tempo erano i luoghi designati dagli dei, oggi spenti e polverosi, che il visitatore neppure si accorge della loro grandezza, di ciò che un tempo hanno idealmente significato, quando la Grecia tutta era considerata il faro della civiltà e della cultura antica. Non una guida di viaggio, dunque, bensì un vademecum di sentimenti, che attraverso il breve rispolvero letterario, vuole insolitamente emozionare il visitatore, invitarlo a “sentire” non con le orecchie ma col cuore, il forte effluvio che si sprigiona dalle parole del mito, e che va oltre l’ammirazione per quei luoghi resi “grandi” dall’arte e dalla storia.
“Mi duole d'aver lasciato scorrere un sì vasto fiume fra le mie dita,
senza averne bevuto neppure una goccia” (1)...
..scrive Giorgio Seferis, ma giunta è l'ora ormai di un mio ritorno, anche se soltanto fra le pagine di un dire che si conduce sulle note cadenzate di un syrtos che mi accompagna, fin dentro l’incanto del momento. Forse è questo che più mi piace della Grecia, la scansione meno concitata del tempo, l'ancor vivo senso dell'ospitalità, la facilità del contatto umano, la curiosità mai appagata, l'amore per la libertà; quel suo essere pietrosa e ruvida, così profondamente vissuta, culla di assopiti ricordi e di segrete memorie, i suoi paesaggi, talora aspri, nei quali si attende sempre di veder spuntare una ninfa o un satiro, il suo cielo immenso e terso, popolato di dei e d'eroi, di lotte e d'orrori, come di beltà e d'onori cosparso.
E ancor più mi piace l'azzurro dei suoi mari antichi, fragorosi d'armi e di navi, l'astrale vento che soffia impavido, ricolmo di voci e di passati richiami, e certamente l'implacabile Sole, il grande arciere del giorno, amato quasi fisicamente come un dio pagano, nella sua bellezza e nella sua luce abbagliante, colui che fuga le tenebre, colmo di forza e d'audacia, che di Febo reca l'aureo sembiante. . .
". . O Titano fulgido come l'oro, o Iperione
splendore celeste
. .che coi destrieri danzando temperi le
stagioni, corridore veloce, fiammante e
giocondo auriga, che percorri la tua via col
giro del turbine infinito
. . tu con la lira d'oro l'armoniosa corsa
misuri del tempo
. . ed ora spegni ed ora accendi i tuoi bei
raggi fulgenti
. . che col flagello sibilante il cocchio
incalzi". (2)
Mi chiedo quanto sia la prodigiosa bellezza della natura, o quanto invece sia l'oscura forza dell'arcano, che in qualche modo conduce i miei passi in questi luoghi sacri che già appartennero al mito. Una risposta, se mai ci possa essere, va ricercata in quella volontà che spesso sconfina dall'umana soglia del possibile e induce ora ad accettare, ora a rifiutare l'impossibile. Come talvolta è un desiderio ignoto a impossessarsi del nostro volere assopito e approfittando del momento ci trascina nell' assoluta irrealtà in cui si rivela la sostanza dell'invisibile. . .
". . e Tu, Febo possente, che di Delfo abiti il sacro suolo". (3)
Ed ecco già che gli antichi eroi del mito si destano e tornano ad affacciarsi dietro le quinte del teatro, al riaccendersi dei bracieri che illuminano il gran teatro dell’immaginario; ed è tutto un fragore di marosi, bizze di venti, suoni e voci, grida disperate e sbattere d’armi, d’una rappresentazione e del ritorno di un tempo che fu, e che si ripete nella quiete che precede ogni tramonto. È questo il momento più propizio ad Apollo citaredo, in grado d’incantare gli esseri viventi e la natura tutta col suono dolcissimo e ingannatore della sua cetra. Il mito narra che un giorno Marsya il Sileno, cui si attribuiva l’invenzione di un particolare flauto a due canne dal nome aulos, osasse sfidare il dio Apollo con la sua cetra, in una disputa musicale rimasta famosa:
____________Marsya Stasimo (4)
Choros:
Sì dolce e armonioso è il canto Tuo
che in noi spontaneo nasce un anelito
che a Te conduce, o d'Iperione figlio,
che dell'Olimpo siedi alle mense
degli dei beato.
Aedos:
Carezzevole come solo Zeffiro ne conosce il modo, echeggia per le valli un suono; è quello d'un aulos, il doppio flauto di canne caro a Marsya il sileno, dapprima lo si sente scivolare leggero sul profilo dei monti, discendere lungo i pendii e i dirupi scoscesi, per spingersi, poi, nei segreti anfratti delle rocce; come a voler svegliare la pigra natura dei luoghi. In altro sito, pascola una mandria di giovani in assoluta quiete, d'imbonire col dolce suono della sua cetra, nel mentre di lirici versi ricolma la natura. Ma, ancor che egli la voce liberi nel canto, si scorge a prestar orecchio ad uno zufolo che l'incanta . . .
“. . chi piega il cuore
al desiato fiore giovanile
e al suono
di zufoli tenesi danza?” (5)
Marsya, da parte sua, pieno d'orgoglio per aver sorpreso il dio d'appresso ad ascoltar quel suono, lo sfida in una gara che di suonar s'avvale, e in cui il vincitore dispone del vinto come vuole. Il dio acconsente, e affida alle ebbre Muse di giudicare l'agone. Acciò Marsya allo zufolo s'adopra e tutt'intorno ognuno si bea di sì piacevole suono. Indi Apollo, posta mano alla sua cetra, una melodia soffusa leva che risvegliare fa d'intorno la natura. Le Muse, ugualmente deliziate, si dichiarano in favore di entrambi, ma il giovane dio, adirato, lancia di rincalzo la propria sfida, e invita Marsya a cimentarsi nel canto. Nell'impossibilità di superar la prova, Marsya sa d'essere perduto e nulla può per imbonire l'astioso Apollo, che intonato un inno agli déi sì caro, induce le Muse ad acclamarlo, della gara, il vincitore. Quando, al dunque, un'efferata sorte per Marsya egli reclama:
Choros:
“Sì dolce e armonioso è il canto Tuo che in noi nasce
spontaneo un anelito che a te conduce. E servi Tuoi,
e della madre Terra noi pastori, leviamo a Te l'umile preghiera:
. .di risparmiare quel satiro superbo,
che di suonar sen va pei campi lieto e rallegrar talvolta
si diletta la vita nostra grama.
Sì tale ingiusta sorte deve dunque egli subir,
sol perché sfidare egli osò per gioco degli dei
il lor voler supremo?
Neppure foss'egli quel re sacralizzato
che dell'inverno scorticar si deve per rendere omaggio
al solstizio che viene?”
Aedos:
Un ontano tien già le spoglie sue ad essiccare al sole, presso la sorgente d'un fiume
ch'ora ne porta il nome . . .
Choros:
Sì dolce e armonioso è il canto Tuo . . .
. . .
". . E già il sole splende sulla terra
le stelle nel cielo ardente fuggono
al suo fuoco, laggiù, verso la sacra notte”. (6)
All’aulos di origine arcaica, era anche dato il nome “magadis”, cioè ottavo, in ragione del suono grave che se ne ricava, una all’ottava dell’altra, e forse proveniente dall’Asia, sebbene ne siano stati rinvenuti di simili in gran parte dell’Europa. Ne ricordo qui uno in particolare e per alcuni versi simile, originario della Sardegna, dal nome is-islauneddas di cui non si conosce l’origine. Ovviamente non è l’unico strumento a fiato che conosciamo, per lo più nel periodo ellenistico vengono esportati/importati dalla Grecia, dovunque fosse giunta la sua cultura, il clarinetto, la zampogna, i flauti pipiza e zournas tipici di alcune regioni più interne; la lira, forse orientale conosciuta a Creta; l’arpa egiziana; il violino e vari cimbali e campanelli; oltre all’ud, il bouzouki, il santouri di forma trapezoidale, e una sorta di tamburelli detti daouli.
Tuttavia in Grecia predomina l’uso della voce sull’esecuzione strumentale, soprattutto nell’interpretazione di brani lirici, come inni e preghiere, brevi poesie e canti processionali lì dov’era richiesta la partecipazione al culto. Tra le numerose pratiche in adempimento di sacrifici, offerte alle divinità, sposalizi e riti funebri, nonché in riferimento a giochi e gare ginniche in cui il canto occupava un posto di rilievo, mentre la musica strumentale era utilizzata solo per l’accompagnamento. La maggior parte dei riti, infatti, erano officiati nell’ambito delle feste periodiche in onore degli déi secondo un preciso calendario, e costituivano, insieme alla danza, elemento fondamentale del culto, in quanto svolgevano funzioni mediatrici tra i membri della comunità e le divinità che, a loro volta, garantivano e indirizzavano l’esistenza umana.
Altri elementi d’interesse letterario ed etnomusicologico in ambito lirico-poetico erano costituiti dal “prosódion” la cui metrica costituiva la base dei canti rituali dalla struttura spesso drammatica, ciò che permetteva di stabilire un dialogo tra capo (attore/i protagonista) e i componenti del coro, generalmente composto da ragazzi e ragazze che eseguivano passi di danza coreografica d’accompagnamento al canto; e dal “dithýrambos”, canto corale di lode e ringraziamento, in forma lirica d’ispirazione culturale-religiosa, legato inizialmente al culto del dio Dioniso, solitamente intonato da un coro e accompagnato, nelle processioni dette appunto dionisiache, dal flauto aulos e tamburelli. Lode e invocazione erano elementi costitutivi della pratica sacra greca che li indirizzava al thymele, di cui si ha testimonianza letteraria e archeologica, formato da un boschetto circolare cresciuto intorno all'ara sacrificale o a una tomba di una certa importanza, attorno alla quale si cantava disponendosi in cerchio ed eseguendo una danza coreografica.
Ciò che ha suggerito in seguito, la forma aperta del teatro greco, ottenuta sfruttando le inclinazioni naturali del suolo, messa in rapporto con lo spazio naturale in cui lo stesso era costruito. Successivamente infatti, attorno al V secolo a.C., il rito entrato ormai nella tradizione, si svolse in questo luogo più ampio destinato esclusivamente alle rappresentazioni, il Theatron, strutturato da un’ampia cavea e una gradinata imponente che permetteva di accogliere un numero più elevato di spettatori che accorrevano in massa alle rappresentazioni. Monumentali resti di teatri sono visibili oggigiorno in molte parti della Grecia classica, fra tutti il maestoso Teatro di Epidauro, preso a modello per i teatri dall’epoca Magna fino ad oggi, dove perfino le parole pronunciate a bassa voce dagli attori in scena, potevano essere distintamente udite anche dagli spettatori più lontani. Carlo Giulio Argan nella sua ormai famosa “Storia dell’Arte Italiana” (7) ce ne ha lasciata una eloquente descrizione:
“Vasta cavità scoperta, semicircolare, ottenuta sfruttando le inclinazioni del suolo. Al centro dell’emiciclo era l’orchestra, circolare o semicircolare, per i movimenti del coro; seguiva il proscenio dove si svolgeva l’azione drammatica sullo sfondo della scena, su di un fondale architettonico fisso. (..) Poiché lo spettacolo era a un tempo la rappresentazione agìta del mito, il teatro diveniva il luogo ideale in cui il ripetersi manifesto del mito al cospetto della comunità riunita, si fondeva con la vita della società o della polis”.
È in questi incomparabili monumenti dell’antichità che ogni anno si compie il miracolo, o se preferite la magia, dello spettacolo più importante cui si possa assistere in assoluto, la rappresentazione della Tragedia Greca (8) così come è stata tramandata nei millenni, seppure con alcuni accorgimenti tecnici che nulla tolgono al passato glorioso degli déi e degli eroi che abbiamo conosciuto attraverso Eschilo, Sofocle ed Euripide, ma anche di Omero e dei grandi della lirica greca che, per qualche verso, tutti noi abbiamo anche un po’ amati. Giunto è quindi il momento di parlare della Tragedia se vogliamo comprendere le ragioni di questa scelta ancora una volta “letteraria”, fortemente propedeutica alla ricerca che stiamo svolgendo, per essere di approfondimento di quella che sin d’ora possiamo definire “archeologia della musica”, e che l’etnomusicologia comparata ci aiuterà a comprendere nelle sue diversificazioni e interazioni conformi al nostro tempo.
La sua struttura originaria, fissata dalla tradizione sull’estensione in senso drammatico dei riti sacri in onore di Dioniso (9), dio della fertilità e della natura in genere, conosciuto in Grecia come dell’Asia minore, raggiunse la sua forma più significativa nell’Atene del V secolo a.C. Strettamente connessa con l’epica, cioè il mito, in greco “o mythos” – parola e racconto che si fondono con l’azione, cioè con la rappresentazione diretta del dramma, nel cui “agire”, il pubblico vede davanti a sé i personaggi che compaiono come entità distinte e agiscono autonomamente sulla schené la scena, (in origine il tendone dei banchetti), provvisti ciascuno di una propria dimensione psicologica. Scrive Aristotele nella “Poetica” (9) che la tragedia, precisamente nata all'inizio dall'improvvisazione, "da coloro che intonano il ditirambo", eseguita cioè da satiri danzanti, e il cui termine pertanto, significherebbe «canto dei capri», appunto in riferimento al coro dei satiri, “era all'inizio breve e di tono burlesco perché conteneva elementi satireschi”. Solo più tardi il linguaggio si fece man mano più grave e cambiò anche il metro, che da tetrametro trocaico, il verso più prosaico, divenne trimetro giambico.
Questa informazione è completata da un passo delle “Storie” di Erodoto e da fonti successive, in cui si attribuisce al lirico Arione di Metimna di aver introdotto il ditirambo nella tragedia cosi detta. Ma come tutti noi sappiamo l'origine della tragedia greca è uno dei tradizionali problemi irrisolti della filologia classica. Gli studiosi hanno formulato una serie di ipotesi riguardo al modo in cui si sia compiuta l'evoluzione dal ditirambo alla tragedia. In generale, si ritiene che ad un certo momento dal Coro che intonava il canto in onore di Dioniso, si sia staccato il corifeo, ossia un capo coro che prese a dialogare con esso, divenuto in seguito vero e proprio personaggio legato alla rappresentazione stessa. In seguito sarebbe stato aggiunto un ulteriore personaggio, che non cantava ma parlava, chiamato hypocritè, ossia "colui che risponde", e che in seguito prenderà il significato di attore. Probabilmente, il dialogo che in questo modo nacque tra attore, corifeo e coro diede vita alla tragedia, da canto epico-lirico, il ditirambo divenne teatro, che a sua volta è all’origine dell’opera lirica.
La tradizione attribuisce a Tespi la prima rappresentazione tragica, avvenuta nel 534 a.C. durante le Dionisie istituite da Pisistrato. Si presuppone che egli fosse attico, appartenente al demo di Icaria. Delle sue tragedie sappiamo poco, se non che il coro era ancora formato da satiri e che fu certamente il primo a vincere un concorso drammatico, Aristotele sostiene che introdusse la figura dell’attore che rispondeva al coro. Inoltre Temistio, scrittore del IV secolo a.C., riferisce che sempre secondo Aristotele, Tespi abbia inventato il prologo e la parte parlata. Gli altri drammaturghi dell'epoca furono Cherilo, autore di probabilmente centosessanta tragedie (con tredici vittorie), e Pràtina di Fliunte che sicuramente gareggiò con Eschilo e operò dal 499 a.C., autore di cinquanta opere di cui 32 drammi satireschi, di cui però ci sono pervenuti solo i titoli, e che si vuole abbiano affiancato le rappresentazioni tragiche.
Quindi di un certo Frinico, del quale Aristofane tesse le lodi nelle sue commedie, come, ad esempio, nelle “Vespe” lo presenta come un democratico radicale vicino a Temistocle. Oltre ad aver egli introdotto nei dialoghi il trimetro giambico e ad utilizzare per la prima volta personaggi femminili, Frinico inventò il genere della tragedia ad argomento storico introducendo in essa una seconda parte recitativa, come nella sua “La presa di Mileto”, di cui solo adesso si cominciano ad avere maggiori informazioni. Da che ci si avviò verso la “trilogia” (Orestiadi), che sarà definitivamente adottata da Eschilo e dai suoi contemporanei e impostata secondo uno schema rigido, di cui si possono definire fin dall’inizio la struttura con precisione, che ha inizio con un prologo, da prò e logos, (discorso preliminare informativo), in cui uno o più personaggi introducono il dramma e spiegano l'antefatto, cosiddetti pàrodoi; l'azione scenica vera e propria si dispiega attraverso tre o più episodi, epeisòdia, intervallati dagli stasimi, stasimon, intermezzi in cui il coro commenta o illustra la situazione che si sta sviluppando sulla scena (o, più raramente, compie delle azioni); e infine la conclusione o esodo, in cui avviene lo scioglimento della vicenda.
Mentre la tragedia vera e propria nasceva e si strutturava, lo spirito più popolare dei riti e delle danze dionisiache sopravvissero all’interno del dramma, a dimostrazione del fatto che la tragedia antica non era solo uno spettacolo, come lo intendiamo oggi, ma piuttosto un rito collettivo della pòlis, da ché il teatro ben presto assunse la funzione di cassa di risonanza per le idee, i problemi e la vita politica e culturale dell'Atene democratica in cui la tragedia, parlando di un passato mitico, diventa metafora dei problemi profondi della società ateniese attuale. Il linguaggio usato nella tragedia ha ovviamente la sua importanza, i dialetti greci utilizzati sono l'attico (parlato ad Atene) per le parti parlate o recitate, e il dorico (dialetto letterario) per le parti cantate. Sul piano metrico, le parti parlate utilizzano soprattutto i ritmi giambici (trimetro giambico) giudicati i più naturali da Aristotele, mentre le parti corali ricorrono ad una grande varietà di metri, mescolando sovente giambi e dattili.
A questo proposito è emblematica la tragedia “I Persiani” di Eschilo, pensate, una tragedia di argomento mitico che riusciva a veicolare messaggi d'interesse civile e sociale tali da coinvolgere il pubblico in modo diffuso e partecipe. La storia è ambientata nella reggia di Susa, capitale dell'impero persiano, dove fin dall'inizio una serie di oscuri presagi, finanche il fantasma del defunto re Dario che accusa il suo successore Serse di aver peccato di superbia, preludono ad una grande catastrofe, annunciata alla fine da un messaggero che con straordinaria drammaticità racconta come la flotta persiana sia stata distrutta. La tragedia (l'unica ad argomento storico a noi pervenuta) venne rappresentata nel 472 a.C. ad Atene, otto anni dopo la battaglia di Salamina, quando la guerra con la Persia era ancora in corso, per cui, già in quel tempo, la voce di Eschilo si trasformò in un forte strumento di propaganda, non a caso il corego dei “Persiani” era lo stesso Pericle.
A cui Aristotele rispose col formulare il concetto di "catarsi" purificazione, secondo cui la tragedia poneva di fronte agli uomini gli impulsi passionali e irrazionali (matricidio, incesto, cannibalismo, suicidio, infanticidio...) che si ritrovano, più o meno inconsciamente, nell'animo umano, permettendo agli individui di sfogarli sulla scena innocuamente, in una sorta di esorcizzazione di massa. Esempio del valore della tragedia per diffondere il consenso intorno ai valori civici è la riflessione dello spettro di Dario nel terzo episodio:
Da i “Persiani” di Eschilo: (10)
“Laggiù li attende il culmine dei mali, la punizione della Dismisura e dei pensieri ignari degli dèi: marciando sulla Grecia, non temettero di spogliare le immagini divine, di ardere i templi e togliere dagli occhi gli altari e le dimore degli dèi, sconvolgendole dalle fondamenta. Soffriranno del male che hanno fatto non meno e tra poco non molto: l'edificio dei loro mali non è giunto al termine, anzi viene crescendo, ed abbondante libagione di sangue verseranno sotto le lance doriche a Platea. Mucchi di morti indicheranno muti agli occhi dei mortali, anche alla terza generazione che semineranno, che chi muore non deve andare oltre col suo pensiero a tutto ciò che muore. La colpa cresce ed ha per frutto spiga di pena e il suo raccolto è tutto lagrime. Guardando ricompense come queste ricordatevi di Atene e della Grecia, perché sprezzando il bene che possiede nessuno, desiderando quello d'altri, non rovesci la sua prosperità. Zeus sta come forte potatore della troppa arroganza, duro giudice”.
Le rappresentazioni delle tragedie ad Atene che – come si è detto – si svolgevano in occasione delle grandi Dionisie, feste in onore di Dioniso (11) celebrate nel mese di Elafebolione, verso la fine di marzo, erano organizzate dallo Stato e l'arconte eponimo, appena assunta la carica, provvedeva a scegliere tre dei cittadini più ricchi ai quali affidare la "coregia", cioè l'allestimento di un coro tragico: nell'Atene democratica i cittadini più abbienti erano tenuti a finanziare il servizio pubblico in favore della "liturgia", con una tassa supplementare. Durante le Dionisie si svolgeva tra l’altro un agone tragico, cioè una gara tra tre poeti, scelti dall'arconte eponimo forse sulla base di un copione provvisorio, ognuno dei quali doveva presentare una tetralogia composta di tre tragedie e un dramma satiresco.
Ogni tetralogia veniva recitata nello stesso giorno a partire dal mattino, così che le rappresentazioni tragiche duravano tre giorni, mentre il quarto giorno era dedicato alla messa in scena di cinque commedie. Alla fine dei tre giorni di gara si attribuiva un premio (Oscar?) al miglior coro, al miglior attore e al miglior autore. Il sistema utilizzato prevedeva che le giurie fossero composte da dieci persone non esperte, ma cittadini comuni estratti a sorte secondo una procedura complessa. Al termine delle rappresentazioni, i giurati ponevano in un'urna una tavoletta con scritto il nome del vincitore prescelto, tra le quali solo cinque tavolette venivano estratte a sorte, e solo in base a quelle veniva proclamato il vincitore. In questo modo la classifica finale era influenzata non solo dalla scelta dei giurati, ma anche in parte dalla fortuna.
Come scritto nel già citato “Poetica” di Aristotele, che a tutti gli effetti va ricordato come il primo studio critico sulla tragedia, ritroviamo elementi fondamentali per la comprensione di concetti quali “mimesi” dal verbo imitare e di “catarsi”, in senso di purificazione, da cui deriva la partecipazione e la passione travolgente dimostrata dai greci per le tragedie. Leggiamone uno stralcio: (12)
“La tragedia è dunque imitazione di una azione nobile e compiuta (..) la quale per mezzo della pietà e della paura provoca la purificazione da queste passioni. In altre parole, gli eventi terribili che si susseguono sulla scena fanno sì che lo spettatore si immedesimi negli impulsi che li generano, da una parte enfatizzando con l'eroe tragico attraverso le sue emozioni, pathos; dall'altra condannandone la malvagità o il vizio attraverso la hýbris - letteralmente "superbia" o "prevaricazione", l'agire contro le leggi divine, che porta il personaggio a compiere il crimine. La nemesi finale rappresenta la "retribuzione" per i misfatti, punizione che fa nascere nell'individuo proprio quei sentimenti di pietà e di terrore che permettono all'animo di purificarsi da tali passioni negative che ogni uomo possiede”.
La catarsi finale per Aristotele quindi, rappresentava la presa di coscienza dello spettatore, che pur comprendendo i personaggi, ne sentiva l’intima consapevolezza, permettendo loro il distacco dalle terrene passioni per raggiungere un livello superiore di saggezza. Il vizio o la debolezza del personaggio portavano necessariamente alla sua caduta in quanto predestinata per il concatenamento delle azioni, tale da sembrare in qualche modo favorito dagli déi, che non agivano direttamente, ma in quanto ex machina. La caduta dell'eroe tragico era però necessaria, perché se da un lato se ne ammirava la grandezza (si trattava quasi sempre di persone illustri e potenti); dall'altra si traeva profitto dalla storia ch’era narrata. Cito qui di proposito quanto affermato dal grande grecista, Jean-Pierre Vernant (13), per il quale la tragedia “è una simulazione”, nel senso utilizzato in campo scientifico, quasi un esperimento da laboratorio:
“La tragedia monta un' esperienza umana a partire da personaggi noti, ma li installa e li fa sviluppare in modo tale che [...] la catastrofe che si produce, quella subita da un uomo non spregevole né cattivo, apparirà come del tutto probabile o necessaria. In altri termini, lo spettatore che vede tutto ciò prova pietà e terrore, ed ha la sensazione che quanto è accaduto a quell'individuo avrebbe potuto accadere a lui stesso”.
In “Le troiane”(14) di Euripide, o “Le troadi” nella lingua originale, ad esempio, rappresentata per la prima volta nel 415 a.C. nell'ambito di una trilogia legata alla guerra di Troia, di cui facevano parte anche le tragedie Alessandro e Palamede (oggi perdute), assistiamo al massimo esempio “tragico” e se vogliamo “realistico” di una possibilità affatto remota, che al dunque può verificarsi dovunque c’è una guerra in corso (quante?), quindi di grande attualità. Tematica questa ripresa più volte a teatro e anche dal cinema, anche ambientata ai giorni nostri. In essa, la città di Troia, dopo una lunga guerra, è infine caduta. Gli uomini troiani sono stati uccisi, mentre le donne devono essere assegnate come schiave ai vincitori. Mentre Andromaca viene data a Neottolemo e Ecuba ad Odisseo, Cassandra è data ad Agamennone, al quale predice le disgrazie che attenderanno lei stessa e il suo nuovo padrone una volta tornati in Grecia, ed il lungo viaggio che Odisseo dovrà subire prima di rivedere Itaca. Andromaca subisce una sorte ancor più terribile, poiché i greci decidono di precipitare dalle mura di Troia Astianatte, il figlio che la donna aveva avuto da Ettore, per evitare che un giorno il bambino possa vendicare il padre e per porre fine alla stirpe troiana. Ecuba ed Elena si sfidano in una sorta di agone giudiziario, per stabilire le responsabilità dello scoppio della guerra. Elena si difende ricordando il giudizio di Paride e l’intervento di Afrodite, ma Ecuba svela infine la colpevole responsabilità della donna, fuggita con Paride perché attratta dal lusso e dall’adulterio. Alla fine la tragedia si è consumata con l’uccisione di Astianatte, il cui corpicino viene riconsegnato ad Ecuba per il rito funebre. E mentre Troia è data alle fiamme, le prigioniere vengono portate via e salutano per l’ultima volta la loro città.
Da “Le troiane” di Euripide, leggiamo insieme il compianto di Ecuba per Astianatte: (15)
“Deponete al suolo quel rotondo scudo di Ettore, spettacolo triste allo sguardo. Voi che andate superbi della vostra vittoria, e non potete altrettanto della saggezza, o Achei; avete compiuto un delitto davvero nuovo: uccidendo un fanciullo per paura. Poteva forse - questo voi temevate – rialzare le mura di Troia? Non ha potuto Ettore, non tutta una schiera di eroi, arrestarne la rovina. E ora che la rovina è qui, ora che i Frigi sono stati sterminati in una notte, avete paura di un fanciullo. Un timore che offusca la ragione è deplorevole.
Ecuba:
Caro, venne su te una morte orribile.
Se tu fossi in battaglia per la patria
morto e avessi gustato prima il bene
di gioventù, d’amore e del potere
che gli uomini fa simili agli déi,
forse ti chiamerebbero felice,
se in queste cose c’è felicità.
Ma tu avevi intravisto appena il mondo
senza scernere nulla dei suoi beni
né apprezzarne il valore né goderne,
che subito sei morto. O sventurato,
le mura della patria, arte di Febo,
ti videro cadere, dal tuo capo
infranto al suolo i riccioli scomparvero
che tua madre aggiustava con la mano
amorosa coprendoli di baci,
mentre dall’ossa rotte salta il sangue.
Oh, ch’io non parli più di cose orrende.
Piccole mani fredde, quale dolce
somiglianza recate con le mani
paterne. O care labbra, da cui spesso
uscivano parole d’infantile
vanto, mute per sempre. Quando i lembi
del mio peplo tiravi o non diceva
il vero la tua voce alta squillante:
«Nonna, mi taglierò per la tua morte
una ciocca di riccioli e verrò
con una lunga fila di ragazzi
a portarti il saluto sulla tomba».
Non tu me seppellisci, ma io te;
io ridotta così, senza più figli,
io vecchia senza patria, io curva, stanca
seppellisco il tuo corpo lacerato.
Oh le mie cure tenere, le veglie
Mie sul tuo sonno. Vane lontananze.
Che cosa potrà scrivere un poeta
su la tua tomba un giorno? Per paura
uccisero gli Achei questo fanciullo.
Vergognosa memoria per la Grecia.
Se non altro dal padre hai ricevuto,
se di nulla sei erede, almeno prendi
il suo scudo di bronzo al tuo riposo.
Scudo, che il poderoso braccio d’Ettore
proteggevi, hai perduto il tuo migliore
custode. Come dolce è a me guardare
nella tua cava imbracciatura il segno
del tuo polso e nel ferreo orlo del cerchio
la traccia del sudore, quel sudore
che dalla fronte di Ettore cadeva
quando stanco su te poggiava il mento
nei rapidi intervalli della mischia.
Portate qui, o Troiane, qualche cosa di quanto è rimasto per onorare il misero cadavere: la sorte non ci consente esequie pompose. Accontentati di quello che ho da offrirti. Folle allegrezza di chi si figura una felicità perpetua. La fortuna salta qua e là come una demente, né mai si ferma. E nessuno (infine) è felice”.
Leggiamo ora un passaggio della “Medea” altra tragedia di Euripide in cui si narra di come Giasone, l’eroe del vello d’oro, intende lasciare Medea, sua legittima moglie e padre dei suoi figli, per sposare Dirce, figlia di Creonte re di Corinto. E di come Medea non si rassegna e chiede in modo accorato a Creonte affinché obblighi Giasone a far ritorno a lei e ai suoi due figli:
Medèa: (16)
“Giove, e di Giove tu figlia, Giustizia,
e tu, raggio del Sole, alta vittoria
or dei nemici nostri, amiche, avremo,
e siam già su la via: speranza nutro
or che i nemici miei la pena scontino,
poi che quest'uom, dal lato ove il periglio
era maggiore, come un porto apparve
dei miei divisamenti. Indi la gomena
da poppa legherò, come io di Pàllade
giunga alla rocca, alla città. Sin d'ora
tutti vi voglio esporre i miei propositi,
né voi crediate che per gioco io parli.
Dei miei famigli alcuno invierò
a Giasone, e ch'ei venga chiederò
al mio cospetto; e, come ei giunga, blande
parole gli dirò: ch'io son convinta,
che mi par giusto quanto accade; e i figli
miei chiederò che restino. Non già
che abbandonarli io voglia in terra estranea;
ma con la frode voglio morte infliggere
alla figlia del re. Li manderò,
che a lei rechino doni: un peplo fine
e, foggiato nell'oro, un serto; e, ov'essa
ne abbellisca le sue membra, morrà
d'orrenda morte, e chicchessia la tocchi:
di tal farmaco i doni intriderò.
Ma tronco qui le mie parole, e gemo
per l'opera che poi compier dovrò:
ché morte ai figli miei darò: nessuno
v'è che salvarli possa. E, poi che tutta
di Giasone sconvolta avrò la casa,
e compiuto lo scempio nefandissimo,
partirò da Corinto, e dei figliuoli
la strage fuggirò: ché dai nemici
esser derisa, amiche, io non lo tollero.
Su via, la vita a lor che giova? Io patria
non ho, né casa, né rifugio ai mali.
Bene errai, quando le paterne case
abbandonai, credendo alle parole
d'un ellèno che il fio mi pagherà,
con l'aiuto d'un Dio: ché i fig1i nati
da me, piú vivi non vedrà, né prole
dalla sua nuova sposa avrà: ché deve
per i tossici miei morir la trista,
di trista morte. Me dappoco e fiacca
non creda, o rassegnata: anzi, al contrario,
per gli amici benigna, e pei nemici
funesta: a gloria cosí giungon gli uomini”.
Nella Tragedia Attica l’ufficio del Coro è così importante che molte tragedie s’intitolano ad esso, una consuetudine che prevale in Eschilo autore di Supplici, Persiani, Eumenidi, Coèfore, in cui sempre più spesso funge da protagonista prendendo parte diretta all’azione che si svolge sulla scena, mentre in altre funge da spettatore, limitandosi a consigliare, o ad ammonire i protagonisti veri e propri della tragedia. Così accade in Sofocle in Le Trachinie e ancora con Euripide in Le supplici, Le Baccanti e Le Troiane. Non di rado, come ad esempio in “Medea”, è il Coro che finisce col nascondere in seno un segreto e che rende possibile la soluzione del dramma in atto. Leggiamone insieme alcuni passaggi.
Coro: (17)
Strofe I
“Piú non ho speme che vivano i pargoli,
non piú: ché già verso la morte muovono.
Riceverà, riceverà la misera
sposa, dono fatal, l'auree bende.
Già per cingere il funebre
ornamento alla sua bionda cesarie,
la mano ella protende.
Antistrofe I
Essa vaghezza certo avrà di cingere
gli ambrosii raggi che dai pepli fulgono
e dall'aurea corona; e già per gl'Inferi
si fa bella: in tal rete ella cadrà,
in tale fato, o misera,
esizïale: ché sfuggire all'ultima
rovina non potrà.
Strofe II
E tu, tristo sposo, di principi perfido genero,
ignaro, conduci a sterminio
la vita dei figli, ed orribile
alla sposa prepari una morte.
O misero, male prevedi la sorte!
Antistrofe II
Ed ora te, madre infelice, compiango, che ai pargoli
la morte darai. Ne fu causa
il letto di nozze: ché l'empio
tuo sposo, che t'ebbe tradita,
ora ha con un'altra comune la vita.
(Entra Aio coi due bambini)
Aio:
Sono dal bando liberi, o signora,
questi fanciulli: di sua mano accolse
la regia sposa i doni, e si compiacque.
Pace, da questa parte, hanno i tuoi figli.
Medèa:
Ahimè!
Aio:
La ventura t'arride, e sei sconvolta?
Medèa:
Ahimè!
Aio:
Con le mie nuove il tuo lagno discorda.
Medèa:
Anche una volta, ahimè!
Aio:
Qualche sciagura,
senza saperlo, t'annunciai? Fu falsa
l'idea che un buon messaggio io ti recassi?
Medèa:
Fu quel che fu, l'annuncio: io non lo biasimo.
Aio:
Ché dunque il volto abbassi, e versi lagrime?
Medèa:
Non mi posso frenar, vecchio: tal danno
i Numi, ed a me stessa io stessa macchino.
Aio:
Fa' cuor: qui tornerai, grazie ai tuoi figli.
Medèa:
Ma saprò far che prima altri ne partano.
Aio:
Non sei la sola tu, che separarsi
debba dai figli: chi mortale nacque,
in pace sopportar deve gli affanni”.
Concedetemi qui una digressione seppure inerente al citare da parte mia l’opera lirica “Medea” (18) di Luigi Cherubini, per fare omaggio a Maria Callas che ne fu interprete incomparabile, entrata a far parte della leggenda della lirica. Ciò serve anche a dimostrare come la forza estrinseca della tragedia abbia influenzato gli animi di artisti anche molto vicino a noi senza aver perso l’importanza della sua carica emotiva. Pier Paolo Pasolini ne trasse un’opera cinematografica a sua volta originale, vuoi per il modo in cui il film venne realizzato: cinepresa a spalla, utilizzo di effetti scultorei nella fotografia ecc. che se pure molto criticata, lascia pur comprendere le difficoltà di interpretazione di un’opera d’arte, la tragedia appunto, vista dall’occhio millenario che la distanzia. Distanza che tuttavia sembra annullarsi se realizziamo che da quando fu scritta autori di una certa rilevanza ne hanno tratto spunto per altre opere e arrangiamenti per balletti e altro, a cominciare da Seneca che segna un punto di arrivo, ai limiti dell’espressionismo verbale, nella quale l’azione drammatica è sostituita dalla declamazione dei sentimenti, contrassegnata dallo scontro di passioni estreme. Dall’illustre senatore romano a Iannis Xenakis il passo è assai lungo, tuttavia non impossibile se la sua opera “Polytope”(19) inizialmente portata in scena nell’area sacra di Micene, pensate con quattro orchestre disseminate tra il pubblico, fu definita dalla stampa “opera monumentale dalla quale sembra di veder risorgere tutta la gloria degli Atridi”.
L’opera, che nel 1967 ha aperto il Padiglione della Francia all’Espozione Universale di Montreal , e che si compone di una parte strumentale, cori, movimenti scenici di massa e maschere che raffigurano gli eroi del mito, ha segnato una momento importante per la tragedia antica che di colpo è stata proiettata in avanti nel XX secolo della nostra era e nell’anima della Grecia di oggi. Iannis Xenakis è inoltre l’autore di una composizione per coro d’uomini e orchestra, formata da clarinetto, contrabbasso, trombone, violoncello e gaites, per la “Medea” (20) di Seneca, andata in scena al Théàtre de France nel 1967, nella quale il musicista ripropone con molta affinità quelli che dovevano essere i suoni d’accompagnamento e l’effetto d’insieme corale delle voci che caratterizzavano il Coro nella tragedia classica. In questa pur breve (25 minuti) della suite registrata su disco, è rilevante come il compositore sia tornato agli esordi ponendosi tuttavia nella prospettiva moderna funzionale, integrata al movimento scenico, alla nuova tragedia greca, non più come nell’uso antico per distinguere le parti narrative e recitative del testo, bensì facendo di essa una protagonista della messinscena.
Del resto, gli effetti prodotti dalla rappresentazione della tragedia sul pubblico ateniese non sono paragonabili a quelli che procurava fino al secolo scorso il melodramma nostrano. Il teatro è per noi cultori di oggi una delle tante forme di intrattenimento dopo la tensione accumulata dall’attività quotidiana. Come già ho detto per i greci era esattamente l’opposto. Assistere a una rappresentazione tragica, significava allora partecipare a un rito, al punto che la novità dell’argomento non sempre costituiva motivo d’interesse. Il mito, da cui il dramma derivava il suo contenuto, rappresentava il vero culmine della situazione, in quanto patrimonio culturale di tutti, perché già conosciuto attraverso l’epica cantata dai poeti lirici. I greci infatti assegnavano un fine moralistico a questa forma d’arte, alla quale attribuivano l’evolversi di una forma poetica educatrice per eccellenza, così grande era ritenuta la sua efficacia che lo Stato provvedeva a sollevare i meno abbienti, dalla spesa del teatro, offrendo loro di assistere gratuitamente agli spettacoli pubblici, dando così atto di un’attenzione per il sociale di grande levatura civile.
Lasciamo dunque il teatro per affrontare l’altro aspetto della tradizione greca che vede all’origine dei “giochi ginnici”, così detti agoni e dedicati alla salute pubblica, in cui i giovani delle città greche concorrevano in gran numero nella città di Olimpia, da cui i più famosi Giochi Olimpici, così come ce li ha tramandati la tradizione. Questi si tenevano in apposite costruzioni come lo stadio o l’ ippodromo (per le corse dei cavalli), sviluppati, per ragioni funzionali lungo assi longitudinali che davano all’insieme una forma allungata invece che semicircolare del teatro. Pur tuttavia lo scopo era lo stesso, cioè quello di contenere il folto pubblico che vi andava per esaltare le qualità naturali e dinamiche della persona umana educata con l’intelligenza e la volontà a dare dimostrazione delle sue capacità e delle sue virtù. E poiché i giochi (almeno alcuni) venivano svolti dai soli uomini per lo più spogliati di tutto, si vuole che la scultura greca si sia evoluta grazie alla possibilità di ammirare le fattezze dei corpi nudi, così come le pose e le torsioni dei movimenti. Differentemente gli artisti non rappresentavano mai la donna nuda, i casi sono davvero sporadici e facevano molto scalpore, e preferivano invece che nelle forme scoperte, cercare gli effetti plastici negli sviluppi del costume e del corpo che si disegna sotto le pieghe delle vesti.
Come scrive Arnold Hauser in “Storia sociale dell’arte”: (21)
“L’aristocrazia ateniese da principio non tollerava il nudo virile se non come richiamo ai ludi atletici, al culto della perfezione fisica e al mito del sangue. Olimpia, dove le statue di efebi nudi furono erette, era il principale centro propagandistico dei Greci: là si foggiava l’opinione pubblica del paese, e l’aristocrazia vi acquistava coscienza della propria unità nazionale (..) in cui prevale il concetto dell’ areté, sintesi di prestanza fisica e di disciplina militare, che si richiama all’origine, della razza, alla tradizione; la kolakagathìa, ideale equilibrio fra il corpo e lo spirito, fra le qualità fisiche e morali; la sophrosyne, ideale dominio di sé, disciplina e misura”.
La tradizione vuole che i Giochi Olimpici abbiano avuto inizio nel 776 a.C., mentre altri, di conseguenza successivi, si fanno risalire al 586 a.C. i Giochi Pitici, al 581 a.C. gli Istmici, e al 573 a.C. e più o meno alla stessa epoca i Nemei, che offrivano al tempo stesso occasione per competizioni canore e musicali di grande rilievo culturale e non solo. Ai giochi erano abbinati anche corrispettivi concorsi femminili di bellezza, fatti risalire al tempo di Omero e intitolati ad Era, che avevano luogo nel santuario di Pira al centro dell’isola di Lesbo. Tuttavia un’altra forma artistica prese da qui l’avvio per la grande evoluzione che avrà in avvenire, e questa è la danza coreografica che accompagnava l’inizio e la fine dei Giochi, momento non solo di esplosione di bellezza, bensì di effusione di creatività ed eleganza, doti tutte femminili che non sfuggivano all’interesse dei greci. Per questo erano tenuti in gran conto alcuni santuari tra i quali, e in particolar modo, quelli di Delfi e Delo, le cui divinità Apollo e Athena (la frivolezza e il rigore) rappresentavano l’ordine divino, interprete l’uno ed esecutrice l’altra del volere di Zeus imperante su tutta la Grecia.
Simonide, Bacchilide e Pindaro, furono i grandi compositori epinici (canti epinici) che raccontarono gli eventi dei “giochi” sulla metrica della “martinàdes” una forma breve di poesia cantata in accompagnamento alla danza che si fa risalire ai più antichi rituali dionisiaci. Il canto era sostenuto da una elementare strumentazione fondata sull’accompagnamento di flauti, cimbali e tamburelli nelle cerimonie più antiche, e che, insieme ad altri strumenti ed ensemble strumentali facevano la loro apparizione nelle competizioni musicali. Frammenti rinvenuti, ahimè in pessime condizioni di conservazione, sono quanto rimane di brani monodici che narrano le gesta dell’eroe omerico Achille, nonché la melodia dell’Oreste di Euripide, due Inni delfici, e i testi di due peana (canti di vittoria) incisi sulle lastre di marmo che rivestivano le pareti del così detto “tesoro degli ateniesi” a Delfi, oggi conservate nel museo locale. Si tratta di due inni di liturgia rituale in omaggio al dio Apollo risalenti al 138 a.C., eseguiti per la prima volta in questo santuario da cori ateniesi di cui, quello qui di seguito trascritto non è noto l’autore, mentre il secondo è di Limenio Ateniese:
Primo Inno Delfico. (22)
“Ascoltate, figlie di Zeus tonante dalle belle braccia,
voi che avete avuto in sorte l’Elicona selvoso:
venite a cantare con inni il fratello Febo dalla chioma d’oro,
egli che per dimora abita le vette di questo monte Parnaso,
e insieme con le inclite donne di Delfi, avanza verso le fonti
di Castaglia dalla bella corrente, per il promontorio di Delfi
spingendosi al colle profetico.
Ecco (è qui) la nobile Attide,
grande città, sita in una contrada che non subisce danni,
grazie alle preghiere della Tritonide armata.
Sui santi altari Efesto brucia cosce di giovani tori,
fumo e profumo d’Arabia si levano verso l’Olimpo,
l’aulo acuto tesse la melodia con arie variate, e la cetra d’oro
di amabile voce risuona per la melodia degli inni.
Tutta la folla dei musici che hanno stanza nell’Attide,
presso questo monte dalle cime nevose celebrano Te, glorioso figlio di Zeus.
Te che a tutti i mortali annunci gli oracoli divini e sinceri,
poi che conquistasti il tripode profetico, custodito dal drago nemico,
quando ne colpisti il corpo maculato e sinuoso con le tue frecce, sin che la
bestia selvaggia spirò scagliando sibili continui e selvaggi …
. . .
Quando l’Ares dei Galati …”.
Credo non ci sia molto da aggiungere, in questo inno troviamo tutto quello che necessita alla nostra ricerca antropologica, sociologica ed etnomusicologica, per approfondire la geografia dei luoghi, le usanze e costumi del popolo greco, quei sentimenti che ci portano diretti nel cuore dramma, il cui svolgersi, apre e chiude la tragedia di generazioni di guerrieri e d’eroi, personaggi e protagonisti, che hanno fatto della propria vita, vissuta o meno, un mito, segnando la storia della filosofia e del pensiero umani. Non di meno che hanno dato ampio spazio al teatro, alla maschera e alla musica, ai cori e alla letteratura, col comporre inni di lode e peana in onore degli déi che nell’Olimpo ascoltavano ingrati le voci degli umani, di intima e suprema devozione, beandosi degli aromi e profumi che questi bruciavano per incensare le loro are profetiche, sulle quali era onoravano la propria mitica religiosità, e dalle quali, noi oggi abbiamo iniziata la nostra ricerca ulteriore approfondita per ogni singola tematica enunciata.
Cerimonie, giochi, canti, danze, musica, rappresentazioni, spettacoli erano fra i greci strettamente legate alla celebrazione dei miti degli déi ed eroi che ne avevano generato la stirpe, funzioni commemorative e solenni che si tenevano attorno alle are dei templi e in funzione della grandezza e dell’importanza degli dèi detentori. Lo attestano gli innumerevoli reperti archeologici come vasi dipinti, fregi ornativi, statue e bassorilievi, nonché i testi letterari di molte opere a noi pervenute. La cerimonia indubbiamente più importante era così detta “paratenaica”, cioè in onore di Athena-Partenope, la massima autorità dopo Zeus, che si teneva sull’Acropoli di Atene, davanti al Partenone, uno dei monumenti più significativi dell’antichità. Come in Carlo Giulio Argan: (23)
“Il grande tempio di marmo pentelico di ordine dorico, visibile da ogni parte della città, fatto erigere da Pericle sull’Acropoli di Atene a simbolo della pace fatta con i persiani e segna il passaggio dalle tradizioni religiose più arcaiche conservate e verosimilmente trasmesse oralmente dalle singole comunità, a quella che potremmo chiamare l’ideologia religiosa della Grecia unificata(..). Misura più di trenta metri nella parte frontale costituita da otto grandi colonne scanalate; e settanta metri per lato formato di 17 colonne che superano i dieci metri di altezza e quasi due metri di diametro alla base. (..) Suddiviso all’interno in tre navate da due file di colonne (..) la cella che un tempo conteneva la gigantesca statua di Athena d’oro e d’avorio, ad opera di Fidia”.
Ciò che a noi più interessa però, ai fini della nostra ricerca etnologica e musicale, è la decorazione scultorea esterna e interna al tempio, concepita da Fidia, questo grande scultore e architetto dell’antichità, e compiuta sotto la direzione di altri mastri scultori provenienti da varie città dell’Attica. Questa, oltre a presentare gruppi statuari a tutto tondo visibili sui due frontoni, presenta nelle novantadue metope della trabeazione interna alla cella, bassorilievi della massima importanza storica per la storia dell’arte e l’evoluzione della scultura greca, delle quali almeno 51 si trovano oggi esposte al Brithish Museum di Londra. Nel fregio sono, infatti, raffigurati i momenti più salienti della processione così detta “paratenaica”, in cui sono ben visibili i preparativi per la grande parata in onore di Athena-Partenope, con cavalieri che si preparano alla sfilata, portatori di doni, vestali eteree, suonatori di lira, flauti e trombe, danzatori e coreuti nei costumi della loro arte, che sfilano davanti ai nostri occhi attoniti come allora, come vivessero nell’attimo costante dell’attesa che li separa da noi solo a causa della rigidità della pietra:
“E s’avanza (il corteo) …
di flauti dolci (e lire) si mesceva il suono,
e fragore di crotali … cantavano
fanciulle un inno sacro e fino al cielo l’eco
divina si spandeva, e il riso
per le vie d’ovunque
…
Misti aromi di mirra, di casia, d’incenso”. (24)
Il Partenone continua a vivere oggi di quell’antico splendore, seppure spoglio di molte delle sue parti, del fasto e della grandiosità conservate nelle sue forme e dimensioni architettoniche che ne facevano una delle “sette meraviglie del mondo”, per cui salire oggi all’Acropoli, superati i propilei che fanno da porta all’area sacra di un tempo ci si può ancora sentire immersi nella grandezza della “pace” che verosimilmente lo ha ispirato. Scrive Tersicore: (25)
“Musa, lascia le guerre
e canta tu con me le nozze degli dèi,
canta i conviti degli uomini,
le feste dei beati”.
Di rigore una visita ai monumenti più insigni come l’Eretteo e i Propilei che racchiudono l’area sacra, non di meno al Museo dell’Acropoli dove è possibile vedere alcune sculture e parte delle metope che adornavano il Partenone. Si discende poi per la via sacra e ci s’immette nell’agorà, un intricato labirinto di strade e stradine sotto l’Acropoli che prende oggi il nome di Placa, centro del massimo sfruttamento turistico formato da ristoranti, bar, taverne, pub ecc, che danno luogo a un macroscopico bazar dove si cerca il divertimento nella musica e nei balli tipici in mezzo agli odori di “sufflaki” (spiedini di carne), “mussakà” (melanzane), e al profumo dei vini aromatici (di produzione locale), in mezzo al mescolarsi di numerose lingue e di musica che vaga nell’aria, e che le orchestrine, distanti pochi metri l’una dall’altra, riempiono di suoni insoliti.
Il turista, distratto da un bouzouki o da un liuto in un orecchio, da un clarinetto o la voce stridula di un cantante nell’altro, poco si orienta di cosa esattamente stia ascoltando, lasciandosi trascinare tra i tavolini e sollevare le gambe in un “sirtaki” movimentato o un “hassapiko” distensivo che si ritroverà poi sul conto. Indubbiamente l’esperto e il ricercatore possono avvalersi oggi di registrazioni eseguite da autentici virtuosi di questi strumenti e non è necessario per lui andare alla ricerca di quell’Orfeo il cui canto accompagnato dalla lira ammaliava gli déi dell’Olimpo, l’uomo, la natura, ma anche le divinità infernali che, infatti, gli consentirono di ritornare dal Regno delle Ombre per trovare Euridice. Leggenda questa le cui origini si perdono nel groviglio della mitologia greca in cui le corrispondenze musicali si sovrappongono all’infinito. Scrive Paolo Aldo Rossi: (26)
“Se la grande metafisica considerava la musica e la filosofia pressoché identiche sul piano sia conoscitivo sia pratico, il mito greco racconta altre storie. Si pensi, per esempio, alle molte narrazioni fantastiche: Apollo, il dio della musica e della medicina, con il suono della lira dava la vita, e con l’arco (identico strumento) dava la morte; le Muse, figlie di Zeus e di Mnemosine (la memoria), rappresentavano i più diversi momenti della musica, del canto, della danza, della poesia, del linguaggio, della storia e della scienza; Orfeo che, con la sua cetra ammansiva bestie feroci, piegava alberi e piante, mitigando gli animi degli uomini; Anfione, fratello gemello di Zeto, costruì le mura di Tebe chiamando a sé le pietre con il solo suono della lira; l’oracolo di Delfi per mezzo di melodie e canti rituali sedava le crisi di manìa; le Sirene incantavano i marinai con lire, flauti e canti”.
Narra la mitologia che la voce di Orfeo, in qualità di figlio divino, possedeva poteri soprannaturali tali che al suono della sua lira (di cui è ritenuto inventore), la natura tutt’attorno si ridestava, gli alberi si piegavano al suo passaggio e le anime più rudi divenivano gentili, e che finanche gli animali più feroci abbandonavano di correre dietro le prede e lo seguivano. Si vuole che il suo canto melodioso e straziante fosse più dolce di quello delle Sirene dalle quali trasse in salvo gli Argonauti, e che intenerisse i demoni dannati degli inferi che, per un istante, li faceva sentire sollevati dall’eterno tormento che li assillava. Infine fu il suono della sua lira, altri dicono del canto appassionato della sua voce, a riportare Euridice di qua dalla morte.
La critica moderna discute se Orfeo sia un personaggio storico o una figura puramente mitica. In campo letterario rivestono comunque notevole importanza i frammenti dei poemi che già in epoca molto antica andavano sotto il suo nome, ma della cui autenticità dubitava già Aristotele. Solo una più precisa conoscenza dell’ “orfismo” , delle sue origini, della sua consistenza come movimento e del suo vero indirizzo, permetterebbe di valutare gli elementi del mito, distinguendo quelli più antichi da quelli più recenti, quelli di origine sacra da quelli poetici.
Inizialmente il mito della discesa di Orfeo nel mondo sotterraneo per riprendere la moglie Euridice e riportarla nel regno dei viventi narrava che infine egli avendo violato la condizione di non voltarsi indietro lungo il percorso in cui doveva precedere la donna per riportarla tra i viventi, veniva fulminato da Zeus. Ma un altro mito orfico, raffigurato in pitture vascolari antiche, riporta all’uccisione e allo strazio di Orfeo da parte delle donne tracie o Menadi infuriate. Ne risulta quella che probabilmente è la trama di un rifacimento di un’altra opera più tarda, scoperta solo nel XVIII sec. l’ “Orphei Tragodia” dove le motivazioni misogine e omosessuali che scatenano l’orgia bacchica e lo sbranamento (omofagia) del poeta sono censurate, come del resto avviene nei successivi rifacimenti drammatico musicali del mito. Delle molte opere che la mistica ascrive ad Orfeo ci sono giunti 87 brevi componimenti poetici in esametri, noti col nome di Poemi Orfici e “Inni Orfici” (27) un’esposizione delle dottrine teosofiche dell’orfismo, la cui fama era già diffusa all’inizio del sec. VI a.C., di cui troviamo traccia in Alceo e che, sembra, venissero enunciati (o forse cantati) con l’accompagnamento di una musica adatta, di un’opportuna disposizione dell’animo e delle circostanze ben note al celebrante e che documentano la particolare interpretazione orfica della divinità del politeismo greco. Delle testimonianze in nostro possesso, nessuna è di indubbia antichità.
Come scrive Eugenio Faggin: (28)
“La più remota, ci è offerta dal papiro berlinese 44, «Orfeo … fece gli Inni che Museo, con poche emendazioni, mise in iscritto», risale al II-I sec. a.C., ma le condizioni del papiro sono tali da richiedere non pochi né lievi emendamenti; la più sicura, del sec. II d. C. è di Pausania: «chiunque sia istruito in fatto di poesia sa che rimangono degli inni di Orfeo, che ciascuno di essi è molto breve e che tutti insieme non sono un gran numero. I Licomedi li sanno a memoria e li cantano nel celebrare i loro riti. Per la eleganza dei versi essi avranno il secondo posto dopo gli Inni di Omero, ma la maestà divina ne hanno anche più di quelli».
Da “Inni Orfici” Leggiamo qui di seguito, questo canto VII intitolato “Agli Astri” (29) (profumo di aromi):
“Degli astri celesti il sacro splendore invoco,
con religiosi canti chiamando i numi augusti.
Astri celesti,
figli diletti della mera Notte,
che v’aggirate intorno al trono
fiammanti,
ed effondete uno splendore immortale, o padri
di tutte le cose
che segnate le tappe del destino e annunciate
il Fato universale,
che reggete il cammino degli uomini mortali
fissato dai numi
ed errando nei cieli sorvegliate la zona delle
sette luci;
astri eterei e terreni, veloci come la fiamma,
ognora indistruttibili,
che rischiarate l’oscuro manto della notte
col vostro fulgente scintillio, benevoli guardiani
delle tenebre,
venite alle sapienti prove del sacro rito
e affrettate la nobile corsa verso le cerimonie
gloriose”.
La ricerca qui avanzata in campo musicale ci porta ancora più lontano, senz’altro alla vena idilliaca che stiamo inseguendo fin dall’inizio tanto congeniale alla favola mitologica quanto al canto, alla danza e alla strumentazione che l’accompagna e che fanno da riscontro alla levità fiabesca che irradia una luce ferma e irreale non priva di preziosità sul colorito mondo idealizzato che un acuto senso della fugacità anima e inquieta. Mi riferisco qui al mito di Orfeo, la cui eco è giunta fino a noi attraverso centinaia di riproposizioni in musica, canto, letteratura, balletto, cinema e in tutta l’arte figurativa ecc. Conosciuta e ripresa già in epoca ellenistica dai romani che la derivarono dagli alessandrini, in seguito sviluppata da Virgilio nelle “Georgiche”, poi da Ovidio nelle “Metamorfosi” nelle forme stilizzate dell’egloga pastorale, ne risulta quella che è probabilmente la prima opera teatrale di contenuto profano.
Il mito di Orfeo, da cui nacque poi il movimento religioso di tipo iniziatico dell’Orfismo, è stato celebrato nelle letterature moderne da Angelo Poliziano nella celebre “Favola di Orfeo” (1480), dalla quale è è tratto il libretto della favola in musica “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi (1607). E successivamente da S. Landi nella “Morte di Orfeo” (1619), da Lope de Vega e Calderon de la Barca che ne trassero commedie con nomi diversi.
Tra le opere musicali vanno certamente ricordate “L’Orfeo” di Luigi Rossi (1647); di W. Gluck (1762)su versi di R. Calzabigi; di Franz J. Haydn (1793); di Franz Liszt che compose un poema sinfonico intitolato “Orfeo” (1854); l’opera comica di J. Offenbach “Orfeo all’Inferno” (1858); R. Ducasse che ne trasse un mimodramma (1913) ed E. Krenek con l’opera “Orfeo e Euridice”(1926). Fino ad arrivare alla bellissima pellicola cinematografica “Orfeu Negro” (vedi discografia) di A. Camus/ V. De Moraes del 1959. Inoltre il mito di Orfeo fu soggetto prediletto di numerosi artisti dell’antichità che ritroviamo dipinto su vasi, scolpito in bassorilievi famosi; in epoca moderna preso a soggetto per quadri e sculture di artisti famosi, tra cui figurano Bellini, Tintoretto, Rubens, Bruegel, Poussin, Corot, Delacroix, Spadini ecc.
Un curriculum non proprio indifferente, lasciatemelo dire, se si pensa che solo in veste musicale non si contano le incisioni riferite alla “favola in musica”. Ed è a questa che faccio qui riferimento, col segnalarvi “L’Orfeo” (30) di Claudio Monteverdi su libretto di Alessandro Striggio, inciso da Nikolaus Harnoncourt con Concentus Musicus Wien con strumenti originali, e che vede la partecipazione di Lajos Kozma, Cathy Berberian, Nigel Rogers, Max van Egmond, da cui è tratto il “lamento” che segue:
Orfeo ad Eco.
“S’hai del mio mal pietade io ti ringrazio
di tua benignitade.
Ma mentr’io mi querelo,
deh, perché mi rispondi
sol con gli ultimi accenti?
Rendimi tutti integri i miei lamenti.
Ma tu, anima mia, se mai ritorna
la tua fredda ombra a queste amiche piagge,
prendi da me queste tue lodi estreme,
ch’or a te sacro la mia cetra e ‘l canto,
come a te già sopra l’altar del core
lo spirto acceso in sacrificio offersi.
Tu bella fusti e saggia, in te ripose
tutte le grazie sue cortese il cielo,
mentre ad ogni altra de’ suoi don fu scarso.
D’ogni lingua ogni lode a te conviensi,
ch’albergasti in bel corpo alma più bella,
fastosa men quando d’onor più degna.
Or l’altre donne son superbe e perfide
ver chi le adora, dispietate instabili,
prive di senno e d’ogni pensier nobile,
on’a ragion opra di lor non lodasi;
quinci non fia giammai che per vil femmina
Amor con aureo stral il cor trafiggami.
…
Si non vedrò più mai
de l’amata Euridice i dolci rai(?)”.
Ora, quali che fossero i canti, a noi interessa più il modo che nell’antichità i greci avessero di cantare. Acciò va rilevato che tra le più antiche canzoni “dhimotikà” a noi rinvenute sussistono interazioni molto forti con antecedenti presenti nei canti religiosi o d’invocazione e, per quanto le notazioni antiche elleniche siano andate perdute, alcuni musicologi pensano che proprio queste siano gli autentici capostipiti di quella tradizione che annovera nel suo interno schemi di riferimento persiani e probabilmente nelle scale più tardive d’origine bizantina:
“La musica ecclesiastica bizantina è uno dei due rami della musica nazionale dei greci, l'altro polo del loro essere, radicato in Grecia nelle sue maniere musicali fin dall’antichità, così come lo sono le sue forme poetiche, ritmiche e melodiche e più particolarmente come si è sviluppata nell’arte cristiana durante il periodo Bizantino. Usando la poesia di grandi poeti e innografi, è un modo unico di lodare Dio e musicalmente parlando, di dichiarare le verità cristiane che la compongono. Più melismatica durante il periodo Bizantino, e regredita negli ultimi secoli a forme ancora più semplici, essa enfatizza il canto piuttosto che la musica. Melodico e monofonico, non si esprime in contrappunto per non interrompere e confondere il significato del poema, consolidando piuttosto il fulcro fondamentale della sua essenza con intervalli consoni. L'ornamentazione e l’ inflessione vocale nel suo svolgersi è indicato dai molti segnali musicali della sua notazione e le alternazioni dagli intervalli nella sua struttura modale. Lontano dall'essere inflessibile o statica, il canto va considerato un vivendo la tradizione in crescendo. I cambi continui e i miglioramenti nella sua forma, e particolarmente nella sua notazione, hanno seguito i prototipi di secoli precedenti, così da risultare all’ascolto una musica nuova e antica al tempo stesso. È questa la musica antica e sempre nuova dell'Ortodosso e più specialmente dei greci del presente”. (31)
Alla liturgia bizantina sono dedicati almeno tre album sonori: “Byzantine Hymns of Christmas”, “… of the Epiphany”, “… of the Epitaphios and Easter” (32) prodotti dalla Society for the Dissemination of National Music con sede in Atene: Lo stesso proposito comunicativo si ripresenta nella bellissima “Missa Greca” (32) elaborata da Mikis Teodorakis, sulla base liturgica della Messa Ortodossa, della quale riproduce ogni singolo passaggio rituale. Purtroppo non ho maggiori informazioni a riguardo perché tutte le note di testo sono strettamente riportate in greco antico, lingua che non mi è dato conoscere. Diversamente da altre culture che musicalmente prediligono il testo con andamento melodico a litania, con assenza di impianti strofici e versificati, i canti greci, sia quelli rituali, narrativi, di lavoro, celebrativi o religiosi, utilizzano strutture a gruppi di versi, tuttavia si antepone qui la danza ritmica al testo.
Uno degli ambienti preferiti dal popolo greco per cantare è la taverna dove si va nei momenti di riposo, o i ristoranti rustici, le osterie, le locande dove ci si reca in occasione di cerimonie festose. Il canto da tavola “tou trapeziou” è stato fin dall’antichità eseguito e messo in pratica all’interno di simposi o banchetti. Fanno parte di questo repertorio le improvvisazioni pastorali, i canti melanconici, i canti erotici, i lamenti, le ninne-nanne, le canzoni per la questua ecc. Ma vi sono anche canti rivolti al mare “tou talassou” eseguiti per scongiurare le tempeste o per avere una pesca abbondante; canti propiziatori rivolti alla natura affinché dia i suoi benefici; canti dell’amore e dell’esilio “tis xenitiàs”, l’allontanamento dalla patria per ragioni sia politiche sia di lavoro. Non mancano i canti rivolti ai briganti, ossia a coloro che lottavano contro gli invasori (turchi o nazifascisti).
Importantissimi sono i “canti cleftiki”, nati nelle regioni settentrionali per reazione all’occupazione ottomana: i contadini clefti si ripararono sui monti dove condussero una guerriglia contro gli invasori. Questi canti, interpretati sempre da uomini, hanno per argomento combattimenti, lotte ed episodi di eroismo, ma talvolta anche scene della vita quotidiana. Uno di questi è senz’altro il ribetiko, una forma di canto nostalgico con il quale si vuole esprimere il rammarico, l’amarezza e la tristezza dovuta all’abbandono delle terre d’origine. I ribetika del Pireo ad esempio, con i loro testi generalmente poco sentimentali, la loro combinazione stridente di bouzuki e baglamas e le loro danze di uomini, meglio rappresentano il sentimento comunitario contro ogni sorta di repressione. Il cantare rebetiko si è poi trasformato in “canto di lotta politica” (almeno fino all’epoca dei colonnelli), attraverso il quale il popolo mostrava rancore contro l’occupazione straniera e contro il potere della dittatura.
Colgo qui l’occasione per parlare della danza coreografica che si svolgeva attorno all’ara sacrale durante le cerimonie per il culto della divinità che l’ospitava: il “syrtòs” (oggi danza nazionale greca), e come la si può ammirare dipinta in molti vasi d’epoca ellenistica. Il “sirtaki” che, nel suo svolgersi prevede di prendersi per mano o poggiando il braccio disteso sulla spalla di qua e di là dei vicini danzatori formando un cerchio aperto, e avanzando ora da un lato ora dall’altro incrociando le gambe a forbice, per poi tornare a unirle e facendo una piccola flessione sulle ginocchia, per poi ripartire con un tempo più veloce, perdurando fino a stancarsene. È questa la famosa danza di Zorba, come l’abbiamo potuta ammirare nel film “Zorba il Greco” (33) per la regia di M. Cacoyannis, con uno straordinario Antony Quinn, tratto dall’omonimo romanzo di Mikis Kazantzakis, e nel quale facciamo conoscenza di uno strumento antico a corde affine al cembalo che richiede un certo virtuosismo per essere suonato: il santouri, di forma trapezoidale che si suona con un minuscolo plettro. Come dice Zorba: “suonare il santouri è cosa diversa è come un animale selvaggio, ha bisogno di libertà …”.
Le danze greche sono ripartite, a seconda della loro origine, in due gruppi principali: rurali o urbane. Le danze rurali sono generalmente ballate da più persone, disposte a cerchio sempre aperto, con un danzatore-guida, in modo non diverso dalla coreutica dell’antichità, con le mani tenute all’altezza dell’omero. Ma forse la più diffusa e antica è il “kalamantianòs” originaria del Peloponneso, (dalla città di Kalamata), e che si balla in cerchio mentre chi guida compie salti e giravolte. In altre, del tipo “klestòs” tipica dell’area Roumeli, che si balla sempre in cerchio aperto, le donne e i bambini, tenendosi a braccia tese, si alternano in due gruppi, e mentre uno canta le liriche tradizionali, l’altro l’accompagna danzando. Un’altra molto famosa è il “pentozali” di Creta, simile alla “pirrica” sempre di origine bellica ma originaria di Sparta, eseguita dai guerrieri, cos’ detta perché ha cinque passi di base. Nelle danze cosiddette urbane il ballo è per lo più di coppia, la più diffusa è senz’altro il “khasapiko” in cui i ballerini sono al massimo due e i cui passi e le figure sono molto spesso improvvisati, al contrario di quelli semplici e ripetitivi delle danze rurali.
Mentre il santouri dal suono intimistico e malinconico è per lo più utilizzato per intonare le vecchie melodie clefte del popolo macedone, le canzoni allegre sono invece intonate al bouzuki, lo strumento a corde della famiglia del liuto dal suono simile al mandolino partenopeo, che trova la sua utilizzazione nella musica popolare soprattutto nei ritmi a-ballo che rallegrano le feste e le cerimonie nuziali, i cui preparativi si protraggono per settimane con la scelta dei costumi tradizionali con i quali usano vestirsi gli sposi e che in alcune zone risalgono alla tradizione bizantina; seguono la preparazione dei piatti tipici e dei dolci, le collane di fiori multicolori in forma di ghirlande che la tradizione più antica deponeva ai piedi degli déi. Qui i brindisi, i canti e le danze, hanno inizio tre giorni prima, in casa dei fidanzati poi il tutto si trasforma in una festa popolare di tipo comunitario, diversa da villaggio in villaggio, da isola a isola. Il rito nuziale così come è rappresentato nel simbolismo greco-ortodosso si svolge di solito in un giorno festivo e si tiene nella chiesa davanti al sacerdote vestito per l’occasione con paramenti ricamati d’oro. La sposa fa il suo ingresso con in testa un copricapo ordinato sulla fronte che lascia intravedere i cappelli sui lati, tenuti da piccole catenelle con monete d’oro e coralli. Altri gioielli adornano il collo della sposa sì da mostrare l’eredità che si porta dietro, ma che al tempo stesso impreziosiscono il corpetto ricamato.
Narra Saffo: (34)
“Ettore con i suoi reca da Tebe sacra da Placia viva d’acque
Una raggiante sposa, navigando sul mare salso:
è la squisita Andromaca,
e con lei reca monili d’oro e vesti di porpora …
gioielli variegati, avori e coppe innumerevoli d’argento”.
“Urla acclamanti delle donne anziane,
gli uomini tutti, con l’inno dilettoso e forte
invocano Peana: il dio dell’arco e della
cetra celebri.
Ettore e Andromaca, gli sposi pari ai numi”.
Nel momento centrale della cerimonia gli sposi coronati di ghirlande di fiori d’arancio, si tengono per mano e insieme al cerimoniere fanno tre giri attorno all’altare, quasi una danza, sottolineata dalle voci del coro. Lo scambio degli anelli conclude la cerimonia, mentre gli intervenuti gettano loro manciate di riso come auspicio di felicità e abbondanza. Eccone un esempio descritto da Stesicoro: (35)
“Mele cidonie a iosa sopra il cocchio regale
gettavano, una pioggia
di foglie di mirto, ghirlande di rose
e coroncine crespe di viole”.
La festa prosegue con brindisi in onore degli sposi a cui fanno seguito pranzi, risa, canti e balli, fino a notte inoltrata. Ed è ancora il poeta più vicino a noi, che si alza da tavola e comincia a declamare i suoi versi ripreso dai commensali a più voci, come se il “dramma” per un istante assopito, mostrasse la sua faccia tragica mai svelata ai mortali, mentre le note malinconiche del santouri si propagano nell’aria. È quella di Costantino Kavafis: (36)
“ E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balìa del quotidiano
gioco balordo degli incontri
ed degli inviti, fino a farne
una stucchevole estranea”.
E già un altro commensale si alza per un brindisi a salutare la notte che viene, è Anacreonte (37) con una superba chiusa:
“L’acqua, il vino, ragazzo,
e ghirlande di fiori!
Porta tutto: con Eros
io voglio fare a pugni”.
(continua)
Note:
1) Giorgio Seferis – “Poesie” – A. Mondadori Ed. 1989.
2) Anonimo “Inni Orfici”, “A Helios”, ASRAM VIDYA - Roma 1986
3) Ibidem , “Ad Apollo”, op. cit.
4) Anacreonte “Gli zufoli”, in “I Lirici Greci”, Einaudi - Torino 1969
5) Euripide “Ione”, in “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” – Sansoni1970.
6) Giulio Carlo Argan “Storia dell’arte italiana” – Vol.1 – Sansoni 1968.
7) AA.VV. “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” – op. cit.
8) Henry Jeanmaire “Dioniso” – Einaudi1972.
9) Aristotele “Poetica”, traduzione e introduzione di Guido Paduano, Editori Laterza.
10) Eschilo “I Persiani”, in “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” – Sansoni1970.
11) Henry Jeanmaire op. cit.
12) Aristotele “Poetica”, op. cit.
13) Jean-Pierre Vernant - “L’uomo greco » - Laterza 1991.
14) Euripide “Le Troiane”, in “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” op. cit.
15) Ibidem
16) Euripide “Medea”, in “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” – op. cit.
17) Ibidem
18) Luigi Cherubini – “Medea” (vedi discografia)
19) Iannis Xenakis – “Polytope” (vedi d.)
20) Iannis Xenakis – “Medea” (vedi d.)
21) Arnold Hauser “Storia sociale dell’arte” – Einaudi 1955.
22) E.Wellesz “Ancient and Oriental Music”, in “The History of Music in Sound” Vol.I,Oxford University Press - London 1957.
23) Giulio Carlo Argan op.cit.
24) “I Lirici Greci”, Einaudi - Torino 1969
25) Ibidem
26) Paolo Aldo Rossi, introduzione a “I suoni di Orfeo” (vedi d.), è professore di Storia del Pensiero Scientifico presso la facoltà di Lettere dell’Università di Genova.
27) Giuseppe Faggin, a cura di, “Inni Orfici” – Asram Vidya 1986.
28) Ibidem
29) Ibidem
30) Claudio Monteverdi – “L’Orfeo” (vedi d.)
31) “Byzantine Hymns of Christmas”, “ … of the Epiphany”, “ …of the Epitaphios and Easter” (vedi d.)
32) Mikis Theodorakis – “Missa Greca” (vedi d.)
33) Nikos Kazantzakis – “Zorba il Greco” - Mondadori.
34) “I Lirici Greci”, Einaudi - Torino 1969
35) Ibidem
36) Costantino Kavafis – “Poesie nascoste” – A. Mondadori Ed. – 1974.
37) “I Lirici Greci”, Einaudi - Torino 1969
Bibliografia:
AA.VV. “Letteratura” – Garzanti 1997.
AA.VV. “Musica” – Garzanti 1989.
AA.VV. “Il Teatro Greco: tutte le tragedie” – Sansoni1970.
AA.VV. “Enciclopedia dei Miti” - Garzanti 1989.
AA.VV. “Grecia”, in Meridiani – Editoriale Domus – a.XIV n.101.
Robert Graves - “I miti greci” – Longanesi 1982.
Roberto Calasso - “Le nozze di Cadmo e Armonia” – Adelphi 1988.
Bruno Gentili - “Lo spettacolo nel mondo antico” – Laterza1977.
H.C. Baldry - “I Greci a Teatro” – Laterza 1981.
Gugliermo Chillemi - “Il dramma antico nella Grecia moderna” – Cappelli Edit. Bologna 1963.
Curt sachs - “Storia della danza” – Il Saggiatore -1985.
Curt Sachs - “Storia degli strumenti musicali” – Mondadori1996.
Jean-Pierre Vernant - “L’uomo greco » - Laterza 1991.
Cinzia Bearzot – “Manuale di storia greca”, Il Mulino Editore.
Massimo Di Marco – “La tragedia greca: forma, gioco scenico, tecniche drammatiche” - Carocci editore.
Aristotele “Poetica”, traduzione e introduzione di Guido Paduano, Editori Laterza.
Discografia:
Stavros Xarhakos / Manos Hadjidakis - “Grece is … Bouzouki” – Emi Columbia 1.
George Zabetas – “Bouzouki my love” – Polydor 2486098.
Tassos Chalkias – “Clarino Soloist” – Emi Columbia 14c 054-70823.
Tassos Chalkias – “The sound of the clarinet” – Lyra 3231.
Aristidis Moschos – “Santouri” – Emi Columbia 14c 064-70818.
Domna Samiou – “Souravli” – Emi Columbia 14c 054-70816.
Domna samiou - “Il flauto greco” – Arion Farn 1051.
Laterna & Ntefi – “Bouzouki-Klarino-Violi” – Emi Columbia 14c 034-70711.
Meridiani Musicali – “I suoni di Orfeo” – Editoriale Domus – red edizioni.
Nana Mouskouri – “My Favourite Greek Songs” – Fontana – TL 5206.
Irene Papas – “Songs of Theodorakis” – RCA Victor – LSP 34092.
Soula Birbili – “Le canzoni più belle di M. Theodorakis” – Zodiaco – VPA 8130.
Maria Farandouri – “The ballad of Mauthausen” – con Theodorakis - Emi Columbia 2J 062-70204.
Maria Farandouri – “In Astate of Siege” – con Theodorakis – Polydor 184357.
Yannis Markopoulous / Nikos Xylouris – «Rizitika » - Emi Columbia 14c 064-70069.
Manos Hadjidakis – “Epistrofi” - Emi Columbia – 2j 062-70236.
Manos Hadjidakis/ Nikos Gatsos/Manolis Mitsias/ Dimitra Galani – “Athanassia” – Emi Columbia 2j 062-70248.
Bithikotsis /Theodorakis – “Bithikotsis sings Theodorakis” – Emi Columbia 14c 062-70894.
Mikis Theodorakis – “Archipelago” – Emi Columbia 2j 054-70232.
Claudio Monteverdi “L’Orfeo” – Concentus Musicus Wien dir. Nikolaus Harnoncourt – Das Alte Werk SKH21/1-3. 3 LPs.
Iannis Xenakis “Syrmos” – “Polytope” – “Medea” – Ensemble « Ars Nova » - Erato RTF – STU 70526
“Byzantine Hymns of Christmas”, “Byzantine Hymns of the Epiphany”, “Byzantine Hymns of the Epitaphios and Easter” (31) sono prodotti dalla Society for the Dissemination of National Music con sede in Atene.
Mikis Teodorakis “Missa Greca” – Minos MSM 527.<br
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etno 6: Romanceros fuochi di una...
“Romanceros: fuochi di una tradizione mai spenta”,
di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, RAI3, e per “Il Canto della Terra”, per RSI (Radio della Svizzera Italiana) e articoli apparsi sulle riviste: Nuovo Sound, Musica e Dischi, Audio Review, La Repubblica).
La completa conoscenza dei popoli implica anche di comprendere quello che è il patrimonio orale, letterario e musicale che gli concerne. Questa ricchezza culturale non basta però leggerla in qualche libro o rivista di viaggio, quasi fosse subalterna alle altre forme culturali che la compongono, è bene anche ascoltarla, apprenderla dalla viva voce di chi la detiene, di quegli stessi popoli che l’hanno coltivata e, in qualche modo, resa fruibile, trasmessa alle generazioni future. Se non altro per meglio “viverne” i contenuti umani ed etnologici ( le ragioni), le testimonianze linguistiche e le sonorità originali che la compongono (*). Al tempo stesso, rendere efficace il lavoro, frutto di ricerche scientifiche approfondite e studi, che molti ricercatori in tutto il mondo hanno fatto e vanno facendo per salvaguardare questo patrimonio che, di fatto, appartiene a tutti noi.
È quanto svolto fin’ora dal Consiglio Internazionale della Musica con sede a Parigi, dall’organizzazione non governativa dell’UNESCO, dal Musée dell’Homme e l’Ocòra a Parigi, dall’Istituto Internazionale di Studi Comparati – Fondazione Cini con sede a Venezia, la Discoteca di Stato e il Museo Etnografico Pigorini a Roma, Museum of Mankind di Londra, Museu Nacional de Etnologia di Lisbona, Museo de América di Madrid, Museo Etnologico di Mexico a Città del Messico, la EMI-Odeon a Londra, la Bärenreiter a Berlino, l’Albatros in Italia, che nell’insieme rappresentano un panorama musicale che abbraccia tutto il mondo conosciuto e la straordinaria varietà dei mezzi di espressione, che pur nelle diverse culture, lo compongono.
La storia del Romance spagnolo narrata in questa ricerca, trova qui un punto fermo, il salto dal vecchio continente al nuovo mondo è assai ampio e richiede un volo temporale (di tempo) per poter coprire lo spazio che da esso ci separa. Pertanto dobbiamo ad ogni costo ripartire da dove la storia ha avuto inizio, cioè da quel 1492 in cui Cristoforo Colombo scoprì l’America. Era inevitabile, per l’epoca in cui avvenne, che i monarchi convogliassero i propri interessi alle risorse economiche delle terre conquistate, piuttosto che ampliare la propria conoscenza di altre culture. Ma questo lo lasciamo decidere agli storici, del resto agli interessi puramente economici, si affiancarono preoccupazioni morali di competenza della Cristianità per ciò che riguardava il “diritto/dovere” di estendere la propria religione nel mondo. All’epoca era dovere imprescindibile convertire “ad ogni costo” le popolazioni per salvare le loro anime e destinarle al paradiso. E può sembrare arduo qui affermare che fu proprio l’opera svolta dai missionari che portò alla diffusione della lingua castigliana nel Nuovo Mondo.
Solo vent’anni più tardi già gli Indios delle Antille si rivolgevano in spagnolo a Bartolomeo de Las Casas, di cui si hanno notizie certe. Ben presto lo appresero i Tlacaltecas del Messico, e gli Aztechi a Sud delle grandi cascate, e in Paraguay. Alla fine del secolo poteva sentirsi parlare spagnolo per le strade di Potosì in Bolivia come a Camajarca e a Cuzco in Perù, e a Quito in Ecuador. Con la diffusione della lingua estesa all’intero continente si cominciò a parlare appunto di America Latina, e di cultura popolare manifestatasi proprio attraverso l’esportazione della musica e della poesia, attraverso il genere che godeva nel vecchio continente di maggior fortuna: il Romance. Tant’è che le “storie” contenute nella Bibbia trovarono un terreno fertile proprio perché “cantilenate” nel modo della salmodia. Finanche la Messa, trasferita nella lingua spagnola, trovò, a un certo punto, una valida trasposizione nel canto e nella musicalità più idonea alla sensibilità di quei popoli.
Il Romancero dal canto suo, che poteva essere un missionario laico o un prete, un domenicano come un francescano, divenne ben presto popolare e il Romance rappresentò di fatto la pagina aperta del libro aperto sui fatti della storia col narrare le imprese dei Conquistadores, o meglio dei Libertadores che vantavano la salvezza dalle fiamme dell’inferno. Non importava che la cultura autoctona degli Indios, appartenesse di fatto all’antichità o alla mitologia dei grandi imperi scomparsi, le cui fantastiche visioni, tramandate nella forma orale attraverso le manifestazioni popolari, rappresentavano un patrimonio ineluttabile che andava in qualche modo conservato in ragione di un sostegno psicologico che mai sarebbe dovuto venir meno. Era più importante demonizzare, detronizzare i vecchi idoli, annientare, ridurre in schiavitù se necessario, pur di ottenere la loro sottomissione e insediarne dei nuovi. Più tardi, già alla metà del secolo successivo, l’assorbimento di alcuni caratteri della cultura colonizzante era entrata nell’uso pratico, dando luogo a una cultura comune, o meglio “accomunante”, a tutti i paesi della Cordigliera che tuttavia (e per fortuna nostra) riuscirono a mantenere (seppure non proprio intatte) alcune delle tradizioni più antiche, tipiche pur nella diversità che oggi li rappresenta.
Acciò il Romance trovò una sua affermazione, adattandosi alla sensibilità delle nuove compagini sociali, seppure soltanto come riflesso dello spirito ispanico che verosimilmente l’aveva originato e finì ben presto per fiorire sulle bocche di poeti ispirati e interpreti spontanei che nel ricordo nostalgico dei Romanceros di Spagna, e del Romance, composero e interpretarono “cantatas” sulle guerre civili che gli Indios andavano combattendo contro l’oppressore che li spodestava di tutto, finanche della propria vita. Il primo strumento che il popolo si trovò a usare per comunicare, e che per lo più troviamo ampiamente utilizzato in tutta l’America Latina, fu proprio la “copla” che, secondo una leggenda, il marinaio Juan de Saravia aveva composto nell’agosto del 1527 all’isola del Gallo, contro Francisco Pizzarro. Tuttavia, la prima testimonianza della presenza del “Romance” sul territorio è data da un certo Bernard Diaz del Castillo, nella sua “Historia de conquista” che narra le imprese di Cortez. Oggi questa tradizione non si è ancora spenta, anche se i Romanceros non usano più appellarsi con questo nome, come ricorda Fernando Alegria (*):
“È comunque il popolo che da al Romance la sua forma definitiva, ogni volta mutandolo, col tagliarlo o con l’aggiungere versi sui versi, col sopprimere o variarne le parole, la lunghezza, la durata della narrazione, col modificarne lo svolgimento o alterare capricciosamente l’origine degli avvenimenti narrati e persino le azioni, le “avventure” dei personaggi che lo compongono”.
L’uso del Romance come mezzo espressivo è comunque rimasto vivo fra le popolazioni e la poesia che ad esso si ispira, è ancora intesa quale voce che ha il potere di essere determinante sullo spirito delle popolazioni. Lo conferma la voce che tanti poeti hanno levato e continuano a levare, lì dove ce n’è più bisogno, per la giusta causa che li vede impegnati nel mondo, a difendere i diritti dell’uomo sul fronte della libertà, della legalità, della giustizia. Scrive Pablo Neruda:
“Io, non credo di aver mai inventato nulla (..) molti altri scrittori hanno sentito il dovere di esprimere il senso geografico e nazionale della nostra America. Unificare il nostro continente, scoprirlo, farlo comprendere, ritrovarlo: questo è stato lo scopo della mia vita”.
Di tutte le forme che concorrono a delineare il carattere di un popolo, nessuna è più autentica della musica, e fare poesia è come fare musica, come il levare la propria voce e modularla nel suono di un parola, piana e soffusa o gridata che sia, è far sentire al mondo che ci circonda la nostra presenza, la realtà della nostra esistenza. La nostra voce racchiusa nel simbolo di ciò che siamo, la forza spirituale della razza, il suo ritmo nostalgico, il suo accento, i suoi colori, il suono stesso della nostra natura di esseri umani. Così come, il linguaggio delle foreste o dei deserti che attraversiamo, l’armonia delle acque e dei mari che ci circondano, la voce dei venti e dei tuoni che sconquassano il nostro cielo. Tale è il canto del maggiore poeta e forse davvero “ultimo” Romancero in ordine di tempo, e che pure cito qui per primo, che l’America possa vantare: Pablo Neruda che, col suo Romance più compiuto: “Canto General” (*) segnò l’inizio di una nuova stagione poetica, contrassegnata dal tema universale dell’attaccamento alla terra sul principio di libertà assoluta, per una “riscoperta dell’uomo” e l’unificazione degli stati latinoamericani.
Da Canto General, leggiamo “Amor America, 1400”: (*)
“Prima della parrucca e della giubba, / furono i fiumi, / i fiumi arteriali / furono le cordigliere, sulle cui onde / consumate / il condor o la neve immobili, / sembravano. / Fu la densità e l’umidore, / il tuono ancora senza nome, / le pampas planetarie. / L’uomo fu terra, ciotola, / palpebra del tremulo fango, / calcolo dell’argilla, / anfora caraibica, pietra cibcha, / coppa imperiale o silice araucana. /Fu tenero e cruento, / ma sull’impugnatura / della sua arma d’umido cristallo / le iniziali della terra erano scritte …”.
Con Neruda, la transizione dal Romance alla “cantata popolare” d’impegno civile e politico, è pressoché completata, in essa si rinnova quell’inquietudine drammatica che da sempre sottolinea l’avanzamento culturale e sociale del continente latinoamericano, e che sfocerà nelle lotte di classe e porterà ai successivi massacri delle popolazioni iniziate fin dai primi anni della Conquista e mai interrottesi dalla civiltà Inca a quella Olmeca, fino all’attuale sterminio degli Indios in Amazzonia, ai Pellerossa negli Stati Uniti, agli aborigeni Australiani, alla pulizia etnica nei Balcani e nella fascia Mediterranea, ai popoli dell’Africa nera, lo sterminio degli Ebrei, degli Zingari, dei gay e a tutte le altre nefandezze di cui non si ha notizia. Ma non è questo il momento né il luogo per parlarne, seppure, va ricordato che una ricerca approfondita e comparata su questo argomento, rientrerebbe nell’ambito della scienza antropologica e dell’etnomusicologia tout court.
Per restare nell’ambito dell’evolversi del Romance in America Latina, tema primario di questa ricerca, incontriamo Luis Advis, uno dei massimi esponenti della cultura più alta nel suo paese, titolare di numerosi posti accademici di musica classica e tradizionale presso l'Universidad de Cile. Da lì il bisogno di dare nuova vita e sviluppo popolare alla musica folklorica attraverso lavori come cantate e sinfonie. Prominente nel suo repertorio è una sinfonia, “Los Tres Tiempos de América” (*) registrato nel 1988 da Quilapayún con la cantante spagnola Paloma San Basilio e un'orchestra di musicisti spagnoli. E “Canto para una Semilla” (*) (Canzone per un Seme) basato su poemi di Violeta Parra, registrato dagli Inti-Illimani, da Isabel Parra. Il "Cantos" consta di sette canzoni, un intermezzo ed una parte recitata fra una canzone e l'altra da Carmen Bunster, diversamente per l’Album italiano del 1977: Voce recitante di Edmonda Aldini nella traduzione di Ignazio Delogu. Leggiamone insieme il testo: (parte)
Da “Canto para una Semilla” di Luis Advis “La Conciencia”: (*)
“Válgame Dios como están /Todos los pobres cristianos /En este mundo inhumano /Partido mitá' a mitá'. /Del rico es esta maldá'! /Lo digo muy conmovida. /Dijo el Señor a María: /Son para todos las flores, /Los montes, los arreboles, /¿Porque el pudiente se olvida? /Si el sol pudieran guardarlo /Lo hicieran de buena gana, /De noche, tarde y mañana /Quisieran acapararlo. /Por suerte que pa' alcanzarlo /Se necesitan cojones. /De rabia esconden las flores /Las meten en calabozos /Privando al pobre rotoso /De sus radiantes colores. /No puede ní el más flamante /Pasar en indiferencia /Si brilla en nuestra conciencia /Amor por los semejantes. /En este mundo moderno /¿Qué sabe el pobre del queso? /Caldo de papas sin hueso /De no saber lo que es tierno. /Por casa callampa, infierno /De lata y ladrillos viejos. /¿Cómo le aguanta el pellejo? /Eso sí que no lo sé: /Pero bien sé que el burgués /Se pita al pobre verdejo./No puede ní el más flamante /Pasar en indiferencia /Si brilla en nuestra conciencia /Amor por los semejantes. /No pierdo las esperanzas /De que ésto tenga su arreglo /Un día este pobre pueblo /Tendrá una feliz mudanza! /El toro solo se amanza /Montándolo bien en pelo. No tengo ningún recelo /De verlo vuelto tirilla /Quando se dé la tortilla, La vuelta que tanto anhelo”.
La coscienza (Versione italiana di Riccardo Venturi):
“Ne guardi Iddio come stanno /Tutti quei poveri cristiani /È questo mondo disumano
Diviso a metà. /E' tutta colpa dei ricchi!/Lo dico assai commossa./Disse il Signore a Maria:/Sono per tutti i fiori,/Le montagne, i declivi,/Perché il potente se ne scorda?/Se il sole potessero ingabbiarlo/Lo farebbero assai volentieri,/Di notte, sera e mattina/Lo vorrebbero tutto per sé./Menomale che per raggiungerlo/Ci vogliono le palle./Per rabbia nascondono i fiori,/Li mettono in guardina/Privando il povero straccione/Dei loro colori splendenti./Neanche chi se ne frega di tutto/Può restare indifferente/Se brilla nella nostra coscienza./L'amore per i propri simili. /In questo mondo di oggi,/Che ne sa il povero del formaggio?/Broda di patate senz'osso,/E la carne se la sogna./Come casa una baracca, un inferno/Di lamiera e tegole vecchie./Come fa a tirare avanti?/Questo proprio non lo so:/Però so bene che il borghese/Piglia per il culo il povero. Neanche chi se ne frega di tutto/Può restare indifferente/Se brilla nella nostra coscienza/L'amore per i propri simili./Non perdo le speranze/Che un giorno tutto s'aggiusti,/Un giorno questa povera gente/Avrà un bel cambiamento!/Il toro solo si ammansisce/Montandolo bene a pelo./Non ho nessuna paura/Di vederlo a gambe all'aria:/Quando si rigirerà la frittata,/Il ribaltamento cui tanto aspiro”.
Altra pietra miliare del movimento della Nueva Cancione Cilena, è la cantata a “Santa María de Iquique” (*), eseguita dal gruppo Quilapayun, è forse il simbolo di un’unità di lotta che vuole essere di ammonimento e di speranza per i popoli in lotta e riassume quelli che sono gli aspetti letterari, narrativi e musicali che meglio rappresentano la tradizione musicale sudamericana. Leggiamone insieme l’incipit:
“Se contemplate la Pampa e i suoi cantoni / vedrete la siccità del silenzio / ascolterete il suolo senza miracolo / e spacci vuoti come l’ultimo deserto. / Forse domani o dopo, / o anche un po’ più tardi / la vicenda da lor vissuta / ricomincerà di nuovo / mille cose possono accadere / a meno che non apprestiamo / qualche soluzione di lotta. /… / la terra sarà di tutti / anche nostro sarà il mare / ci sarà giustizia per tutti / e anche libertà. / Lottiamo per ciò che è nostro / e non deve essere di nessun altro”…
Il motivo religioso tradizionale della Cantata si distingue per certe caratteristiche essenziali risulta sostituito con un ordine diverso, più sociale e realistico; pur non tralasciando i nessi con la tradizione del vecchio continente, sono stati aggiunti tipi diversi di melodia e ritmica, modulazioni armoniche elementi ritmici di estrazioni ispano-americana. Al pari di un antico Romancero, Luis Advis ha trasferito nella forma della “cantata popolare” una pagina di storia civile, nella rievocazione della tragedia svoltasi sotto il governo di Pedro Mont a Iquique (Chile), il 21 dicembre 1907, in ricordo di uno dei più brutali massacri della storia di questo paese. Le altre composizioni includono un quintetto di vento, musica per teatro, cinema e televisione, in un catalogo musicale che comprende più di 150 lavori e che copre tutte le sfere che vanno dal classico alla canzone popolare. All’orchestra classica utilizzata per la Cantata sono stati conservati il violoncello e il contrabbasso, e un particolare ensemble formato da due chitarre, due flauti, un charango tipico e una grancassa.
Sulla scia di questa Cantata ormai famosa, tutte le sue composizioni, tra preludi, canzoni e melodie ecc. scritte da compositori che vivono o che hanno vissuto in America Latina, facenti parte di gruppi o musicisti esiliati, presentano tutte quante una vicinanza con per così dire “spirituale” con il ricco passato che precedette gli eventi della repressione. L’insieme di ritmi e suoni di ieri e le parole scritte oggi dai poeti che questo continente ha prodotto, danno a queste canzoni liricità e originalità, e soprattutto forza al linguaggio espressivo che sarà ripreso da molti gruppi in quegli stessi anni.
Héctor Miranda, argentino della provincia di Buenos Aires, è il leader del gruppo folk Los Calchakis, creato nel 1960 e di cui è direttore artistico e voce baritono. Conoscitore della musica etnica del continente, Miranda suona molti strumenti tipici, come siku, moceño, tarka, pinkillo, bombo e un numero indecifrato di percussioni. Gli altri componenti il gruppo sono: Sergio Arriagada, cileno di Santiago del Cile, è responsabile della realizzazione musicale, suona tutti gli strumenti andini: kena, charango, antara, siku, cuatro, kenacho, oltre alla chitarra ed altre percussioni; Enrique Capuano, argentino della provincia di Córdoba, voce tenore e chitarra solista; Pablo Urquiza, argentino della provincia di Córdoba, voce tenore e chitarra, suona tutti gli strumenti andini: kena, kenacho, siku, antara, aykhori, charango, cuatro e bombo; Mario Contreras, cileno, ha spesso collaborato col gruppo in qualità di artista invitato. Con più di 40 opere discografiche al loro attivo, Los Calchakis sono considerati uno dei più importanti interpreti del folclore musicale latinoamericano, testimoniato inoltre dai loro concerti e numerosi tour tenuti sui palchi dei teatri dell'Europa e del Nord America.
Fra i moltissimi album, nel 1972 interpretano la colonna sonora del film “L'Amerikano” di Costa Gavras, composta da Mikis Theodorakis, insieme ad altri, dedicati al folklore sudamericano. Tra questi, spicca un’antologia interessante: “I poeti dell’america Latina” (*) che offre una selezione di opere tra le più rappresentative del periodo, vuoi per la ricerca minuziosa dei temi trattati, che per l’uso che essi fanno degli strumenti tipici. Le canzoni in esso raccolte, musicate e cantate dal Los Calchakis, e in gran parte firmate dallo stesso Miranda, appartengono sia a poeti famosi, come Pablo Neruda, Nicolas Guiellen, Cesare Valleio, Victor Jara, Carlos Ayala, sia a poeti a noi sconosciuti ma ben noti nei loro rispettivi paesi. Ma è con un’ltra raccolta, dal titolo più esplicito: “I poeti della rivoluzione” (*), che Los Calchakis affrontano il tema dello scontro sul piano dell’attualità politica con testi che esulano dal commercialismo per entrare a far parte di una cultura di massa che non trova altro modo per poter far sentire la propria voce.
Sebbene si presenti come fenomeno di massa, assai diverso da quello fino allora conosciuto, il foklore latinoamericano è cosa viva, quotidiana, mai reperto archeologico, bensì creazione che nasce spontanea, fermamente legato alla terra d’appartenenza, al pari di qualsiasi altra espressione artistica in tutta la sua essenzialità e qualità, al pari della poesia evoluta dai grandi che l’hanno raccolta tra le millenarie storie di lontananze, solitudini, e quant’altro, ma anche dalla fantasia, dalla magia della terra, accresciute col tempo nei racconti, nei Romance, nelle coplas, per la viva voce dei suoi interpreti. In questa raccolta, bene si esplica tutto il risentimento di una razza volta al recupero della propria dignità, quella scaturita dalle nuove generazioni che non accettano i soprusi cui hanno dovuto sopportare i padri, e che si propone ancora oggi, come quesito sociale e culturale, in molte parti del mondo, Italia compresa.
Da “I poeti dell’America Latina”, leggiamo “Cancion con todos”:
“Tutte le voci, tutte / tutte le mani, / tutte, tutto il sangue può / essere canzone nel vento. / Canta con me, canta / Latino – Americano / libera la tua speranza / con un grido nella voce”…
Non si pensi che il tema “letterario” alla base della nostra ricerca sia venuto meno, anche se sembra qui trascurato in realtà esso è sempre presente, perché oltre che dalla poesia, i poeti latinoamericani colgono lo spirito letterario del tempo e da esso traggono forza. Abbattendo la parete divisoria fra letteratura e musica, fra musica e sociologia, Manuel Scorza con “Rulli di tamburo per Rancas”(*), il primo romanzo della "pentalogia" intitolata “La Ballata”, ha inventato in quegli anni, un affascinante ritmo narrativo che coinvolgeva tutti e tutto, raccontando sotto forma di romanzo la lotta dei comuneros (i contadini indigeni) realmente avvenuta in Perù negli anni sessanta. Molti personaggi del libro (Héctor Chacón, per esempio) sono realmente esistiti. Il romanzo (insieme a tutta la pentalogia) viene considerato dagli indios il racconto epico delle loro gesta. Come è sua abitudine, Scorza cerca di riprodurre il ritmo racconti popolari andini, attraverso una narrazione mimetica e realistica che ricorda i parlanti popolari di Giovanni Verga: il narratore non interviene mai in prima persona, non presenta né i personaggi, ma parla come parlerebbe uno dei suoi personaggi. Spesso il lettore viene confuso dal fatto che uno stesso personaggio venga chiamato in modi diversi. In alcuni capitoli Scorza interrompe il flusso della narrazione e presenta piccoli riassunti della situazione economica e sociale del Perù, senza mai però perdere il suo tono impersonale.
Altra caratteristica di Scorza è la sua scrittura in cui i capitoli si alternano, seguendo ora la lotta dei manifestanti di Rancas, ora la storia di Héctor Chacón, frammentando molto la narrazione. Dopo secoli di soprusi subiti da parte del dottor Montenegro, un latifondista locale, i comuneros di Rancas (una comunità contadina vicina a Cerro de Pasco) scoprono che un enorme recinto sta pian piano rinchiudendo tutti i loro territori, lasciandoli senza più terre da coltivare. Il recinto è costruito dalla multinazionale americana Cerro de Pasco Corporation, che agisce con il benestare del dottor Montenegro e delle istituzioni, senza aver avvisato né chiesto autorizzazione ai comuneros, legittimi proprietari delle terre.
Tra lo sconcerto iniziale della comunità, la situazione raggiunge livelli insostenibili: ora diventa persino difficile raggiungere Rancas, dato che il Recinto ha inglobato anche fiumi e strade. I contadini si rivolgono al loro rappresentante locale, il Personero don Alfonso Rivera, ma i suoi reclami restano inascoltati. Intanto Héctor Chacón della comunità di Yanahuanca, detto il Nittalope, inizia a raggruppare una banda allo scopo di eliminare il prepotente Montenegro. Chacón, l'Abigeo, il Ladro di Cavalli organizzano l'omicidio, ma, scoperti, sono costretti a rifugiarsi sui monti e a vivere da banditi. Stufi di presentare reclami, istigati da Fortunato, che ha visto uccise tutte le sue pecore dai bravacci della Cerro de Pasco, i comuneros di Rancas trasportano tutte le pecore morte davanti alla Prefettura di Cerro, ottenendo solo l'arresto di Fortunato.
Il Personero, convinto oramai della faziosità delle autorità, fa riunire in una piazza tutti i maiali che la comunità riesce a recuperare, li tiene a digiuno per una settimana, per poi liberarli nei pascoli recintati, rendendoli inutilizzabili. Héctor Chacón nel frattempo sta per mettere in atto il suo piano, anche a costo di travestirsi da donna ed infiltrarsi nel palazzo di Montenegro. Per ottenere i vestiti adatti, torna a casa sua di nascosto. Ma tradito da un suo parente, viene arrestato dalla Guardia Civile ed imprigionato. Ridotti a far pascolare le pecore nei cimiteri, dopo che le guardie della Cerro de Pasco hanno impedito anche ai pochi animali rimasti di lasciare il paese, i comuneros si decidono alla lotta armata: attaccano la guardia repubblicana con fionde e sassi. Anche qui interviene la Guardia Civile, che sgombera il villaggio, massacrando la popolazione e bruciando le abitazioni. I comuneros si ritrovano sotto terra, morti, a raccontarsi le ultime violenze subite.
Sul Perù troviamo il libro di un noto viaggiatore francese, Alfred Metraux, antropologo e promotore dei diritti umani ha sempre alternato l'insegnamento universitario alle ricerche sul campo, che lo hanno portato in Africa, nelle Americhe centro-meridionali e nel Pacifico. Delle sue opere Einaudi ha pubblicato “Incas” (*)(1969 e 1998). Già sognato come la terra dell'El Dorado e delle Amazzoni, e considerato nell'Europa illuminista come il paese dell'Utopia, quasi uno Stato socialista, il Perù viene qui riportato nelle sue dimensioni storiche. Metraux fa giustizia di queste ingenue raffigurazioni e sottolinea piuttosto le rassomiglianze con le monarchie asiatiche. La denuncia delle atrocità dei conquistatori si unisce allo studio delle cause che produssero la rapida caduta dell'impero, e delle continue ibridazioni che da allora hanno dato al Perù il volto complesso che oggi conosciamo. Si può dire che con Metraux l'etnologia è riuscita a conoscere gli altri attraverso noi stessi, e noi stessi attraverso la «diversità» di civiltà favolosamente remote.
L'impero del Sole e i suoi miti, le strutture economiche, politiche e sociali, la cultura, l'impatto devastante della Conquista spagnola: della civiltà Inca questo libro, apparso per la prima volta nel 1961, ci offre un quadro vivacissimo e insuperato. Il suo linguaggio misto di poesia e ironia, immaginazione e sdegno, li fonde tutti insieme mirabilmente. Così come Alfred Métraux con “Incas”, svelava quella che è l’origine nobile di questa razza e le ragioni della dignità profondamente offesa. Su tutto ovviamente ha pesato molto la massima, macchiata di sangue, di Simon Bolivar l’eroe venezuelano che dedicò la vita per l'indipendenza degli stati sudamericani: “Tirannia e schiavitù sono il compendio di tutti i mali e di tutte le guerre” da cui la poesia sudamericana trasse la forza per manifestare il proprio sdegno, per quella che sarà causa popolare e proletaria dei “diritti dell’uomo” contro ogni forma di oppressione.
La letterata impegnata, quella più fulgida e allo stesso tempo stravolgente, appartiene allo scrittore peruviano José Maria Arguedas, scrittore peruviano la cui voce si leva isolata, “quasi avesse voluto tenersi in disparte dal mondo” ricordato per un libro carico di tensione: “I fiumi profondi” (*). Visse gli anni decisivi della sua infanzia a stretto contatto con la popolazione india. In questo modo scoprì la cultura indigena e imparò il quechua, lingua che utilizzò per tutta la vita e che solo dopo aver compiuto 8 anni affiancò all'uso del castigliano. Figlio di un avvocato, che per ragioni politiche e professionali, si vide obbligato a viaggiare con frequenza attraverso il territorio delle Ande. Il futuro scrittore, che quasi sempre accompagnava il padre nei suoi viaggi, allargò i suoi orizzonti culturali ed entrò a contatto con la tradizione india. Nel 1931 entrò nella facoltà di lettere dell'Universidad Mayor de San Marcos di Lima. La sua attività creativa iniziò poco tempo dopo.
L'opera di Arguedas abbraccia vari campi; troviamo, infatti, romanzi, poesie e studi letterari, traduzioni dal quechua allo spagnolo e viceversa. In lui intravediamo sempre una preoccupazione costante per la lingua, i suoi usi e la interrelazione reciproca. Il suo esordio avvenne con una serie di canti con il titolo "Aqua", pubblicato nel 1935. È del 1941 la sua prima novella intitolata "Yawar Fiesta". Le sue opere mature comprendono "Los ríos profundos" del 1958, "Todas las sangres" del 1964 e "El zorro de arriba y el zorro de abajo" pubblicato nel 1971. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. Ancora scosso dai traumi subiti durante la sua infanzia e disilluso per gli effetti della politica culturale del suo paese, cercò di suicidarsi nel 1966 senza riuscirci, ma, il 28 novembre del 1969, si sparò alla testa e morì quattro giorni dopo, il 2 dicembre dello stesso anno.
“Il filo conduttore del suo libro “I fiumi profondi”- ha scritto Mario Vargas Llosa – è soffuso di nostalgia e a tratti di passione: “È la storia di un bambino straziato da una doppia origine che lo ha simultaneamente radicato in due mondi ostili. Figlio di bianchi, allevato dagli indios, ritornato al mondo dei bianchi, Ernesto, il narratore dei "fiumi profondi", è un disadattato, un solitario: ma anche un testimone che gode di una situazione di privilegio per evocare la tragica opposizione di due mondi che si ignorano a vicenda, si respingono e che neppure nella sua persona riescono a coesistere senza dolore”. Il romanzo nasce dall'esperienza autobiografica di Arguedas, figlio di un avvocato di provincia, che per anni vagabonda da un paese all'altro delle Ande, senza riuscire mai a stare in un posto tanto da affezionarsi, costretto ogni volta a partire. Mentre il padre si trova in carcere, il bambino viene allevato dalle vecchie "mamme" di una comunità india. Queste due esperienze, il contatto con la natura e l'essere cresciuto in un mondo arcaico, puro e forte, hanno marcato indelebilmente il suo carattere. Quando viene messo in collegio vivrà nel ricordo dei suoi amici indios e degli austeri paesaggi che gli erano entrati nel sangue. E quando nel paese scoppierà la rivolta, sentirà in quegli sconvolgimenti il segno di un destino superiore.
A detta dei maggiori scrittori sud-americani, Arguedas è stato per loro un vero e proprio maestro che ha segnato una vera e propria svolta nella letteratura latino-americana. Le atmosfere create da questo autore ci spingono fortemente alla lettura di altri suoi due libri: “Festa di sangue” e “Tutte le stirpi”. Considero questa trilogia indispensabile per conoscere, e credetemi ne vale la pena, il fantastico mondo della letteratura di questo continente, proseguito con Marquez, Llosa, Sforza, Soriano e altri. Ed è proprio alla genialità popolare e ad una innata ricchezza di espressione, piena di conflitti interiori e di opposte tensioni, che presento qui un altro grande della letteratura sudamericana, Gabriel Garcia Marquez. Il suo “Cent’anni di solitudine” (*) riesce a creare un paese fantastico dove il meraviglioso è impregnato dei colori e dei sentimenti umani, quelli più veritieri che non sono della realtà.
Per tornare alla “poesia” va qui citato Raúl González Tuñón, poeta e viaggiatore che condivise l'avanguardia letteraria argentina degli anni ‘20 e viaggiò a lungo in tutta Europa. Visse a Parigi e a Madrid, città nelle quali fece amicizia con Robert Dai, César Vallejo, Garcia Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Federico García Lorca e Pablo Neruda. González Tuñón fu anche giornalista, lavorò al quotidiano "Critica", un vespertino degli anni '20 e '30, di marcata tintura sensazionalista, ma che reclutò inoltre a Tuñón, notevoli scrittori dell'epoca, tra cui Borges, Roberto Arlt, , Carlos della Punta, Nicolás Olivari, e che nel giornaliero "Clarino" scrisse di critica d’arte e cronache di viaggio. Legato da profonda amicizia con Pablo Neruda e sua moglie Delia della Corsia, anch’essa argentina, quando esplose la Guerra Civilein Spagna, entrambi si trasferirono da Madrid a Santiago dove condivisero la stessa casa. Neruda assecondò il poeta cileno nella fondazione dell'Alleanza di Intellettuali per la Difesa della Cultura, organizzazione antifascista creata dopo il Congresso degli Scrittori di Valencia, realizzato a Barcellona, in mezzo ai bombardamenti franchisti.
La copiosa bibliografia di Raúl González Tuñón (*) inizia con "Le porte di fuoco" che pubblicò a Buenos Aires in 1923, a 21 anni. In quell'epoca, collaborò con la rivista “Martín Fierro”, nella quale scrissero tra gli altri anche Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Francisco Luis Bernárdez, Leopoldo Marechal, Macedone Fernández ed Eduardo González Lanuza. La sua opera influenzò decisivamente la cultura argentina degli anni '50 e '60 dove è tutt’oggi considerato uno dei fondatori della corrente moderna della così detta “poesia urbana”. Nel 1928, poco prima di imbarcarsi per l'Europa, González Tuñón pubblicò "Mercoledì di cenere". Una volta a Parigi, scrisse uno dei libri considerati fondamentali nella sua opera: "La strada del buco nella calza", edito nel 1930. Poco più tardi, nel 1936, esce un altro dei suoi libri chiave, "La rosa blindata", ispirato a un sollevamento minerario nella provincia spagnola delle Asturie. Ma è con “Lluvia” un breve poema d’amore eseguito in forma di Tango dal Cuarteto Cedron, dove il poeta annuncia: 'sto meditando della tua vita e della tua morte', e che comincia con questa frase: “Allora comprendemmo che anche la pioggia era bella”, anche se, come nel caso della Guerra Civile spagnola, non c’era possibilità di schivare la morte e la sofferenza. Scrive in proposito l’autore, “… dopo una stagione che sembrò inegualmente lunga, mi svegliai con 'tutta la tenerezza della pioggia'. Quella che appare come di buon mattino un mormorio. L'immagine la rubai, da un tango, che come seppi dopo veniva da un poema d’amore, folgorante e umido, scritto per un bonaerense che fu in altri tempi conosciuto per le sue avventure, i suoi compromessi ed i suoi versi inquietanti”.
Lluvia (Inviato per Luis Córdova il 01/08/2008): (*)
“Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa.
Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados.
Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres.
De cualquier manera la lluvia es saludable y triste.
Sus tambores acunan nuestras noches y la lectura corre a su lado por los canales del sueño.
Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban.
No habían despertado todavía al amor, no sabían nada de nosotros.
De nuestro gran secreto.
Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga.
Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto o sospechado, los ademanes y las palabras de ellos. Todo, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección.
Te quiero con toda la ternura de la lluvia.
Te quiero con toda la violencia de la lluvia.
Te quiero con todos los tambores de la lluvia.
Te quiero con todos los violines de la lluvia.
Aún tenemos fuerzas para subir la callejuela empinada. Recién estamos descubriendo los puentes y las casas, las ventanas y las luces, los barcos y los horizontes.
Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana; increíble, pero tan real; numerosa, pero tan mía.
Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño.
Oh, visitante.
Ya es seguro que ningún desvío nos separará.
Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único.
Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño.
Porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable.
Oh, visitante.
Estoy lleno de tu vida y de tu muerte.
Estoy tocado de tu destino.
Al extremo de que nada te pertenece sino yo.
Al extremo de que nada me pertenece sino tú.
Sin embargo yo quería hablar de la lluvia, igual, pero distinta, ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra congoja, los humildes barrios de los trabajadores.
La lluvia es bella y triste y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría. Intima, recóndita alegría.
Estoy tocado de tu destino.
Oh, lluvia. Oh, generosa”.
“Allora comprendemmo che anche la pioggia era bella./A volte cade tranquillamente ed uno pensa ai cimiteri abbandonati./ Altre volte cade con furia ed uno pensa ai maremoti che si sono divorati tante splendide/isole di estranei nomi./In qualche modo la pioggia è salutare e triste./ I suoi tamburi cullano le nostre notti e la lettura corre al suo fianco/per i canali del sonno./Tu venivi verso me e gli altri esseri passavano./Non avevano svegliato ancora all'amore, non sapevano niente di noi./Del nostro gran segreto./ Ignoravano l'intimità dei nostri abbracci voluttuosi, la tenerezza della nostra fatica./Per caso i visi amici, le fotografie, i paesaggi che abbiamo visto insieme,/tanti gesti che abbiamo intravisto o sospettato, i gesti e le parole di essi./Tutto, tutto è sparito e siamo soli sotto la pioggia, soli in nostro condiviso, nel nostro stretto destino,/ nella nostra possibile morte unica,/nella nostra possibile resurrezione./Ti voglio con tutta la tenerezza della pioggia./Ti voglio con tutta la violenza della pioggia./Ti voglio con tutti i tamburi della pioggia./Ti voglio con tutti i violini della pioggia./Abbiamo ancora forze per portare sulla stradina ripida./Appena stiamo scoprendo i ponti e le case, /le finestre e le luci, le barche e gli orizzonti./Tu stai sopra, sontuosa e biblica, ma tanto umana; incredibile, /ma tanto reale; numerosa, ma tanto mia./Io ti vedo fino a nell'ombra imprecisa del sonno./Oh, visitatore./È già sicuro che nessuna deviazione ci separerà./Uguali brilli segnali ci attraggono verso la condivisa vita, verso il destino unico./Né nella nostra carne né nel nostro spirito non passeremo mai la linea dell'autunno./Perché l'intensità del nostro amore è tanto grande, tanto poderosa che non ci renderemo/ conto quando tutto sia morto, quando tu ed io siamo due ombre ed ancora siamo incollati,/insieme, portando su sempre la stradina senza fine di una passione irrimediabile./Oh, visitatore./Sono pieno della tua vita e della tua morte/Sono toccato del tuo destino./All'estremo che niente ti appartiene bensì me./All'estremo che niente mi appartiene bensì te./Tuttavia io volevo parlare della pioggia, ugualmente, ma distinta, già cadendo sui giardini,/già scivolando per i muri, già riflettendo sull'asfalto le subitaneo, le fuggitive luci rosse delle automobili,/già inondando i quartieri della nostra solidarietà e della nostra angoscia, gli umili quartieri dei lavoratori./La pioggia è bella e triste e per caso il nostro amore sia bello e triste, /e per caso quella tristezza sia una maniera sottile dell'allegria. Intima, recondita allegria./Sono toccato del tuo destino./ Oh, pioggia. Oh, generosa”.
Con la sua opera, di grande importanza politico-letteraria, Tuñón si inserisce di forza nel movimento avanguardistico del XX secolo, ed occupa inoltre una delle più ferme posizioni a favore dei Poeti della Guerra Civile Spagnola che trovò in Miguel Hernández uno dei più rappresentativi. Nei suoi poemi che alludevano a viaggi, egli parla dei quartieri di Parigi e di Buenos Aires, paesi della Cordigliera e della Patagonia, posti lontani, tuguri strani, personaggi di circo, marinai, delinquenti o contrabbandieri, che denotano influenze tanto dissimili come Villón, Rilke, Evaristo Carriego, o payadores come Bettinotti e Gabino Ezeiza. Come, per esempio, “Junacito Caminador”, un personaggio ispirato a un artista di circo e alla marca di whiskey Johnny Walker, è trasformato dal poeta, in un alter ego letterario dell'autore stesso e che leggiamo qui di seguito “Junacito caminador : (*)
“Junacito caminador
murió en un lejano puerto-
El prestidigitador
poca cosa deja al muerto.
Terminada su función
-canción, paloma y baraja-
todo cabe en una caja,
todo, menos la canción.
Ponle luto a la pianola,
al conejito, a la estrella,
al barquito, a la botella,
al botellón, a la bola.
Música de barracón
-canción, baraja y paloma-
flor de campo sin aroma
Todo, menos la canción.
Ponle luto a la veleta,
al gallo, al reloj de cuco,
al fonógrafo, al trabuco,
al vaso y a la carpeta.
Su prestidigitación
-canción, paloma y baraja-
el tiempo humilla y ultraja,
Todo, menos la canción.
Mucha muerte a poca vida,
que lo entierre de una vez
la reina del ajedrez
y un poeta lo despida.
Truco mágico, ilusión,
-canción, baraja y paloma-
que todo en broma se toma,
todo, menos la canción”.
“Junacito Caminador /morì in un lontano porto -/Il prestigiatore/poca cosa lascia al morto./Finita la sua funzione/- canzone, colomba e mescola le carte/- tutto sta in una scatola,/tutto, meno la canzone./Metti lutto alla pianola,/al coniglietto, alla stella,/alla barchetta, alla bottiglia,/al bottiglione, alla palla./Musica di baraccone/- canzone, mescola le carte e colomba -/fiore di campo senza aroma/Tutto, meno la canzone./Metti lutto alla banderuola,/al gallo, all'orologio a cucù,/al fonografo, al trombone,/al bicchiere e la cartelletta./La sua prestidigitazione/- canzone, colomba e mescola le carte -/il tempo umilia ed oltraggia./Tutto, meno la canzone./Molta morte a poca vita,/che lo seppellisca d'un colpo/la regina degli scacchi/ed un poeta lo licenzi./Trucco magico, illusione,/ - canzone, mescola le carte e colomba -/che per scherzo tutto si prende,/tutto, meno la canzone”.
Ritenuto contemporaneamente uno dei precursori della poesia sociale e combattiva dell'Argentina, è famoso per i suoi "poemi civili", riferiti ad avvenimenti politici e sociali, che molto influirono sulla società bohémien dell’epoca, formata da autori come Julio Huasi, Juan Gelman, con i così detti i poeti del "Pane duro" Roberto Santoro, Francisco Urondo ed in linea generale di tutta la generazione degli anni 60. Fu un intellettuale politicamente compromesso ed in più di un'opportunità assistette ad eventi internazionali che videro impegnati intellettuali ed artisti di cinque continenti. Alcune poesie di Raúl González Tuñón sono state musicate ed eseguite dal Quarteto Cedron, in un album condiviso con Paco Ibañez (*)dal quale leggiamo il suo “poema” dal titolo significativo “La libertad”: (*)
La libertad.
I
“De pronto entró la Libertad.
La Libertad no tiene nombre,
no tiene estatua ni parientes.
La Libertad es feroz.
La Libertad es delicada.
La Libertad es simplemente
la Libertad.
Ella se alimenta de muertos.
Los Héroes cayeron por Ella.
Sin angustia no hay Libertad,
sin alegría tampoco.
Entre ambas la Libertad
es el armonioso equilibrio.
Nosotros tenemos vergüenza,
la Libertad no la tiene,
la Libertad anda desnuda.
(Y el señor Jesucristo dijo
que el reino de Dios vendrá
cuando andemos de nuevo desnudos
y no tengamos vergüenza.)
Hermanos, nosotros sabemos,
pero la Libertad no sabe”.
II
“Hay que ser piedra o pura flor o agua,
conocer el secreto violeta de la pólvora,
haber visto morir delante del relámpago,
conocer la importancia del ajo y el espliego,
haber andado al sol, bajo la lluvia, al frío,
haber visto a un soldado con el fusil ardiente,
cantando, sin embargo, la Libertad querida.
Viva el amor, la vida poderosa,
la muerte creadora de olores penetrantes
y eso porque uno muere y resucita,
la luz sobre los techos de la aurora,
sobre las torres del petróleo,
sobre las azoteas de las parvas,
sobre los mástiles del queso y el vino,
sobre las pirámides del cuero y el pan,
la gente retornando,
una ventana con la bandera en familiar bordado
y la exacta ambulancia, con heridos,
cantando, sin embargo, la Libertad querida.
Hay que ser como el puente necesario,
natural como el lirio, como el toro,
saber llegar al fondo del silencio,
al subsuelo del brote y a la raíz del grito,
hay que haber conocido el miedo y el valor,
haber visto una mano que agita una linterna
de noche, hacia el distante nido de metralla,
hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo
cantando, sin embargo, la Libertad querida”.
III
“De pronto entró la Libertad.
Estábamos todos dormidos,
algunos bajo los árboles,
otros sobre los ríos,
algunos más entre el cemento,
otros más bajo la tierra.
De pronto entró la Libertad
con una antorcha en la mano.
Estábamos todos despiertos,
algunos con picos y palas,
otros con una pantalla verde,
algunos más entre libros,
otros más arrastrándose, solos.
De pronto entró la Libertad
con una espada en la mano.
Estábamos todos dormidos,
estábamos todos despiertos
y andaban el amor y el odio
más allá de las calaveras.
De pronto entró la Libertad,
no traía nada en la mano.
La Libertad cerró el puño.
¡Ay! Entonces...”.
I
“Di colpo entrò la libertà./La Libertà non ha nome,/non ha statua ne’ parenti./La Libertà è feroce./
La Libertà è delicata./La Libertà è semplicemente/la Libertà./Essa si ciba di morti./Gli eroi caddero per Lei./Senza angoscia non c’e’ Libertà,/senza allegria neppure./Tra le due la Libertà/è l’armonioso equilibrio./Noi abbiamo vergogna,/la Libertà non ne ha,/la Libertà va nuda/(E Gesu Cristo disse/che il regno di Dio verrà/quando andremo di nuovo nudi/senza vergogna)./Fratelli, noi sappiamo,/ma la Libertà non sa.”
II
“Bisogna essere pietra/camminare al sole, sotto la pioggia, al freddo,/aver visto un soldato con il fucile ardente,/cantando, tuttavia, la Libertà amata./Viva l’amore, la forte vita,/la morte creatrice di odori penetranti/e questo perché uno muore e resuscita,/la luce sui tetti dell’aurora,/sulle torri del petrolio,/
sui terrazzi delle messi,/sugli alberi maestri del formaggio e del vino,/sulle piramidi del cuoio e del pane,/la gente ritornando,/una finestra con la bandiera casereccia/e l’esatta ambulanza con feriti/
cantando, tuttavia , la Libertà amata./Bisogna essere come il ponte necessario,/naturale come il giglio, come il toro,/saper giungere al fondo del silenzio,/nel sottosuolo del germoglio ed alla radice del grido,/
bisogna aver conosciuto la paura e il coraggio,/aver visto una mano che agita una lanterna/di notte, verso il distante nido di mitragliatori,/bisogna aver visto un morto cicatrizzato e solo/cantando, tuttavia, La Libertà amata.”
III
“Di colpo entrò la Libertà./Dormivamo tutti/alcuni sotto gli alberi,/altri sopra i fiumi,/alcuni ancora tra il cemento,/altri più sottoterra./Di colpo entro la Libertà/con una torcia in mano./Stavamo tutti svegli,/alcuni con picconi e pale,/altri con un paralume verde,/alcuni ancora tra i libri/altri trascinandosi, soli./Di colpo entrò la Libertà/con una spada in mano./Dormivamo tutti,/eravamo tutti svegli/e c’erano l’amore e l’odio/più in là dei teschi./Di colpo entrò la Libertà,/non portava nulla in mano./La Libertà chiuse il pugno.
Ahi! Allora...”.
Tra i musicisti così detti impegnati, troviamo Ariel Gravano leader dell’argentino Quinteto Tiempo (*) che, nelle “canzoni di lotta” raccolte sotto l’egida del movimento della Nueva Cancion Cilena, rappresentano un’altra interessante espressione dello scontro sociale e politico nel quadro della “rinascita culturale” avviata in quegli anni in Cile, e riferite a precisi avvenimenti che hanno segnato la vita politica e civile. Mezzo di propaganda dell’Unità Popolare, queste canzoni segnarono un ritorno alla tradizione nell’intento di ridare valore ai legami millenari del popolo con la nativa terra. Traggo dall’intervista rilasciata all’autore di questo servizio, quanto affermato proprio da Ariel Gravano: “Uno dei compiti fondamentali di un artista popolare è quello di essere veritiero e creatore di cultura, quello di un artista impegnato è dare alle masse una nuova svolta culturale e politica per un fecondo contributo artistico. Le nostre voci sono la testimonianza di molte altre voci spente e imbavagliate che hanno rappresentato il nostro grido alla libertà. Sono le voci di coloro che caddero per conquistare la luce, così come di quelli che scontano con dignità una condanna che pretende di mettere le grate al pensiero, tenere in prigione il passo della storia. Siamo la voce di migliaia di mani tagliate che non suoneranno più una chitarra, di migliaia di occhi che non vedranno la nuova vita, di labbra che non baceranno il futuro”.
Sempre nell’ambito della Nueva Cancion Cilena, vanno qui elencate le “voci” altissime di
poeti e musicisti che più hanno contribuito nel tempo a questo movimento: Victor Jara, Violetta Parra, Inti-Illimani (dei quali segue breve intervista), per aver essi espresso nelle loro canzoni quelle che erano le tensioni psicologiche che hanno preceduto gli eventi, col farsi partecipi del processo evolutivo della “rivoluzione” culturale e intellettuale in atto in Cile. Da non dimenticare Juan Capra il quale, come tutti i migliori, si è formato nella fedeltà ai modelli tradizionali, nell’impegno di costruire, proprio su quei modelli, non per sofisticato estetismo o inutile archeologia, una precisa coerenza ideologica che portò alla “Nuova Canzone Civile”. La scelta dei canti che vi sottopongo qui di seguito testimonia la continuità di un cantare autentico che si è evoluto da canto tradizionale a canto di lotta e che rappresentano l’inizio di un tracciato che in seguito si è allargato a tutto il continente sudamericano.
Tali sono anche gli apporti di Isabel e Angel Parra, entrambi cileni figli di Violetta e continuatori del suo insegnamento; in Venezuela Alì Primera, in Uruguay Yamandu Palacio, in Bolivia Gato Barbieri, in Argentina Athaualpa Yupanqui e Charo Cofre, a formare un itinerario coerente che attraversa tutto il continente, come impegno alla responsabilità, all’impegno sociale e alla solidarietà, sempre.
Di Victor Jara: “ Te recuerdo Amanda”: (*)
“Te recuerdo Amanda
la calle mojada
corriendo a la fabrica donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo,
no importaba nada
ibas a encontrarte con el,
con el, con el, con el, con el.
Son cinco minutos
la vida es eterna,
en cinco minutos.
Suena la sirena,
de vuelta al trabajo
y tu caminando lo iluminas todo
los cinco minutos
te hacen florecer.
Te recuerdo Amanda
la calle mojada
corriendo a la fabrica
donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha
la lluvia en el pelo
no importaba nada,
ibas a encontrarte con el,
con el, con el, con el, con el.
Que partì a la sierra
que nunca hizo dalo,
que partì a la sierra
y en cinco minutos,
que de tі destrozado.
Suenan las sirenas
de vuelta al trabajo
muchos no volvieron
tampoco Manuel.
Te recuerdo Amanda,
la calle mojada
corriendo a la fabrica,
donde trabajaba Manuel”.
“Ti ricordo Amanda /la strada bagnata/correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel./ Il sorriso largo, la pioggia nei capelli,/non importava niente/andavi a trovarti con quello,/
con quello, con quello, con quello, con quello./Sono cinque minuti/la vita è eterna,/in cinque minuti./Suona la sirena,/di giro al lavoro/e tuo camminando l'illumini tutto/i cinque minuti/ti fanno fiorire./Ti ricordo Amanda/la strada bagnata/correndo alla fabbrica/dove lavorava Manuel./Il sorriso largo/la pioggia nei capelli/non importava niente,/andavi a trovarti con quello,/con quello, con quello, con quello, con quello./ Che parti in montagna/che non fece mai ritorno,/che partì in montagna /ed in cinque minuti,/che di te sconquassato./Suonano le sirene/il turno del lavoro/molti non si girarono/neanche Manuel./Ti ricordo Amanda,/la strada bagnata/correndo alla fabbrica,/dove lavorava Manuel”.
Di Violeta Parra: “Gracias a la vida”: (*)
“Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo, lo negro del blanco
Y en el alto cielo, su fondo estrellado
Y en las multitudes, el hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el oído, que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna, de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido, y el abecedario
Con el las palabras, que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha, de mis pies cansados
Con ellos anduve, ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió el corazón, que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes, que es el mismo canto
Y el canto de todos, que es mi propio canto
Y el canto de ustedes, que es mi propio canto”.
(traduzione italiana di Riccardo Venturi).
“Grazie alla vita che mi ha dato tanto, /mi ha dato due stelle che quando le apro/perfetti distinguo il nero dal bianco,/e nell'alto cielo il suo sfondo stellato,/e tra le moltitudini l'uomo che amo./Grazie alla vita che mi ha dato tanto,/mi ha dato l'ascolto che in tutta la sua apertura/cattura notte e giorno grilli e canarini,/martelli turbine latrati burrasche/e la voce tanto tenera di chi sto amando./Grazie alla vita che mi ha dato tanto,/ mi ha dato il suono e l'abbecedario/con lui le parole che penso e dico,/madre, amico, fratello luce illuminante,/la strada dell'anima di chi sto amando./Grazie alla vita che mi ha dato tanto,/mi ha dato la marcia dei miei piedi stanchi,/con loro andai per città e pozzanghere,/spiagge e deserti, montagne e piani/e la casa tua, la tua strada, il cortile./ Grazie alla vita che mi ha dato tanto,/mi ha dato il cuore che agita il suo confine/quando guardo il frutto del cervello umano,/quando guardo il bene così/lontano dal male,/quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari./
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,/mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto,/così distinguo gioia e dolore/i due materiali che formano il mio canto/e il canto degli altri che è lo stesso canto/e il canto di tutti che è il mio proprio canto./Grazie alla vita che mi ha dato tanto”.
Di Juan Capra: “Yo me vuelvo para Chile”: (*)
“Dos años que ando rodando
buscando una solución,
formándome la memoria
y ahora yo quiero la acción.
A Chile lo explotan
como a toda América del Sur,
también Chile es indio y pobre
aunque me lo niegues tú.
Me dicen que Chile es libre,
de santa reformación.
Pero yo no escucho, amigos,
la voz de la religión.
Pregúntenle a los pampinos
y a los mineros del cobre
si la santa democracia
reforma el hambre del pobre.
Los que ya comieron dicen
que Chile es país civil,
creen que nadie recuerda
lo que pasó un dos de abril.
Cuando Frei mató mineros
se oyó una lamentación,
pero ninguno hizo nada:
la izquierda está en división.
Yo me vuelvo para Chile
y ahora quiero la acción.
Callampas, campo y Mapocho
me darán su aprobación”.
“Due anni che cammino ruzzoloni/cercando una soluzione,/formandomi la memoria/ ed ora io voglio l'azione./Al Cile lo sfruttano/come a tutta l'America del Sud,/anche il Cile è indio e povero/benché me lo neghi tu./Mi dicono che il Cile è libero,/di sacra riformazione./Ma io non ascolto, amici,/la voce della religione./Domando ai bambini/ed ai minatori del rame/se la sacra democrazia/riforma la fame del povero./Quelli che mangiarono già dicono/che il Cile è paese civile,/credono che nessuno ricorda/
quello che passò un due di aprile./Quando Friggei ammazzò i minatori/si sentì un lamento,/ma nessuno fece niente:/la sinistra sta in divisione./Mi giro per il Cile/ ed ora voglio l'azione./Callampas, Campo e Mapocho/Mi daranno la loro approvazione”.
“VENID A VER LA SANGRE POR LAS CALLES” – poesie e canzoni per la libertà.
Di Giorgio Mancinelli (Articolo apparso su AudioReview n.23 – 1983).
Solidarietà Popolare, Amnesty International, Nueva Canncion Chilena, Unidad Popular, ne cito solo alcune tra le tante che si sono levate un po’ in tutta l’America Latina e nel mondo, e che sono le tappe di un problema scottante che forse avevamo solo dimenticato, o che speravamo definitivamente risolto, e che invece, all’improvviso, torna di attualità (mai come adesso). Grida Pablo Neruda, e già la sua voce è canto sulla bocca di tutti:
“Per questi morti, i nostri morti, esigo un castigo!”
Oggi, alla luce dei fatti avvenuti e a tantissimi anni di distanza dal golpe che portò la dittatura in Cile nel 1973, la parola “libertà” si sottrae al letargo forzato in cui è stata rinchiusa e torna a essere protagonista di un impegno sociale e civile in difesa dei diritti di tutti contro l’oppressione.
Da “La radice del tuo grido” di J. Cumbo: (*)
“Ti dissero di non gridare, invece gridasti fortissimo.
Non c’era paura sopra i tuoi piedi nudi.
La ragione del tuo grido è rimasta invece nelle nostre mani”.
Da “Los Hermanos” di Atahualpa Yupanqui: (*)
“Possiedo tanti fratelli che non li posso contare e una sposa tanto bella
che si chiama libertà”
Da “Un rio de sangre” di Violeta Parra: (*)
“Un fiume di sangue colo sui contorni del mondo, un grido si alza da tutte le altitudini.
Chiedo il permesso di cogliere il fiore della comprensione, l’erba della speranza, e la piccola foglia del sentimento”.
Da “El pueblo unido” dei Quilapayun: (*)
“Conquistiamo la nostra felicità in un clamore, nelle voci di lotta che si alzeranno,
che canteranno canzoni di libertà”.
Da “Cantata para un Hombre libre” dei Los Calchakis: (*)
“Il giorno in cui nasceranno nei solchi le spighe della libertà, sulle ali di un condor
egli ritornerà verso il suo destino.
Ritornerà dentro i ritmi dei tamburi, sugli arpeggi di tutte le chitarre, ogni volta che una
mano si leva nell’aria per segnare cadenza armoniosa di una danza.
Ritornerà sui fiumi opulenti lungo l’estensione immobile delle pianure, ogni volta
che un destriero galoppa nella Pampa e che un flautista
suona le antiche melodie e sarà il mattino in cui sorge il sole della pace”.
Sono queste le voci dei tanti poeti, spesso gravate dalla preoccupazione per la sorte popolare che si levano da ogni parte dell’America del Sud, di quanti hanno conosciuto l’esilio e di tantissimi altri che si sono fatti portavoce del messaggio “altissimo” quale strumento necessario alla causa cui si sono affidati con impegno. Espressioni culturali a volte considerate incompatibili eppure così affini se si tiene presente la funzione altrettanto importante della musica al servizio della parola, per la quale è stato messo a punto un linguaggio strumentale suggestivo e trascinante, sostenuto dalla padronanza dell’uso degli strumenti tipici. Un modo di fare musica questo, che ha contrassegnato il ritorno alla forma popolare nella continuità della tradizione.
Da “Canciones para mi America” di Daniel Viglietti: (*)
“Dale tu mano al indio
Dale que te hará bien
Y encontrarás el camino
Como ayer yo lo encontré
Dale tu mano al indio
Dale que te hará bien
Te mojara el sudor santo
De la lucha y el deber
La piel del indio te enseñará
Toda las sendas que habrás de andar
Manos de cobre te mostrarán
Toda la sangre que has de dejar
Es el tiempo del cobre
Mestizo, grito y fusil
Si no se abren las puertas
El pueblo las ha de abrir
América esta esperando
Y el siglo se vuelve azul
Pampas, ríos y montañas
Liberan su propia luz
La copla no tiene dueño
Patrones no más mandar
La guitarra americana
Peleando aprendió a cantar”.
“Da' la tua mano all'indio/Dagli che ti farà bene/E troverai la strada/Come ieri io lo trovai/Da' la tua mano all'indio/Dagli che ti farà bene/Ti bagnasse il sudore sacro/ Della lotta ed il dovere/La pelle dell'indio ti insegnerà/Tutti i sentieri che camminerai/ Mani di rame ti mostreranno/Tutto il sangue che devi lasciare/È il tempo del rame/Meticcio, grido e fucile/Se non si aprono le porte/Il paese deve aprirli/America questo sperando/Ed il secolo diventa azzurro/Pampas, fiumi e montagne/Liberano la sua propria luce/La solfa non ha padrone/Modelli non più comandare/La chitarra americana/Litigando imparò a cantare”.
Di Angel Parra un’altra canzone intitolata “La Libertà”: (*)
(o Canción de la libertad)
“La palabra cobra vida
cuando entramos a la mar,
la misma barcaza que antes
nos privó de libertad
hace el camino de vuelta,
a Iquique nos llevará.
En el destierro lejano
quemaba una interrogante:
¿cómo es la libertad?
no puedo el rostro encontrarle.
La libertad eres tú,
son tus ojos y tu pelo,
es la leche de los niños,
es la bandera del pueblo,
es buenos días, señora,
es el tranvía o el cerro,
es el canto esperanzado,
es Neruda en el desvelo,
(libertad es el papel,
complemento de mis versos,
es el abuelo sentado,
la pala del pirquinero,)
es el aire, son las flores,
es el viaje de regreso,
es el marinero errante,
o el que se quedó en Quintero,
es la noche y es el vino,
es el mantel recién puesto,
es el hombre trabajando
en la fábrica o en el puerto,
es la esencia de los libros,
es el silbido del viento,
es no poder decir nunca
que la libertad ha muerto”.
“La parola riscuote vita/quando entriamo alla mare,/la stessa chiatta che prima/ci privò di libertà/fa quello verso giro,/ad Iquique ci porterà./Nell'esilio lontano/bruciava un interrogante:/come è la libertà/non posso il viso trovarlo./La libertà tu sei,/sono i tuoi occhi ed i tuoi capelli,/è il latte dei bambini,/è la bandiera del paese,/è buon giorno, Sig.ra,/è il tram o il dorso,/è il canto speranzoso,/è Neruda nelle insonnie,/libertà è la carta,/completo dei miei versi,/è il nonno seduto,/la pala del pirquinero,)/è l'aria, sono i fiori,/è il viaggio di ritorno,/è il marinaio errante,/o quello che rimase in Fittavolo,/è la notte e è il vino,/è la tovaglia appena posto,/è l'uomo lavorando/nella fabbrica o nel porto,/è l'essenza dei libri,/è il sibilo del vento,/è non potere non dire mai/che la libertà è morta”.
Da “Vientos del Pueblo”, di Isabel Parra leggiamo “Ni toda la tierra entera”: (*)
“Ni toda la tierra entera
será un poco de mi tierra.
Dondequiera que me encuentre
seré siempre pasajera.
Mi trabajo cotidiano,
mis estrellas, mis ventanas
se convirtieron cenizas
de la noche a la mañana.
Puedo hablar, puedo reír
y hasta me pongo a cantar
pero mis ojos no pueden
tanta lágrima guardar.
A pesar de lo que digan
no me olvido, compañero,
de que el pan que me alimenta
siempre será pan ajeno.
Quisiera estar en mi puerta
esperándote llegar.
Todo quedó allá en Santiago,
mi comienzo y mi final.
Si me quedara siquiera
el don de pedir un sí
elegiría la gloria
de volver a mi país”.
“Né tutta la terra intera/sarà un po' di mia terra./Dovunque mi trovi/sarò sempre passeggera./Il mio lavoro quotidiano,/le mie stelle, le mie finestre/si convertirono cenerine/di punto in bianco./Posso parlare, posso ridere/e fino a mi metto a cantare/ma i miei occhi non possono/tanta lacrima conservare./Nonostante quello che dicano/non mi dimentico, compagno,/che il pane che mi alimenta/sarà sempre pane altrui./ Volesse stare nella mia porta/aspettandoti arrivare./Tutto rimase là in Santiago,/il mio principio ed il mio fine./Se rimanessi almeno/il dono di chiedere un sé/sceglierebbe la gloria/di ritornare al mio paese”.
Di Mercedes Sousa “Todavia Cantamos” (*)
“Todavia cantamos
todavia pedimos
todavia soñamos
todavia esperamos …
a pesar de los golpes
que arestó en nuestras vidas
el jingenio del odio
desterrando al olvido ...
a nuestros seres queridos.
Todavia cantamos ...
que nos digan adonde
han escondido a las flores
que aromaron las calles
persiguindo un destino ...
dónde, dónde se han ido.
Todavia cantamos ...
que nos den la esperanza
de saber que es posible
que el jardín se ilumine
con las risas y el canto ...
de los que amamos tanto.
Todavia cantamos ...
por un día distinto
sin apremios ni ayunos
sin temor y sin llanto
porque vuelvan al nido ...
nuestros seres queridos.
Todavia cantamos
todavia pedimos
todavia soñamos
todavia esperamos ...”.
"Ancora cantiamo/ancora chiediamo/ancora sogniamo/ancora speriamo …/nonostante i colpi/che arrestò nelle nostre vite/l’ingegno dell'odio/confinando alla dimenticanza.../ai nostri esseri cari./ Ancora cantiamo.../che ci dicano dove/hanno nascosto ai fiori/che aromatizzarono le strade/ perseguendo un destino.../dove, dove sono andati via./Ancora cantiamo.../che ci diano la speranza/di sapere che è possibile/che il giardino si illumini/con le risate ed il canto.../dei che amiamo tanto./ Ancora cantiamo.../per un giorno distinto/senza frette né digiuni/senza paura e senza pianto/perché ritornino al nido.../i nostri esseri cari./Ancora cantiamo/ancora chiediamo/ancora sogniamo/ancora speriamo...”.
Da “El rio està llmando” del Quinteto Tiempo: (*)
“Avanti compagna! Usciamo nella strada, Il fiume sta chiamando.
Avanti compagna! Non per arrenderci ma spingere la lotta. Avanti!”.
Gli esempi qui riportati ed altri testi significativi, sono stati raccolti in un opuscolo dal titolo “La Nueva Cancion Chilena, ieri, oggi e domani” (*), edito dalla ONAE di Roma che, oltre a dare un’ampia informativa dei fatti salienti occorsi, offre un panorama della musica etnica, degli strumenti e degli artisti che, con il loro contributo si sono fatti portatori del messaggio di libertà. “Libertà!”, una parola uguale in tutte le epoche e in tutti i continenti che, come un fiore abbiamo visto sbocciare sulla bocca dei poeti spontanei che combatterono per conquistarsi il diritto alla vita, o che scontarono con dignità l’esilio o una condanna che pretende di mettere le grate al pensiero, di offuscare la parola, contrastare il passo alla storia. Libertà! Una parola che non può essere svuotata di significato, in essa l’uomo si fa seme, cresce, diventa moltitudine, torna ad emergere per una efficace riproposta di pace. È ancora “l’uomo fratello dell’uomo” che si fa portatore di un messaggio universale, diventa insegnamento, vessillo dei molti, pretesto, arma e pena, la cui eco rimbalza ovunque c’è un popolo che lotta per riaffermare la propria dignità offesa. Mille e più voci levatesi a risvegliare emozioni, sentimenti che trovano fondamento nel rispetto umano, nella solidarietà popolare. Tale è anche il canto del massimo romancero cileno, forse il più grande che l’America Latina può vantare: Pablo Neruda, la cui voce ha spalancato le porte per una riscoperta dell’uomo e dei suoi più alti ideali:
Da “Canto General” di Pablo Neruda: (*)
“… tengo un pacto con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo
... e una parola sola: Libertad!”.
Bibliografia: (consigliata)
José María Arguedas, “Arte popolare, religione e cultura degli indios andini”, Titolo originale: “Formacion de una cultura nacional indo americana”; trad. di Anna Marina Arriola; collana: Nodi, Torino, Einaudi, 1983.
José María Arguedas, Antonio Melis (a cura di), “Musica, danza e riti degli indios del Perù”, Collana: Saggi brevi ; 18, Torino, Einaudi, 1991.
Note:
1)Giorgio Mancinelli, “Musicologia per capire i popoli” – in Etnomusicologia 1, in larecherche@larecherche.it
2)Fernando Alegria, “La obra literaria de Fernando Alegria” – Editorial Mosquito – Santiago de Chile 2000.
1) Pablo Neruda, “Canto General” Vol. I-II – Sansoni Accademia 1970
2) Quilapayun (vedi discografia)
3) Ibidem
4) Los Calchakis (v.d.)
5) Manuel Scorza, “Rulli di tamburo per Rancas” – Feltrinelli 1972.
6) Alfred Metraux, “Gli Inca” – Einaudi 1993.
7) José María Arguedas, “I fiumi profondi”, prefazione di Mario Vargas Llosa - Einaudi, 1971.
“Tutte le stirpi” – Einaudi 1974. - “Festa di Sangue” – Einaudi1976.
8) Gabriel Garcia Marquez, “Cent’anni di solitudine” – Feltrinelli 2005.
9) Raúl Gonzáles Tuñon, “Antologia Poética” – Editorial Losada, Buenos Aires 1992.
10) Raúl Gonzáles Tuñon, in Quarteto Cedrón (v.d.)
11) Ibidem
12) Quinteto Tiempo (v.d.)
13) Victor Jara (v.d.)
14) Violeta Parra (v.d.)
15) Juan Capra (v.d.)
16) Jolu Cumbo (v.d.)
17) Atahualpa Yupanqui (v.d.)
18) Violeta Parra (v.d.)
19) Quilapayun (v.d.)
20) Los Calchakis (v.d.)
21) Daniel Viglietti (v.d.)
22) Angel Parra (v.d.)
23) Isabel Parra (v.d.)
24) Inti Illimani (v.d.)
25) Quinteto Tiempo (v.d.)
26) La Nueva Cancion Chilena (v.d.)
27) Pablo neruda op. cit.
Discografia: (essenziale per entrambi gli articoli pubblicati)
(prima parte)
Early Music Quartet –“Musica Iberica 1100-1600” – Das Alter Werk –Lp 6.48004.
Clemencic Consort-René Clemencic – “Troubadours : l’Amour Coutois au Pays d’Oc (XI-XII sec.)” – Harmonia Mundi – CD 2901524.27.
Ensemble Guillaume de Machaut – « Il Canto dei Trovatori » - Arion – Lp 429.
Gregorio Paniagua – “La Spagna:XV-XVI-XVII Cent.”, con Atrium Musicæ de Madrid BIS - CD 163.”
Gregorio Paniagua – “Villancicos” - con Atrium Musicæ de Madrid – Harmonia Mundi – CD 1901025.
Hespèrion XX – Jordi Savall – “El cancionero de la Colombina” – Astrée Auvidis CD E8763.
Hespèrion XX – Jordi Savall – “El cancionero de Palacio” – Astrée Auvidis CD E8762.
Hespèrion XX – Jordi Savall – “Juan del Enzina: Romances & Villancicos” – Salamanca 1496 - Astrée Auvidis CD E8707.
Hespèrion XX – Jordi Savall – “Canciones y Danzas de España: de l’Epoque de Cervantes” – Lp MEC 1028.
Ensemble Accentus – “Cancionero Musical de Palacio: Musica alla Corte di Spagna 1505-1520” – Naxos – CD 8-553536.
Alla francesca – “Libre Vermell de Montserrat » - Opus – CD 111.
AA.VV. “Las España de las tres Culturas” – Severa records – CD SCD-614.
Orquesta Andalusì de Tanger – “Encuentros” con Juan Peña Lembrjiano – cD Ariola 9J-257240.
Luis Delgado – “Halilem: Resonance de Fesarad” – in Medievalia-New Sounds – CG MED 002.
Sarah Gorby – “Romanceros Judio-Españoles” – Arion Lp FARN 1045.
Rafael Mazas – “Cantos de Espaaña” – Arion Lp FARN 1066.
Monumentos Historicos de la Musica Española – “La musica en la Corte de Los Reyes Catòlicos: Cancionero de Palacio” – Lp MEC 1001.
Monumentos Historicos de la Musica Española – “Musica en la Obra de Cervantes” . Lp MEC 1028.
Monumentos Historicos de la Musica Española – “Cantigas de Santa Maria de Alfonso X El Sabio” – CD MEC 1022-23.
Monumentos Historicos de la Musica Española – “El Canto Mozarabe” – Lp MEC 1009.
(seconda parte)
Aguaviva – “la que mana y corre naturalmente” – Carosello CLN 25.002.
“La casa de San jamas” – Carosello CLN 25031.
“Apocalipsis” – Carosello CLN 25.005.
“No hay derecho” – EMI-Odeon 15203-1977.
Manuel De Falla – “El Retablo de Maese Pedro” dir. P.De Freitas Branco – HispaVox HH – 10-78.
Joaquin Diaz – “Cancionero de Romances” – Movie Play (5Lp) – 27.0002/7.
“Temas tradicionales de la Comunidad de Madrid” – Cons. de Cultura – Lp SED 5034.
“Canciones de los Ancares” - Cons. de Cultura – SAGA Lp SED 5034.
“Jaquin Diaz - Seleccion” – MoviePlay -17.0969.
Paco Ibañez – “La Poesie espagnole”, vol.1-2-3 – Moshé Naim 5310 001/02/03.
“A flor de tiempo” – Ariola 200188-1.
“Por una Cancion” – PDI 30.2331.
“Oroitzen” con Imanol – A Flor de Tiempo – DL B-13435-1999.
Inti Illimani - “Canto de pueblos andinos” vol.1-2 – Zodiaco 8277-8305
“Hacia la Libertad” – Zodiaco VPA 8265
“Viva Chile” – Zodiaco VPA 8263
Lluis Llach – “ Venim del Nord, venim del Sud” – Divergo DVA 024.
Joan Manuel Serrat - “Dedicado a Antonio Machado” – Zafiro SA.
“Los mejores de J.M. Serrat” – IEMPSA – ELD 02.15.507.
“El Retablo de Maese Pedro” dir. Josep Ponce – Harmonia Mundi – HMC 905213.
(parte terza)
Leandro Gato Barbieri – “Bolivia” – Philips 6369-352
“Hasta siempre” – Impulse AS95728
“Latin America” – Impulse AS-9248
Los Calchakis -“Cantata per Santa Maria de Iquique” – Arion –Farn 1023
“Poeti dell’America Latina” – Arion –Farn 1093
“I poeti della rivoluzione” – Arion Farn 1039
Charo Cofrè - “El canto de Chile” – Zodiaco 8224
Marta Contreras – “Canta Nicolas Guillen” – Zodiaco VPA 8362
La Nueva Cancion Chilena – autori vari – ONAE Roma 1980
Yamandu Palacios - “Cancion de nuetsro tempo” – Zodiaco 8235
Juan Capra - “Canti popolari di ieri e di oggi” – Albatros 8180
Victor Jara - “El derecho de vivir en paz” – Albatros 8205
“Te recuerdo Amanda” – Albatros 8184
Violeta Parra - “Santiago penando estas” – Albatros 8183
“Un rio de sangre” – Arion – Farn 1021
Isabel Parra - “Vientos del pueblo” – Zodiaco 8216
Angel Parra - “La libertà” – Zodiaco 8282
Alì Primera - “Adios en dolor mayor” – Zodiaco 8226
Quarteto Cedrón - “Canta Raúl Gonzáles Tuñon” – Polydor 2473 068.
Quilapayun - “Adelante!” – Zodiaco 8346
“Cantata Santa Maria de Iquique” – Zodiaco 8324
Quinteto Tiempo - “El rio esta llmando” – Emi-Odeon 062-81653
Mercedes Sosa – “¿Sera Posible el Sur?” – Philips – 824032-1-A.
“En Argentina” – Philips6388 107/8.
Atahualpa Yupanqui – “A que llman distancia” – Odeon LD 1839
“Cancion para Pablo Neruda” – Le Chant du Monde – LDX 74540.
“Vidala del silenzio” - Le Chant du Monde – LDX 74697.
Chavela Vargas – “Canta Neruda, Yupanqui, Cabral, Falu, Guillen” – Orfeon 32.719.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomus. 6: Il Romance -seconda parte
“Il Romance Spagnolo tra Letteratura e Musicologia”, (seconda parte)
di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, RAI3, e per “Il Canto della Terra”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RSI (Radio della Svizzera Italiana) e articoli apparsi sulle riviste: Nuova Scienza, L’Annuario Discografico, Audio Review).
Dalla monumentale “The History of Music in Sound” edita dalla Oxford University Press / His Master’s Voice, apprendiamo quanto segue sulla tematica della lettura del testo. La storia del Romance è anche la storia di ogni singolo testo nell’ambito di un gusto e di una tradizione comuni. L’identificazione letteraria del romance non si fonda perciò sulla sua origine ma insieme è tematica e stilistica:
“Il tempo breve della composizione (del Romance qui di seguito riportato) è rallentato dal frequente ricorso alla formula ed al parallelismo, che si fa insistente e dolcissimo nella ripetizione immediata o genera le serie anaforiche, e perfino senza riprese verbali governa tutta la struttura del discorso. Altrettanto frequente è la contrapposizione, anch’essa semplicissima ed espressiva. A ogni modo il poeta non interviene mai in prima persona e la narrazione è sempre concretissima e di scorcio ed in genere si subordina al discorso diretto: si veda la descrizione di Granada in “Abenàmar, Abenàmar” (*) o l’inizio di “Rosa fresca”, dove noi non sappiamo nulla del passato amore ma lo intuiamo, come là non sappiamo in che modo Juan II sia giunto davanti a Granada e chi sia Albenàmar, né importa che la storia ci dica che il re fu in vista della città il 27 di giugno 1431, accompagnato dall’infante moro Abenalmao. Il romance non ci pone davanti a fatti o a cose ma alla coscienza di fatti e cose: la domanda del re e la risposta di Abenàmar presuppongono già l’incanto ed il desiderio da cui nascerà la proposta appassionata del re alla città”.
“Così il romance sembra alternare momenti di intensità drammatica, scatti del sentimento o del destino, con altri di distensione e di contemplazione, secondo l’alternanza di contrapposizioni e parallelismi, di perfetti e imperfetti, ma i due aspetti si integrano in un drammatismo decantato, nel senso vivissimo del destino in cui risolvono tutte le tensioni ed i contrasti, chiusi nella misura di un tempo soprannaturale, insieme incalzante e fermo. In “Abenàmar, Abenàmar” la città si nega al re castigliano eppure deve arrendersi, in “Pèsame de vos” non si riconosce colpa eppure si accetta la pena suprema, in “A cacar va don Rodrigo” Mudarrillo è inspiegabilmente atteso fin dall’inizio, ed infatti giunge e non lascia scampo. Il romance racchiude in sé una coscienza della vita forse poco ragionata eppure ricca di singolare modernità per la sua individualità ed il suo drammatismo; ed insieme una coscienza nuova del rapporto fra vita e poesia, riscattato dalla medievale esemplarità, dal didatticismo e dalla mediazione problematica ed idealizzante della letteratura cortese”.
Leggiamo dunque insieme, questo straordinario testo entrato nella tradizione spagnola che, per la bellezza del testo e la sua espressione poetica e al tempo stesso drammatica, giustifica il suo valore e la presenza in questa breve antologia:
"¡Abenámar, Abenámar, / moro de la morería, / ed día que tu naciste / grandes señales había! / Estaba la mar en calma, / la luna estaba crecida; / moro que en tal signo nace / no debe decír mentíra. / No te la diré, señor, / aunque me cueste la vida. / Yo te agradezco, Abenámar, / aquesta tu cortesia. / ¿Qué castillos son aquéllos? / ¡Altos son y relucían! / El Alhambra era, señor, / y la otra, la mezquita; / los otros, los Alixares, / labrados a maravilla. / El moro que los labraba, / / cien doblas ganada al día, / y el día que no los labra / otras tantas se perdía; / desque los tuvo labrados, / el rey le quitò la vida / porque no labre otros tales / al rey del Andalucía. / El otro es Torres Bermejas, / castillo de gran valía; / el otro Generalife, / huerta que par no tenía. / Allí hablara el rey don Juan, / bien oiréis lo que decía: / Si tu quisieras, Granada, / contigo me casaria; / daréte en arras y dote / a Cordoba y a Sevilla. / Casada soy, rey don Juan, / casada soy, que no viuda; / el moro que a mi me tiene / muy grande bien me quería. / Hablara alli el rey don Juan, / estas palabras decía: / Echenme aca mis lombardas / doña Sancha y doña Elvira; / tiraremos a lo alto, / lo bajo ello se daría. / El combate era tan fuerte / que grande temor ponía".
"!Abenámar, Abenámar, / moro del quartiere arabo, / ed giorno che tuo nascesti / grandi segni avevo! / Stava la mare in calma, / la luna era cresciuta; / moro che nasce in tale segno / non deve dire bugia. / Non te la dirò, signore, / benché mi costi la vita. / Io ringrazio per te, Abenámar, / questa tua cortesia? / Che castelli sono quelli? /! Alti sono e rilucevano! / L'Alhambra era, signore, / e l'altra, la moschea; / gli altri, gli Alixares, / coltivati a meraviglia. / Il moro che li coltivava, / / cento pieghi guadagnata al giorno, / ed il giorno che non li coltiva / altrettante si perdeva; / dopo che li ebbe coltivati, / il re gli tolse la vita / perché non coltivi altri tali / al re dell'Andalusia. / L'altro è Torri Vermiglie, / castello di gran valeva; / l'altro Generalife, / orto che pari non tenia. / Lì parlasse il re Don Juan, / bene sentirete quello che diceva: / Se tua volessi, Granada, / con te mi sposerei; / daréi caparra e dote / a Cordova e Siviglia. / Sposata sono, re Don Juan, / sposata sono che non vedova; / il moro che a mio mi ha / molto grande bene mi amavo. / Parlasse lì il re Don Juan, / queste parole diceva: / Mi getti qua le mie bombarde / donna Sancha e donna Elvira; / tireremo alla cosa alta, / la cosa sotto ciò si darebbe. / Il combattimento era tanto forte / che grande paura metteva."
Pervenuti per lo più in manoscritti tardivi, in rielaborazioni di seconda e terza mano, talvolta decurtati di alcune parti, quando non ridotti a poco più di semplici testi sovrapposti uno sull’altro, i romance costituiscono il retaggio di un “fare teatro” che li riscatta dall’etichetta narrativa nel loro insieme, per restituirli integri nella loro originalità, al teatro drammatico vero e proprio, tipico della finzione scenica che trascende la contingenza di luogo e di tempo, per acquisire significato universale, un artifizio questo di molto teatro popolare. Il genere si commenta da solo, a poco – come si è visto – è servito in questa sede, un’analisi sistematica dei testi, coniugare il soggetto coi personaggi o con la metrica del verso.
Le forme musicali più frequenti sono, come si è detto, il villancico somigliante alla frottola italiana, e lo zejel arabo. Il fraseggio compositivo delle canzoni non è unificato e varia dalla semplice monodia: dall’espressione vocale formata da tre-voci nel discanto, lasciato al tenore e al controtenore, alla forma polifonica vera e propria a sei-voci del XVI secolo. Altra forma presente, sebbene in numero minore, è ancora il romance, letteralmente "portato” nelle corti e foderato con perfezioni e squisitezze colte, diverso nella metrica che risulta irregolare, fiorita per bocca di buffoni e narratori che l’adattarono ai canoni dell’epoca. Trascritto più tardi in versi di otto sillabe (ottonari) in forma strofica che, vale qui la pena ricordarlo, il romance sempre inizia con un verso introduttivo (estribillo), continua con una strofa originale (copla), e termina con la (vuelta), cioè il ritorno all’inizio.
Forme queste, che ritroviamo anche nella musica popolare, basata su una struttura armonica molto semplice, che man mano si andò arricchendo di nuove espressioni strumentali con inserimenti corali, e una più sensibile espressione del testo, al pari di quella “spiritualità” cortese di stampo religioso conosciuta come musica sacra. In ognuna delle molte canciones o villancicos il canto popolare sempre si mostra come il fiore della vita culturale spagnola, destinato, per il tramite d’una risorta autocoscienza, fortificata dal fatto dell’avvento di un nuovo spirito nazionale che attraverso il contatto con le altri nazioni europee, che caratterizzò in profondità lo stile musicale del romance – “accompagnato da brevi e monotone note” , come ha commentato l'eminente Menéndez Pidal, che lo ha ben esposto nel suo "Romancero Ispanico" (*):
“… quello que sin ningun orden, regla ni cuento, facen estos romances e cantares de que las gentes de baxa e servil condicion se allegra, forman un solo cuerpo tradicional”.
"… quello che senza nessun ordine, riga né conto, fa di questi romanzi cavallereschi e dei canti che le genti di bassa e servile condizione rallegra, forma un solo corpo tradizionale".
Non in ultimo, va riscontrata un'indubbia tendenza del romance verso il verismo, che però non deve confondersi con un realismo troppo dettagliato, il che lo porterebbe a eliminare la sua potenza archetipica e i suoi misteriosi suggerimenti. La realtà che i “romance cavallereschi” ci mostrano è di per sé una realtà in certa misura trasfigurata nell’aspetto, più o meno veridico della cosa ideale o idealizzata, connessa con chiavi ed echi di magica trascendenza; le cui caratteristiche possono apprezzarsi, in certo qual modo, più per la stringente spontaneità, che per rilevanza storica o realistica. Come si può riscontrare in “L'apparizione” (*), di anonimo, che qui leggiamo un breve stralcio nella versione di Campaspero di Valladolid:
"Se ha asustado mi caballo / yo tambien me sorprendì. / No te asustes, caballero / no te asustes tù de mì, / que yo soy la tu querida / la que llaman Beatriz. / Còmo siendo mi querida / no me hablas tù a mi?/ Boca con que yo te amaba / ya no la traigo yo aquì, / que me la pidiò la tierra / y a la tierra se la dì. / Ojos con que te miraba / tampoco les traigo acquì, / que me les pidiò la tierra / y a la tierra se les dì. / Brazos con que te abrazava, / tampoco les traigo aquì, / que me les pidiò la tierra / y a la tierra se les dì. / Yo venderé mi caballo / para misas para tì, / y me venderé a mì mismo / porque no pases allì. / No vendas a tu caballo / ni te pongas a servir; / cuantas màs misas me digas / màs tormentos para mì".
“Si è spaventato il mio cavallo / che anch’io mi sorpresi. / Non ti spaventare, cavaliere / non ti spaventare di me, / che io sono la tua amante / quella che chiamano Beatrice. / Come mai, pur essendo la mia amante / non parli tu a me? / Bocca con che io ti amavo / non la porto oramai io qui, / che io la chiesi alla terra / ed alla terra io la diedi. / E gli occhi con cui io ti guardavo / neanche quelli porto io qui, / che io li chiesi alla terra / ed alla terra essi li ho dati. / E queste braccia con che tu abbracciavi, / neanche loro porto qui, / che io essi chiesi alla terra / ed alla terra essi ho dato. / Io venderò il mio cavallo / per dire messe per te, / e venderò me stesso / perché non passi lì. / No, non vendere il tuo cavallo / né mettiti a servire; / quante più messe tu mi dica / più aumentano i tormenti per me".
Come è possibile comprendere dal testo che abbiamo appena letto, l’atmosfera dell’amor cortese, fa ancora da sfondo a quella culturale del periodo entro il quale il Romance fiorì e si sviluppò, e che, ritessuta nelle forma più erudita del genere novelesco, trovò una sua evoluzione più tardi, in epoca Barocca e per certi versi nel corso dei secoli XVI e XVII in cui assistiamo a una ripresa assai suggestiva, da parte di musicisti e letterati illustri che ne fecero un genere raffinato, utilizzato poi nella successiva forma polifonica. Ne sono esempi illustri: Luis de Góngora, teso al recupero dell’aspetto primario ricco d’immaginazione e fantasia; Francisco de Quevedo, che nel Romance evidenziò l’aspetto satirico e menzognero; Lope de Vega il cui ideale cortese consisteva in un colto casticismo che sovrapponeva la tradizione del Romancero, all’eleganza e alla dolcezza della metrica italiana. Per arrivare alla nostra epoca con Blas de Otero, che trasformò la figura del “poeta” in un “profeta” che segnala gli errori del presente per riuscire a superarli ed accedere a un futuro migliore. In entrambi i casi, questi autori, con fare di moderni musicologi, si adoperarono nel recupero delle antiche melodie tradizionali e poemi anonimi e popolari di molti autori del passato, e altri ne composero, interpretando con notevole compiacenza, i sogni e gli ideali della Spagna feudale.
Facciamo anche noi un passo indietro nell’affrontare un aspetto finora trascurato in questa ricerca che a fatica s’inoltra nel mare magnum della letteratura spagnola riferita al Romance, e recuperare, lì dove ci siano state carenze, alcuni testi di rilevante importanza. Ovviamente il semplice elencare testi non comporterà una loro assunzione nella ricerca qui avviata che certo non valica il muro della conoscenza archeologica, ma si vuole essere di stimolo per riscoprire quanto di essi ha contribuito alla nostra formazione letteraria e non solo. Soprattutto di quanto oggigiorno viene utilizzato da molti autori che crediamo originali, creatori di fumetti e romanzi, giochi elettronici e cinema fantasy, e che invece, sicuramente, dobbiamo a quanti: filologi e ricercatori, etnomusicologi e musicisti, letterati e semplici ricercatori appassionati, che si sono prodigati nel recupero di tanta letteratura e che ci permettono di rivisitare quell’epopea portentosa del passato, non senza scaturire in noi, attuali fruitori senz’anima, una pur vaga emozione che testimonia una creatività esemplare, mai venuta meno.
La tradizione del Romance dunque, si presenta a noi di una tale ricchezza che definirei quasi miracolosa, e che invito qui a riscoprire, per l’essere sorprendentemente ricca di spunti poetici e non solo. A partire da un autore che in assoluto si leva su tutti (almeno per noi ricercatori), testimone della popolarità che ebbero il Romance e i Romanceros nella tradizione spagnola: Miguel de Cervantes de Saavedra. Il quale, nel suo “Don Quijcote de la Mancia” (*), che di fatto possiamo definire quasi un lungo “romance nel romance”, elenca circa quaranta strumenti musicali in accordo con la loro funzione e colore timbrico perfettamente allogati e aggettivati secondo la lingua popolare. Nonché venti danze e balli tra quelli menzionati; altrettanto dicasi delle canzoni che corrono di bocca in bocca e che l’autore fa cantare ai suoi personaggi; mentre sono almeno una dozzina i romance citati. Un esempio di quella che è la sua sterminata conoscenza enciclopedica, lo troviamo in apertura del capitolo XXXXIII, in cui il Romance è annunciato dal canto “in sulla prima ora dell’alba”, l’ora propizia per il canto amoroso in letteratura:
“Marinero soy de amor / y en su piélago profundo / navego sin esperanza / de llegar a puerto alguno … ”.
“Marinaio son d’amore / e nel suo pelago profondo / navigo senza speranza / di arrivare in porto alcuno …”.
Il romance popolare spagnolo si rivela comunque in tutta la sua ricchezza di contenuto, quale mezzo espressivo di sentimenti che vorremmo fossero nostri, nel ritrovare quella compostezza, quella integrità nazionalistica di un popolo che già allora si distingueva per il temperamento virile dei suoi personaggi, per l’ardire di un torneo o di una corrida, per i ritmi sfrenati dei suoi bailes, l’andamento malinconico del cante, la nostalgica cadenza della vihuela, l’insolenza della chitarra flamenca o morisca, la voce alta dei suoi poeti. Una voce altamente sonora, con la quale ogni poeta d’oggi che si misura nel romance, diventa subito autentica e popolare, nell’accezione della parola stessa di narrazione, che prende forma dal popolo e nel suo essere popolare trova la sua continuità e la sua massima affermazione creativa, secondo il metodo che restituisce al popolo la sua storia, e di cui diviene – in senso assoluto – protagonista:
“… col tagliare e aggiungere versi, col sopprimere o variare le parole, col modificare lo svolgimento o alterare capricciosamente gli avvenimenti e le azioni dei personaggi, o meglio, col riscrivere la storia secondo un singolare punto di vista, secondo una propria logica dei fatti …”.
È qui che in veste di protagonisti, storici o leggendari che siano, gli eroi chiamati ad agire all’interno del romance, si destano e reclamano quella vita letteraria che spetta loro di diritto, che pure va oltre la finzione scenica, oltre la carta stampata, per entrare a far parte della mitografia popolare. Come ancora scrive Miguel de Cervantes nella sua opera più famosa:
“… para mover los sentidos de sus lectores e nel teatro, de sus posibles spectatores”.
“… per muovere i sensi dei suoi lettori e nel teatro, dei suoi possibili spettatori”.
A dimostrazione del fatto che nella tradizione del romance troviamo una tale ricchezza, che definirei prodigiosa, e che invito a raccogliere e a rivalutare, malgrado sia ormai molto diversa dalle origini che abbiamo affrontato, e che si presenta ancora sorprendentemente ricca di spunti poetici.
“Quello che c’è di prodigioso nel “Don Chisciotte” è la totale assenza di artificio e la continua fusione di illusione e realtà, che ne fanno un libro così comico e così poetico”…
Con queste parole Flaubert celebrava, più di due secoli dopo la sua pubblicazione, la grande opera con la quale Miguel de Cervantes aveva dato inizio al romanzo europeo, inventando una forma narrativa che, sotto il segno dell’ironia, si è dimostrata capace di rappresentare le grandi contraddizioni dell’uomo e del mondo; il confine tra il sogno, la fantasia e la cruda realtà materiale che la dice lunga sull’eterno disagio di vivere, sui desideri e sulle frustrazioni, e a distanza di tanti anni continua a raccontare tutto il tragico e il comico del mondo, da cui l’incipit del prologo:
“Lettore mio, che non hai nulla di meglio da fare …”.
Non poca importanza va quindi attribuita al Cervantes musicologo, conoscitore ed estimatore della musica del suo tempo, tanto più va sottolineata la sua funzione di ricercatore e trasmettitore dell’antica tradizione, sebbene, egli ne abbia fatto, per così dire, un uso speculativo all’interno del suo romanzo (e che romanzo), col voler dare ai suoi personaggi una parvenza di realtà e di lucida follia. E che bene interpretò il noto compositore contemporaneo Manuel de Falla, il quale, nella messa in musica di “El retablo de Maese Pedro”(*), improntato sulla storia di “Gaiferos e Melisenda” (*), d’appartenenza al Romance epico, in cui il “retablo”, cioé il teatrino dei burattini, fa da sfondo alla rappresentazione che si svolge davanti a Don Quijote, l’ultimo e certamente il più nobile dei cavalieri erranti che siano mai esistiti.
Nel suo romanzo Miguel de Cervantes, l’antico e romance vijeos assume una posizione di grande rilievo, rendendogli quell’attualità che in parte esso aveva perduta nel tempo, ottenendo così un duplice effetto: integrativo della rappresentazione che si svolge sulla scena, alla vita dello spettatore e viceversa e, al tempo stesso, permette a Don Quijote di entrare nel vivo della rappresentazione. Una scena che ritroviamo nella finzione del “teatro nel teatro” e ancor più nel cinema: da “Hellzapopping” di Henry C. Potter, a “La Rosa purpurea del Cairo” di Woody Hallen , dove la “finzione sostituisce la realtà che sostituisce la finzione”, in quanto elemento caratterizzante di un accadimento, attraverso il quale l’autore colto, il musicista galante, il narratore forbito, con l’assegnare ai personaggi certe emozioni, li consegna alla vita reale o inventata che sia, restituendo al lettore prima, all’ascoltatore poi, così come al cineamatore meravigliato, una diversa condizione esistenziale, attraverso la quale è sollecitato il sogno, la fantasia, l’istinto, la follia, l’ignoto:
Giace qui l’hidalgo forte
Il cui valore arrivò
A tal punto che ebbe in sorte
Che la morte non trionfò
Della vita con la morte.
Poco il mondo calcolò.
Se ebbe d’orco la figura,
un’insolita mistura
la ventura in lui provò:
visse pazzo e morì savio.
È ancora Cervantes che ci fa dono di questo sonetto, se pure va ricordato che sono passati secoli da che Miguel de Cervantes scrisse il suo famoso romanzo e altrettanti da che l’eco di quella che fu la poesia epica spagnola fosse ripresa dai suoi poeti più insigni: “che è poi il segreto spirito del romance che torna a forgiare noi moderni”, come affermato da Léon Felipe, uno dei grandi poeti spagnoli del novecento che ha dato nuova voce al romance epico e cavalleresco, quello stesso spirito che releghiamo all’antica voce della terra e che trascende la contingenza di luogo e tempo, per acquisire quei significati universali che sono propri della grande poesia. Quand’ecco:
“Per la pianura della Mancha / torna a vedersi la figura /
di Don Chisciotte passar”.
L’affermarsi del Romance nuevos, portato in parallelo all’evoluzione del gusto letterario castigliano, si rivolge dunque ad atteggiamenti più moderni, ciò che avviene in quasi tutti i campi della cultura la cui frammentazione è senza dubbio, come dice Menendéz Pidal: “Un poderoso atto creativo, straripamento di lirismo che infonde nei versi vecchi una poesia nuova di incalcolabile virtualità”. Quindi non nasce da un gusto storicamente individuato e cronologicamente determinato. Che sia del tutto casuale e forse del tutto estraneo ai secoli precedenti? C’è tempo per una risposta, intanto riprendiamo da dove avevamo lasciato. Numerosi sono i romance viejos inseriti nella discografia di molti interpreti attuali, cantanti, narratori ecc. di fama internazionale, ed altri fanno parte della produzione poetico - letteraria di altrettanti autori moderni, a rappresentare che il romance non si è mai estinto, bensì è sempre stato di grande attualità nella cultura spagnola, nelle forme dello spettacolo teatrale e della produzione discografica.
Sul finire del ‘900, il Romance trova rifugio nella letteratura colta, utilizzato dai grandi poeti delle generazioni del ‘27 e del ‘98, di cui ricordiamo i geniali esempi di Francesco de La Torre, Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Cesar Vallejo, Ruben Dario, Francisco de Quevedo, Blas de Otero, Michel Hernandez, Jorge Manrique, Fanny Rubio, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Léon Felipe, Gabriel Celaya, José Antonio Munoz, Gloria Fuertez, nelle cui opere, solitamente non tutte molto considerate dalla critica letteraria, troviamo invece una perfetta simbiosi fra voce di popolo e voce d’artista che, in brevi quadretti, sovente costruiti secondo lo schema iterativo del “botta e risposta” tipico della espressività popolare, ci confermano la loro estrazione popolare e proletaria. Infatti non possiamo qui parlare dei “canciones y poemas” di questi autori senza parlare di alcuni di essi che hanno dato un forte e glorioso contributo alla moderna poesia spagnola. In questo spettro ravvicinato di poeti va senz’altro annoverato Federico Garcia Lorca, “la voce della poesia popolare”. Enrico Lepari (*) ha scritto di lui:
“Nonostante si sia formato culturalmente (Università di Granada), Lorca possiede in sé quegli elementi che sono propri della cultura popolare, per cui il diritto alla vita lo si conquista giorno dopo giorno, fra mille sconfitte, infinite sofferenze, ma anche con grandi e improvvisi squarci di autentica gioia e felicità”.
Sentimenti come l’amore, la libertà, il diritto al lavoro, le passioni giovanili, la lotta civile, l’odio, l’amicizia, la sconfitta e la vittoria, sono tutti grandi temi cui Lorca a saputo dare una risposta o e che almeno sono stati la base da cui poterli affrontare in maniera diretta, talvolta immediata, con quel senso di concretezza che è distintivo dell’animo popolare. Soprattutto quando, con l'aiuto di Fernando de Los Ríos, che nel frattempo è diventato Ministro della Pubblica istruzione, García Lorca, con attori e interpreti selezionati dall'Istituto Escuela di Madrid con il suo progetto di Museo Pedagocico, realizza insieme a Rafael Rodríguez Rapún, studente d'ingegneria conosciuto a Madrid, il progetto di un teatro popolare ambulante, chiamato La Barraca.
Lorca, che ne è insieme ideatore e regista, nonché animatore entusiasta della piccola troupe teatrale, vestito con una semplice tuta azzurra a significare ogni rifiuto di divismo, porta in giro negli ambienti rurali e universitari il suo teatro facendo conoscere gran parte del repertorio classico spagnolo. In un primo tempo Lorca manifesta il suo talento come espressione orale seguendo lo stile della tradizione giullaresca riscuotendo un grande successo. Il poeta infatti recita, legge, interpreta i suoi versi e le sue pièce teatrali davanti agli amici e agli studenti dell'università prima ancora che siano raccolte e stampate. Ma pur essendo un artista geniale ed esuberante, mantiene verso la sua attività creativa un atteggiamento severo chiedendo ad essa due condizioni essenziali: amor y disciplina. Attività questa che egli svolge senza interruzione fino all'aprile del 1936, a pochi mesi dallo scoppio della guerra civile in Spagna.
Nel “Libro de poemas” (*), composto dal 1918 al 1920 García Lorca documenta il suo grande amore per il canto e la vita; dialoga con il paesaggio e con gli animali con il tono modernista di un Rubén Darío o un Juan Ramón Jiménez facendo affiorare le sue inquietudini sotto forma di nostalgia, di abbandoni, di angosce e di protesta ponendosi domande di natura esistenziale:
“Qué me encierro en mí / ¿en estos momentos de tristeza? / Ay, quién corta mis bosques / ¡dorados y floridos! / Qué leo en el espejo / de plata compadecida / qué la aurora me ofrece / sobre el agua del río?”.
“Che cosa racchiudo in me / in questi momenti di tristezza?/ Ahi, chi taglia i miei boschi / dorati e fioriti! / Che cosa leggo nello specchio / d'argento commosso / che l'aurora mi offre / sull'acqua del fiume?”.
In questi versi ci sembra ancora di sentire il sottofondo musicale che, modulando la pena del cuore, riflette la situazione d'incertezza vissuta e il suo distacco dalla fase dell'adolescenza. Il periodo che va dal 1921 al 1924 rappresenta un momento molto creativo e di grande entusiasmo lirico, anche se molte delle opere prodotte vedranno la luce solo anni dopo, come il suo “Libro de canciones” (*) del 1927, in cui trasfuse gli spiriti di un lirismo moderno e genuino col reinventate parti melodiche e testi semi-dimenticati, cui ne aggiunse altri di sua creazione. Nel suo precedente “Poema del Cante jondo” (*), (canto profondo della terra andalusa), scritto tra il 1921 e il 1922, troviamo invece tutti i motivi del mondo andaluso ritmati sulle modalità musicali del Cante Jondo a cui Lorca aveva lavorato con il maestro De Falla in occasione della celebrazione della prima Fiesta del Cante jondo, cui aveva dedicato, nel 1922, la conferenza “Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado «cante jondo»”, dal quale traggo questo inizio di canto:
“… Sobre el tablado oscuro / la Parrala sostiene / una conversaciòn / con la muerte, / La llama / no viene / y la vuelve a llamar / ...”.
“... Sopra il tavolaccio oscuro / La Parrala tiene / una conversazione / con la morte. / La chiama / non viene / e torna a chiamarla / …”.
E ancora:
“… Hasta el alma me duele, seniores, / De tanto querer. / Los tormentos de mis negrs duquelas / Yo no se los mando / A mis nemigos / ...”.
“... Perfino l’anima mi duole, signori, / Per il tanto amore. / I tormenti delle mie nere pene / Io non li auguro nemmeno / Ai miei nemici / …”.
Il testo vuole essere un'interpretazione poetica dei significati legati a questo canto primitivo che esplode nella ripetizione ossessiva dei suoni e dei ritmi popolari, espressi poi nelle canciones: siguiriya, soleá, petenera, tonáa, liviana, accompagnate dal suono della chitarra, da cui prende il nome il sonetto che segue:
“Empieza el llanto / de la guitarra. / Se rompen las copas / de la madrugada. / Empieza el llanto / de la guitarra. / Es inútil callarla. / Es imposible callarla. / Llora monótona / como llora el agua, / como llora el viento / sobre la nevada”.
“Comincia il pianto / della chitarra. / Si spezzano le coppe / dell'alba. / Comincia il pianto / della chitarra. / È inutile tacerla. / È impossibile tacerla. / Piange monotona / come piange l'acqua. / Come piange il vento sulla montagna”.
Voler spiegare qui le caratteristiche tecniche vocali del Cante Jondo, le sue numerose varietà di forma, si presenta quanto di più arduo. Tuttavia, a una lettura più approfondita, appare come una sorta di linguaggio dalle forti emozioni, in cui il cantore gitano esprime i propri sentimenti interiori, l’intimità del suo pensiero profondo, il verbo recondito della parola esteso all’infinito nella ricerca di possibili assonanze che si riallacciano alla vita, all’amore, o forse a una rivalità riferita a un sogno, al ricordo di un cielo perduto dietro una montagna che si fa canto. O ancora, a un afflato essenzialmente notturno, che meglio risuona nell’oscurità e nell’intimità della notte come il gorgheggio dell’usignolo: un canto doloroso di una malinconia struggente lasciata al vento, confidente di una profonda pena d’amore. Quegli stessi sentimenti che Garcia Lorca tradusse in linguaggio vivido e concitato, che trasferì nei suoi testi teatrali più famosi: “Bodas de sangre”, “Yerma”, autentici Romance rusticani che abbiamo visto danzati in maniera strepitosa da Antonio Gades, rappresentati a teatro da innumerevoli compagnie di tutto il mondo e non in ultimo ripresi poi in sede cinematografica dal regista Carlos Saura.
Altro esempio importante nel quale troviamo una simile venatura poetica “rusticana”, benché talvolta più ricercata, è Antonio Machado. Nelle elezioni del 1931 fu tra gli strenui sostenitori della Repubblica e, l'anno successivo si trasferì definitivamente a Madrid insieme alla famiglia del fratello José (pittore e disegnatore) e all'anziana madre che restarono con lui fino alla morte. Intanto proseguì la pubblicazione dei suoi versi e nel 1933 fu la volta della terza edizione delle “Poesías completas” (*) cui venne aggiunta una ulteriore sezione: “De un cancionero apócrifo”. In “Soledades” (1899-1902), la sua prima raccolta poetica pubblicata, è presente in modo evidente l'impronta del modernismo rubendariano ma, contemporaneamente, si può ben notare la propria tensione verso un linguaggio apparentemente semplice e l'intensa introversione poetica. Il titolo stesso “Solitudini”, annuncia l'essenza intimistica del libro: solitudini non solo dell'uomo ma anche dello spazio abitato solo dal soggetto che dialoga in modo autobiografico con i fantasmi del proprio passato, onde tutto appare velato di malinconia e di nostalgia attraverso le immagini tipiche del decadentismo: i giardini abbandonati, i vecchi parchi, le fontane, che in chiave simbolica, rappresentano lo stato d'animo del poeta.
In “Campos de Castilla” (1907-1917) il poeta evoca con tratti essenziali la solennità del paesaggio circostante, rievocato con un'ottica quasi visionaria in cui l' “io” si apre al dialogo entrando a far parte del "noi" del proprio tempo storico segnando definitivamente il distacco dell'estrema soggettività di “Soledades” dalla dimensione storica, come si legge appunto nella sua introduzione. In molti passi, infatti, sono presenti rimandi agli eventi passati della storia della Spagna e al dibattito ad essi collegato. Tematica che verrà ripresa in seguito, allorquando la nazione si troverà a essere soggiogata dal potere dittatoriale e dalla guerra civile:
“Mas otra España nace, la España del cincel y de la / maza, / con esa eterna juventud che / se hace / del pasado macizo de la raza. / Una España implacable y / redentora, / España que alborea / con un hacha en la mano vengadora, / España de la rabia y de la idea”.
“Ma un'altra Spagna nasce, / la Spagna dello scalpello e della / mazza,/ con quella eterna gioventù ch'è / fatta / del passato massiccio della razza. / Una Spagna implacabile e / redentrice, / Spagna che albeggia / con un'ascia nella mano / vendicatrice, / Spagna della rabbia e dell'idea”.
Il nostro maggiore interesse va però al suo libro “Cancionero apócrifo” (*) (attribuito ad Abel Martín, uno degli eteronimi di Machado) dove il poeta accentua l'esplorazione della propria identità e riflette sull'eterogeneità dell'essere, nel quale il poeta opta per la prosa con una forte tendenza alla frammentazione nella quale si riflette il convincimento della disgregazione dell'esistenza. Da “Soledades” leggiamo insieme questo “Poema Caminante No Hay Camino” che più risente della forma del romance, nel modo in cui la ripetizione di alcune parole (versi, grida) ricorda da vicino l’enfasi del narrare del Romanceros:
“Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, / caminos sobre el mar. / Nunca persequí la gloria, / ni dejar en la memoria / de los hombres mi canción; / yo amo los mundos sutiles, / ingrávidos y gentiles, / como pompas de jabón. / Me gusta verlos pintarse / de sol y grana, volar / bajo el cielo azul, temblar / súbitamente y quebrarse… / Nunca perseguí la gloria. / Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. / Al andar se hace camino / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante no hay camino / sino estelas en la mar… / Hace algún tiempo en ese lugar / donde hoy los bosques se visten de espinos / se oyó la voz / de un poeta gritar / “Caminante no hay camino, / se hace camino al andar…” / Golpe a golpe, verso a verso… / Murió el poeta lejos del hogar. / Le cubre el polvo / de un país vecino. / Al alejarse le vieron llorar. / “Caminante no hay camino, / se hace camino al andar…” / Golpe a golpe, verso a verso… / Cuando el jilguero no puede cantar. / Cuando el poeta es un peregrino, / cuando de nada nos sirve rezar. / “Caminante no hay camino, / se hace camino al andar…” / Golpe a golpe, verso a verso”.
"Tutto passa e tutto rimane, / ma egli nostro è passare, / passare facendo strade, / strade sul mare. / Mai perseguì la gloria, / né lasciare nella memoria / degli uomini la mia canzone; / io amo i mondi sottili, / imponderabili e gentili, / come pompe di sapone. / Mi piace vederli dipingersi / di sole e grana, volare / sotto il cielo azzurro, tremare / improvvisamente e rovinarsi … / non perseguii Mai la gloria. / Viandante, sono le tue orme / la strada e nient'altro; / viandante, non è strada, / si fa strada camminando. / Camminando si fa strada / e girando dietro la vista / si vede il sentiero che mai / deve tornare a pestare. / Viandante non è strada / bensì steli nella mare … / Fa qualche tempo in quello posto / dove oggi i boschi si vestono di spini / si sentì la voce / di un poeta gridare / "Viandante non è strada, / si fa strada camminando"… / Colpo a colpo, verso a verso … / Morì il poeta lontano dalla casa. / Lo copre la polvere / di un paese vicino. / Allontanandosi videro piangere. / "Viandante non è strada, / si fa strada camminando"… / Colpo a colpo, verso a verso … / Quando il cardellino non può cantare. / Quando il poeta è un pellegrino, / quando di niente ci serve pregare. / "Viandante non è strada, / si fa strada camminando"… / Colpo a colpo, verso a verso."
Di Francico de Quevedo: “Romance satirico” (*)
“Pues me hacéis casamentero, /Ángela de Mondragón, / escuchad de vuestro esposo / las grandezas y el valor. / Él es un Médico honrado, / por la gracia del Señor, / que tiene muy buenas letras / en el cambio y el bolsón. / Quien os lo pintó cobarde / no lo conoce, y mintió, /que ha muerto más hombres vivos / que mató el Cid Campeador. / En entrando en una casa / tiene tal reputación, / que luego dicen los niños: / «Dios perdone al que murió». / Y con ser todos mortales / los Médicos, pienso yo / que son todos venïales, / comparados al Dotor. / Al caminante, en los pueblos / se le pide información, / temiéndole más que a la peste / de si le conoce, o no. / De Médicos semejantes / hace el Rey nuestro Señor / bombardas a sus castillos, / mosquetes a su escuadrón. / Si a alguno cura, y no muere, / piensa que resucitó, / y por milagro le ofrece / la mortaja y el cordón. / Si acaso estando en su casa / oye dar algún clamor, /tomando papel y tinta / escribe: «Ante mí pasó». / No se le ha muerto ninguno / de los que cura hasta hoy, / porque antes que se mueran / los mata sin confesión. / De envidia de los verdugos / maldice al Corregidor, / que sobre los ahorcados / no le quiere dar pensión. / Piensan que es la muerte algunos; / otros, viendo su rigor, / le llaman el día del juicio, / pues es total perdición. / No come por engordar, / ni por el dulce sabor, / sino por matar la hambre, / que es matar su inclinación. / Por matar mata las luces, / y si no le alumbra el sol, / como murciégalo vive / a la sombra de un rincón. / Su mula, aunque no está muerta, / no penséis que se escapó, / que está matada de suerte / que le viene a ser peor. / Él, que se ve tan famoso / y en tan buena estimación, / atento a vuestra belleza, /se ha enamorado de vos./ No pide le deis más dote / de ver que matáis de amor, / que en matando de algún modo / para en uno sois los dos. / Casaos con él, y jamás / vïuda tendréis pasión, / que nunca la misma muerte / se oyó decir que murió. / Si lo hacéis, a Dios le ruego / que os gocéis con bendición; / pero si no, que nos libre / de conocer al Dotor”.
“Perché mi fate pronubo, / Ángela di Mondragón, / ascoltate di vostro marito / le grandezze ed il valore. / Egli è un Medico onesto, / per la grazia del Sig., / che ha molto buone lettere / nel cambiamento ed il bolsón./ Chi ve lo dipinse codardo / non lo conosce, e mentì, / che è morto più uomini vivi / che ammazzò la Cid Prode. / In entrando in una casa / ha tale reputazione, / che dopo dicono i bambini: / Dio perdoni a quello che "morì." / E con essere tutti mortali / i Medici, io penso / che sono tutti veniali, / comparati al Dottor. /Al viandante, nei paesi / gli è chiesto informazione, / temendolo più che alla peste / di se lo conosce, o no. / Di Medici simili /fa il nostro Re Sig./ bombarde ai suoi castelli, / moschetti al suo squadrone. / Se ad alcuno curato, e non muore, / pensa che resuscitò, / e per miracolo gli offre / il sudario ed il cordone. / Semmai stando nella sua casa / sente dare qualche clamore, / prendendo carta e tinge / scrive: "Davanti a me passò." / Non gli è stato morto nessuno / dei che cura fino ad oggi, / perché prima che muoiano / il cespuglio senza confessione. / Di invidia dei boia / maledice il Governatore, / che ecceda gli impiccati / non gli vuole dare pensione. / Pensano che è la morte alcuni; / altri, vedendo il suo rigore, / lo chiamano il giorno del giudizio, / perché è totale perdizione./ Non mangia per ingrassare, / né per il dolce sapore, / bensì per ammazzare la fame, / che è ammazzare la sua inclinazione. / Per ammazzare cespuglio le luci, / e se non l'illumina il sole, / come murciégalo vive / all'ombra di un angolo./ La sua mula, benché non sia morta, /non pensiate che fuggì, / che è uccisa di fortuna / che gli viene ad essere peggiore. / Egli che si vede tanto famoso / ed in tanto buona stima, / attento alla vostra bellezza, / si è innamorato di voi. / Non gli chiede diate più dote / di vedere che ammazzate di amore, / che in ammazzando in qualche modo / ferma in uno siete i due. / Sposatevi con lui, e se mai /di lui avrete passione, / che mai la stessa morte / si sentì dire che morì. / Se lo fate, a Dio lo prego / che vi godiate con benedizione; / ma se non che ci liberi / di conoscere al Dottor”.
Di Gabriel Celaya, leggiamo: “La poesia es un arma cargada de futuro” (*)
“Cuando ya nada se espera personalmente exaltante / más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, / fieramente existiendo, ciegamente afirmando, / como un pulso que golpea las tinieblas, / cuando se miran de frente / los vertiginosos ojos claros de la muerte, / se dicen las verdades: / las bárbaras, terribles, amorosas crueldades; / Se dicen los poemas / que ensanchan los pulmones de cuántos, asfixiados, / piden ser, piden ritmo, / piden ley para aquello que sienten excesivo. / Con la velocidad del instinto, / con el rayo del prodigio, / como mágica evidencia, lo real se nos convierte / en lo idéntico a sí mismo. / Poesía para el pobre, poesía necesaria / como el pan de cada día, / como el aire que exigimos trece veces por minuto, /para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. / Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan /decir que somos quien somos, / nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. / Estamos tocando el fondo. / Maldigo la poesía concebida como un lujo / cultural por los neutrales / que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. / Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. / Hago mías las faltas. Siento en mí a cuántos sufren / y canto respirando. / Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas / personales, me ensancho. / Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, / y calculo por eso con técnica, qué puedo. / Me siento un ingeniero del verso y un obrero / que trabaja con otros a España en sus aceros. / Tal es mi poesía: Poesía-herramienta / a la vez que latido de lo unánime y ciego. / Tal es, arma cargada de futuro expansivo / con que te apunto al pecho. / No es una poesía gota a gota pensada. / No es un bello producto. No es un fruto perfecto. / Es algo como el aire que todos respiramos / y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. / Son palabras que todos repetimos sintiendo / como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. / Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. / Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos. / Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan / decir que somos quien somos,/nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. / Estamos tocando el fondo”.
“Quando non si raggiunge più niente di personalmente esaltante / ma si palpita e si afferma al di là della coscienza / la selvaggia esistenza e la cieca presenza /come un polso che palpiti nelle tenebre / che martelli le tenebre. / Quando si guarda negli occhi / il vertiginoso sguardo bianco della morte / le verità si fanno avanti / le barbare terribili amorose crudeltà / amorose crudeltà. / Poesia dei poveri, poesia necessaria / come il pane quotidiano / come l’aria che esigi tredici volte al minuto / per essere e per affermarlo, per affermare / che siamo uomini, affermare che siamo uomini. / Giacché viviamo appena, e appena ci lasciano / dire chi siamo / allora i nostri canti non saranno senza macchie, pura forma, / ché stiamo toccando il fondo / stiamo toccando il fondo. / Maledetta la poesia concepita come un lusso / culturale per i neutrali /i sordi, quelli con le mani pure / maledetta la poesia che non parla / un linguaggio compromesso. / Io mi assumo i miei errori, sento la mia sofferenza / se canto respirando / canto, canto e cantando al di là delle pene / delle mie personali / mi spingo, mi spingo. / Voglio spingere la vita, provocare nuovi atti / e a ciò adopero ogni calcolo e strumento / mi sento un ingegnere del verso, un operaio / che lavora con voi alla Spagna / la Spagna e ciò che può. / Non è una poesia goccia a goccia pensata, / non è un bel fiore, non è un frutto perfetto / è ciò che è necessario, ciò che non ha nome / un gesto per terra / un grido nel cielo. / Giacché viviamo appena, e appena ci lasciano / dire chi siamo / allora i nostri canti non saranno senza macchie, pura forma, / ché stiamo toccando il fondo / stiamo toccando il fondo”.
Di Blas de Otero: “Me queda la palabra”. (*)
“Si he perdido la vida, el / tiempo, todo lo que tiré, / como un anillo, al agua; / si he perdido la voz en la maleza, / me queda la palabra. / Si he sufrido la sed, el hambre, todo / lo que era mio y resultó ser nada, / si he segado las sombras en silencio / me queda la palabra. / Si abrí los ojos para ver /el rostro puro y terrible de / mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrarmelos, / me queda la palabra. /Me queda la palabra. / Si los labios abrí, / si me lo desgarré, / si he sufrido la sed, / se he segado las sombras, / si ho perdido la vida, / si he perdodo la voz, / me queda la palabra.
“Se ho perduto la vita, il / tempo, tutto quello che gettai, / come un anello, nell’acqua; / se ho perduto la voce nella / sterpaglia, / mi resta la parola. / Se ho sofferto la sete, la fame, / tutto quello che era mio / e risultò esser niente, / se ho falciato le ombre in silenzio / mi resta la parola. / Se ho aperto gli occhi per vedere / il volto puro e terribile della / mia patria. Se apersi le labbra / fino a lacerarle, / mi resta la parola. / Mi resta la parola. Se le labbra aprii, /se me le lacerai, / se ho sofferto la sete, / se ho falciato le ombre, / se ho perduto la vita, / se ho perduto la voce, / mi resta la parola”.
Di Léon Felipe: “Mia es la voz” (*)
“Hermano … tuya es la hacienda / la casa, el caballo y la pistola. / Mia es la voz antigua de la tierra. / Tú te quedas con todo / y me dejas desnudo y / errante por el mundo, / mas yo te dejo mudo ... / ¡mudo! / Y ¿cómo vas a recoger el trigo / y alimentar el fuego / si yo me llevo la canción? / Mia es la voz”.
“Fratello ... tuo è il podere / la casa, il cavallo, la pistola. / Mia è la voce antica della terra. / Tu ti tieni tutto e mi lasci nudo / ed errante per il mondo, / ma io ti lascio muto! / Muto! / E come raccoglierai il grano / e come alimenterai il fuoco/ se io mi porto via la canzone? / Mia è la voce”.
Di Luis Cernuda: “Un espanol habla de su tierra” (*)
“Las playas, parameras / al rubio sol durmiendo, / los oteros, las vegas / en paz, a solas, lejos; / los castillos, ermitas, / cortijos y conventos, / la vida con la historia, / tan dulces al recuerdo, /ellos, los vencedores /Caínes sempiternos, /de todo me arrancaron. / Me dejan el destierro. / Una mano divina /tú tierra alzó en mi cuerpo /y allí la voz dispuso /que hablase tu silencio. /Contigo solo estaba, /en ti sola creyendo; / pensar tu nombre ahora /envenena mis sueños. /Amargos son los días / de la vida, viviendo /sólo una larga espera /a fuerza de recuerdos. /Un día, tú ya libre /de la mentira de ellos, /me buscarás. Entonces /¿qué ha de decir un muerto?”.
“Le spiagge, regioni desertiche / al biondo sole dormendo, / i picchi, le pianure / in pace, a sole, lontano; / i castelli, eremi, / fattorie e conventi, / la vita con la storia, / tanto dolci al ricordo, / essi, i vincitori / Caínes sempiterni, / di tutto mi strapparono. / Mi lasciano l'esilio. / Una mano divina / tu terra alzò nel mio corpo / e lì la voce dispose / che parlasse il tuo silenzio. / Con te assolo stava, / in te sola credendo; / pensare ora il tuo nome / avvelena i miei sonni. / Amari sono i giorni / della vita, vivendo / solo una lunga attesa / a forza di ricordi. / Un giorno, tu già libero / della bugia di essi, / mi cercherai. Allora / che cosa deve dire un morto?”.
Di Cesar Vallejo: “Amada” (*)
“Amada, en esta noche, tú te has crucificado / entre los dos maderos curvados de mi beso./ Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado / y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. / Amada, en esta noche, tú te has crucificado. / Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos / y ya no habrán reproches en tus ojos benditos / ni volveré a ofenderte. Y en una sepoltura / dormiremos los dos como dos hermanitos”.
"Amata, in questa notte, tu ti hai crocifisso / tra i due tronchi ricurvi del mio bacio. / E la tua pena mi ha detto che Gesù ha pianto / e che c'è un venerdì Sacro più dolce di quello bacio. / Amata, in questa notte, tu ti hai crocifisso. / Amata, morremo insieme i due, molto insieme / e non ci saranno oramai rimproveri nei tuoi occhi benedetti / né tornerò ad offenderti. E in una sepoltura / dormiremo i due come due fratelli."
Di Fanny Rubio: “El Rey Almutamid” (*)
“Soñaba en su lecho el rey / soñaba de madrugada / que entre las ondas del rio / buscaba manzanas blancas. / Noche de miedo en Sevilla / víspera de la batalla. / Y el rey Almutamid / en el sueño contemplaba / la dulce fruta de nieve / que en los espejos temblaba. / Noche de miedo en Sevilla / víspera de la batalla. / En Sevilla, Almutamid / abrió los ojos al alba / cuando el sol enrojecia / en la ventana más alta. / Y ni amanecer halló / ni arrayán bajo la almohada / ni del agua el dulce nido / donde vio manzanas blancas. / Noche de miedo en Sevilla / víspera de la batalla”.
"Sognava nel suo letto il re / sognava di buon mattino / che tra le onde del fiume / cercava mele bianche. / Notte di paura a Siviglia / vigilia della battaglia. / Ed il re Almutamid / nel sonno contemplava / la dolce frutta di neve / che tremava negli specchi. / Notte di paura a Siviglia / vigilia della battaglia. / A Siviglia, Almutamid / aprì gli occhi all'alba / quando il sole arrossava / nella finestra più alta. / E né alba trovò / né mirto basso il cuscino / né dell'acqua il dolce nido / dove vide mele bianche. / Notte di paura a Siviglia / vigilia della battaglia."
In ordine di tempo possiamo dire che Rafael Alberti (*) è l’ultimo (ma non l’ultimo), che si è misurato con il romance, in una versione propositiva di grande presa sull’ascoltatore: Ignazio Delogu, ha scritto di lui: “Certo, nella poesia il sentimento più generale e la motivazione collettiva prevalgono sui motivi individuali o di gruppo, ma restano nella poesia civile, e in quella di Alberti in maniera particolare, una ribellione anche individuale, un furore che non possono essere trasferiti e che danno a questa poesia un accento inimitabile e una estrema, travolgente persino, capacità di persuasione”. Di Rafael Alberti leggiamo insieme “La colomba” (*):
“Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo; que la noche, la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas, rocío; que la calor; la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa; que tu corazón, su casa. Se equivocaba. (Ella se durmió en la orilla. Tú, en la cumbre de una rama)”.
“Si sbagliò la colomba. si sbagliava. per andare al nord fuggì al sud. credette che il grano fosse acqua. si sbagliava. credette che il mare fosse il cielo; e la notte, la mattina. si sbagliava. credette che le stelle fossero rugiada; e il calore neve. si sbagliava. credette che la tua gonna fosse la tua blusa e il tuo cuore la sua casa. si sbagliava. (Lei si addormentò sulla spiaggia. Tu, sulla cima di un ramo)”.
E ancora: “A galopar” (*)
“Las tierras, las tierras, las tierras de España, / las grandes, las solas, desiertas llanuras. / Galopa, caballo cuatralbo, / jinete del pueblo, / al sol y a la luna. / ¡A galopar, / a galopar, / hasta enterrarlos en el mar! / A corazón suenan, resuenan, resuenan / las tierras de España, en las herraduras. / Galopa, jinete del pueblo, / caballo cuatralbo, / caballo de espuma. / ¡A galopar, / a galopar, / hasta enterrarlos en el mar! / Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie; / que es nadie la muerte si va en tu montura. / Galopa, caballo cuatralbo, / jinete del pueblo, / que la tierra es tuya. / ¡A galopar, / a galopar, / hasta enterrarlos en el mar!”.
“Le terre, le terre, le terre della Spagna, / i grandi, le sole, deserte pianure. / Galoppa, cavallo cuatralbo, / fantino del paese, / al sole ed alla luna. / A galoppare, / a galoppare, / fino a seppellirli nel mare! / A cuore suonano, risuonano, risuonano / le terre della Spagna, nei ferri di cavallo. / Galoppa, fantino del paese, / cavallo cuatralbo, / cavallo di schiuma. / A galoppare, / a galoppare, / fino a seppellirli nel mare! / Nessuno, nessuno, nessuno, che affronti non c'è nessuno; / che è nessuno la morte se va nella tua cavalcatura. / Galoppa, cavallo cuatralbo, / fantino del paese, / che la terra è tua. / A galoppare, / a galoppare, / fino a seppellirli nel mare!”.
Una nota a parte meritano i Romanceros di ultima generazione, alcuni vanno considerati continuatori di quella tradizione popolare mai venuta meno, che possiamo ben indicare, “a flor de tiempo”, luce della poesia spagnola. Molti dei quali sono noti al grande pubblico, non solo in Spagna: Angel Baltanàs, Manuel Dicenta, Luis Prendes, Adolfo Marsillach, Antonio Mairena, Jose Torregrosa, Antonio Carmona, Joaquin Diaz, Paco Ibanez, José Agustin Goytisolo, Fernando Guillén, Juan Manuel Serrat, Manolo Diaz, Aguaviva (… la que mana y corre naturalmente), Joaquin Diaz, Quarteto Cedron, possono sembrare solo nomi senza volto, ma come pure afferma Umberto Eco, nel suo libro “Vertigine della lista” (*): “Questo secondo modo di rappresentazione è la lista o elenco. Ci sono liste che hanno fini pratici e sono finite, come la lista di tutti i libri di una biblioteca; ma ve ne sono altre che vogliono suggerire grandezze innumerabili e che si arrestano incomplete ai confini dell'indefinito”; ognuno di essi ha una propria ragione di essere, per aver dato nel tempo, o perché continua a dare, un supporto vitale, poetico e letterario, che testimonia di una realtà linguistica e musicale, all’interno di una tradizione, quella spagnola, apprezzandola e facendola conoscere in tutto il mondo. E che del mondo continua a scrivere la grande storia dell’umanità, in funzione di un sentire che facilita la comprensione tra i popoli, pur nel loro stanziamento geografico.
Tengo qui a ripetere una massima che ho scritto all’inizio di questa avventura sull’etnomusicologia trascritta per larecherche@larecherche.it, iniziata molti anni fa, in occasione della mia prima collaborazione con l’UNESCO, per la presentazione della collana “Musical Atlas” (*) curata dal prof. Alain Danielou e, successivamente, in occasione del primo programma RAI da me condotto e dal titolo “Folkconcerto” (*): “È nello scoprire il fascino ancestrale della musica dei popoli che la infinita ricerca di «noi stessi» si amplia di nuovi importanti capitoli, che vanno ad aggiungersi a quella macroscopica «storia universale» che tutti stiamo scrivendo. Soltanto nello scoprire «noi stessi» saremo un giorno in grado di conoscere il mondo in cui viviamo”. Con il quale la RAI, e poi la RSI (Il canto della terra), sottoponevano all’attenzione del grande pubblico, la magica comunicativa della musica dei popoli, alcuni molto lontani da noi e dalla nostra cultura, e che ottenne un inaspettato successo d’ascolto.
Come spesso si è trovato a dire Joaquín Díaz, uno dei ricercatori più affermati, nonché egli stesso arrangiatore ed esecutore vocale del folklore spagnolo: “È possibile che, il folclore non stia lì per sparire, la cosa certa è che, la canzone folcloristica riceve di tanto in tanto una nuova linfa di cui beneficia e da cui trae vigore”, ma noi sappiamo anche, che non è stato sempre così e che, nel tempo di “fermo”, cade l’interesse che lo sostiene e un po’ si perde strada facendo. Se è vero che molto si è fatto, pochissimo invece si fa per ciò che il folklore continua a dare in termini di “ecologicamente parlando” conoscenza del territorio, e non solo per quel che riguarda il passato. Un passato che ritorna e che ancora sorprende, quando a rivisitarlo con altri interessi sono i giovani.
Quegli stessi giovani che, nel ricordo di Joaquín Díaz, dopo aver ascoltato alcune canzoni, di quelle che egli interpreta per dimostrarne la validità. È allora che i ricordi ripetono il solito ritornello del “prima”, quando si cantava a tutte le ore e bastavano cinque o sei feste all'ano, per mantenere le illusioni della gioventù sveglie: “All’epoca – ricorda ancora - si ballava la molinera, la donzaina, il ben fermo, lo spostato e la jota aragonesa. E come dietro tutto ciò, si prendeva parte a qualche Via Crucis, si cantavano le canciones su temi di navidad e le devozioni particolari, radicate nella religiosità a dispetto di vivere nell'epoca di miscredenza attuale”. Ovviamente non c’era solo quello, e gli occhi brillano per l'emozione del ricordo o per l'orgoglio di quei compositori che cantavano le loro coplas nelle fiere locali che riempivano di versi mille le celebrazioni, da offuscare perfino le nuove orchestrine che misero fine all'era dorata dei tamburelli a sonagli.
Attualmente il prestigio di Joaquín Díaz è ben solido, costruito sulla sua serietà professionale e il suo interesse nel far partecipi gli altri delle sue conoscenze, divenute ormai enciclopediche, a conferma di un lavoro silenzioso, poco spettacolare, quello dello studioso e del ricercatore della tradizione spagnola nei suoi molteplici aspetti, nazionali e regionali, comunque sempre popolari. Antonio Garcia Rayo (*), parlando di lui racconta:
“… se ne stava in disparte, quando, tutti gli altri protestavano contro la dittatura franchista ma egli non cantava per protestare per niente, sebbene tutta la sua musica era un torrente in piena, una cascata per la quale usciva con urla la vecchia cultura musicale spagnola, quella che gli etnologi oggi chiamano tradizionale. È a lui che dobbiamo ciò che un giorno, da vero innamorato della sua eredità, nella quale si accumulavano ancora ricchezze di terra colta, strappate al suo entusiasmo, è venuto a creare il Centro di Studi Tradizionali oggi a lui intitolato. Lui, che con i mezzi che poté racimolare della sua raccolta, volle che facessimo la stessa cosa. Col passare del tempo, può sembrare logico dire che cantasse come quei figli del tempo. A tanti ani di distanza, ripensare a quel tempo di oscurità e miseria culturale, con la luce della libertà redenta, mi accade di pensare che il suo cantare altro non fosse che il pagamento che oggi dobbiamo a questo poeta della terra”.
Altro grande è Paco Ibañez (basco), figura straordinaria sotto molti aspetti che parlare di lui trascurando la sua ideologia politica può essere più complicato di quanto s’immagini, per essere egli un personaggio già mitico: “quasi leggendario, capace di catturare la gente di tutto il mondo nella sua rete di versi e il suono della chitarra”. Compositore, arrangiatore, cantautore, ha saputo restituire alla poesia spagnola, quella risonanza assoluta, che la eleva all’alto rango di “colta”, vuoi per la sontuosità narrativa, che per il “misterio” che la circonda. Egli è considerato il “romanceros” per eccellenza, cantore di Ruíz, de Gongora, de Quevedo, Ortiz, Lorca, Celaya, Dario, Alberti, de Otero, Cernuda, Felipe, Machado, Goytisolo, Manrique, Rubio, Vallejo, Raúl Gonzales Tuñón; amico di pittori famosi quali Salvador Dalì, Corneille, Pablo Picasso, Antonio Saura, Ortega; cantanti e poeti di grido Rafael Alberti, Georges Brassens, Leo Ferré, Atahualpa Yupanqui e numerosi altri. Dire quale è il segreto del suo successo, varrebbe a chiedersi qual è il segreto della poesia(?), che ovviamente sfugge anche ai filosofi più ferrati, competenti in fatto di letteratura, intenditori di musica e di quei risvolti della psiche umana che talvolta ci sorprendono e ci affascinano.
Chi come me lo ha incontrato e intervistato (seguirà intervista su questo stesso sito), è rimasto affascinato dalla sua voce impostata e ferma, capace di levarsi dal sussurro a toni elevati e gravi, di scolpire le parole quasi più che cantarle, come farebbe uno scalpello nella pietra; che davvero credo egli abbia consegnato al mondo ciò che restava di un’arte di quel dire lirico - epico, che la poesia moderna non arriverà mai a conoscere. Risale al 1998 il suo album “Oroitzen” (*) (“Ricordando”) cantato completamente in lingua basca insieme al cantante (basco) Imanol Landeta. Paco Ibañez ha inoltre dedicato un intero album a un altro grande della canzone spagnola: José Augustin Goytisolo, (Barcellona 1928/1999), forse il meno conosciuto da tutti noi, e che pure fu uno degli autori più importanti della generazione degli anni 50, più precisamente nella scuola poetica di Barcellona, detta anche “Gruppo Catalano”. Insieme ad altri poeti della generazione del '27 Goytisolo fu anche traduttore, in particolare dell'opera poetica di Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo e Pier Paolo Pasolini.
Di Goytisolo leggiamo, “Nessuno è solo” (*):
“In questo stesso istante /c’è un uomo che soffre, /un uomo torturato /solo perché ama / la libertà. / Ignoro /dove vive, che lingua /parla, di che colore / ha la pelle, /come /si chiama, ma /in questo stesso istante, /quando i tuoi occhi leggono / la mia piccola poesia, / quell’uomo esiste, grida, / si può sentire il suo pianto / di animale / perseguitato / mentre si morde le labbra / per non denunciare / i suoi amici. Lo senti? /Un uomo solo / grida ammanettato, esiste / in qualche posto. / Ho detto solo? / Non senti, come me, / il dolore del suo corpo / ripetuto nel tuo? / Non ti sgorga il sangue /Sotto i colpi ciechi?”.
“Sono così” (*):
“Si sa il loro mestiere è molto antico /ed immutato è giunto fino ad oggi /attraverso più secoli e molte civiltà. /Non sanno la vergogna né il riposo /tengono duro a lungo nonostante le critiche /certe volte cantando /altre patendo l'odio e la persecuzione /ma quasi sempre sotto tolleranza. /Platone interdi loro la Repubblica. /Credono nell'amore /sia pur con tutto il carico di corruzione e vizio /amano mitizzare l'infanzia a sufficienza /e hanno dei medaglioni e dei ritratti / che guardano in silenzio quando sono un po' tristi. /Che curiose persone che delle volte giacciono / in letti lussuosissimi ed enormi
/ma che pure si sanno rotolare /nei lerci pagliericci della concupiscenza /se gli viene il capriccio. /Vogliono dalla vita più di quanto offra. /Difficilmente mettono da parte un po' di soldi /la previdenza non è il loro forte /e marciscono intanto poco a poco /in maniera ridicola /se prima non li ammazzano per chissà che motivo. /Così sono i poeti /le vecchie prostitute della Storia”.
“Affare di famiglia” (*):
“Non dolerti se hai un figlio fannullone /se è imbroglione e bugiardo e spende molto /giacché tu lo hai educato senza accorgertene /da bravo cittadino con il tuo esempio”.
Le tre poesie sono tratte dal libro di José Agustín Goytisolo, “Poesia civile” (*), a cura e traduzione di Matteo Lefèvre, formano un ampio spaccato su quella che è la produzione poetica di Goytisolo (oltre venti libri di poesia che vanno dal 1955 al 1996), che fu anche traduttore (Pasolini, Pavese) e scrittore di racconti per bambini, fa parte dei poeti spagnoli della generazione "de los años cinquenta" che doveva vedersela con la Spagna franchista e una dura crisi economica. Il titolo dell'antologia "poesia civile" pone subito l'accento sulla caratteristica di questa poesia legatissima al sociale, concreta e comunicativa, sebbene spesso spinosa e dura, senza toni declamatori, d'un sobrio pessimismo. Le poesie (con testo a fronte) sono precedute da un ampio saggio dello stesso Matteo Lefèvre: "La lingua della denuncia nella lirica di José Agustín Goytisolo", utile e preciso nel cogliere i vasti riferimenti poetici di Goytisolo (Marziale, Blas de Otero, Pasolini...) e nel sottolineare il rigore linguistico, mai disgiunto da quello etico.
Voglio parlarvi adesso di un altro cantautore semi-dimenticato dal pubblico italiano e per lo più sconosciuto alle giovani generazioni, Juan Manuel Serrat (*), seppure sia stato un giovane “indignados” dei giorni che furono della ribellione spagnola, quando Juan cantava:
“Golpe a golpe, verso a verso … / Cuando el jilguero no puede cantar. /Cuando el poeta es un peregrino, / Cuando de nada nos sirve rozar. / Caminante no hai camino, se hace camino al andar …/ golpe a golpe, verso a verso”...
"Colpo a colpo, verso a verso… / Quando il cardellino non può cantare. / Quando il poeta è un pellegrino, / Quando di niente ci serve sfiorare. / Viandante non hai strada, si fa strada camminando… / colpo a colpo, verso a verso"...
… canta Serrat i versi di Antonio Machado cui ha dedicato un intero album, ed altri come Rafael Alberti, Augusto Algueró, Sergio Endrigo, arrangiamenti dello stesso Juan Manuel Serrat. Sue canzoni sono cantate in italiano da Gino Paoli, Mina, Ornella Vanoni, Ana Belen, e tantissimi altri, come quella che segue di cui si conoscono diverse versioni, dal titolo: “Ballata d’autunno” (*) nella trasposizione di P. Limiti:
“Piove / là dietro la finestra piove, piove …/ sopra quel tetto rosso e spaccato, / sopra quel fieno tagliato, / sopra quei campi, piove. / Si gonfia di grigio il cielo / e il suolo è già grondante di foglie, / si è profumato d’autunno. / Il tempo che si addormenta / mi sembra un bimbo in braccio al vento / come in un canto d’autunno. / Una ballata d’autunno / un canto triste di malinconia / vien dietro al giorno che va via … / Una ballata in autunno / pregata a voce spenta, / soffiata come il lamento / che canta il vento. / Piove, / là dietro la finestra piove, piove … / sopra quel tetto rosso e spaccato, / sopra quel fieno tagliato, / sopra quei campi piove. / Io ti racconterei / che sta bruciandosi l’ultimo legno al fuoco e poi / che la mia povertà / è anche di un sorriso che sono solo ormai / ma io da solo son finito, ormai. / E ti racconterei che i giovani / son giovani perché non sanno mai / che no, non è la vita / la bella cosa che / che loro gira in mente, io questo lo so. / Magari si potesse, / del domani e del passato / dire quello che ho sognato … / Ma il tempo passa / e ti canta pian, piano, / con voce sempre più stanca, / una ballata d’autunno. /Piove, / là dietro la finestra piove, piove … / sopra quel tetto rosso e spaccato, / sopra quel fieno tagliato, / sopra quei campi piove”.
Considerato il più grande cantautore spagnolo e catalano J. M. Serrata Inizia la sua carriera quasi cinquant'anni fa, nel 1965, in pieno franchismo, aderendo al collettivo di cantanti in lingua catalana “Els Setze Jutges” ("I sedici giudici"), che diverrà ispiratore e "spina dorsale" di un più vasto movimento di rinnovamento della canzone catalana, già attivo dai primi anni '60, noto come "Nuova Canzone Catalana". Movimento di rinnovamento e protesta nella "pace terrificante" della Spagna di allora; già l'uso di una lingua diversa dal castigliano era simbolo di non accettazione e di ribellione! Nonostante tutto ciò, la "N. C. C." ottiene un successo clamoroso. Ben presto, Serrat diventa - assieme a Lluís Llach (*)e ad altri - un simbolo di opposizione autentica al franchismo; un simbolo niente affatto "teorico", date le noie spesso di carattere poliziesco e intimidatorio che deve subire.
Nel frattempo Serrat comincia a essere conosciuto anche all'estero; sue canzoni sono tradotte un po' ovunque e cantate, ad esempio, da David Broza in Israele, da Carlos do Carmo in Portogallo, da Mina e Gino Paoli in Italia e da Jaime Marques e Ana Belen in Brasile. Con la fine del franchismo, Serrat non cessa di scrivere e cantare le sue canzoni piene di bellezza, di libertà e di meraviglia del vivere come “Mediterraneo”; ne è prova l'"aggiornamento" regolare di una sua vecchia canzone, "Fan vent'anni che avevo vent'anni" o le lacrime nello stadio di Santiago del Cile (lo stesso dove venne ucciso Víctor Jara, poco dopo la fine del regime fascista di Pinochet nel 1989), mentre canta “Volver a los dieci siete” di Violeta Parra. Il suo ultimo lavoro sono giustappunto "rielaborazioni" di canzoni latinoamericane mediante il suo "alter ego" Tarrés, in un album intitolato “Cansiones” (2000), da rileggere e riascoltare.
Di Juan Manuel Serrat (alias rarrés) leggiamo: “Para la libertad” (*)
“Para la libertad sangro, lucho y pervivo. / Para la libertad, mis ojos y mis manos, / como un árbol carnal, generoso y cautivo, / doy a los cirujanos. / Para la libertad siento más corazones / que arenas en mi pecho. / Dan espumas mis venas / y entro en los hospitales y entro en los algodones / como en las azucenas. /Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, / ella pondrá dos piedras de futura / mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas / crezcan en la carne talada. / Retoñarán aladas de savia sin otoño, /reliquias de mi cuerpo / que pierdo en cada herida. / Porque soy como el árbol talado, / que retoñoy aún tengo la vida.
(Versione italiana di Riccardo Venturi):
“Per la libertà sanguino, lotto e continuo a vivere. / Per la libertà, i miei occhi e le mie mani, / come un albero carnale, generoso e prigioniero, / le consegno ai chirurghi. / Per la libertà, sento d'avere nel petto / più cuori che grani di sabbia. / Schiumano le mie vene / e entro negli ospedali, / entro nelle bende di cotone / come in candidi gigli. / Perché dove compariranno orbite d'occhi vuote / lei porrà due pietre per lo sguardo futuro / e farà crescere nuove braccia e nuove gambe / nella carne devastata. / Germoglierà di nuovo l'energia a colpi d'ala, / senza autunno, / reliquie del mio corpo / che perdo a ogni ferita. / Perché sono come l'albero strappato: / rigermoglio e ancora ho vita”.
Sono questi i poeti di un nuova stagione della “Poesia civile spagnola” che si chiude qui con José Agustín Goytisolo, ma che si riapre in America Latina con quanti hanno elaborato sullo spirito del Romance le loro composizioni, e hanno levato le loro grida contro l’ingiustizia e la mancanza di libertà; di quanti hanno cantato con anima grave le sofferenze cui sono state sottoposte le popolazioni, contro il potere autoritario delle dittature; di tutti coloro che hanno levato la loro voce contro: Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Ruben Dario, Jorge Guillen, ma anche Victor Yara, Violetta Parra, Angel e Isabel Parra, Daniel Viglietti, Sergio Ortega, Rolando Alarcón, nonché numerosi gruppi musicali che abbiamo conosciuto durante la resistenza cilena: Inti Illimani, Quinteto Tiempo, Quilapayun, Los Calchakis, sembrano far parte di un altro elenco di nomi indifferenti, altresì sono poeti e scrittori moderni di Romance, di canciòn y coplas y villancicos, che hanno reso grande la tradizione spagnola trasmigrata in Sudamerica. Ancor più essi sono di riferimento nel mondo della “canzone di protesta” e della “canzone d'autore”, politicamente impegnati e conosciti a livello internazionale.
È così che la poesia diviene quindi intuizione di un microcosmo individuale di fulminea durata eppure densissimo di realtà perenni. Intuizione consegnata in versi (alla storia della letteratura) insieme espliciti e reticenti: “Yo no digo esta canciòn / sino a quen comigo va”; e con ciò partecipi a pieno diritto alla letteratura moderna, diffusa a tutto il mondo. Al loro insegnamento si rifaranno gli attuali cantares forgiati nello spirito della tradizione del vecchio Romance dell’epoca d’oro, risonante di frammenti melodici assai diffusi nella musica popolare spagnola, solenni e un poco remoti, raramente lirici, di cui utilizzano la caratteristica cadenza ritmica, sulla sonorità della “copla” (solfa), il cui termine definisce quella che per noi è la comune canzone, indicandone le diverse stanze (poetiche), legate dal ritornello che viene di tanto in tanto ripetuto. Così dicendo, il tutto potrebbe sembrare banalmente riconducibile a una moda legata al tempo in cui si è verificata. Ma se soltanto pensiamo che dietro queste canzoni di grande impatto lirico e poetico si è innescata “La Nueva Canción Chilena” un movimento culturale e musicale sorto in Cile negli anni sessanta, improntato al recupero e alla rielaborazione del folklore latinoamericano e all'utilizzo della musica come arma di lotta ed impegno sociale e politico, ci accorgiamo che un solo sperduto verso di una di queste canzoni fa la differenza.
Non a caso il destino degli artisti della “Nueva Canción Chilena” (*) è profondamente segnato dal Golpe di Pinochet dell'11 settembre 1973: Jara viene imprigionato e ucciso pochi giorni dopo, mentre gli Inti Illimani e i Quilapayún sono costretti a rimanere a lungo in esilio, rispettivamente in Italia e in Francia, dove si trovavano per concerti al momento del colpo di stato. Con il regime militare fu anche soppressa l'etichetta che pubblicava i dischi di quasi tutti i musicisti della Nueva Canción, la DICAP (Discoteca di canto popolare). Si pensi inoltre alle migliaia di “desaparecidos”, alle uccisioni di massa, a quanti è stata tolta la libertà, a quanti è stata tolta definitivamente la parola. Una storia, questa, che pur restando nella ricerca musicale, affronteremo in un prossimo Quaderno dedicato. Tuttavia fin da subito va sottolineato quanta strada fin qui è stata fatta, di come attraverso la nostra ricerca, partita da una “banale” tradizione popolare, siamo arrivati a trattare di letteratura e storia, di poesia e canto, di contrasti sociali e di grandi ideali guidati da sentimenti forti, rimasti tali, che non hanno mai smesso di far sentire il loro grido altissimo, levato in difesa di un’identità da salvare, la nostra, di tutti quei popoli liberi che giustamente riscattano la propria esistenza.
Se è vero che a volte le cose ci vengono semplicemente incontro, allora c’è da chiedersi: “A che serve la musica che ci suona nella testa senza essere evocata e forse nemmeno desiderata?”. E la domanda è inclusiva di quella risposta spontanea che Oliver Sacks (*) non si è ancora data: cioè che noi l’abbiamo evocata, l’abbiamo desiderata, attraverso la nostra ricerca. L’invito è sollecitato dal recupero effettuato negli archivi della memoria che abbiamo portato avanti con discrezione e che ha attirato la nostra attenzione su quanto fin qui avevamo trascurato e che per una strana coincidenza della mente, si avvale di una strana forma d’immaginazione in cui una canzone o una melodia, ma anche una fiaba o una narrazione, salgono immediate alla mente, per assolvere a una funzione simile a quella del sogno. Scrive ancora Sacks: “Quale che sia il suo messaggio segreto, la musica di fondo che accompagna il nostro pensiero cosciente non è mai accidentale” … come dire che tutto ciò che fin qui abbiamo apprezzato: narrazioni, leggende, favole antiche e nuove, musica e poesia, cantes e romance, ma anche storia di tradizioni , di folklore popolare, di lotta e di scontento che fanno parte della nostra realtà, del nostro essere antropologicamente umani:
“… Copla de mis amores / cantar de mis dolores, / entonces tù seràs / la copla verdadera, / la alondra mananera, / que lejos volaras, / y en labios de cualquiera / de mi te olvidaras!”
“… Canzone dei miei amori / cantare dei miei dolori, / allora tu sarai / la solfa vera, / l'allodola mattiniera, / che lontano volerai, / e sulle labbra di chiunque / di me ti dimenticherai!”.
(Manuel Machado: “El cantar”)
(continua)
Note:
1) “The History of Music In Sound” - Vol.II - Oxford University Press / His Master’s Voice - London.
2) “Romance de Abenàmar” di anonimo del XV secolo - In Wikipedia Libera Enc.
3) Ramon Menéndez Pidal - in “Flor nueva de romances viejos” - Espasa-Calpe - Madrid 1985.
4) “L’apparizione” di anonimo del XIV secolo - in Wikipedia Libera Enc.
5) - in “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes op. cit.
6) Manuel de Falla - “El retablo de Maese Pedro” - (vedi discografia)
7) “Gaiferos e Melisenda”, ballata judeo-españolas in “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes op. cit.
8) Federico Garcia Lorca - “Poesie” – Guanda 1959.
9) Federico Garcia Lorca - “Libro de Poemas”, “Nueva Canciones” - Residencia de Estudiantes – Madrid 1917.
10) Federico Gracia Lorca - “Canti Gitani e Andalusi” a cura di Oreste Macrì - Guanda - Parma 2005.
11) Federico Garcia Lorca - “Poema del Cante Jondo” - Espasa Calpe - Madrid 1936; e in Giorgio Mancinelli “Musica Zingara: Testimonianze etniche della cultura europea” - MEF Firenze Atheneum - 2006.
12) Antonio Machado - “Poesie, Proverbios y Cantares” - a cura di Claudio Rendina – Newton Compton 1971.
13) Antonio Machado - “Prose e poesie scelte” - I Meridiani Mondadori -
14) 15) 16) 17) 18) 19) - in Paco Ibanez (vedi d.)
20) 21) Rafael Alberti - “Cal y Canto”, “Sobre los Angeles”, “Il quartiere dei profeti” - De Donato ed.
22) Umberto Eco - “Vertigine della lista” - Bompiani 2009.
23) A cura di Alain Danielou - “Musical Atlas” - Collana Discografica (vedi d.)
24) “Folkoncerto” - Programma RAI sull’Etnomusicologia diretto da
25) Antonio Garcia Rayo in “Cancionero de Romances” - Joaquin Diaz (vedi d.)
26) Paco Ibañez - “Oroitzen” – (vedid.)
27) José Augustin Goytisolo - “Poesia Civile” - Perrone Editore 2006.
28) Juan Manuel Serrat - (vedi d.)
29) Lluis Llach - (vedi d.)
30) Juan Manuel Serrat - (vedi d.)
31) Inti Illimani - “Nueva Cancion Chilena” - (vedi d.)
32) Oliver Sacks - “Musicofilia” - Adelphi 2009.
33) Manuel Machado - “Antologia Poetica” - EDAF 2007.
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusicologia 6: Il Romance spagnolo
“Il Romance Spagnolo tra Letteratura e Musicologia”, (prima parte)
di Giorgio Mancinelli (*).
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, RAI3, e per “Il Canto della Terra”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RSI (Radio della Svizzera Italiana), e stralci da articoli diversi apparsi sulle riviste: Nuova Scienza, L’Annuario Discografico, Nuovo Sound, AudioReview).
(Avviso importante: nell’impossibilità di tradurre correttamente tutti i testi medievali presenti nel saggio mi scuso se alcuni di essi non sono riportati in italiano. Chiunque sia in grado di farlo o di apportare migliorie è ben accetto. Può farlo inserendo le traduzioni nei commenti o usando la posta personale, grazie!)
Perché si possa parlare di qualcosa di diverso nell’ambito della etnomusicologia che qui concerne, ma che pure esula dalle linee conformi alla ricerca antropologica tout-court, occorre prima individuare un qualche rapporto esistente tra due entità relative, quali, ad esempio, quelle che qui sono l’oggetto dell’investigazione: la musica e la letteratura conformi alla tradizione orale e alla parola scritta, e tuttavia soggette alle interazioni (influenze reciproche), agli scambi formativi, di una diversa ricezione della cultura specifica che vogliamo trattare. Ma cosa avviene quando a formare una determinata realtà culturale contribuiscono più di un singolo sapere o più di una entità popolare che, verosimilmente, ne forgia l’anima multiforme, dando ad essa quell’impronta originale, tipica del territorio o del popolo che l’ha tramandata?
A fronte di una domanda siffatta è compito di questa ricerca trovare una risposta che abbia un senso compiuto, senza per questo andare a rimestare nelle scienze o nelle religioni riconosciute dall’ufficialità gestante, per la maggior parte, prive di curiosità e d’interesse per la nostra ricerca, che invece trova il suo peculiare coinvolgimento proprio in ciò che c’è d’involontario e accidentale e che si muove al di fuori dell’ufficialità educativa e della religiosità teologica, sulle quali una determinata cultura, solitamente di tipo “etnocentrico”, è fondata. Di contro, quello che più ci interessa è l’interpretazione “evoluzionista” senz’altro più concernente e interessante nello sviluppo culturale del gruppo sociale che si sviluppa all’interno di modalità ineluttabili, culturali, biologiche e del pensiero, che esulano da qualsiasi etichettazione programmata.
In realtà l’incompatibilità fra le due visioni non è poi così totale o incommensurabile come sembra, un risvolto unitario va necessariamente trovato al fine di dare luogo alla nostra ricerca, onde poter individuare quelle che sono le parti essenziali di un discorso culturale unitario e unificante, sia esso di transizione o definitivo, purché adeguato allo scopo della ricerca. È comunque importante non perdere di vista la méta iniziale che ci si è dati, che può anche cambiare durante il percorso e percorrere strade inusitate non corrispondenti a quelle esplorate dall’antropologia tradizionale, per avvalorarne altre, che invece si rifanno allo strutturalismo antropologico, necessario per comprendere più a fondo l’oggetto della ricerca in ogni suo aspetto. In questo caso specifico, l’uso dell’etnomusicologia comparata, è disciplina indicativa dell’esperienza socio-culturale della conoscenza umana più approfondita.
Il che equivale ad ammettere la sua legittima funzione di scienza fondamentale, indispensabile per colmare ogni spazio rimasto vuoto nella altre discipline formative, a iniziare dalla distanza che ci separa dalle “silenziose pianure del passato” e la “sovranità e il predominio del futuro”; così come ogni altra differenziazione nel campo della conoscenza applicata, per cui ogni popolo, ogni singolo soggetto sociale, ha le stesse capacità e le stesse possibilità di sviluppare una propria cultura originale che – non smetterò mai di ripeterlo – va considerata e rispettata per quella che è. Questo implica che nulla in linea di principio, ci impedisce di valutare positivamente modalità di valutazione che un tempo (per qualche millennio), sono state ritenute valide e che, in qualche modo, ancora oggi ci rappresentano.
Tuttavia, se è vero che la musica ha avuto ed ha il potere di mantenere vivi certi suoi caratteri millenari, che continua a essere suonata e verosimilmente intonata negli stessi luoghi dove si è formata, lo studio dell’etnomusicologia offre qui l’occasione per una sua rivalutazione in qualità di scienza necessaria per riappropriarci dell’identità smarrita del mondo, ossia: “della materia stessa di cui è formato il linguaggio sonoro” (*), che vede inclusa sia la musica che la parola orale, il canto e la danza; sia il linguaggio gestuale che pure ci compete e che, nell’insieme, formano quel tutt’uno culturale che dobbiamo riconsiderare, per una migliore comprensione del mondo in cui viviamo. Del resto, vivere il mondo della musica oggi, significa vivere il mondo sonoro nella sua totalità in una condizione sperimentale che non conosce precedenti.
Pertanto, anche quella che consideriamo esclusiva tematica musicologica o letteraria che si vuole affrontare in questa ricerca, trova nell’etnomusicologia, nella sua accezione specifica riferita alla forma orale ancor prima che scritta, una ragione investigativa e di screening, che spalanca una finestra sul “paesaggio sonoro” (*) della nostra immaginazione, che ci permette infine di ricapitalizzare quel patrimonio culturale che rischia altresì di andare perduto, o che è ancor peggio, di essere dimenticato. Tuttavia, prima di entrare nel vivo dell’investigazione, necessita qui trattare, seppur brevemente, quello che era il contesto letterario medioevale di rilevanza musicologica, che verso la fine del XIII secolo salutò in Spagna il sorgere di forme culturali autonome come la “prosa epica” e la “poesia lirica”, corrispettivi di un sostrato “etnico” preesistente – forse retaggio di più antichi aedi – formatosi sulla scia dei “cantare de gesta” e sfociato poi nel Romance epico-cavalleresco, giunto a noi esclusivamente in forma letteraria, ma che un tempo era fondamento della tradizione orale.
Si tratta in breve di una sorta di narrazione che, fluita attraverso i cuentos (racconti, novelle, fiabe), le coplas (canzoni, versi, ballate), subì notevoli mutazioni prima di definirsi nella forma del Romance che noi conosciamo e che, una volta oltrepassati i confini nazionali, arrivò nelle Corti dell’Europa medievale, al seguito di venditori ambulanti, viaggiatori e pellegrini, guitti e trovatori, subendo modifiche di aggiustamento secondo la lingua e la cultura ospitante, onde per cui una stessa “ballata”, magari d’origine inglese o francese, italiana o spagnola, all’occorrenza rimaneggiata, raggiungeva e diventava popolare in altre parti del mondo all’ora conosciuto, nei territori tedeschi e olandesi, o attraversati i mari, addirittura in quelli scandinavi e oltre.
Caratteristica dell’epoca fu la riduzione, da parte di narratori e cantori che li avevano appresi dalla tradizione orale, di Romance più o meno anonimi che venivano rappresentati nei teatri improvvisati all’interno delle corti medievali, alla presenza di nobili e prelati altolocati, nonché di signorotti arricchiti, e da cui, verosimilmente, prese forma quello che sarà la grande tradizione del Teatro spagnolo passando per Garcilaso de La Vega, Lope de Vega, fino a Calderon de la Barca. Quello stesso che, ad uso e consumo della catechesi dilagante, trascinerà sui sagrati delle chiese, dando sfogo all’attività processionale nella chiusa dei Sacramentales, recitativi di derivazione religiosa, conosciuti anche come Sacre Rappresentazioni. Allo stesso modo che, seppure in forma assai ridotta, entrava nei Retablo degli spettacoli di piazza, tenuti in occasione di fiere e mercati, o durante le festività ad uso e consumo del popolino, sempliciotto e credulone, ma non per questo sciocco e sprovveduto, che cercava nel Romance un certo acume vivace e spesso salace, in cui si rispecchiavano le debolezze umane, le passioni e gli intrighi dei nobili o delle Corti.
Spettacoli questi molto popolari che, con l’avanzare d’una maggiore conoscenza della lingua e della scrittura, acquistarono man mano un certo gusto espressivo e se vogliamo finanche pittoresco che ritroveremo più tardi nella zarzuela, l’operetta tipica del teatro spagnolo, che fornì ai “Romanceros”, sorta di divulgatori d’una primitiva forma di comunicazione sub-mediale, forme linguistiche e letterarie originali profuse di latino, giudaico-cristiano, moresco, e alcuni dialetti volgari che, in buona misura, ritroviamo nelle canciónes liriche e in alcuni Romance famosi, come questo “Romance del Quintado” (*), nella sua forma più tradizionale, trascritto da Joaquin Diaz:
“Ciento y un quintado llevan, todos van para la guerra. / Unos ríen y otros cantan; otros bailan y otros juegan. / Si no es aquel buen soldato, que tan largas son sus penas, / que el día que la casaron, sus bodas fueron sin fiestas. / Ya se acerca el capitán, le dice de esta manera: / ¿Qué tiene mi buen soldado; qué tiene que non se alegra? / Que el día que me casé me llevaron a la guerra / y he dejado a mi mujer, ni casada ni soltera. / Coge mi caballo blanco y vete en busca de ella, que con un soldado menos, también se acaba la guerra”.
"Cento ed un reclutato portano, tutti vanno per la guerra. / Alcuni ridono ed altri cantano; altri ballano ed altri giocano. / Se non quel buon soldato che tanto lunghe sono le sue pene, / che il giorno che si sposarono, le sue nozze furono senza feste. / Si avvicina già il capitano, gli dice di questa maniera: / Che cosa ha il mio buon soldato; che cosa ha che non si rallegra? / Che il giorno che mi sposai mi portarono alla guerra / e ho lasciato mia moglie, né sposata né nubile. / Prendi il mio cavallo bianco e vatti alla ricerca di lei che con un soldato in meno, finisce anche la guerra."
Riguardo alla composizione dei testi, molti erano gli autori che usavano stilare i loro versi sullo stile del virelai (*) provenzale, una delle tre forme impiegate nella poesia e nella musica medioevale, le altre sono la ballata italiana e il rondeau francese che rimandano a quel patrimonio musicale comune di una vasta area che dalla penisola Iberica raggiungeva l’Occitana fino alla Lombardia. Non di meno la musica strumentale era altresì ricca di straordinari esecutori per vihuela, chitarra saracena, cornamusa, ribeca, che si servivano per l’accompagnamento di tintinnambulum, flauti diversi, crotali, tamburi e tamburini, e timpani per segnare il “passo” nelle processioni. Nel tempo, vanno citati i francesi Jehannot de l'Escurel, Guillaume de Machaut e Guillaume Dufay che ci hanno lasciato composizioni ballate e mottetti, e alcuni complainte, molto eleganti nella forma; gli italiani Francesco Landini, compositore, organista, poeta, cantore, organaro e inventore di strumenti musicali, uno dei più famosi compositori della seconda metà del XIV secolo; e il più acclamato del suo tempo non solo in Italia, Jacopo da Bologna, compositore che si inserisce nella corrente musicale dell’Ars Nova, noto soprattutto per i suoi madrigali, e le sue numerose “cacce”. In Spagna, Alonso Mudarra, Luis de Milàn, Diego Ortiz e altri, i quali composero brani preminentemente strumentali utilizzando generi diversi, come: la “gagliarda”, la “fantasia”, la “ballade”, la “pavana” e le così dette “recercar” e “folias”.
Vanno ricordati inoltre, quei Troubadour (così si chiamavano nell’Europa medievale) che, oltre a suonare strumenti di vario tipo, come: lira, arpa, organetto, piffero e Fidel, intonavano la “voce” su versi di loro stessa composizione, improvvisando nei diversi “dialetti” regionali, canzoni e musiche a ballo in occasione di feste, matrimoni e banchetti, nelle nascenti Corti e presso i Signori dell’epoca. Tra i molti rimasti anonimi spiccano i nomi di Peire Vidal, Bernart de Ventadorn, Rambaut de Vaqueiras, La Comtessa de Dia, Marcabrun, Jaufre Rudel che scrissero madrigales cortesanos, romance e villancicos amorosos, danzas e bailes para cantar y taner (per cantare e suonare). In quel tempo, la maggior parte della poesia lirica e i poemi cavallereschi, le cronache storiche, i Romance e le opere filosofiche, erano per lo più scritte (o trascritte) in castigliano antico, che accoglieva in sé molte espressioni popolari, e che, una volta adeguatamente affinate o del tutto rimosse, diedero forma alla lingua spagnola così come è conosciuta ai giorni nostri.
È in quest’ambito cortigiano e popolare che, nel XIII secolo Alfonso X di Castiglia, detto “el Sabio”, dispose la raccolta delle “Cantigas de Santa Maria” (*), quattrocentoventisette composizioni in onore della Vergine Maria e dei suoi miracoli, in cui è fatto uso del volgare desunto dal latino, dovuto a copisti non sufficientemente esperti della lingua, che lo intervallarono con espressioni d’uso quotidiano a loro forse più naturali. Conservate in parte a Madrid e altre a Firenze, in quattro manoscritti contenenti inoltre raffigurazioni pittoriche di strumenti e suonatori, le Cantigas, ricche come sono di suggestioni musicali improvvise e di apporti letterari diversi, rappresentano una forma “commemorativa” di notevole pregio, sia nell’uso della “cantata”, sia per la struttura musicale utilizzata, che ben presto confluirono nella cultura delle austere corti d’Aragona e di Castiglia, d’Aquitania e di León, al pari del teatro e della danza annoverate tra gli svaghi preferiti dagli aristocratici del tempo.
Ad Alfonso X “el Sabio”, si deve inoltre l’aver incrementato con le sue opere, la letteratura del tempo e le discipline storiografiche e giuridiche, in aggiunta alla sua già copiosa biblioteca, indubbiamente una delle più ricche e conosciute dell’epoca, costituita da un numero impressionante di manoscritti redatti da intellettuali latini e arabi, ebrei e islamici, iberico cristiani e provenzali che formavano l’importante scuola da lui fondata detta dei Traduttori di Toledo, il cui apporto letterario e scientifico andò sviluppandosi nei secoli successivi. A lui si devono alcune fra le Cantigas più belle:
Da la “Cantigas 7”: (stralcio senza traduzione)
“Esta é de como Santa Maria pareceu en Toledo a Sant Alifonsso, et deu-ll’huia alua que trouxe de Parayso, con que dissesse missa”.
“Muito dovemos, varóes, / loar a Santa Maria, / que sas graças et seus dòes / dá a quen por ela fia. / Sen muita de bòa manna / que deu a un seu prelado, / que primado foi de España / et Affons’ era chamado; / deu-ll’húa tal vestidura / que trouxe de Para’yso, / ben fe’yta a ssa mesura, / porque metera seu siso / en a loar no’yf’e dia. / Ben enpregou él seus ditos, / com’achamos en uerdade, / et os seus bòos escritos /que fez da Virigihndade / d’aquesta Sennor mui santa; / per que sa loor tornada / fai en España de quanta / a end’auian de’ytada / jvdeus et a eregìa. / Porén deuemos etc.”...
In questa atmosfera culturale incontriamo Martin Codax, compositore ed esecutore colto, forse originario di Vigo, di cui non si hanno ulteriori riferimenti biografici, annoverato come giullare di estrazione medio borghese, in contrapposizione al troubadour galiziano probabilmente titolato. A giudicare dall'analisi scrittoria, egli doveva essere attivo durante la metà del XIII secolo, l’unico autore a fare uso nella composizione, della forma strofica arcaica (distico rimato seguito da un ritornello), impiegando inoltre un sistema di rime utilizzate a strofe alternate. La stessa che ritroviamo nel “Cancionero” (*), una raccolta in cui è citato come autore di almeno sette manoscritti rintracciabili in alcuni canzonieri galiziano-portoghesi. A lui si devono inoltre alcune delle canciones contenute in una pergamena scoperta in modo fortuito a Madrid, tra il materiale bibliotecario dell’antiquario e bibliofilo Pero Vindel, da cui la pergamena prende il nome. Sue sono inoltre le sette “Cantigas de amigo” (*) su un totale di ottantotto, le uniche in galiziano antico ad essere accompagnate da notazione musicale (sebbene con lacune), tranne che la sesta, in cui l’autore espone lo sfogo di una dama innamorata che lamenta la lontananza dell’amato, dal titolo: "Quantas sabedes amar”:
“Mia irmana fremosa, treides comigo / a la igreja de Vigo u è o mar salido / e miraremos las ondas. / Mia irmana fremosa, treides de grado / a la igreja de Vigo u è o mar levado / e miraremos las ondas. / A la igreja de Vigo u è o mar salido / e verrà i mia Madre e o meu amado / e miraremos las ondas”.
“Mia graziosa sorella, vieni con me / alla chiesa di Vigo dov’è il mare in tempesta, / e guarderemo le onde. / Mia graziosa sorella, vieni di buon grado / alla chiesa di Vigo, dove il mare si è alzato, / e guarderemo le onde. / Alla chiesa di Vigo, dove il mare si è levato, / e verrà mia Madre e il mio amato, / e guarderemo le onde”.
È indubbio che all’origine di tanta ricchezza di brani sia strumentali sia cantati che compongono il “Cancionero”, si noti la molteplice coesistenza di diverse forme musicali, quelle stesse che hanno accompagnato la grande evoluzione culturale che si andò conformando nella Spagna dei secoli XIII e XIV, e che videro l’evolversi, accanto agli inni processionali, ai canti dei pellegrini e le preghiere ispirate, altre forme musicali popolari, accostate a canciones amorose e profane, melodie per vihuela e arie di danza e d’occasione, impiegate come brevi “intermezzi musicali” durante la lettura dei primi Romance viejos d’argomento religioso che segnarono un’autentica evoluzione del genere.
Uno dei più noti, è senz’altro la “Historia de los enamorados Flores y Blancflor” di anonimo medievale, il primo esempio di romance esposto in forma letteraria, conosciuto in tutta l’Europa già nel XIII secolo, in cui si narra di due innamorati, modello di fermezza e di costanza, la cui lealtà superò ogni pena che la vita inflisse loro per separarli, e di come, infine, riuscirono a coronare il loro sogno d’amore: “… essendo Flores d’origine mora e Blancaflor cristiana”:
“Señora mia: De la pena vuestra duele al ànima mia, que, de la vida mia, yo tengo por bien empleada, porque, cuando yo de espana partì, fice cuenta de perder la vida por vos. Pues Dios me ha enderezado asì, creo que me sacarà a mì y a vos de todo este peligro. Màs una sola cosa, señora, vos demando merced, si a vos placerà: que demos complimiento a nuestros amores”.
“Signora mia: Della vostra pena duole all’anima che, della mia vita io ho ben impiegata, perché, quando io partii di Spagna, feci conto di perdere la vita a causa vostra. Perché Dio mi ha indirizzato così, credo che tirerò fuori voi e me da tutto questo pericolo. Ma una sola cosa, Signora, voglio chiedere grazia, se a voi piacerà: che si dia compimento ai nostri amori”.
Ancora in questo secolo Alfonso XI detto “el Justiciero”, per la fermezza e la crudeltà con la quale seppe reprimere le rivolte della nobiltà che gli era ostile, quando, salito al trono di Castiglia e León, pose fine allo stato di anarchia in cui si trovava il suo regno, dopo che i Merinidi (Mori), con l'assedio di Tarifa nel 1340, avevano occupato Gibilterra e da lì avevano conquistato possedimenti in Andalusia, stabilendosi a Siviglia e Granada. Ma fu nel 1344 che, dopo oltre due anni di assedio, e con l'aiuto dei cavalieri di tutta Europa, egli conquistò la città di Algeciras bloccando l'espansione dei Merinidi nel Sud del continente, dando inizio a quella che sarà ricordata come l’epoca della Reconquista da parte della nazione spagnola sui Mori invasori.
Sull’onda di questi avvenimenti la borghesia acculturata e per buona parte anche la popolazione meno abbiente, si appropriarono delle conoscenze culturali e artistiche dell’invasore, avviando quello scambio culturale e commerciale che, in qualche modo, arricchiva la sua conoscenza. Furono apprese nuove tecniche scientifiche, si impreziosirono i costumi, le arti, la musica e, soprattutto, si fecero propri gli eroi delle vicende guerresche, nel modo dei vecchi “cantare de gesta”, e se ne crearono di nuovi. Ne sono un esempio i molti poemi in versi, riferiti al periodo detto fronterizos o moriscos, ovvero della presenza dei Mori sul territorio spagnolo: “Romance del cautivo y el alma buena”, “Romance de los Moros de Moclin” ecc.; e altri detti di tema “historicos-novelescos”, come: “Mocedades de Rodrigo”, “Poema de Alfonso Onceno”, “Poema de Mio Cid”, in gran parte ascrivibili alla lirica castigliana del tempo, e che tuttavia favorirono una certa trasformazione del linguaggio orale, più recepito e quindi popolare, e che in seguito scaturì nella forma del Romance epico.
Fra i poemi di carattere “epico-cortesanos”, troviamo il leggendario “Cantar de mio Cid” (*) che è forse il più completo, oserei dire senz’altro il più ardito della letteratura spagnola. La stesura definitiva del poema, così come si presenta nell’edizione critica dello storico Ramón Menéndez Pidal che lo ha restituito all’antico splendore, faceva parte di un numero indecifrato di cronache precedenti, forse copie di testi precedenti probabilmente redatti tra il 1140 e il 1180. Nel testo originale, relativo a un manoscritto del XV secolo conservato nella Biblioteca National de Madrid, come risulta da un attento esame linguistico dello stesso Pidal, la figura di Rodrigo Diaz de Vivár, anche detto nei racconti in volgare “el Campeador” per le sue numerose imprese, e cioè “signore delle battaglie”, fu circondata di grande fama quando egli era ancora in vita, ragione per cui i suoi contemporanei Mori, gli tributarono l’epiteto “el Cid” o “Mio Cid”, dall’arabo “sayyiddì”, una forma di rispetto regale che significa “mio signore”. Alla sua morte, avvenuta nel 1099, la tradizione ne trasmise le sue gesta in forma di leggenda.
Verso il 1140 il “Romance del Cid”, si poteva già ascoltare per intero nella stesura che oggi conosciamo, sebbene, in altri componimenti popolari si fa riferimento a situazioni non inerenti che lo rappresentano talvolta come eroe ardito e a tratti violento, mentre, per i cronisti arabi fu valoroso uomo d’armi, rapace e a volte sleale. Ripresa successivamente, l’epopea del Cid ha subito manipolazioni e trasformazioni che ne stravolsero il linguaggio originale, in quanto autori, talvolta anche affermati, ne ricavarono opere drammaturgiche di scarso interesse storico. È il caso dello spagnolo Guillen de Castro che nel 1600 lo trasformò in un dramma desunto da vari romance popolari, dal titolo: “Las mocedades del Cid” (la gioventù del Cid). Spetta invece a Pierre Corneille, francese, il merito di averlo reso celebre al di fuori di Spagna, con la sua – molto discussa – tragicommedia “Il Cid”, rappresentata sul finire dello stesso secolo.
Il poema “Cantare del Cid” si divide in tre parti detti anche “cantos”: dell’esilio, in cui si narra come Alfonso VI di Castiglia incorse nell’ira regia dando esilio a Rodrigo Diaz de Vivár (el Cid), e da qual fatto si vuole abbiano avuto inizio le sue scorribande in terra mora. Bellissimo è l’inizio di questo primo canto che leggiamo nella traduzione di Cesare Acutis, che di recente lo ha riproposto all’attenzione dei lettori, in una edizione suggestiva e in tutta la sua piacevole leggibilità:
“Dagli occhi suoi / così forte piangendo, / volgeva la testa / / e indugiava guardando. / Vide le porte aperte, / senza pelli né manti / e senza falconi, / senza più astori mudati. / Sospirò il Cid, / che aveva grande affanno. / Parlò il Cid, / bene e con tanto senno: / - Ti dico grazie, Dio / Padre che sei in alto! / Questo han fatto di me / i miei nemici malvagi!”.
E, mentre numerosi cavalieri si apprestano a partire con il Cid verso Burgos, all’uscita di Vivàr: “Il Cid scosse le spalle / e poi scrollò la testa: / - Buone nuove , Alvar Fánez / siamo cacciati dalla nostra terra! /.
E ancora: “Le genti di Burgos / alle finestre stanno / piangendo dagli occhi / per il gran dolore …”.
Il primo “cantos” si chiude con l’arrivo del Cid a Toledo regno dei Mori, da dove hanno poi inizio le gesta che lo renderanno famoso: dalla sfida lanciata al Conte di Barcellona, fino alla conquista della spada Colada. Nel secondo “cantos” si fa riferimento alle nozze tra due Infanti di Spagna e le figlie del Cid, doña Elvira e doña Sol, rese possibili grazie alla mediazione del re Alfonso, il quale, nel frattempo, ha concesso il perdono al Campeador. La scena si svolge a Valencia, dopo l’ingresso trionfale del Cid:
“Il Cid s’incamminò alla fortezza / (con le due figlie e la moglie Jimena) / le faceva salire / sulle torri più alte. / Occhi si belli / guardano da ogni parte; / guardan come si stende / spaziosa Valencia / e poi, dall’altra parte / la vastità del mare. / Osservano il verziere / lussureggiante e grande. / Sollevano le mani / Iddio a ringraziare” /.
Il terzo “cantos” è detto dell’oltraggio, vi si narra della sconfitta dei Mori ed altre imprese. L’oltraggio consiste nell’abbandono delle figlie del Cid nel querceto di Corpes, da parte dei rispettivi mariti e del vanto che essi – gli Infanti di Carriòn – fanno della loro mala impresa. Il Cid, rivoltosi al Re Alfonso, chiede venga fatta giustizia e il re stabilisce che l’onta subita dal Cid sia cancellata con un duello. I tre campioni del Cid vincono il torneo e tornano vittoriosi a Valencia dove, nel frattempo, si preparano le nozze delle figlie con gli Infanti di Navarra e d’Aragona, con i quali il Cid lega definitivamente la sua stirpe alla regalità spagnola dell’epoca. Il “cantos” si chiude con la morte del Cid senza un atto testamentario che invece si trova in un romance popolare, recuperato da una versione più tarda.
La trasformazione da poema lirico in Romance è di carattere popolare e avrà un lungo seguito, per cui tutti i poemi più o meno attendibili, nati come brevi evocazioni di leggende o ascrivibili a cronache realistiche, divennero veri e propri romance lunghi, paragonabili a sequel di più puntate, tra questi: “Romance del Rey Don Rodrigo y la perdida de España”, “Bernardo del Carpio”, “Romance de los siete Infantes de Lara”, ed altri, di cui rimangono solo alcuni episodi, come nel caso del: “Romance de Don Bueso”, del “Romance de Abenámar y el rey Don Juan”, o del “Romance del Prisonero” (*) che leggiamo qui di seguito:
“Por el mes de mayo era / cuando hace la calor, / cuando los trigos ancañan / y estan los campos en flor, / cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor, / cuando los enamorados / van a servir el amor; / sino yo triste, cuitado, / que vivo en esta prison, / que ni se cuando es de dia, / ni cuando las noches son, / sino es por una avecilla / que me cantaba el albor / matomela un ballestero, / !déle Dios mal galardon! / Mas quien ahora me diese / un pajaro hablador, / siquiera fuese calandria, / o tordico o ruiseñor; / criado fuese entre damas y avezado a la razon, / que me lleve una embrajada / a mi esposa Leonor, / que me envìe una empanada, / no de trucha ni salmon, / sino de una lima sorda / y de un pico tajador: / la lima para el torreon. / Oidolo habia el rey, / mando quitar la prision”.
“Per il mese di maggio era / quando fa il caldo, / quando i grani si alza / e i campi sono in fiore, / quando canta la calandra / e risponde l'usignolo, / quando gli innamorati / servono l'amore; / bensì me triste, afflitto, / che vivo in questa prigione, / che non la vedo quando è giorno, / né quando le notti sono, / bensì è per un'avecilla / che mi cantava l'albore / me l’ha uccisa un balestriere, /! dalle Dio un cattivo premio! / Ma chi ora mi desse / un uccello parlatore, / almeno fosse calandra, / o tordo o usignolo; / che addomesticato fosse tra dame e avvezzo alla ragione, / che mi porti un'ambasciata / a mia moglie Leonor, / che m’invii un panzerotto, / non di trota né salmone, / bensì di una lima sorda / e di un becco tagliente: / la lima per il torrione. / Oídolo aveva il re, / quando comandò di togliermi di prigione”.
Ancora sul finire del XIII secolo, assistiamo al nascere di un nuovo uso del linguaggio, divenuto più composito e ricco di espressioni idiomatiche, sul modello del “romance novelescos” di tipo lirico (narrato e talvolta cantato), che raggiunge uno straordinario sviluppo e instaura una nuova ripresa della tradizione. È questa una trasformazione importantissima che permetterà agli autori (spesso anonimi), di maneggiare altre forme di espressività letteraria, distinta da quella utilizzata in precedenza nei poemi destinati alla recitazione sul genere dei “cantare de gesta”. Era dunque inevitabile che anche in questo “nuovo genere” si avessero delle diversità di linguaggio, ampliate e fortemente intrise di spettacolarità, sul tipo del “Tirante el Blanc” e del “Amadis de Gaula” con il quale s’inaugura il “romance d’avventura” del genere cortese, poi ripreso nella forma da tutta la letteratura successiva, non solo spagnola.
Garci Rodriguez de Montalvo, autore dell’ “Amadis de Gaula” (*), compila una minuziosa geografia fantastica in cui principi e cavalieri, draghi e giganti, maghi e maghe autori d’incantesimi, vengono bizzarramente mescolati ad elementi del genere picaresco, quanto ad elementi del romanzo epico - cavalleresco. Non deve sorprendere dunque se il primo fantasy della letteratura spagnola conserva una religiosità profonda e una forte risonanza avventurosa, tipica dei poemi cavallereschi dei cicli carolingio e bretone, quanto invece che questi offrirono spunti ad altri autori di aggiungervi altri episodi non sempre ben argomentati.
Tra questi ricordiamo Gil Vicente, drammaturgo e poeta portoghese autore di un “Amadis de Gaula” tratto dall’omonimo romanzo in cui si alternano vicende d’amore, di gelosia e pentimento, di grande eleganza letteraria. Nonché Bernardo Tasso (italiano) padre di Torquato, il quale, rimasto affascinato dalla trama, rielaborò la materia del poema e ne proseguì la historia, in un poema in ottave “Amadigi”, formato di 100 canti. E l’altro, quel “Romance del cautiverio de Guarinos” di anonimo pubblicato in pliegos sueltos, cioè in fascicoli sciolti, all’inizio del XIV secolo, in seguito ricordato da Miguel Cervantes nella sua opera più famosa “El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha”(*), nel passo in cui, Don Quijote andando a trovare Dulcinea, lo ascoltò cantare da un agricoltore del Toboso, il cui incipit è pressoché indimenticabile:
“!Mala la hubistes, franceses, / la caza de Roncesvalles ...”
“! Cattiva la subiste, francesi, / la caccia(ta) da Roncisvalle...”
L’opera letteraria più importante dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes de Saavedra, giustamente ritenuta una delle più rappresentative della letteratura mondiale, è anche un eccellente compendio di musica del suo tempo, infatti fa dire al burlone scudiero Sancio Panza:
“Señora, donde hay mùsica no puede haber cosa mala.
La mùsica siempre es indicio de regocijo y fiestas”.
"Signora, dove c'è musica non può esserci cosa cattiva.
La musica è sempre indizio di gioia e festa"…
È questa la più alta testimonianza della popolarità del Romance in terra di Spagna, che ci permette di dar credito a quella che è una prima informazione musicale (ne troveremo delle altre) che forse stavamo cercando fin dall’inizio e che fa da autentica cornice all’epica tardo-rinascimentale e quindi barocca, in cui sfocerà il Romance successivo. L’attendibilità di questo discorso, ci fornisce la chiave di lettura dell’intero romanzo, che è racchiusa nella frase che Cervantes fa dire proprio al protagonista indiscusso della sua opera, quel “Don Chisciotte della Mancia” audace cavaliere errante:
“Todos o los mas Caballeros andantes de la edad pasada,
fueron grandes trovadores y grande musicos”.
“Tutti o forse i più dei Cavalieri erranti dell'età passata,
furono grandi trovatori e grandi musicisti”.
Con ciò, s’introduce qui la figura del “Romamceros”, ovvero dello scrittore di romance, da non confondere con la raccolta di Romance cosiddetta cancioneros, quei narratori medievali, trovatori e menestrelli (vecchi e nuovi) che ancora all’inizio del XIV secolo, giravano per i borghi e nei contadi portando oltre alle cantate popolari e le canciones, quei componimenti poetici di carattere epico-lirico espressi in doppi ottonari assonanti con o senza estribillo (ritornello) fra l’una e l’altra strofa, simile alla ballata trovadorica e, come questa, lineare e monotona, gravata da una pena inarrivabile e dolente, tipica delle lamentaciones religiose. Dire che i Romanceros, narratori di storie leggendarie e avvenimenti di cronaca spesso rimaneggiati, obbedivano in certo qual modo, a quel codice dell’amor cortese, modello di virtù e moralità, nel quale la società cortigiana del tempo piaceva rispecchiarsi, è più che superfluo, nessuno di loro sfugge a quelle che sono le linee (o le mode) “letterarie” dell’epoca in cui si trovavano ad esercitare uno dei mestieri più antichi del mondo: l’affabulazione.
È però nella forma del “Romance nuevo” che i Romanceros mettevano insieme sentimenti diversi anche contrastanti quali: amore e odio, vendetta, magia, esotismo, fantasia (che più tardi saranno detti romantici), e che oggi ancora abbagliano l’improvvisato ascoltatore e l’acculturato lettore per le tematiche riferite a eroi lontani e vicini (nel tempo o nella realtà), e che piuttosto desidera burlarsi di loro, piuttosto che ammirarli per quelli che sono o che rappresentano. Non si sa bene se fin dall’inizio, ma comunque e sempre più spesso, i Romanceros rendevano una trasposizione fortemente emotiva, inframmezzata di pause e silenzi più o meno prolungati che accrescevano nell’ascoltatore una certa suspense nella narrazione. Così come, sul tipo della canciones epica, usavano accompagnarsi al suono di una chitarra, o una viella, alternando la narrazione con brevi parti cantate, o “villancicos” che, oltre ad alleggerire il racconto, permettevano, in ragione dell’orecchiabilità della musica, una maggiore memorizzazione del fatto narrato, per cui non sorprenda che il risultato artistico possa vantare una storia fra le più lunghe e continue, dal medioevo a oggi.
Da “La Letteratura Spagnola” (*) di Carmelo Samonà e Alberto Vàrvaro, apprendiamo quanto segue:
“Contemporaneamente alla lirica tradizionale affiora nella penisola iberica un altro tipo di poesia popolare, una specie di zibaldone che andava scrivendo nel 1421, un giovane maiorchino che studiava legge in Italia, Jaume de Olesa, il quale mise per scritto (ma lasciandola a mezzo), una versione molto catalanizzata del “Romance della Dama e del Pastore”, una sorta di pastorella alla rovescia, che ancora in tempi recenti veniva cantata dagli ebrei sefarditi del Marocco e del Levante. In un canzoniere conservato a Londra è detto come Juan Rodrìguez del Padròn, attivo verso il 1430-1440, scrivesse tre “romances”, così esplicitamente chiamati, che trovano corrispondenza nella tradizione ulteriore (uno di essi è una versione contaminata del “Conde Arnaldo”): il confronto prova che l’intervento di Rodriguez del Padròn non deve essere andato molto oltre la semplice raccolta dei testi dalla tradizione orale”.
Molteplici sono gli aspetti colti presenti nei romance redatti durante il XV secolo, corrispettivo del rinascimento europeo, in cui la Spagna, governata dai Los Reyes Católicos Ferdinando d’Aragona e Isabella la Cattolica, vide la fini delle lotte intestine per la supremazia del territorio tra le diverse Corti. Ma siamo ancora nel 1496, inizio di un’altra epoca storica e letteraria che vede, verso la fine del secolo, il prevalere, a fianco di una concreta esplosione religiosa e dall’embrionale presa di coscienza nazionalistica delle corti feudali, il fiorire delle arti e della musica in particolare, che almeno in certe forme tipiche vide il prevalere di un tono più popolare e meno artificioso. È il caso del “Cancionero de la Colombina” (*), così detto dal nome della Biblioteca della Colombina che ne conservava il manoscritto spagnolo contenente brani strumentali e vocali del XV secolo, copiato probabilmente attorno al 1460-1480 da un unico copista di cui si ignora la provenienza.
Originariamente constava di 107 fogli, dei quali 17 andati perduti, consta oggi di 95 brani musicali, alcuni dei quali incompleti. Degli altri, pervenuti per lo più anonimi, 53 sono ascritti a diversi autori incontrati in altre raccolte, tra i quali spiccano: Juan Cornago, Juan de Triana, Juan Urrede, Enrique, Juan del Encina, Francisco de la Torre, Juan de León. Inoltre si è potuto identificarne altri, alcuni dei quali sono più conosciuti in qualità di poeti, come García Álvarez de Toledo (duca d’Alba), Rodríguez del Padrón o Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana). Il repertorio del manoscritto è molto variato, passa attraverso diversi generi musicali strumentali e canciones, villancicos, romance e ensaladas, molti dei quali affrontano tematiche particolarmente licenziose:
Dal “Cancionero de la Colombina”, leggiamo:
“¿Como no le andaré yo, / mesquina, tan desmayada? / Dixo la niña al pastor: / - Mira, pastor, qué tetas. / Dixo el pastor a la niña: / - Más me querría dos setas, / mi çurrón, mi çamarrón, / mi cayada y mi almarada / y mi yesca y mi eslabón. / ... / Dime, triste coraçón, / ¿por qué callas tu passión? / Cativo no sé qué diga. / A quien sirvo es mi enemiga, / plázele con mi fatiga, / desespero galardón. / ... / Querer vieja yo, / no quiera Dios, no. / Una vieja como sarra, / los gargueros de guitarra, / ya me dava una çamarra / porque le quisiese yo. / Querer vieja yo, / no quiera Dios, no. /.../ ¡Allá yrás, doña vieja, / con tu pelleja! / Sospira como moçuela, / dize que amor la desuela, non tiene diente ni muela, / rrumia, al comer, como una oveja. / ¡Allá yrás, doña vieja! / ....”.
"Come non ti vado io, / meschina, svestita? / Disse la bambina al pastore: / - Guarda, pastore, che tette. / Disse il pastore alla bambina: / - Più amerei due funghi, / il mio çurrón, il mio çamarrón, / il mio cayada ed il mio almarada / e la mia esca ed il mio anello. /... / Dimmi, mio triste cuore, / perché taci la tua passione? / Cattivo non so che cosa dica. / A chi servo è la mia nemica, / piacerle con la mia fatica, / esasperato premio. /... / Essere vecchia io, / non voglia Dio, no. / Una vecchia come Sara, / le strozze di chitarra, / già io le davo una çamarra / perché lo volesse io. / Voler essere vecchia io, / non voglia Dio, no. /... / Lo dirà, signora vecchia, / col tuo cuoio! / Sospira come moçuela, / dice che amore la devasta, dispari ha denti che macina, / rumina, mangiando, come una pecora. / Lo vedrà, signora vecchia! / mia".
La forma del Cancionero divenne in seguito oggetto di elaborazioni artistiche raffinate da parte dalle classi più colte, seppure un’indagine erudita dei testi, comincerà ad occuparsene solo in epoca successiva, allorché si scorse all’interno di essi una fase dell’evoluzione del poema epico - cavalleresco d’importanza nazionale. In realtà, la presenza di grandi personalità, oltre che a narratori e cantori anonimi, a loro volta autori dei poemi e dei brevi Romance che entravano a far parte della raccolta, permise loro di conoscere più ampia eco nella cultura ufficiale e il loro “dire” fu preso ad esempio del nobile parlare Castigliano. Successivamente trascritti nella lingua letteraria utilizzata per celebrare eroi e personaggi illustri che, in qualche modo, si erano rivelati di primaria importanza nella storia dell’odierna Spagna, il Romance si confermò, in seguito, tra le forme letterarie, la più rappresentativa dell’anima spagnola. La cui narrazione, parimenti amata sia dal principe che dal contadino, a un certo momento, si trovò a spaziare tra una settantina di testi letterari redatti su melodie più antiche, quando specificamente composte appositamente per questa forma, e pervenuteci, per la maggior parte, in famose raccolte, quali il “Cancionero musical de Palacio”(*), il “Cancionero musical de la Casa de Medinaceli”(*), il “Cancionero de Montecassino” (*), “Il Cancionero di Upsala” (*) e il “De musica libri septem” (*) - Salamanca 1577, di Francesco Salinas, in cui predominano i temi dell’amore, dell’ineluttabile fatalismo e del dolore, caratterizzati da un’intonazione dichiaratamente drammatica.
La pratica più comune voleva che la musica per il romance si scrivesse per una sola strofa, onde poi cantarla sull’aria di un villancicos conosciuto. Così facevano ancora nel XVI secolo Luys de Narvàez e Alonso Mudarra, nel fornire accompagnamenti per due strofe. Mentre Valderàbano, in particolare, completava le melodie popolari alla maniera del canto fermo (cantus firmus) con lunghe, espressive cadenze sulla vihuela in coincidenza di pedali nelle parti vocali, mentre, ad esempio, in “Durmiendo yva el Senor”, le strofe sono collegate da un’elaborazione polifonica sulla melodia di Romance per vihuela. Diversamente Diego Pisador e Miguel de Fuentellana, vihuelista y compositore del Rinascimento, ci hanno lasciato introduzioni strumentali per Romance di cui sono state trovate versioni diverse tra loro; lo stesso può dirsi per numerose trascrizioni rispettivamente per voce e chitarra.
È tuttavia Luis de Milán che riesce a trarre il miglior partito artistico dalla forma del romance. Come avverte l’autore stesso : “L’effetto di una musica così gravemente bella ed elementare si fa ancor più potente se si ha cura di cantare le melodie senza fretta, in maniera ampia e libera, e di suonare il più velocemente possibile i passi strumentali tra le frasi vocali”. Successivamente altri musicisti introdussero particolari innovazioni, ma nessuno raggiunse la perfezione dei suoi quattro esempi. Tre di essi si dividono in due parti: la melodia della prima è popolare; quella della seconda è di sua mano, benché affine alla prima. Come ad esempio, la seconda parte della sua “Durandarte”, appartenente ai “Romances del ciclo Carolingio”, sviluppa l’ultima frase della prima, che riappare immutata alla fine del testo. Le indicazioni di tempo di de Milán e Valderàbano, sia detto incidentalmente, sono tra le più antiche conosciute: Dal “Cantar de Roncisvalles” (*) leggiamo:
I
“Durandarte, Durandarte, / buen caballero probado, / yo te ruego que hablemos 7 en aquel tiempo pasado, y dime si se te acuerda / cuando fuiste enamorado, / cuando en galas e invenciones / publicabas tu cuidado, / cuando venciste a los moros / en campo por mi aplazado; / agora, desconocido, / dí, ¿por qué me has olvidado? / - Palabras son lisonjeras, / señora, de vuestro grado, / que si yo mudanza hice / vos lo habéis todo causado, / pues amaste a Gaiferos, / cuando yo fui desterrado; / quei si amor queréis conmigo / tené islo muy no sufris ultraje / moriré desesperado”.
II
“Muerto yace Durandarte / debajo de una verde haya; / con él está Montesinos, / que en la muerte se hallara; / la fuesa le está haciendo / con una pequeña daga. / Desenlázale el arnés, / el pecgo le desarmaba; / por el costado siniestro / el corazón le sacaba, / volviéndolo en un cendal,/ de mirarlo no cesaba. / Con palabras dolorosas / la vista solemnizaba: / - ¡Corazón del más valiente / que en Francia ceñía espada, / ahora seréis llevado / a donde Belerma estaba! / Para dar clara señal / de la verdadera llaga, / será hecho el sacrificio / que ella tanto descaba, / del amador más leal / a la más cruel y brava. / Use clemencia en la muerte, / pues en vida os la robaba. / ¡Si vuestra muerte le duele, / dichosa será la paga / a quien está aguardando / el contenuto de su dama, / que hasta ver la licencia / el cuerpo muerto acompaña! / Allegando Montesinos / a donde Belerma estaba, / le dice con el semblante / que el color le convidaba: / - Si la potencia de amor / te ha rendido en su batalla, / muéstralo en saber que es muerto / el que más a sí te amaba. / Belerma con estas nuevas / no menos que muerta estaba; / mas después que ya tornó, / entre sí se razonaba: / - ¡Mi buen señor Durandarte, / Dios te perdone la tu alma, / que según queda la mia, / presto te tendrá compaña!”.
I
"Durandarte, Durandarte, / buon cavaliere provato, / io ti prego che parliamo 7 in quello tempo scorso, e dimmi se si ricorda Lei / quando fosti innamorato, / quando in regali ed invenzioni / pubblicavi la tua attenzione, / quando vincesti i moro / in campo per mio posticipato; / agorà, sconosciuto, / diedi, perché mi hai dimenticato? / - Parole sono lusinghiere, / Sig.ra, del vostro grado, / che se io trasloco feci / voi l'avete causato, / perché amaste Gaiferos, / quando io fui confinato; / che se amore volevate a me / tenervi a lui molto e non soffrite oltraggio / mentr’io morirò disperato."
II
"Morto giace Durandarte / sotto una verde siepe; / con lui sta Montesinos, / che procurandogli la morte; / una ferita sta facendogli nel petto / con una piccola daga. / Slacciatogli l'arnese, / che il petto disarmava; / per il fianco sinistro / gli tirava fuori il cuore, / girandolo nell’armatura, / mentre di guardarlo non cessava. / Con parole dolorose / la vista solennizzava: / - Cuore del più coraggioso / che cingeva la sua spada in Francia, / ora sarete portato / la dove Belerma stava! / Per dare chiaro segno / della vera piaga, / sarà fatto il sacrificio / che ella tanto cercava, / dell'amatore più leale / al più crudele e valoroso. / Usa clemenza nella morte, / perché in vita ve la rubava. / Se la vostra morte gli duole, / felice sarà la paga / a chi sta aspettando / il contenuto della sua dama, / che fino a vedere la licenza / il corpo morto accompagni! / Raccogliendo Montesinos / la dove Belerma stava, / gli dice con l'aspetto / che il colore l'invitava: / - Se la potenza di amore / infine si è arreso nella battaglia, / mostralo adesso, che lo sai morto / quello che più per sé amava. / Belerma con queste notizie / non meno che morta stava; / ma dopo che tornò, / tra sé si ragionava: / - Il mio buon signore Durandarte, / Dio perdoni la tua anima, / che come rimane la mia, / presto ti avrà in compagnia! ".
Ciò che può dirsi anche per i villancicos (inseriti all’interno del Romance per alleggerirne la portata narrativa) e che, all’inizio, muovevano da un’occasione storica volendo rendere omaggio a una città o a un personaggio importante, oppure commentare comuni avvenimenti di corte o santificare le festività religiose. Il numero sempre crescente di villancicos religiosi costituì nel tardo ‘500 l’essenziale premessa per la trasformazione di questa forma, nella più ampia “Cantata Sacra” di cui sono piene le pagine della musica colta. Tuttavia l’amore, quello affettivo e intimistico, speso a un livello ben più familiare, rimase l’argomento preferito. Ne è un esempio quello qui di seguito riportato, musicato dallo stesso de Milán e in cui il numero dei versi e il numero delle sillabe di ogni verso, varia da canto a canto:
“Toda la vida hos amé, / si me amais, yo no lo sé, / bien sé que teneis amor, / al desamor y al olvido. / Sé que soy aborrecido, / ya que sabe el disfavor. / Y poe sempre vos amaré / si me amais, yo no lo sé”.
“Tutta la vita vi ho amato. Se voi mi amate, io non lo so. So bene che voi tenete l’amore in disamore e oblio. So che sono odiato, poiché ho provato il disfavore. E sempre vi amerò. Se voi mi amate, io non lo so”.
Una sostanziale quanto necessaria ripartizione, distingue i Romance in cinque classi: storici, carolingi, romanzi, lirici e biblici, che il Milá y Fontanals, riprendendone, in epoca più tarda, lo studio “De la poesia heròico popular castellana” (*), riconobbe nei Romance viejos non soltanto forme poetiche posteriori agli antichi “cantare de gesta”, altresì frammenti superstiti di una elaborazione storico epica di testi risalenti a secoli precedenti e che pertanto annullava di per sé la ripartizione del Romance. Dichiarazione questa che, ripresa nelle sue linee sostanziali ed elaborata da Ramón Menéndez Pidal (*) il quale, nonostante le critiche non prive di valore che gli vennero mosse sulla fondamentale differenza di metro e d’intonazione del Romance lirico dal più antico poema epico, fu da lui vivamente contestata, facendo osservare che di per sé semmai l’elaborazione popolare trasformava l’intonazione epica in romanzesca, e il tono narrativo in lirico.
Obiezioni che permisero allo stesso Pidal di riferirne l’evoluzione a forme sociali e borghesi più tarde, e che ci sembra oggi decisamente la più accettabile. Di fatto egli distinse le forme come: “romance viejos”, quelli anteriori al pieno fiorire del rinascimento, compresi quelli di materia storico-tradizionale; in “fronterizos”, o di frontiera, quelli riferiti a scrittori spesso curiosi delle forme erudite che il romance offriva loro; in “moriscos” (da Mori), di genere epico-cavalleresco quelli che si ascoltavano durante la dominazione araba, per lo più elaborati sui cicli carolingio e brettone. A seguire, quelli detti “eruditos” e quelli “novelleschi” più lirici, sottilmente carichi di accenti e frasi arcaiche, privi di quell’ingenua e limpida ispirazione che rimane il maggior pregio delle vecchie romanze, e il cui affermarsi corrispondeva al pieno fiorire di quella rinascenza letteraria e artistica che investì la Spagna e il resto d’Europa alla fine del XV secolo.
Proseguendo nella nostra ricerca c’imbattiamo, di sicuro più agevolmente, in qualche edizione di “Storia della Musica” (*) che, seppure da un certo punto di vista, sorvola quanto raccolto dalla nostra ricerca, comunque utile per accertare l’evoluzione del romance spagnolo in genere:
“Il romance si diffonde negli strati sociali più bassi ed è in origine un genere popolare, senza per questo rimanere estraneo alle esperienze delle persone più colte, anche se per qualche tempo costoro lo considerano privo di validità letteraria. (..) Ancora nel 1444, un certo Juan de Mena, accenna ad una versione della morte di Fernando IV, “segun dizen rustico d’esto cantando”, secondo il dire rustico di questo cantare, (ed in realtà noi troviamo questo tema nel romancero), e poco dopo Santillana parla di “romances e cantares de que las gentes de baxa e servil condiciò se allegra”. Qualche anno più tardi, alla corte di Napoli, Carvajal compone, a imitazione di quelli tradizionali, due romance, uno dei quali è databile al 1454. Dopo questi primi affioramenti, di cui va notata la localizzazione per lo più periferica, sotto il regno di Enrique IV (1454-1474), che li cantava egli stesso, comincia la gran voga del genere in Castiglia e questa fortuna durerà fino a metà circa del Seicento; poi i romance scompaiono, ma in realtà erano solo passati di moda fra le persone colte ma il popolo li ripeteva dovunque fossero giunte genti ispaniche, dall’America alle Filippine e, dopo che il romanticismo ne ebbe restaurato il gusto al livello sociale e culturale più alto, essi sono andati riaffiorando a migliaia ad opera di amorosi raccoglitori, primi fra tutti Menéndez Pidal e sua moglie, Marìa Goyri.
Il testo raccolto da Jaime de Olesa è in doppi ottonari con il primo emistichio piano e il secondo tronco e con assonanza in e dei secondi emistichi; i tre romance di Juan Rodrìguez del Padròn hanno la stessa struttura, ma il verso è meno regolare ed uno dei testi usa la e paragogica dell’epica antica (Juane, mare, cantare, ecc.). poiché Santillana dice che essi erano composti “syn ningund orden, regla, nin cuento”, par lecito pensare che in origine i romances fossero in versi anisosillabici, anche se a base di emistichi ottonari, ma è la struttura del testo dello studente maiorchino quella poi normale del genere: nel Cinquecento gli emistichi divennero veri e propri versi, ma l’assonanza rimase limitata ai versi pari e perdurò la preferenza per terminazioni piane in sede dispari. L’intera gamma tematica del romancero viejos è dunque documentata fin dalle sue prime attestazioni. Pertanto, verosimilmente, la sua origine è senz’altro più antica dei testi che ci sono pervenuti; resta da stabilire di quanto, e quali ne siano le origini. Esaminando la tematica dei più antichi testi a noi noti: la “Dama e il Pastore” è un’invenzione su uno spunto indigeno (la serranilla). I romantici, che vedevano nella poesia popolare l’espressione spontanea della collettività e gli incunaboli della produzione poetica di un popolo, ritennero antichissima l’origine del romance di cui l’epica sarebbe stata un posteriore sviluppo. Più tardi la revisione del concetto di poesia popolare ha portato a sottolineare l’origine individuale e non collettiva dei singoli testi e contemporaneamente il rapporto fra epica e romancero è stato capovolto, soprattutto per merito del Milà y Fontanals.
I primi romance sono in qualche modo legati alla data (o poco posteriori) dell’avvenimento che cantano; il più antico è da questo punto di vista proprio quello ricordato da Juan de Mena, che narra come il re Fernando IV sia stato citato davanti al tribunale di Dio da due condannati e sia poi deceduto misteriosamente trenta giorni dopo (1312). Ma non è possibile stabilire con sicurezza quando questa leggenda, che è raccolta anche da una cronaca già verso la metà del trecento, abbia dato luogo ad un romance. Più sicuro pare il caso di un romance sulla ribellione di Hernàn Rodrìguez, priore dell’ordine di San Giovanni, contro Alfonso di Castiglia (1328), romance che par proprio destinato a dar notizia degli avvenimenti. Ad ogni modo devono essere considerati contemporanei ai fatti i romance su re Pedro il crudele, in quanto è probabile che i romance storici e quelli epici, siano stati almeno in parte composti per impressionare l’opinione pubblica a favore dei Trastàmara, dunque in funzione propagandistica e di “guerra psicologica”, e siano poi rimasti nella memoria popolare per la tragicità delle vicende di quel regno, (..) molti dei quali paiono però di origine giullaresca e di intento sia celebrativo, sia informativo del popolo che poco sapeva di molte vicende. Pare anche che questi più antichi testi giullareschi fossero ampi e circostanziati ed abbiano acquisito il tipico taglio che ci è noto solo grazie all’elaborazione della tradizione orale.
Poiché dai romance storici non ricaviamo tutto sommato molta luce sul problema delle origini del genere, esaminiamo i testi di tema epico-nazionale. I poemi epici erano recitati dai giullari che a volte si limitavano a qualche episodio isolato; s’è pensato perciò che i romance epici fossero in origine semplici brani enucleati da un più ampio poema, precisamente, i punti più salienti che il pubblico imparava e ripeteva. Al di là delle apparenze, la differenza con l’epica non potrebbe essere maggiore: il tema narrativo è estratto dal nesso causale e lo presuppone soltanto in modo vago, non necessario; dalla struttura distesa ed esplicita del racconto si passa a quella contratta ed implicita di un momento drammatico per se stesso compiutamente espressivo e valido. La conclusione non può essere dunque che vaga ed ipotetica”.
Riprendiamo, quindi, da dove eravamo rimasti, lì dove il Romance si attesta e si sviluppa nella Castiglia del XIV secolo, da cui poi giunge in Portogallo, ricevendo una “nuova” impronta sul finire del XV sec. dalla maggior grazia d’invenzione e la profusa delicatezza dei sentimenti cui si ispirarono molti compositori dell’epoca. I temi nazionali portoghesi furono dapprima reinterpretati sulla scia del romance castigliano; ma è possibile ammettere una priorità della redazione portoghese per alcuni romance di carattere sentimentale, come ad esempio quelli intitolati alla “Bella Infanta”, a “Don Bueso” e al “Conde Claros”, ecc.: vuoi per la “genuina melodia del folklore, piuttosto che popolare, e che come moltissime altre, ebbero vasta notorietà perché su di essa si potevano cantare tanti altri “romance” e, soprattutto, perché la sua indubbia monotonia melodica era un agevole campo d’azione per i compositori, che potevano sbrigliarvi il talento in una serie di variazioni. (..) Infatti,la forma della variazione pare sia nata in Spagna, per la necessità di alleviare la monotonia dell’accompagnamento del liuto durante la recitazione di un romance lungo” (*).
Con il “Cancioneiro Geral” (*) di Garcia de Resende portoghese del XV secolo, si testimonia la più antica presenza del Romance sul territorio, a conferma dell’avvenuta interazione della tradizione spagnolo-portoghese con quella che era la tradizione musicale ebraica e araba, rintracciabile nelle ricche ornamentazioni musicali che irrompono improvvise con l’esplosione sonora e vocale, tipiche di quelle culture. Siamo però già un passo troppo avanti, prima di questa raccolta che contrassegna un vero e proprio nucleo di riferimento del Romance viejos e la linea di svolta con i “nuevos”, c’erano stati almeno due avvenimenti non trascurabili, entrambi ascrivibili al 1492: la guerra di Reconquista culminata con la caduta definitiva del regno musulmano di Granada e la conseguente cacciata degli ebrei-sefarditi che non riconoscevano la cristianità; e la scoperta del “Nuevo Mundo” da parte di Cristóbal Colón, che riaccesero gli animi nazionalistici e diedero ulteriore vigore alla rinascita dell’epopea epica.
Ancora in epoca trovadorica, nell’Andalusia araba, era conosciuta una composizione simile come struttura alle canciones di cui si è precedentemente parlato: “el zéjel”, in cui si alternavano “strofe” cantate da un solista, con inserimento di un “estribillo” (ritornello) cantato invece dal coro sullo stile del responsorio; nel modo in cui agli “a-solo” del cantante rispondevano i “vocalizzi” del coro, onde all'estribillo iniziale succedeva una o più strofe, o rime deferenti: le così dette solfe, l'ultima delle quali, la vuelta, veniva sostituita dal ritornello. Altresì si conoscono Romance contenenti, al loro interno, uno o più canti appassionati dal nome vivace, detti “villancicos”, di carattere popolare: “vivo e traboccante di allegria, spesso ironico o picaresco”, apparentato – è bene ricordarlo – con il “virelai” francese che, a sua volta, faceva da sfondo alla “ballata” italiana.
Ciò non toglie che anche nel Romance di questo periodo si facesse un uso strumentale d’accompagnamento, come infatti è testimoniato in alcuni testi dove è fatto riferimento oltre che all’esposizione narrativa, a un fare musica per così dire “improvvisata”, o come si diceva allora “intavolata”, per accentuare la sua estrazione popolare e ricreare quell’atmosfera, reale o fantastica che fosse, più adatta allo svolgersi degli accadimenti. E che, così utilizzata, serviva a colmare i vuoti che separavano i diversi periodi e i salti di tempo richiesti dalla narrazione. Acciò assolveva spesso i villancicos (canto dei villani), di stampo vivace e gaio usato nelle feste, ma anche le canciones di genere amoroso, così come le ninne-nanne, i canti religiosi per la natività ed altri, più o meno spontanei, accompagnati dal liuto, dalla tiorba, o dalla chitarra; mentre per la musica colta erano già in uso il l’arpa, il chitarrone, il violòn e altri.
Nei primi Romance di genere nuevos, fortemente ispirati dalla cultura arabo-moresca, tipica delle correnti andaluse, era consuetudine la tendenza a limitare l’uso alla voce narrante e l’accompagnamento a un solo strumento (rebèc, lyra, viella, guitarra morisca); mentre, la monodia vocale, all’origine della polifonia (a più voci), rivelava segreti rapporti con la cultura ebreo-sefardita nell’andamento salmodiante dei recitativi, e per certi aspetti l’influenza mozárabe e bizantina. Ecco che allora, anche la guerra contro l’infedele, la celebrazione dell’eroe tragico, oppure altri temi epici, spesso molto più antichi, davano forma alle trame di un repertorio al tempo stesso creativo e fantasioso, certamente partecipe del nobile lamento o del veemente compianto popolare.
Oltre agli strumenti già citati, e in seguito sostituiti da altri (vihuela, chitarra, liuto, flauto, percussioni), non è stato rintracciato riferimento alcuno che fossero usati durante la narrazione del Romance così detto, poiché il genere richiedeva una particolare capacità interpretativa e quindi una struttura armonica imprevedibile. Tuttavia, più in generale, si evita di parlare di liutisti spagnoli, seppure il liuto fosse allora lo strumento più diffuso durante “l’età d’oro” della musica spagnola. Abbondantemente rappresentato nell’iconografia medievale dopo la conquista araba, il liuto, descritto a quattro o cinque corde e apparentato con l’ud – etimologicamente il legno – che invece non conobbe alcuna notazione scritta, perlomeno non in quel tempo, in quanto strumento d’estrazione musulmana e quindi rifiutato dai cristiani.
È interessante notare come la scrittura nel Romance tenda a esemplificare oltremodo l’uso della tecnica utilizzata dal Romanceros, nell’uso che egli faceva (e tutt’ora fa) di scandire ogni frase, ogni parola con l’ardore di chi esprime intensità di sentimenti o di passioni in modo struggente e implacabile, con slancio impetuoso; tale da determinare un qualche effetto commovente o comunque profondamente drammatico, quasi voglia attestare la supremazia della propria voce che, riprodotta a oltranza, caratterizza l’obiettivo della sua esposizione, al pari di un leit-motiv ripetuto per l’intera durata della narrazione. Nel frattempo le forme vocali, ancora lontane dal regolarizzarsi, non saranno avvertite almeno fino alla metà del XVI secolo. Dopodiché il Castigliano, come lingua parlata e scritta, pur mantenendo un sapore legato al territorio, assumerà una sua eleganza formale, con l’allontanarsi definitivamente dalle pretese latinizzanti che lo tenevano imbrigliato, in ragione dell’immissione letteraria di nuovi talentuosi compositori, perdendo così ciò che rimaneva della sua rudezza, compensata dalla spontaneità del “castiglianismo” a oltranza.
Per altro, oltre che a coltivare i diversi generi narrativi, i Romanceros accrebbero quelli che erano gli stampi linguistici del Romance viejos, incorporando quelle risorse linguistiche popolari ch’erano presenti sul territorio, allorché il castigliano, sulla scia dell’ampliamento culturale in atto, conobbe una rinnovata "coscienza" nazionalistica e, in un certo qual senso, obbligò i nuovi autori di cercare nel “castigliano” tutte le risorse linguistiche di cui necessitava. Il successivo abbandono di certi ideali, a seguito della rimessa in discussione di molti valori secolarizzati, sia religiosi che socio-politici, riguardanti i privilegi del potere ecclesiastico e della borghesia laica, sostituiti in parte da quel rifiorire che porterà infine al Rinascimento, furono all’origine di un altro tipo di Romance che possiamo definire “comico-burlesco” carico d'ingegno e di malizia popolare che pretendeva solo di divertire.
In esso troviamo infatti, oltre ai racconti giocosi, le “fabula" e le “apologie”, con le loro morali e una gran quantità di "punizioni esemplari" ed "esempi moraleggianti" di ogni tipo, che furono gli ingredienti costanti del successivo impegno letterario di molti autori minori, come del resto lo erano i Sacramentales di religiosa memoria, i quali, se da una parte mettevano in luce le virtù teologali, dall’altra, con la stessa spudoratezza, esibivano le armi usate dalla borghesia in difesa dei propri interessi e come risultato dei propri bassi appetiti.. Come risulta da questo grazioso “Romance de la Loba Parda” (*) su un tema rusticano, che Enrique de Mesa inquadra in un precedente passaggio di “Nieves del Guadarrama”:
"Estando yo en la mi choza / pintando la mi cayada, / las cabrillas altas iban / y la luna rebajada; / mal barruntan las ovejas, / no paran en la majada. / Vide venir siete lobos / por una oscura cañada. / Venían echando suertes / cuál entrará a la majada: / le tocó a una loba vieja, / patituerta, cana y parda, / que tenia los cocolmillos / come punta de navaja. / Dio tres vueltas al redil / y no pudo sacar nada; / a la otra vuelta que dio, / sacó la borrega blanca, / hija de la oveja churra, / nieta de la orjisana, / la que tenian mis amos / para el domingo de Pascua. / - ¡Aquí, mis siete cachorros, / aquí, perro el de los hierros, / a correr la loba parda! / Si me cobráis la borrega, / cenaréis leche y hozaga; / y si no me la cobráis, / cenaréis de mi cayada. / Los perros tras de la loba / las uñas se esmigajaban; / siete leguas la corrieron / por unas sierras muy agrias. / Al subir un cotarrito / la loba ya va cansada: / - Tomad, perros, la borrega, / de tu boca alobadada, / que queremos tu pelleja / pa’ el pastor una zamarra; / el rabo para correas, / para atacarse las bragas; / las tripas para vihuelas / para que bailen las damas”.
"Stando io nella mia capanna / dipingendo la mia cayada, / le cabrillas alte andava / e la luna ribassata; / male si presentano le pecore, / non ferme nell'ovile. / Vide venire sette lupi / per un'oscura gola. / Venivano gettando fortune / quale entrerà all'ovile: / toccò una lupa vecchia, / dalle gambe storte, capello bianco e bruna, / che tenia i cocolmillos /e mangiava in punta di coltello. / Girò all'ovile / e non poté tirare fuori niente; / all'altro giro che diede, / tirò fuori la borrega bianca, / figlia della pecora churra, / nipote dell'orjisana, / quella che avevano i miei padroni / per la domenica di Pasqua. /- Qui, i miei sette cuccioli, / qui, il cane quello dei ferri, / si mise a correre dietro la lupa bruna! / Se mi riscuotete la borrega, / cenerete latte e hozaga; / e se non me la riscuotete, / cenerete della mia cayada. / I cani oltre alla lupa / le unghie Lei esmigajaban; / sette leghe la rincorsero / per alcune catene montuose molto aspre. / Portando su una combriccola / la lupa era già stanca: / - Prendete, cani, la borrega, / del tuo bocca alobadada, / che vogliamo il tuo cuoio / per farci il pastore una zimarra; / la coda per cinturini, / per attaccarsi le mutande; / le budella per la viella / affinché ballino le dame."
Molti sono gli autori spagnoli di Romance vecchi e nuovi, che solo un elenco sarebbe qui impossibile quanto inutile azzardare, pertanto mi limito a citarne uno, il primo e senza dubbio il più grande, colui che, in qualche modo, ha contrassegnato la sua epoca, il XIV secolo: Juan Ruiz, più noto come Arcipreste de Hita, nato presumibilmente ad Alcalá de Henares (la stessa patria di Cervantes) nel c.1280, anche famoso per essere l’autore del “Libro de buen amor” (*) considerato uno dei capolavori della poesia medievale spagnola. Un poema di 7 mila versi assortiti divisi in 1728 strofe, con forme che rimandano alla poesia devota, alla lirica, all'allegoria, alla satira, e personaggi molto realistici (come la mezzana Trotaconventos, e doña Endrina). Nel prologo si allude a una prigionia che una didascalia di un amanuense dice ordinata dal cardinale Gil Albornoz, dove il "buen amor" del titolo, cioè l'amore divino, si contrappone al "loco amor", l'amore folle e terreno.
Senz’altro uno dei libri più singolari e significativi delle origini della produzione in castigliano, scritto in "cuadernavía", un verso in sedici sillabe, usato soprattutto nella parte narrativa, ma sono presenti anche altri tipi di versi. Con la pretesa/pretesto di svelare i sottili inganni dell'amore mondano, attraverso una concreta varietà di “exempla”, “Libro de buen amor” si muove tra digressioni e divagazioni di ogni genere, presentando una serie di esperienze galanti e sensuali in cui la seduzione si conclude sempre con uno scacco, tranne in una sola eccezione. Alla costruzione del poema pseudo autobiografico confluiscono dati e toni disparati: avventure immaginarie e esperienze reali, schemi dottrinali e atteggiamenti goliardici e giullareschi, l'invettiva e il tradizionalismo, fonti classico-latine e cristiane, mentre influenze francesi e orientali sono inserite nel flusso della vita quotidiana. Quest'ultima è deformata in modo caricaturale da un irrefrenabile umorismo fantastico e un vitalismo che si mescola con pressanti preoccupazioni didascaliche, e tuttavia di edificazione etico- religiosa.
Dal “Libro del buen amor” leggiamo:
“El hombre debe alegrar su corazón, pues las muchas tristezas pueden nublar su entendimiento. Son palabras de Catón el sabio, que yo hago mías ahora. Mas nadie puede reírse de cosas serias, por eso yo pienso introducir en este libro algunos chistes con objeto de que aquéllos que los lean puedan divertirse y alegrar su ánimo. Pero te ruego, lector, que entiendas bien lo que digo y no tomes el rábano por las hojas. Medita bien la esencia de mis palabras. No me pase contigo lo que sucedió al doctor de Grecia con su rival romano, un hombre ognorante y de pocas luces. He acquí el cuento: ...”.
"L'uomo deve rallegrare il suo cuore, perché le molte tristezze possono offuscare il suo intendimento. Sono parole di Catone il saggio che io faccio ora mie. Ma nessuno può ridere di cose serie, per qual motivo io penso di introdurre in questo libro alcune storielle che quelli che li leggono possano divertirsi e rallegrare il proprio animo. Ma ti prego, lettore, capisci bene quello che dico e non prendere il ravanello per le foglie. Medita bene l'essenza delle mie parole. Non mi passi con te quello che succedette al dottore della Grecia col suo rivale romano, un uomo ignorante e di poche luci. C'è qui il racconto: ... ".
Autore di straordinaria importanza per la nostra ricerca è senz’altro Juan de Fermoselle, detto Juan del Encina (da Encinas presso Salamanca, 12 luglio 1468 – León, 1529), poeta, drammaturgo e musicista del quale non si conosce l’origine del nome che forse risponde solo a un appellativo non di origine spagnola, subito cambiato in quel del Encina o Enzina. Una volta diplomatosi in diritto, entrò al servizio del Duca d’Alba, Don Fadrique Alvarez de Toledo, nipote del re di Aragona Fernando V che dopo alcuni anni, nel 1498 lo designò Maestro di Cappella nella Cattedrale di Salamanca. In ragione della sua veste fu spesso a Roma con incarichi forse diplomatici, dove contava del favore di diversi papi, da Alessandro VI, Giulio II e Leone X. Sebbene non se ne conosca la ragione, del Encina ricevette gli ordini minori, forse per i suoi trascorsi di un viaggio in Terrasanta.
A partire dal 1523, prese residenza in León, dove papa Leone X lo aveva nominato Priore della Cattedrale, trascorse i suoi ultimi anni e vi morirà sul finire del 1529. Queste le sole date interessanti della sua lunga biografia che, se da una parte ci danno la dimensione del personaggio nulla ancora ci dicono della sua grandezza di musicista e non spiegano il perché della “nostra” scelta. Sta di fatto che del Encina, fu uomo dalla personalità molto spiccata, che è quasi impossibile immaginare il corso della sua vita amorosa e sapere se le allusioni della sua poesia corrispondono all'esperienza o al convenzionalismo galante dell'epoca. Il successo del suo “Cancionero” (*), fu tale che la sua pubblicazione, avvenuta in Salamanca nel 1496, è certamente da ritenersi la prima edizione affermatasi in Spagna, ed una delle prime in Europa, di uno stesso autore in vita.
Lo testimoniano le cinque edizioni successive tra 1501 e 1516, in alcune città spagnole tanto lontane da Salamanca come Saragozza e Siviglia, nonché l’ampia influenza letteraria che queste ebbero nella letteratura dell’epoca. È certo che egli compose molte delle sue liriche ancor prima di aver compiuto 25 anni di età. Poeta dunque, egli compose le sue “Eglogas” in forma di villancicos per il teatro, e che lo attestano patriarca della scena teatrale spagnola. Ciò che più ci interessa, sia per l’aspetto etnologico per aver egli operato sul territorio, sia per l’aspetto comunicativo del suo essere “mùsico”. Maestro de Capilla, el Encina non scrisse né messe, né mottetti, cosa quest’ultima che non gli avrebbe permesso di mantenere il suo posto, compose invece molte canciones, ispirate esclusivamente sui propri poemi, dimenticando talvolta di essere un chierico molto compromesso che s’imponeva con un'opera esclusivamente profana. La sua vita, a partire da 1500, sembra dividersi in due, una prima sedentaria e creatrice alla Corte del Duca d’Alba, cui rimase innegabilmente legato vuoi per affetto o per adulazione cortigiana; e l’altra, vissuta tra l’ambulante profano e la religiosità del chierico.
Fermiamoci per un momento sul componimento più importante della sua produzione, quel “A la dolorosa muerte del Principe Don Juan” (1497), da cui è tratto il romance “Triste España sin ventura” (*):
“Triste España sin ventura, / todos te deven llorar. / Despoblada de alegrìa, / para nunca en ti tornar, / tormentos, penas, dolores / te ninieron a poblar. / Sembròte Dios de plazer / porque naciesse pesar; / hìzote la màs dichosa / para más te lastimar. / Tus vitorias y triunfos / ya se hovieron de pagar: / pues que tal pérdida pierdes, / dime en qué podras ganar. / Pierdes la luz de tu gloria / y el gozo de tu gozar; / pierdes toda tu esperanca, / no te queda qué esperar. / Pierdes Principe tan alto, / hijo de reyes sin par. / Llora, llora, pues perdiste / quien te havìa de ensalcar. / En su tierna juventud / te lo quiso Dios llevar. / Llevote todo tu bien, / dexòte su desear, / porque mueras, porque penes, / sin dar fin a tu penar. / De tan penosa tristura / note esperes consolar.”
“Triste Spagna senza sorte, / tutti ti devono piangere. / Spopolata della tua allegria,
che mai più in te tornerà, / tormenti, pene, dolori / sono tornati a popolarti. / Sembra che Dio abbia dichiarato il suo piacere / affinché nascesse a te / la più felice delle gioie,/ non per ferire, / altresì soffrendo per tale perdita. / Ora per le tue vittorie e i trionfi / ti corre l’obbligo di dover pagare: / affinché la tua sofferenza sia minore / del perché di una tale perdita, / non c’è cosa che tu possa guadagnare. / Hai perso la luce della tua gloria / e il godimento ultimo della tua felicità; / e di tutta la tua speranza, / infine non ti rimane niente in cui sperare, / dal momento che hai perduto questo grande Principe, / figlio di re senza pari. / Adesso piangi, piangi, per ciò che hai perduto / quell’unico che ti esaltava / nella sua tenera gioventù. / Dio ha voluto toglierlo a noi per portarlo con sé / togliendoti con lui ogni tuo bene, / secondo il suo desiderio. / Affinché tu muoia, / perché tua sia la pena, / senza poter mettere fine al tuo penare. / Perché di tanta penosa afflizione / Tu non possa sperare nella consolazione”.
La distanza storica che ci separa dal suo autore non ci permette qui di comprendere i timori, che alla morte di Don Juan, figlio unico di Ferdinando V e Isabella d’Este, visse con dolore seppure foderato di nobile dignità, per l'irreparabile catastrofe che si preparava a seguito della notizia della presa di Granada e la conseguente caduta dei Reyes Catòlicos. La morte del principe Don Juan è uno dei grandi temi sui quali poggia il suo “Cancionero”; di cui non si comprenderebbe la portata, se si dimenticasse che Don Juan rappresentava la speranza di una dinastia stabilizzata, in un paese che cercava in ogni modo di accedere al rango di stato moderno. Con la prospettiva del tempo, oggi arriviamo a dire che i suddetti avvenimenti influenzarono senza ombra di dubbio le sue scelte non solo letterarie, ma non ci ingannino certi accenti colti, seppure ciò costituisse una rottura nella vita del suo essere artista dottissimo.
Ciò che più coglie l'attenzione, oltre alla spiccata indole genuinamente spagnola di Juan dell'Encina, è l'armonia che intercorre tra i poemi scritti e la loro traduzione musicale operata nei villancicos e nei romance cavallereschi di cui è autore. Ogni inflessione del testo dà luogo a un'invenzione melodica e ritmica che traduce il suo sommo dominio delle risorse disponibili che danno forma all'espressione musicale: sia che si tratti della disperazione (nel ciclo dedicato a Don Juan), nell'umore colorito (Cucù cucù, cucucù; Si habrà en este baldrés), o picaresco (Hoy comamos y bevamos), o grazioso dell’attore comico (Fata la parte). Ancor più, ironicamente moralizzatore di (El que rige y el regido), o dell'amore cortese e platonico (Amor con fortuna; Ay, triste, que vengo; Mas vale trocar), in cui il “tono” scelto è tanto gradevole da risultare irresistibile. È infatti l'immediatezza di questi brani, a darci l’esatta percezione dell’elemento popolare delle canciones e dei villancics, non per questo meno colto, nonché la chiave della sua originalità.
In breve il “Cancionero” entrò a far parte del repertorio al servizio della Cappella Reale, come “Cancionero musical de Palacio” (*), il cui ritrovamento nella biblioteca del Palazzo Reale a Madrid, testimonia all’origine la vita musicale delle Corti in Spagna dal finire del XIV fino al XVI secolo. Originalmente inclusivo di 551 composizioni, di cui 460 molto ben preservati, non è il lavoro di uno ma piuttosto di molti scrivani che ne copiarono la notazione, pur facendo molti errori e alimentando gli cambi fonetici dei testi, anche se si pensa che molti poemi scaturirono dall'entourage del Duca d’Alba, mecenate di Juan del Encina. Tuttavia le canciones non appaiono ordinate in sequenza e per lo più sono di generi diversi: storie d’amore, resoconti politici e storici (mai è toccato il tema della cattura di Granada), soggetti religiosi, cavallereschi e pastorali, brani più allegri e musica da ballo. Sulla scia del successo ottenuto e per compiacere il re, le altre Corti spagnole non vollero essere da meno e aprirono i propri palazzi a cantori e strumentisti, nonché a quei compositori in grado di gareggiare con la Cappella Reale.
Lo testimoniano i numerosi “Cancionero” dell’epoca, nei quali si riscontra il Castigliano, essere la lingua più frequente, con una piccola quantità di testi misti in latino, francese, italiano, portoghese ed anche basco. Così come simili sono nello spirito “triste e lamentoso”, verosimilmente carico di “malinconia”, tipico di molta musica dell’epoca, la cui melodia, seppure arricchita di fioriture ritmiche, è trasferita nella costante disputa all’interno delle canzoni popolari, colorita di altre assonanze e di nuovi strumenti e musicisti virtuosi. Tuttavia, per comprendere tutto ciò occorre cercare nella Spagna cristiana piuttosto che in altra area musicale, dove, certo troviamo tracce di quella cultura colma di colore ed eleganza che tanto impressionò tutta la musica successiva europea.
Parallelamente, il Romance tradizionale si ampliò con l’affrontare le tematiche religiose e di quella letteratura romanza carica di storie prese da gesta banditesche e narrazioni più semplici, scaturite dall’ambiente rurale e trasferite, in seguito, nelle famose “zarzuela”, sorta di operetta leggera cantata e spesso danzata che fin da allora, continua ad occupare la scena teatrale spagnola.
Nel suo genere, almeno in quello ascrivibile all’epica castigliana, il Romance come genere, s’impone alla nostra attenzione più per originalità che per l’attinenza storica che lo si distingue da quello francese, giocato sulla perfezione del linguaggio. Del resto gran parte della letteratura ispanica riferita al Romance che affolla i secoli passati è pregna di lirismo poetico e, in definitiva, di un alone di sentimentalismo narrativo che troviamo in quelli più antichi cosi detti “Romance viejos”, dedicati a personaggi famosi della storia nazionale spagnola: “Re Rodrigo”, “Bernardo del Carpio”, “Fernan Gonzales Conte di Castiglia”, gli “Infanti di Lara”, “El Cid Campeador”, “El Conde Arnaldos”, “Don Alvarez de Luna”, e in quei tanti altri che raccontano eventi epici accolti nei cicli “carolingio” e “bretone” di genere avventuroso - cavalleresco. In particolare, quello riferito al “Re Rodrigo e la perdita di Spagna” (*), datato – pensate – tra l’860 e il 930, e ritenuto a ragione il più antico pervenuto nella forma orale.
Nell’impossibilità di tradurre l’intero Romance, del resto assai lungo, leggiamo insieme un brano riferito alla “Penitencia del Rey Rodrigo”:
“Después que el rey Rodrigo a España perduto habia, / ibase desesperado / huyendo de su desdicha; / solo va desventurado, / no quiere otra compania / que la del mal de la muerte / que en su seguimento iba: / métese por la montanas, / las más espesas que veìa. / Topado ha con un pastor / que su ganado traìa; / dijole: "Dime, buen hombre, / lo que preguntar querìa: / si hay por aquì monasterio / o gente de clerecia". / El pastor respondiò luego / que en balde lo buscaria, / porque en todo aquel desierto / solo una ermita habia, / donde estaba un ermitano / que hacia my santa vida. / El rey fue alegre desto / por all'ì acabar su vida; / pidio al hombre que le diese / de comer si algo tenia, / que las fuerzas de su cuerpo / del todo desfallecian. / El pastor sacò un zurròn / en donde su pan traia;/ diòle de él y de un tasajo / que acaso allì echado habia;/ el pan era muy moreno, / al rey muy mal le sabia, / las lagrimas se le salen, / detener no las podia,/ acordandose en su tiempo / los manjares que comia. / Después que hubo descansado, / por la ermiya pedia; / el pastor le enseno luego / por donde no erraria; / el rey le dia una cadena / y un anillo que traia;/ joyas de gran valor / que el rey en mucho tenia. / Comenzando a caminar, / ya cerca el sol se ponia, / a la ermita hubo llegado / en muy alta serrania. / Encontrose al ermitano, mas de cien anos tenia. / "El desdichado Rodrigo / yo soy, que rey ser solia, / el que por yerros de amor / tiene su alma perdida, / por cuyos negros pecados / toda Espana es destruida. / Po Dios te ruego, ermitano, por Dios y Santa Maria, / que me oigas en confesion / porque finar me queria". / El ermitano se espanta / y con lagrimas decia: / "Confesar, confesaréte, / absolverte no podia". / Estando en estas razones voz de los cielos se oia: / "Absuélvelo, confesor, / absuélvelo por tu vida 7 y dale la penutencia / en la sepultura misma". / Segun le fue revelado / por obra er rey lo ponia. / Metiose en la sepoltura / que a par de la ermita habia; / dentro duerme una culebra, / mirarla espanto ponia: / tres roscas daba a la tumba, / siete cabezas tenia. / "Ruega por mi, el ermitano, / por que acabe bien la vida". / El ermitano lo esfuerza,7 con la losa lo cubria, / rogada a Dios a su lado / todas las horas del dia. / "Como te va, penitente, / con tu fuerte compania?". / "ya me come, ya me come, / por do mas pecado habia, / en derecho al corazon, / fuente de mi gran desdicha". / Las campanicas del cielo / sones hacen de alegria; / las campanas de la tierra / ella solas se tanian; / el alma del penitente / para los cielos subia".
"Dopo che il re Rodrigo la Spagna perduto aveva, / rimase disperato / fuggendo dalla sua sfortuna; / solo va sventurato, / non vuole un'altra compagnia / che quella del male della morte / che andava al suo seguito: / mettila per le montane, / ma ispessisci che veìa. / Urtato c'è con un pastore / che il suo bestiame traeva; / dicendole: Dimmi, buon uomo, / quello che domandare voleva: / si va per qui al monastero / o gente di clero?" / Il pastore rispose dopo / che invano lo cercherebbe, / perché in tutto quel deserto / solo un eremo aveva, / dove stava un eremita / che verso la mia sacra vita. / Il re fu allegro desto / per finire la sua vita; / chiese all'uomo che gli desse / da mangiare se qualcosa tenia, / che le forze del suo corpo / del tutto l’abbandonavano. / Il pastore prese un zurròn / dove il suo pane portava; / lo diede a lui con una carne salata / che per caso lì per lì cacciato aveva; / il pane era molto bruno, / al re molto cattivo egli sapiente, / le lacrime uscirono, / che fermarle non poteva, / ricordandosi nel suo tempo / i manicaretti che mangiava. / Dopo che aveva riposato, / per l'eremo chiedeva; / il pastore gli insegnò / per dove non poteva sbagliare; / il re gli regalò una catena / ed un anello che portava; / gioielli di gran valore / ai quali il re in molta riguardo teneva. / Cominciando a camminare, / già il sole accerchia si metteva, / all'eremo era arrivato / in molto alto serrania. / Incontrò l'eremita, che più di cento anni aveva. / "Lo sfortunato Rodrigo / io sono che re essere soleva, / quello che per errori di amore / ha la sua anima persa, / per i cui neri peccati / tutta la Spagna è distrutta. / Per Dio ti prego, eremita, per Dio e Santa Maria, / che mi senta in confessione / perché morire mi amavo". / L'eremita si spaventa / e con lacrimi diceva: /"Confessare, ti confesserei,/ assolverti non posso". /Stando in queste ragioni voce dei cieli si sentiva: /"Assolvilo, confessore, / assolvilo per la tua vita 7 e dagli la penitenza / nella sepoltura stessa". / Come gli fu rivelato / per opera il re lo metteva. /Messosi nella sepoltura / che a pari dell'eremo aveva; /dentro dorme una biscia, / guardarla spavento metteva: / tre viti dava alla tomba, / sette teste tenia. /"Prega per me, l'eremita, / per che finisca bene la vita." / L'eremita con la forza,/con la lastra lo copriva, / pregava Dio al suo fianco / tutte le ore del giorno. /"Come ti va, penitente, / con la tua forte compagnia?". /“Già mi mangia, già mi mangia, / perdono che peccato aveva, / in diritto al cuore, / fonte della mia gran sfortuna."/Le campana del cielo / suonava di allegria; /le campane della terra / da sole suonavano; / mentre l'anima del penitente / per i cieli saliva".
Sono questi Romance che più d’ogni altra cosa ci rendono, ancora una volta, la dimensione degli avvenimenti pseudo storici, quando addirittura leggendari, che ci permettono di rivisitare, seppure attraverso l’ottica etnomusicologica, un certo piacere del semper et nunc filtrato dal gusto popolare del narrare, e comunque, sottilmente elaborato nello stile personale del narratore, quel Romancero che nel tempo, ne ha permesso la sedimentazione all’interno della tradizione. Numerosi sono i Romance che si ascoltavano ancora negli ultimi anni della dominazione araba, cosiddetti “moriscos” per l’argomento trattato. La cristianità è partecipe in questi testi elaborati contro il pericolo musulmano degli Almoràvidi che, intorno al 1114 avevano risalito l’Ebro e vi erano installati, per la vittoria riportata a Tolosa (1215) che aprì ai cristiani la strada della Reconquista, culminata molto tempo più tardi – è bene ricordarlo – con la caduta di Granada (1492), con la quale si pose fine alla dominazione araba in Spagna. L’eco di quelle “algarades”, ovvero scorrerie (la parola viene dall’arabo attraverso lo spagnolo), è rintracciabile nel “Romance del Moro que perdiò Alhama” (*), riferito al primo fatto saliente della caduta di Granada, allorquando Don Rodrigo Ponce de Léon conquistò, in maniera sorprendente, la ricca piazza di Alhama, luogo ideale dei re Mori. Raccontano le cronache dell’epoca, che fu tanta la pena dei “granadinos” (gente di Granada)per quella perdita, che in seguito fu proibito eseguirlo, perché tanto era il dolore che infondeva negli animi che finiva per disanimare il popolo.
Da “La gran pérdida de Alhama” leggiamo:
“Paseábase el rey moro / por la ciudad de Granada, / desde la puerta de Elvira / hasta la de Villarrambla. / ¡Ay de mi Alhama! / Cartas le fueron venidas / que Alhama estaba ganada; / las cartas echó en el fuego / y al mensajero matara. / ¡Ay de mi Alhama! / Descabalga de una mula / y en un caballo cabalga; / por el Zacatín arriba / subido se había al Alambra. / ¡Ay de mi Alhama! / Como en el Alambra estuvo / al mismo tiempo mandaba / que se toquen sus trompetas, / sus añafiles de plata. / ¡Ay de mi Alhama! / Y que tambores de guerra / aprisa toquen alarma, / para que lo oigan sus moros, / los de la Vega y Granada. / ¡Ay de mi Alhama! / Los moros, que el son oyeron, / que al dios de la guerra llama, / uno a uno y dos a dos, / se ha juntado gran batalla. / ¡Ay de mi Alhama! / Allí habló un moro viejo, / de esta manera hablara: / -¿Para qué nos llamas, rey? / ¿Para qué es esta llamada? / “¡Ay de mi Alhama! / -Habéis de saber, amigos, / una nueva desdichada, / que cristianos de braveza / ya nos han ganado Alhama. / ¡Ay de mi Alhama! / Allí habló un alfaquí / de barba crecida y cana: / -Bien se te emplea, buen rey; / buen rey, bien se te empleara. / ¡Ay de mi Alhama! / Has matado Abencerrajes, / que eran la flor de Granada, / y cogido a renegados / de Córdoba la nombrada. / ¡Ay de mi Alhama! / Por eso mereces, rey, / una pena muy doblada: / que te pierdas tú y el reino, / y aquí se pierda Granada. / ¡Ay de mi Alhama! / Ahi del mio Alhama! / Per quel motivo meriti, re, / una pena molto arcuata: / che ti perda tu ed il regno, / e qui si perda Granada. / Ahi del mio Alhama!”
“Passò il re moro / per la città di Granada, / dalla porta di Elvira / fino a quella di Villarrambla. / Ahi del mio Alhama! / Lettere gli furono giunte / che Alhama era perduta; / le lettere gettò nel fuoco / ed egli fece uccidere il messaggero. / Ahi del mio Alhama! / Quindi smonta dalla mula / e in sella una cavallo cavalca; / verso il Bazar sopra la piazza recinto. / Ahi del mio Alhama! / Come in quello recinta stette / contemporaneamente comandava/ che si suonassero le trombe, / e il suo corno d’argento. / Ahi del mio Alhama! / E che i tamburi di guerra / rapidamente suonino l’allarme, / affinché lo sentano i suoi mori, / quelli della Pianura e quelli di Granada./ Ahi del mio Alhama! I mori, che quel suono sentirono, / che il dio della guerra chiama, / uno ad uno e due a due, / si unirono a lui gran battaglia. / Ahi del mio Alhama! / Così parlò al vecchio moro, nel modo che in questa maniera parlasse: / - Per che motivo ci chiami, re? / Per quale motivo hai fatto questa chiamata? / Ahi del mio Alhama! Dovete sapere, amici, / una notizia sfortunata, / che cristiani di bravura / già hanno riguadagnato Alhama. / Ahi del mio Alhama! / Ahi parlò un vecchio dalla barba cresciuta e dal capello bianco: / - Bene si impiega, buon re; / bene buon re, se non avessi osato. / Ahi del mio Alhama! / Hai ammazzato Abencerrajes, / che erano il fiore di Granada, / e addirittura hai rinnegato Cordova la famosa. / Ahi del mio Alhama! / Per questo motivo meriti, re, / una pena molto infame: / che tu perda tu e il regno, / e che si perda Granada. / Ahi del mio Alhama! / Hai del mio Alhama! / Per quel motivo meriti, o re, una pena molto cercata: / che tu perda il tuo il tuo regno, e che tu perda Granada. /Ahi del mio Alhama!”
(continua).
Bibliografia:
(*) Giorgio Mancinelli - Etnomusicologia 1: “Musicologia per capire i popoli” (in questo sito).
AA.VV. “Enciclopedia della musica” - The Oxford University Press / Garzanti - 1996.
Francisco M. Marìn - “Literatura Castellana Medieval: de la jarchas a Alfonso X” - Editorial Cincel - Madrid 1980.
Rosa Bobes Naves - “Clerecìa y juglarìa en el s. XIV: Libro de Buen Amor” - Editorial Cincel – Madrid 1980.
Luis Diaz Viana - “Del Medievo al Renacimiento: Poesìa y prosa del s. XV” - Editorial Cincel – Madrid 1980.
Dionisio Preciado - “Folklore Espanol: musica, danza y ballet” - Studium Ed. Madrid 1969.
G. Di Stefano - “El Romancero: estudio, notas y comentarios de texto” - Narcea de Ed. - Madrid 1985.
Javier Villalibre - “Selection de Romances” - Editorial Everest - Leòn 1983.
Cesare Acutis, a cura di, "Romancero: Canti Epici del Medioevo Spagnolo" - Einaudi1983 e
"Cantare del Cid" - Einaudi 1986.
Note:
1) Giorgio Mancinelli - “Il paesaggio sonoro” in Etnomusicologia 2, (in questo sito).
2) Giorgio Mancinelli - “Il linguaggio sonoro” in Etnomusicologia 3, e “La comunicazione vocale” in Quaderni di Etnomusicologia 3 (in questo sito).
3) Joaquin Diaz - “Cancionero de Romances” (vedi discografia)
4) “virelai”, per una conoscenza più approfondita vedi: note e libretto in Guillaume de Machaut - “Chanson 1-2” del - EMI 2Lp 3C 053-30106/09. (vedi d.)
5) “Cantigas de Santa Maria” (vedi d.)
6) M. Pedro Ferreira - “O som de Martin Codax sobre a dimensao musical da lirica galego-portughesa” - UNYSIS - Lisboa 1986.Martin Codax
7) Martin Codax - “Cantigas de Amico” – in Cohen “500 camposdas letras” – Porto 2003.
8) “Flores y Blancaflor” - romanzo anonimo medievale, edizioni varie.
9) “Cantar de mio Cid” – in Ramon Menendez Pidal - “Flor nueva de romances vijeos” – Espasa-Calpe Madrid 1985.
10) Joaquin Diaz “Romance del prisonero” – in “Cancionero de Romances” op. cit.
11) Garci Rodriguez de Montalvo - “Los cuatro libros del virtuosa caballero Amadis de Gaula” – romanzo del XV
12) Miguel Cervantes de Saavedra “Don Chisciotte della Mancia” – Einaudi 1972.
13) C. Samonà – A. Varvaro “La Letteratura Spagnola: dal Cid ai Re Cattolici” – Sansoni – Milano 1972.
14) Samonà, Mancini, Guazzelli, Martinengo “La Letteratura Spagnola: I Secoli d’Oro” - Sansoni – Milano 1973.
15) “Cancionero della Colombina” - (vedi discografia)
16) “Cancionero de Palacio” (vedi discografia)
17) “Cancionero de la Casa de Medinaceli” - (vedi d.)
18) “Cancionero de Montecassino” - (vedi d.)
19) “Cancionero de Upsala” - (vedi d.)
20) Francisco de Salinas - “De musica libri septem” - in Documenta Musicologica n.13 - Bärenreiter - Kassel 1958.
21) “Cantar de Roncisvalles” – in Ramòn Menéndez Pidal op. cit.
22) Milà y Fontanals “De la poesia heroico popular castillana” 1988-96 - in La obras completa - a cura di Manuel Pelayo.
23) Ramon Menéndez Pidal – op. cit.
24) AA.VV. “Storia della Musica” vol. III - La Feltrinelli - Garzanti, 1996.
25) Ibidem
26) Garcia de Resemde - “Cancionero Geral” – Impresada Universidade - Coimbra1917.
27) “Romance de la Loba Parda” - di anonimo, in Ramon Menéndez Pidal - op. cit.
28) “Libro del Buen Amor” - in Storia della letteratura spagnola” - op. cit.
29) Juan del Encina – “Monumentos Historicos de la Musica Española” – Salamanca 1496.
30) Juan del Encina - “Cancionero de Palacio” - (vedi d.)
31) “Romance del re Rodrigo e la perdita di Spagna” - (vedi d.)
32) “Romance del moro que perdio Alhama” - (vedi d.)
Discografia: in chiusura dell’ultima parte.
*
.jpg) - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomus. 5: Cambogia, Laos, Viet Nam
CAMBOGIA, LAOS, VIET NAM: “Splendori di una tradizione secolare”, di Giorgio Mancinelli.
(Ricerca etnomusicologica per “Folkoncerto”, trasmissione radiofonica in onda su RAI-Radio3, e “Itinerari Folkloristici”; Reportage trasmesso dalla RSI – Radio della Svizzera Italiana, apparso inoltre in forma di articoli sulle riviste: Super Sound, Nuova Scienza, Musica e Dischi).
Al dolce suono del chapey, un liuto a due corde che accompagna il canto delle donne al mercato dei fiori, proseguiamo il nostro viaggio nella musica dell’Estremo Oriente e giungiamo in Cambogia, parte del “triangolo d’oro” che, con Laos e Thailandia, forma il sub continente asiatico dell’Indocina che si affaccia sul Golfo del Siam. Il Regno di Cambogia (in lingua khmer: Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea) con capitale Phnom Penh, è oggi una monarchia costituzionale, la cui lingua ufficiale è il khmer. La religione ufficiale è il Buddhismo e la maggior parte della popolazione ne pratica la dottrina Theravada. Già nell'VIII secolo, le dispute tra fazioni interne alla corte portarono alla scissione del regno in Alto e Basso Chēn-la. L’ascesa al trono di Jayavarman II, in seguito consacrato "sovrano universale", segnò la fine della sottomissione degli khmer da parte di Java e la nascita di uno stato khmer autonomo conosciuto allora come "Angkor", cui seguì un costante periodo di stabilità.
La seconda figura di rilievo nella storia del regno è Indravarman I (il cui regno va dal 877 al 889), che fece costruire un tempio in onore degli antenati di Preah Ko e il tempio-montagna di Bakong, il primo tempio-montagna nella storia del regno, dando così inizio all’opera di ricostruzione, poi continuato da tutti i suoi successori. L'evoluzione architettonica di Angkor arriva al suo apice nel XII secolo con la costruzione di Angkor Wat da parte del re Suryavarman II, sovrano celebrato per le sue vittorie, soprattutto sul Champa, e fervente visnuita. Ma è durante il regno di Jayavarman VII , che l'impero raggiunge l'apice politico, controllando la maggior parte dell'area del Sud-Est asiatico: parte dell'odierno Vietnam, Laos, Thailandia, Myanmar e penisola malese, inoltre il regno riceveva tributi da piccoli regni del Nord, dell'Est e dell'Ovest.
Successivamente i Thai, per ben tre volte conquistarono e distrussero Angkor (nel 1335, nel 1353 e nel 1431), che vedrà il centro politico spostarsi più a Sud, negli antichi territori dove originariamente si trovava il regno di Chēn-la. In seguito alla caduta del prospero Impero Khmer, i cui antichi splendori sono rintracciabili negli antichi templi e palazzi di Angkor, l’antica capitale del regno. Dacché la Cambogia subì per secoli l'influenza politico-militare dei paesi limitrofi, e attraversò un periodo di instabilità e guerre con il coinvolgimento nel conflitto vietnamita e il regime di terrore degli khmer Rossi e infine l'invasione vietnamita. Inutile dire che la cultura in Cambogia ha risentito di tali avvenimenti storici (era culturale di Angkor, colonizzazione francese, dominio degli khmer rossi, globalizzazione) e, ovviamente,
dell’influenza dalla religione: Buddhismo Theravada e Induismo, provenienti dall'India, oggetto di scambio con le vicine etnie del Laos e Thailandia per molti secoli. Mentre il linguaggio della corte è il sanscrito, il popolo per lo più parla khmer, entrato nella tradizione dell'etnia principale, gli khmer appunto, ma anche delle altre popolazioni che abitano le montagne, e chiamate comunemente khmer loeu.
Le arti tradizionali in Cambogia sono ancora oggi la lavorazione dell'argento, l'arte di intagliare e lavorare il legno, la scultura della pietra e la pittura, sviluppatesi e prodotte durante l'Impero khmer nell'era del massimo splendore di Angkor. L’architettura e la scultura presentano stili simili a tutta l’Indocina, lo rivelano i templi di Angkor Wat e Angkor Thom, testimoni eminenti di quella grandezza. Ancora oggi fabbri e argentieri riproducono gli oggetti più antichi di grande pregio artistico, indubbiamente i migliori esempi di cultura khmer. Oltre alla tessitura, di cui i krama e i sampot sono elementi del vestiario tradizionale, per lo più tessuti con il cotone, capi più pregiati possono essere in seta e avere finiture in oro e argento.
Così come l'arte in genere, la musica e la danza di quel periodo sarebbero diventati i modelli per il successivo sviluppo della cultura cambogiana, ancora oggi rintracciabile nelle sue varie forme culturali, preponderanti di quella che è riconosciuta (dall’UNESCO e da altre importanti Istituzioni Internazionali) come la cultura egemone di un popolo, la cui eco è giunta fino a noi anche attraverso la sua musica, gli strumenti, il teatro, la danza. Ciò che più importa alla nostra ricerca, per conoscere quelle che sono le tradizioni musicali di questa terra, almeno nell’aspetto degli usi e costumi che sono stati tramandati nel corso dei secoli.
Assieme al Laos e alla Thailandia, la Cambogia è indubbiamente il paese musicalmente più interessante dell'Indocina; la musica cambogiana continua in molti aspetti fondamentali la tradizione iniziata durante l'Impero khmer con costante originalità, risultato di vari apporti stilistici: un sostrato indigeno, un primo superstrato indiano e un secondo cinese. Questi tre elementi hanno diverso peso tra i vari paesi dell'area e sono alla base della musica cambogiana di tipo più antico, ma non nel modo così detto “moderno” dell'espressività indiana. Infatti, con la fine dell'Impero khmer, l'India è stata esclusa dai successivi cambiamenti evolutivi della musica; anche la successiva influenza cinese ha avuto meno risultati che negli altri paesi della zona. L'elemento strutturale della musica cambogiana rimane comunque di tipo indiano-khmer, almeno quella più arcaica, e solo recentemente presenta intromissioni di origine cinese, giavanese ed ovviamente europea, con una forte presenza di musica occidentale, in particolare il jazz si è molto affermato nelle città.
Come in tutto il Sud-Est Asiatico, anche qui la musica è considerata un'offerta alle divinità e ha carattere sacro; è trasmessa per tradizione orale e segue il principio organizzativo della stratificazione polifonica, ovvero il sovrapporre a una melodia di riferimento comune variazioni improvvisate della stessa melodia da parte degli altri strumentisti. La scala musicale utilizza i 7 suoni della scala diatonale; il ritmo è sempre binario e l'accento principale cade sull'ultima pulsazione di ogni unità ritmica. Le orchestre possono essere di tre tipi: "pinpeat", "mohori" e "phleng khmer". L'orchestra pinpeat è la principale e presenta xilofoni e carillon di gong di registro grave e acuto, oboe ("sralai"), flauto ("khloi"), tamburo a due membrane ("samphor") e cimbali a mano; è usata per accompagnare cerimonie o opere teatrali e danzate. La mohori, usata soprattutto per l'intrattenimento, presenta rispetto al pinpeat l'aggiunta di cordofoni. La phleng khmer è invece l'orchestra di tipo più arcaico e tradizionale. Le composizioni si suddividono in varie sequenze ("choan") che vengono di volta in volta rielaborate e sviluppate musicalmente.
Pertanto, la musica tradizionale cambogiana del periodo, è forse da considerarsi la branca artistica che ha resistito di più agli stravolgimenti delle guerre e per questa stessa ragione sono poi state istituite alcune istituzioni per salvaguardare e valorizzare il patrimonio musicale della nazione. L’importanza di questo patrimonio culturale è rintracciabile nelle molte festività nazionali che vengono celebrate durante l’anno. A cominciare dalle due feste di capodanno, una il 1º gennaio ed è il capodanno internazionale, l'altro è il Songkran, ovvero il capodanno solare, che si festeggia il 14 15 e 16 aprile, ed è una delle maggiori feste dell'anno durante la quale gli Khmer puliscono e decorano la propria casa, fanno offerte e giocano a giochi tradizionali.
Fra le festività tradizionali principali vi sono anche molte festività tipiche del paese: Il "Bonn Dak Ben" e il "Bonn Pchoum Ben" sono due parti della stessa festività che si festeggia in agosto/settembre; la prima consiste nella commemorazione degli spiriti dei morti, l'altra, attuata 15 giorni dopo, consiste nel portare offerte ai templi. Il "Bonn Kathen" è un'altra festività religiosa, festeggiata in ottobre, lunga 29 giorni e consiste in un festival religioso e la popolazione marcia in processione verso i templi e i monaci cambiano da loro la loro vecchia roba con della nuova. Il Water Festival cambogiano, in lingua khmer chiamato "Bon Om Touk" o con altre varianti, è un'annuale e tradizionale festa cambogiana che si svolge durante la luna piena del mese di Kadeuk del calendario buddhista, si festeggia il 7, l'8 e il 9 novembre, ovvero durante la luna piena del calendario buddhista; in questa occasione si festeggia per tutto il paese con festival, esibizioni e gare navali, fuochi d'artificio e baldoria generale; nonché gli sport tradizionali come le arti marziali; tecniche tradizionali del popolo khmer sono il Bokator, da cui deriva la disciplina sportiva Pradal Serey, e il wrestling tradizionale khmer ("Bok Cham Bad" in lingua khmer). L’alimentazione è per lo più composta da riso e pesce, essendo questi gli alimenti principali della popolazione.
Va qui ricordata inoltre, la sopravvivenza della più antica forma di teatro di tutto l’Oriente, il cosiddetto: Nang sbek thom, nella tipica forma cambogiana, ovvero il “Teatro delle Ombre”, ripreso in seguito dal teatro colto, cioè con veri attori presenti sulla scena. Consistente in origine in una rappresentazione coreografica svolta all’aperto di fronte a uno schermo bianco (ricavato da un telo di cotone sottile) rischiarato dalle fiamme di un braciere, davanti al quale, venivano mossi (o anche agitati a seconda della situazione), grandi pannelli di cuoio traforati che i danzatori animavano dinanzi lo sguardo attonito dei presenti. Il chiarore del fuoco faceva sì che gli dèi e gli eroi leggendari delle storie narrate fossero solo delle ombre che la fantasia popolare rivestiva dei colori e della bellezza che ad essi si addiceva. L’effetto è ancora oggi di grande emotività e la rappresentazione restituisce alla vista ciò che (a noi) può sembrare occluso: il buio della notte, il fuoco del braciere, la musica degli strumenti, il canto, gli incensi bruciati, gli spettatori impressionati con gli sguardi belli, (nonché noi meravigliati da tanta magia), compongono il resto, il tutto trasfuso della sacralità di un rito che si svolge fuori dal tempo, fluttuante nella notte al pari delle stelle.
Prima di ogni singola rappresentazione ha luogo la “cerimonia di sacralizzazione dei cuoi”, detta Sampeah Kru, e dei danzatori che vi prendono parte, nel corso della quale, il capo-compagnia (o coreografo), recita le formule che permettono agli spiriti degli eroi di entrare nei corpi dei danzatori (che agitano i cuoi) e renderli vivi per il tempo della rappresentazione. Il canto recitativo dell’introduzione è inframmezzato dagli a-soli di un oboe e di un tamburo, invocanti lo spirito della danza: Moha Eysey, al quale si chiede l’autorizzazione di rappresentare episodi della vita del “Reamker”: il cui nome significa "Gloria di Rama", il poema epico cambogiano in strofe basato sul poema epico indiano “Rāmāyaṇa”, suddiviso in due parti, entrambe incomplete, scritte in versi e solitamente cantato.
L'intero “Reamker” fu scritto nel periodo medio della letteratura khmer (XVI-XIX secolo), ma dalla comparazione tra il linguaggio delle due parti si evince che la prima è molto più antica della seconda. La prima parte è infatti scritta in metri tradizionali quali il Bamnol, il Brahmagiti, il Kagati ed altri, mentre la seconda è scritta in un metro più recente, cioè il Pad baky pram-muoy, e in un linguaggio più prolisso. il “Reamker” è un'allegoria filosofica che esplora gli ideali di giustizia e fedeltà rappresentati dai protagonisti, ovvero il principe Rama e la regina Sita e adatta le idee hindu ai temi buddhisti, mostrando l'equilibrio tra bene e male nel mondo. Mentre nel “Rāmāyaṇa” il principe Rama è un dio che ha il compito di combattere il male sulla terra, il Rama del “Reamker” è presentato come il Buddha stesso ed il personaggio ha una seria importanza religiosa. Gli elementi sovrannaturali e divini nella storia sono costantemente portati in primo piano.
L'influenza del “Rāmāyaṇa” in Cambogia si è iniziata a sentire durante il periodo Angkoriano (IX-XIII secolo d.C.), se non prima, e continua ad essere sentita ancora oggi. Gli scultori khmer conoscevano il già dall'VIII secolo. La storia del poema rappresentata sui bassorilievi di Angkor è diventata in seguito il tema preferito degli affreschi sulle pareti dei templi. Rappresentazioni sceniche del “Reamker” ancora oggi precedono le pratiche religiose dei brahmani in Cambogia, oltre ad essere rappresentate alle cerimonie della corte o della cappella reale. Nonostante la costruzione narrativa del “Reamker” sia basata su quella del “Rāmāyaṇa”, le sue forme di rappresentazione sono espressioni della cultura cambogiana. L'epopea è ben conosciuta tra la popolazione khmer per le rappresentazioni fatte nei teatri di danza khmer (Lkhaon) e nei vari festival cambogiani. Oltre che un riadattamento della favola epica è un pilastro del repertorio del balletto reale Khmer.
Il noto poema “Rāmāyaṇa” (*), dal sanscrito रामायण, lett. il viaggio ayana - di Rama), è un’antica summa di leggende indiane trasferite nella tradizione letteraria (e non solo) di tutto l’Oriente. Insieme al “Mahābhārata” è uno dei più grandi poemi epici della mitologia induista, oltre ad uno dei testi sacri più importanti di questa tradizione religiosa e filosofica. L'epos rāmaico consta di 24.000 śloka (versi), 86.000 in meno rispetto al più complesso “Mahābhārata”, suddivisi in oltre cinquecento sarga (sezione di testo) distribuiti in sette libri (kānda), di cui il primo (Bāla-kānda) e il settimo (Uttara-kānda) sono considerati, a giudizio unanime della critica, delle addizioni posteriori.
In esso si narra la storia di Rama, settimo avatar di Viṣṇu, sovrano ideale e guerriero valoroso, e della sua sposa, Sita. Rama, principe ereditario del regno di Koshala viene privato ingiustamente del diritto al trono ed esiliato dalla capitale Ayodhya. Rama trascorrerà 14 anni in esilio, insieme alla moglie Sita ed al fratello Lakshmana, dapprima nei pressi della collina di Citrakuta, dove si trovava l’eremo di Valmiki e di molti altri saggi, in seguito nella foresta Dandaka, popolata da molti demoni (rakshasa). Lì Sita viene rapita dal crudele re dei demoni, Ravana, che la conduce nell’isola di Lanka. Rama e Lakshmana si alleano con i Vanara, potente popolo di uomini-scimmia, ed insieme ai guerrieri scimmia, tra i quali c’è il valoroso e fedele Hanuman costruiscono un ponte che collega l’estremità meridionale dell’India con Lanka. L’esercito affronta l’armata dei demoni, e Ravana viene ucciso in duello da Rama, che torna vittorioso nella capitale Ayodhya, e viene incoronato re. Rama, per rispettare il dharma, è costretto a ripudiare Sita, a causa del sospetto che abbia ceduto alle molestie di Ravana. Per dare prova della sua purezza, Sita accetta di sottoporsi alla prova del fuoco, ed esce indenne dalle fiamme.
L’insieme degli strumenti che formano l’accompagnamento orchestrale, “pimpeat”, riservato alle danze, un tempo famose, si componeva di alcune centinaia di musicisti che i principi di Angkor offrivano ai bramini e ai re cambogiani, e che servivano da accompagnamento alle migliaia di danzatrici destinate ai rituali dei templi. Di cui la leggenda narrata nel Nang sbek thom vuole che accompagnasse la partenza delle “Scimmie del Rāmāyaṇa” nel combattimento. L’insieme delle percussioni, comprendeva inoltre un tamburo a due membrane detto skor thom, che assumeva così un ruolo preponderante nel ritmare la marcia dei danzatori, producendo un vero e proprio fuoco d’artificio sonoro.
La storia della danza cambogiana si data a circa un migliaio di anni fa: frutto dell'influenza indiana sulle corti reali, che incoraggiarono questa forma artistica. La danza tipica della Cambogia è quella khmer, che conosciamo riprodotta sulle pareti dei templi. Le danzatrici in Cambogia erano mantenute nei ginecei dei templi induisti ed erano equiparate alle Apsaras, ovvero figure minori della mitologia indiana. La danza khmer è caratterizzata da una dettagliata attenzione per il più piccolo movimento della danzatrice: negli spettacoli le ragazze cambiano espressione con lo sguardo o con movimenti del collo, i movimenti non sono plateali, ma minimi e aggraziati, i movimenti delle mani sono delicati e complicati; una danzatrice è scelta soprattutto per l'aspetto fisico, per l'espressività del viso e per la lunghezza delle mani.
Uno speciale modo di cantare fa riferimento alle antiche leggende: Jokata, tramandate oralmente, e solo recentemente trascritte in almeno una delle lingue a noi accessibili, si ravvisa un’attività coreografica e teatrale di grande pregio musicale, in cui il chapey assume importanza fondamentale. Infatti, è uno strumento ideale per l’accompagnamento alle improvvisazioni vocali, grazie alle sue possibilità tecniche e agli effetti che si possono ottenere a seconda di come vengono toccate le corde. Generalmente voce e strumento si alternano in modo che i brevi a-soli musicali permettono al cantante di trovare il tempo per la sua ispirazione, di volta in volta diversa, per ogni esecutore. Essendo i canti spesso improvvisati sulla base di “trame” oralmente apprese e trasmesse da un cantore, Tuk-Mon. I maestri musicisti, i coreografi e gli insegnanti di musica continuano ancora oggi ad insegnare gruppi designati di studenti le rappresentazioni del “Rāmāyaṇa”
Editoria:
Mandakranta Bose; et al., The Ramayana in the Arts of Thailand and Cambodia in The Rāmāyaṇa revisited, Oxford University Press US, 2004.
Judith M. Jacob, Kuoch Haksrea, Judith M. Jacob (a cura di), Reamker (Rāmakerti): the Cambodian version of the Rāmāyaṇa, Routledge, 1986.
(*) Traduzioni italiane di questa importante opera:
“Il Ramayana”, a cura di G. Gorresio, 3 voll., Fratelli Melita, Genova 1988
“Il Ramayana”, a cura di R. K. Narayan, Guanda, Milano 1991 (nell'originale è una riduzione in inglese del capolavoro della letteratura classica)
LAOS
Da secoli il Laos è occupato da Thai migrati da altre zone (tra cui shan, siamesi e lao) e da tribù hmong-mien che vivono sulle montagne praticando l'agricoltura con il sistema 'taglia e brucia'. I primi principati si consolidarono nel XIII secolo dopo l'invasione della Cina sud-occidentale da parte delle armate mongole di Kublai Khan. Nella metà del XIV secolo un comandante militare di nome Fa Ngum, con l'appoggio dei Khmer, unì alcuni principati sparsi nella zona di Luang Prabang e diede vita a un regno proprio, chiamato Lan Xang ('un milione di elefanti'). Inizialmente il nuovo regno prosperò, ma nel XVII secolo, a causa delle divisioni interne e delle pressioni esercitate dai principati vicini, si suddivise in tre regni le cui capitali erano Luang Prabang, Wieng Chan (oggi Vientiane) e Champasak.
Alla fine del XVIII secolo gran parte del Laos era sotto la sovranità siamese (Thai), ma subiva anche pressioni dal Vietnam; non potendo (o non volendo) servire due padroni, negli anni '20 del XIX secolo il paese entrò in guerra con il Siam, ma questa scelta si rivelò disastrosa e i tre regni caddero sotto il controllo Thai. Alla fine del XIX secolo la Francia aveva già dato vita all'Indocina francese nelle province vietnamite di Tonchino e Annam e in seguito i thai cedettero interamente il Laos ai francesi, i quali si accontentarono di utilizzarlo come zona cuscinetto tra i loro possedimenti coloniali e il Siam.
Dei tre stati che costituivano l'Indocina francese, il Laos è il meno sviluppato e il più enigmatico. Dopo il rovinoso avvicendarsi del dominio coloniale, dei conflitti intestini e del socialismo dogmatico, negli anni '70 il paese si ritrovò non solo in ginocchio, ma anche a registrare un calo della sua popolazione, perché emigrata. Ora, dopo quindici anni di isolamento dal mondo esterno, questa nazione senza sbocchi sul mare e scarsamente popolata si sta finalmente godendo la pace, stabilizzando le proprie strutture politiche ed economiche e cominciando ad aprire le frontiere ai turisti stranieri.
L'assenza di influenze esterne offre al visitatore l'impareggiabile occasione di entrare in contatto con uno stile di vita tradizionale che è rimasto pressoché inalterato nel tempo. Dalle fertili pianure della valle del Mekong agli aspri rilievi dell'Annam, le persone che hanno visitato il Laos concordano nel dire che questo paese è la perla del sud-est asiatico. La popolazione, prevalentemente i Lao bassi e alcune tribù Thai, pratica il Buddhismo Theravada. È previsto che tutti i laotiani buddhisti di sesso maschile siano monaci per una breve parte della loro vita, di solito nel periodo compreso tra la fine della carriera scolastica e l'inizio del lavoro o il matrimonio. La principale 'religione' non buddhista è il phii, un culto degli spiriti che ufficialmente è vietato. Le tribù hmong-mien praticano l'animismo e il culto degli antenati; solo una piccola minoranza di laotiani, composta principalmente dall'élite che studia nelle scuole francesi, è di fede cristiana.
La lingua ufficiale del Laos è il lao nella forma parlata e scritta a Vientiane. In quanto idioma ufficiale esso è diventato con successo una lingua franca usata per i rapporti tra le varie etnie lao e non lao del paese. Ci sono cinque dialetti principali, ciascuno dei quali può essere suddiviso in diverse varianti locali. Tutti i dialetti lao sono strettamente imparentati con le lingue parlate in Thailandia, nel Myanmar settentrionale e in alcune zone della provincia cinese dello Yunnan. La cultura tradizionale laotiana è stata fortemente influenzata da varie correnti culturali khmer, vietnamite e thailandesi. I lao bassi hanno gli stessi antenati di molte tribù Thai, quindi le somiglianze tra la cultura laotiana e quella thailandese sono particolarmente forti, come risulta evidente nella scultura, nella musica classica, nei drammi danzati e nelle arti della lavorazione dell'oro e dell'argento. Le arti tradizionali nel Laos sono in genere, l’intaglio del legno e la tessitura, per lo più finalizzate alla realizzazione di opere di carattere religioso, quali la costruzione muraria e scultorea dei Wat (templi), degli Stupa (tombe) e le rappresentazioni del Buddha, qui raffigurato in stile tipicamente laotiano.
L’antica Wieng Chan, oggi Vientiane è la capitale e sede del governo, situata in un'ansa del Mekong in mezzo a fertili pianure alluvionali. A dispetto del suo turbolento passato, è una città tranquilla con alcuni bei wat e qualche vivace mercato. Il Pha That Luang (Grande Stupa Sacro), simbolo tanto del buddhismo quanto della sovranità del Laos, è il monumento nazionale più importante del paese. Altri luoghi interessanti sono il Wat Pha Kaew, che in passato era un tempio reale e ora ospita un museo; il Wat Si Saket, il tempio più antico e, infine, il Wat Xieng Khuan, con un gruppo di interessanti sculture buddhiste e hindu situato in un prato che si trova a circa 24 km a sud. Vientiane ha una decina di alberghi di categoria elevata e altrettante pensioni, molte con prezzi medi, ma da qualche anno è aumentata considerevolmente la disponibilità di camere economiche.
La maggior parte degli alberghi si trova in centro che, non è più, quel centro dei divertimenti illeciti che era all'inizio degli anni '70: ora i bordelli sono vietati, le bancarelle di marijuana sono scomparse dai mercati e la birra, attuale 'svago' notturno, ha sostituito l'oppio. Per i pasti, se si vuole gustare una buona cucina laotiana è da provare il mercato notturno di Dong Palan sulla sponda orientale dei laghetti Nong Chan. I divertimenti vanno dalla musica dal vivo e dalle discoteche (di solito con pop occidentale o musica tradizionale laotiana in versione elettrificata) ai film thailandesi, cinesi, indiani e persino bulgari. Per quanto riguarda lo shopping gli articoli migliori sono gli oggetti di produzione tribale, le stoffe, i gioielli e i mobili.
Altra città importante è Luang Prabang, che si sta appena risvegliando dal lungo sonno causato da decenni di guerra e rivoluzione. Le principali attrattive di Luang Prabang sono i suoi templi antichi (dei 66 costruiti prima della colonizzazione francese ne sono sopravvissuti 32) e la sua suggestiva posizione, incorniciata dalle montagne e situata presso la confluenza dei fiumi Khan e Mekong. Tra i monumenti da visitare vi sono il Museo del Palazzo Reale, il Wat Xieng Thong e il Wat Wisunalat. A soli 25 km di distanza lungo il Mekong ci sono le famose grotte di Pak Ou, alcune delle quali sono abitate da statue del Buddha di ogni misura e stile, mentre a una trentina di km circa a sud della città c'è la grande cascata a più balzi di Kuang Si.
La cultura, di tradizione, si rifà a quella già trattata della Thailandia di cui un tempo era considerata regione limitrofa, presenta una particolare predilezione per il canto. Si conoscono infatti numerose canzoni laotiane dedicate alla “corte d’amore”. Si chiama così il periodo il periodo in cui i giovani uomini cantano alle ragazze in fiore sotto la luna di primavera. Un rito quello dell’arrivo della bella stagione che si festeggia da sempre da tutti i popoli, e che anche noi non disconosciamo. Con la primavera, si sa, la natura rinasce alla vita e con essa si risvegliano i giovani spiriti, giungono lieti i doni di fiori segno di amicizia fra il popolo laotiano. Uniamoci dunque al coro in questa bellissima canzone della regione Luang Prabang, cantata alla “corte dell’amore”; così si chiama il periodo in cui i giovani uomini cantano il loro amore alle ragazze in fiore sotto la luna di primavera:
“ … a primavera / la natura rinasce alla vita / si risvegliano i giovani cuori / ognuno pensa all’amore / quale dono mi porterà?”.
E un dono è pur sempre un segno di amicizia fra il popolo laotiano; insieme segno di accoglienza e di prosperità.
Riguardo alla musica tradizionale laotiana si può affermare che è sovente d’accompagnamento alla danza o alle rappresentazioni teatrali, nelle quali viene utilizzato un linguaggio molto colloquiale, a volte licenzioso e scurrile. Tale musica dà carattere a tutte le festività religiose e stagionali, a tutte le cerimonie destinate ad allontanare le sventure, a placare gli spiriti maligni o a ringraziare le divinità tutelari. La musica di questo genere, imperniata a uno scopo pratico ed attinenti alle necessità quotidiane dell’uomo, è anonima ed è trasmessa oralmente, mentre ogni esecutore è libero di darle un’impronta personale. In questo la musica tradizionale assolve una speciale insostituibile funzione ed è per solito vocale, anche se a volte il canto viene accompagnato da semplici strumenti che provvedono all’armonia e al ritmo. Uno strumento tipico è il khen o sheng, lo strumento a fiato fatto di canne, cui si è già dato cenno, qui esistente anche nella versione di tipo gigante, lungo fino a due metri e mezzo, che si suona alternativamente soffiando e aspirando, allo stesso modo in cui nel rituale (vedico) del sacrificio, l’espirazione e l’inspirazione sono riferiti ai fuochi iniziatici:
“… poiché all’inizio i fuochi sono questi soffi: l’ahavaniya e il garhapatya, l’espirazione e l’inspirazione. Origine di tale ardua trasposizione fu un episodio della guerra fra i Deva e gli Asura. Allora i Deva non erano ancora dèi – e perciò erano mortali, come anche gli Asura. Fra le due schiere nemiche c’era un solo essere immortale, a cui tutti ricorrevano: Agni. Così i Deva pensarono di infonderlo in se stessi. Si lasciarono invadere da quell’essere immortale – e così ebbero il sopravvento sugli Asura. Da quella volta, parlare den dentro e del fuori, di ciò che accade visibilmente nel mondo e di ciò che accade invisibilmente in ciascun essere, diventò molto più agevole (..). Dacché, poggia tutta la dottrina dello yoga e s'introduce "la suprema funzione del respiro (da qui discendono le innumerevoli riflessioni sui soffi) e si giustifica, come mai il mondo (..), abbia bisogno di un soffio per filtrarsi, per animarsi, per rendersi usabile in un atto cerimoniale" (1)
Questo a dimostrazione del fatto che la ricerca, sia essa musicologica o anche soltanto filologica porta spesso a scoprire, anzi, direi a trovare, segni evidenti di collegamento, non solo tra discipline diverse bensì tra culture diverse. Non è un caso che la più antica cultura musicale dell’Asia, dal Champa, alla Cambogia, alla Thailandia e il Laos usa essenzialmente strumenti in forme polifoniche, in cui si sovrappongono più suoni, la cui origine è difficile localizzare geograficamente, ma che corrispondono a principi comuni a vaste regioni e fondamentalmente distinti da quelli di altre zone, anche se talvolta limitrofe. E con ciò, stesse forme poetico – liriche e letterarie che assumono forme diverse e utilizzi diversi all’interno delle diverse culture. Accanto a queste forme, che non siano quelle riservate al culto o ai diversi culti religiosi, rimaste per lo più quelle di un tempo, si è sviluppata una musica “dotta” che ha seguitato a convivere con la musica popolare. È possibile dire che la musica di questo tipo, trae le proprie origini dalla musica popolare, ma si distingue da quella per l’alto livello artistico e per la specifica funzione raggiunta.
È così che anche nel Laos si sono sviluppate forme musicali libere da una dichiarata funzione sociale, le quali, proprio perché svincolate da presupposti rituali, hanno progredito rapidamente sulla via del perfezionamento tecnico e del raffinamento del gusto, tuttavia, le due forme musicali hanno stabilito pochi contatti tra loro e raramente si è verificata una reciproca influenza. Caratteristiche, queste, che la rendono ben diversa dalla musica dei professionisti e dei musicofili, i quali fanno uso di strumenti più complessi, di tecniche vocali e strumentali più elaborate, di scale più varie, e di repertori più ricchi.
VIET NAM
Dei 54 gruppi etnici riconosciuti, una quarantina di gruppi minori sono collettivamente noti come degar o, in francese, montagnard, perché abitano sugli altipiani. La tradizionale denominazione in lingua vietnamita fa riferimento alla loro natura barbara e ostile (ai Kinh). I Thai di etnia thailandese e vivono nella parte centrale e nord del paese, vivono nelle zone di transizione fra pianura e collina del nord del paese. La loro lingua fa parte del sottogruppo centrale delle lingue tai ed è molto simile alla lingua zhuang della Cina meridionale. Gli Zhuang sono la principale minoranza etnica cinese, concentrata nello Guangxi e, in parte, nello Yunnan, province entrambi confinanti con il Vietnam. I Mường sono un gruppo etnico autoctono, i più affini alla maggioranza Kinh (o Viet: i vietnamiti in senso stretto) dal punto di vista culturale e linguistico; vivono nelle zone collinari e montagnose del nord.
I Khmer Krom sono di etnia Khmer o cambogiana e vivono nel delta del Mekong e a sud di esso, in territori per lungo tempo parte dell'Impero Khmer. Gli Hoa sono di origine cinese (Han), in prevalenza del Guangdong, parlano la lingua cantonese o la lingua teochew e vivono nelle aree urbane in tutto il paese. I Nùng sono un'etnia imparentata linguisticamente con i Thai e gli Zhuang. Gli H'Mông, già noti come Meo, corrispondono ai Miao della Cina, dove sono concentrati nel Guizhou, e anche nell'Hunan e nello Yunnan. Meo e Miao sono considerati termini offensivi dagli Hmong. I Dao o Yao sono un'etnia imparentata linguisticamente con gli H'Mông.
La maggioranza della popolazione vietnamita è di religione buddista, conseguentemente all'influenza cinese. Alla tradizionale religione del buddismo Mahayana si sono aggiunti i culti più recenti di Cao Đài e Hòa Hảo. Vengono praticati anche il Confucianesimo, il Taoismo e le relative religioni cinesi. In Vietnam sono presenti numerosi parchi nazionali, tra cui il Parco nazionale di Con Dao. Il Parco nazionale di Phong Nha-Ke Bang è stato designato come patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO, insieme alla Baia di Ha Long, il Santuario di Mỹ Sơn, al Complesso dei monumenti di Hué e all'Antica città di Hoi An. Sono anche presenti sei riserve della biosfera: la Foresta di Mangrovie di Can Gio, il Parco nazionale di Cat Tien, il Parco nazionale di Cat Ba, il Parco nazionale di U Minh Thuong, il Delta del Fiume Rosso, il Nghe An Occidentale.
Tale commistione di etnie presenti sul territorio rende il Vietnam un “campo di ricerca” straordinario per l’etnologo e il ricercatore musicale che desideri conoscere e armonizzare gli “opposti” delle diverse culture qui messe a confronto. Scrive Tran Van Khe (2):
“In genere i contatti tra paesi che hanno una comune base culturale sono molto fruttuosi. Essi nascono spontaneamente da un lodevole desiderio di progresso che spinge a cercare diverse esperienze, a tentare mezzi espressivi non recepiti dai propri maestri e predecessori e a dare alla propria musica un’impronta personale. Si sa che i popoli troppo chiusi nella cultura autoctona evolvono molto lentamente, mentre, ogni occasione di contatto con i paesi vicini causa sensibili mutamenti, anche a causa dell’incontro avvenuto nel corso dei due ultimi secoli, tra le antiche civiltà rurali dell’Asia con la civiltà industriale dell’occidente, che è stato traumatizzante. La “nuova musica” che appare un po’ ovunque in Indocina, spesso è il risultato di una acculturazione, cioè dell’adozione di una cultura estranea: un tale processo è nocivo quanto la scomparsa degli antichi generi musicali”.
È del tutto normale che ciò accada, da sempre i popoli colonizzati hanno cercato di imitare i dominatori, persuasi che la superiorità tecnologica si riflettesse necessariamente in una superiorità del senso estetico e musicale. Si è così finito per confondere il progresso con l’occidentalizzazione. Non in ultimo, lo sviluppo delle comunicazioni ha reso i viaggi più facili anche per i musicisti orientali, i quali sono rimasti affascinati dalle orchestre sinfoniche occidentali e hanno preso a scrivere partiture musicali per gli strumenti tradizionali, finendo per far nascere forme musicali ibride. L’ibridismo è, in tali casi, deteriore, perché tenta di applicare gli strumenti e lo stile di una tradizione ad un’altra assolutamente incompatibile. Ciò non toglie che, in alcuni sporadici casi si è tratto da una cultura affine elementi che funzionano da catalizzatori che hanno arricchito la tradizione del paese d’origine. L’ingegnosità di certi strumentisti inoltre, ha permesso che alcuni strumenti tradizionali o addirittura arcaici facessero il loro ingresso nelle orchestre “tradizionali” di un paese. È il caso di alcuni strumenti tipici dell’India, entrati nella tradizione del Vietnam: gong, xilofoni, ciotole che riempite d’acqua a differenti livelli vengono battute sull’orlo per trarne suoni di varia altezza, sono tutti strumenti che producono suoni con una vibrazione naturale, tra cui, degno di nota, è il Khong-vong (Thailandia), entrato nelle formazioni musicali del Vietnam, formato da 17 gong posti su un supporto circolare di bambù che li fa vibrare meglio.
Un altro esempio è dato da un tipo particolare di conchiglia (a tromba), conosciuta quasi ovunque in Asia, utilizzata unicamente per accompagnare cerimonie e cortei, che in Vietnam è destinata ad essere suonata anche al di fuori per il richiamo al lavoro quotidiano. Esiste in Vietnam un repertorio di canti a voci alternate frutto di improvvisazione poetica eseguito da giovani ragazzi e ragazze che per l’occasione osservano l’uso di “legarsi in amicizia”. Per l’occasione viene intonato il “Coi giau”, (il piatto del betel), considerato un canto di benvenuto col quale le ragazze invitano i ragazzi a prendere il betel, simbolo dell’amicizia e anche dell’amore coniugale. Ma è un altro canto appartenente alla tradizione del Ca-Tru (letteralmente canto “a tavolette”), tipico del Vietnam del Nord, e forse molto antico, dal titolo “Raccogliendo i fiori”, opera di un famoso autore, Phan Duy conosciuto in tutta l’Indocina, che possiamo assaporare quanto il sentimento dell’amicizia sia davvero sentito in tutto il paese:
“Amico, devi cogliere i fiori con attenzione / taglia solo quelli che sono appassiti / non lasciarli morire sullo stelo. / Ti Ring … / Il vento soffia lontano / e i fiori sono in boccio / amo il loro profumo / non coglierli. / Quando il vento soffia, i fiori sorridono / le belle farfalle giocano con essi e li accarezzano / i fiori che mostrano affezione, saranno ben presto vecchi. / La farfalla gioca e il fiore soffre / i bambini giocano coi fiori, li colgono senza rimpianto / i fiori innocenti cercano amore: / Non fare che il loro giardino incantato resti vuoto”.
La tradizione vuole che questo canto non fosse accompagnato da alcuno strumento musicale ma, durante gli ultimi anni, gli strumenti tradizionali accompagnano i giovani cantanti. Ovviamente dieci secoli di dominazione cinese (dal 111 a.C. al 939 d.C.), hanno lasciato un’impronta profonda nella cultura e nella musica di questo paese. Strumenti musicali come la viella a due corde, la cetra a sedici corde, il liuto a forma di luna, il violino a due corde, il flauto traverso di bambù, il monocordo, nonché cimbali, risuonatori di pietra, campane, grandi e piccoli tamburi, sono decisamente di origine cinese, per lo più utilizzati nella musica “colta”, che presenta nozioni codificate di ritmo e di ornamento, destinata ad essere eseguita esclusivamente per l’ascolto. I nomi degli strumenti vengono scritti in caratteri cinesi, ma la formula cambia a seconda che siano pronunciati in lingua da un cinese o da un vietnamita.
Va qui ricordato che la prima teoria musicale di questa musica fu redatta in Vietnam, sotto la dinastia LE (1428-1788), sullo stile di quella cinese d’epoca Ming, (teoria fondata su cinque gradi, sette toni e dodici Yju, o toni fondamentali), e suddivisa a sua volta in otto tipi di musica di corte. Interessante (e forse curioso) è leggere i caratteri che la compongono:
“Musica della volta celeste” / “Musica dei templi” / “Musica dei cinque sacrifici” / “Musica per aiutare la luna e il sole in caso di eclissi” / “Musica per le grandi udienze” / “Musica per le udienze ordinarie” / “Musica per i banchetti” / “Musica di palazzo”.
Non è una meraviglia di ipotesi su cui far lavorare la fantasia? Ma c’è di più. Oltre alla musica eseguita per l’imperatore, anche le danze di corte hanno una loro suddivisione altrettanto affascinante:
“Danza militare (vo-vu)” / “Danza civile (van-vu)” / “Danza dei rami fioriti (hoa dang vu)” / “Danza della fenice (phung vu)” / “Danza del liocorno (ma vu)” / “Danza dei quattro favolosi animali (tu linh vu)” / “Danza degli otto barbari che presentano i loro doni (bàt mantaw cong vu)”.
Semplicemente strepitose non è vero?, se pensate che solitamente sono accompagnate da una ensemble (nhac) composta di flauto, tamburi a doppia membrana, corno di bufalo, cimbali e sonagli.
In chiusura di questo lungo excursus nella musica dell’Oriente, non voglio essere fatalista e preferisco pensare che la musica tradizionale di questi paesi non stia morendo, ma sia solamente passata nel dimenticatoio, e se si adottano immediatamente le misure del caso, la si possa salvare. Tran Van Khe, (sempre che sia ancora in vita), fa un appello che, allo stesso tempo, è un invito: “ad aiutare a salvare il salvabile” che vorrei qui accoglieste con sentimento estremo di solidarietà e possibilmente con partecipazione.
È di questi giorni anche l’appello de La Recherche alla sottoscrizione per la “liberazione” del Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, e per tutto il popolo del Myammar (ex Birmania). Sono fermamente convinto che ognuno di noi, nelle sue possibilità, possa fare qualcosa, anche semplicemente sottoscrivere questo appello. Io, nel mio piccolo, ho cercato di sollevare l’attenzione sulla cultura di questi popoli così violentemente provati dalle guerre e dalle afflizioni, sulla loro cultura e sulla loro musica, affinché anche attraverso la gioia del canto, della danza, dei resti dei monumenti antichi, si possa dare una mano a risollevare quella cultura che è patrimonio di tutti noi.
Note:
1)Roberto Calasso “L’Ardore” – Adelphi Edizioni - Milano 2010.
2)Tran Van Khe “Musica addio” articolo, Il Corriere Unesco, anno XI e “Musique et Societé” – Rivista Internazionale “Cultures” – Unesco.
Discografia:
Centro Studi di Musica Orientale presso l’Istituto di Musicologia dell’Università di Parigi.
Consiglio Internazionale della Musica Fondazioni Cini – Venezia, diretto da Alain Danielou.
“Melody of Thai” - Siam Gramophone Slp 1001
“Laos” – Emi-Odeon 064/18080
“Ngun Bargeman” – History of Music – La Voce del Padrone HLP1
“Viet Nam” – Albatros – VPA 8396
“Viet Nam” – Baden Reiter BM 30 – L 2022
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusicologia 5: Thailandia
“THAILANDIA: splendori di una tradizione secolare”, di Giorgio Mancinelli
(Da “Folkoncerto”, trasmissione radiofonica in onda su RAI-Radio3, e “Itinerari Folkloristici”, reportage trasmesso dalla RSI – Radio della Svizzera Italiana, apparso inoltre in forma di articoli sulle riviste: Super Sound, Nuova Scienza, Il corriere della musica).
Bangkok si apre davanti ai nostri occhi in modo autentico e originale di moderna capitale di uno stato assai grande e grandioso di storia, contrassegnata da un’evoluzione dinamica e rivoluzionaria dei canoni tradizionali, con numerosi alberghi e un turismo cosmopolita che non ha tardato a condursi dentro le linee irrefrenabili della industrializzazione tecnologica. Tuttavia, sembra resistere ancora bene alle influenze distruttive tipiche di una occidentalizzazione fin troppo pressante, e della globalizzazione invadente, con l’aver conservato le sue tradizioni plurisecolari e un artigianato tutt’ora fiorente. La vita giornaliera ha inizio prima del levarsi del sole, ciò che avviene sfruttando quelle ore ancora più fresche che consentono di spostarsi senza troppa difficoltà attraverso le vie d’acqua, tra mille giunche colme di masserizie e derrate di riso e ortaggi, frutti tropicali, carni essiccate, e pesci appena pescati. È questa l’atmosfera un po’ rarefatta del floating market, il mercato galleggiante, meta dello shopping quotidiano per tutto ciò che concerne il sostentamento energetico. Un fluttuare di voci e di suoni armoniosi che ben presto si trasformano in autentico richiamo, benevolo e delizioso, colmo di sorrisi e di sguardi suadenti di una popolazione multietnica che fa della cortesia e dell’accoglienza, un vero baluardo di concretezza.
Lungo le vie d’acqua si scorgono appena, nascosti dall’alta vegetazione, i tetti di legno ricurvi delle abitazioni tipiche. S’odono ricorrersi nell’aria e risuonare allegre, mille campanelle a vento appese, e il diffondersi dell’odore inconfondibile del sandalo dagli stecchi accesi davanti alle divinità e i piccoli tabernacoli accanto alle case, nei giardini e sull’acqua. Quando ècco, altissimo sulla riva del fiume Chao Phraya, nel dominio assoluto del cielo, svettano le guglie del Wat Arun, il “tempio della prima alba”, tempestate di vetri multicolori e ceramiche a smalto che si accendono al levarsi maestoso del sole. La visita continua nel tempio, ammessi alla presenza del Buddha dal sorriso metafisico che perennemente invita alla meditazione. quello stesso identico sorriso che si scorge sul volto delle numerose persone che lì accendono profumi e incensi e che fanno offerte di piccole lamine d’oro e monete ai bonzi calvi, nei loro panni color zafferano.
La scelta della visita guidata alla Città Reale permette d’immergerci nella realtà favolistica delle costruzioni, tra guglie e pinnacoli, pareti di piccole colonne e rientranze, che ci si perderebbe se non fosse per gli enormi yakshah dalle teste demoniache, i guerrieri di pietra messi a guardia delle entrate dei templi, per spaventare gli spiriti maligni. Qui, e per la maggior parte, ogni elemento è rivestito di una patina d’oro, con lapislazzuli e pietre colorate, come per una rappresentazione dell’inimmaginabile che abbaglia, tanto splendente risulta alla luce di una venerazione che ha del sacro. Finanche le nuvole che s’accumulano uggiose e oscurano il cielo sono qui le benvenute, quasi fossero portatrici d’una speranza riposta, il cui dono, assai ambito, è accolto col fervore di una manna. Lo scroscio d’acqua di un monsone di breve durata, infatti, riporta il sorriso sulle facce della gente che si ferma, quasi a ubriacarsi del generoso effluvio di un nettare che la restituisce alla vita.
Immersi fino alle ginocchia nell’acqua piovana che ristagna nelle strade e scola dai tetti delle case, la vita riprende infine a sorridere. Attivi come e più di prima, grondanti d’acqua, i giovani fanno festa al sole che ha fatto capolino, e già le grida e le voci sonanti accolgono la processione dei bonzi che al suono di gong e cimbali s’avvia lungo la strada, accolta dalla popolazione con piccoli doni di fiori, di umili preghiere e di cibo. Un suonatore ambulante con uno strumento a forma di piccola viola e un manico e due corde e suonato con una sorta di archetto, improvvisa una musica arcana che prende per la sua tenue “leggiadria”. Il canto – mi dice la guida che mi accompagna – è tipico delle regioni montane del Nord, nel linguaggio dialettale più antico (forse una lingua), in cui sono enunciati i relativi dèi delle festività annuali, qui usato in forma di benvenuto e d’amicizia, affinché gli dèi siano propizi nell’accoglierci.
Per il ristoro, prima di riprendere il viaggio, ci si affida alle golosità di un tipico ristorante Thai, le cui inservienti ci accolgono col rispettoso saluto “Sawasdee!” e le mani congiunte sul petto, facendoci dono di una graziosa orchidea, simbolo della loro benevolenza. Il pranzo si compone essenzialmente di riso, alternato a delicate zuppe di pesce, o come per la cucina cinese, insieme con contorni di carne di piccoli uccelli, di anatra selvatica, di maiale cucinato in una infinità di modi; oppure con crostacei e arrosti conditi da una vasta gamma di salse piccanti o in agrodolce, preparate a base di erbe aromatiche e ortaggi. Non c’è che dire, è qui possibile soddisfare anche il palato più ricercato. A completamento del pranzo si possono gustare frutti deliziosi di produzione locale come arance giganti, ananas succulenti, mango e papaya da gustarsi con una schizzata di limes.
Per i curiosi della cucina esotica c’è da sbizzarrirsi nella ricerca di ristoranti diversi cantonesi e vietnamiti, e altrettanti occidentali di buon livello. Non mancano piccoli mercati rionali dove trovare venditori ambulanti di zuppe e contorni tipici della cucina contadina e popolare a base di piccoli crostacei e verdure che, anche se non proprio affidabili per la pulizia (almeno ai nostri occhi) sono però davvero molto buoni. E venditori di ben sei diversi tipi di banane gustosissime la cui vera specialità è in quella fritta. Provare per credere, se non altro sono cibi autentici e tutti cucinati al vapore in modo tradizionale, a dirlo sono i numerosi accoliti che fanno la fila per accaparrarsi la loro porzione giornaliera.
La sera ci attende con i suoi richiami luminosi, dei numerosi bar e pub ma anche dei saloni di massaggio e locali notturni, molto fiorenti nella cosmopolita Bangkok. Il traffico, soprattutto quello pedonale, si svolge maggiormente su due strade principali: Patpong e Patchburi, ma non bisogna lasciarsi troppo prendere dalle occasioni. I divertimenti leciti o illeciti che la città offre sono sì una caratteristica locale ma, come in tutte le altre metropoli crocevia internazionale, si può incorrere facilmente in sorprese non proprio auspicabili. È però forse il “massaggio tailandese” ad offrire la prospettiva più attraente ed eclatante. Praticato da giovani e attraenti fanciulle debitamente selezionate alle quali si può chiedere una prestazione maggiorata che, intendiamoci bene, la si ritrova poi aggiunta sul conto da pagare.
Per i più tranquilli c’è sempre e comunque il richiamo della cultura. Allora anche la cena può trasformarsi in un intrattenimento con danze tipiche e l’ascolto di ottima musica classica suonata da gruppi di strumenti Thai. Oppure di assistere ad altre forme di spettacolo come quelle dei burattini o del teatro Khon, una forma di dramma secolare danzato e accompagnato da musica vocale e strumentale, la cui durata ahimè varia da una a tre ore, dove è però visibile tutta l’arte che in esso si raccoglie: dai costumi finemente lavorati, alle stupende maschere semplicemente “meravigliose” dei protagonisti, agli stupendi trucchi cosmetici che rendono così espressivi i volti delle danzatrici e danzatori che calcano la scena.
Per chi è più interessato all’arte orientale, l’itinerario è alquanto impegnativo, poiché esistono più di 300 monasteri buddhisti nella sola Bangkok e la provincia che la circonda. Tutti da visitare in quanto contengono reperti importanti non solo per la religione di stato ma anche per l’intrinseco valore d’arte. Tuttavia i più importanti da visitare sono in ordine: il Wat Phra Keo, all’interno della cinta del palazzo Reale contenente il più famoso Buddha di Smeraldo. Il Wat Banchama Bophit costruito in marmo bianco di Carrara, in cui è maggiormente messo in risalto lo stile Thai della costruzione, e il Wat Po annesso al Monastero del Buddha giacente , contenente la più vasta collezione di immagine del Buddha, iscrizioni e bassorilievi con scene della vita del “Ramayana”. Il Wat Traimit incluso nel Monastero del Buddha d’Oro la cui costruzione risale al 1238 in cui è possibile ammirare una della più antiche immagini di Buddha ricoperta d’oro e, non in ultimo, il Wat Sraket, detto il tempio della Montagna d’Oro che si vuole sia stato costruito sui resti della casa del Buddha.
Il Museo Nazionale di Bangkok è indubbiamente il più grande di tutto il Sud-Est asiatico e raccoglie oggetti significativi dell’arte di tutto il Sud-Est asiatico, a partire dal V secolo a oggi, con esempi straordinari di sculture in pietra e bonzo, e manufatti di porcellana e legno dell’antico regno del Siam, Kmer e Birmana, del Laos e della Cambogia. Assolutamente da non mancare è The House on the Klong, nel villaggio Pak Hai, fatta costruire nel 1800 dall’inglese James H. W. Thompson (1). Un magnifico esempio di casa Thai nel suo stile più tipico, immersa nella vegetazione del parco a ridosso del fiume Klong. In essa si conserva una stupenda collezione d’arte e pezzi d’antiquariato, forniture e arredamenti di manifattura Thai e Kmer a partire dal sec. VI al XVIII:
“L’intera casa è costruita in sezioni pre-fabbricate appese sulla sovrastruttura senza connessioni di sorta o chiodi; le colonne che la sostengono e l’inclinazione del tetto, di conseguenza, è inclinato verso il centro. Lo scopo pratico di questo sistema è incerto, ma esteticamente aggiunge all'illusione di altezza ed eleganza che forse sono la caratteristica più memorabile di architettura tailandese tradizionale”. Una visita questa, che non deluderà il più sofisticato amatore di cose d’arte per il suo gusto raffinato e il profano in cerca di forti sensazioni.
Intanto è giunto il tempo di riprendere il nostro viaggio verso il cuore della Thailandia in direzione del Bang Pa In, sulla strada per Ayuthia, l’antica e gloriosa capitale del Siam, più conosciuta come la “Città del Paradiso”. Risalendo il Chao Phya Menam, ovvero la Grande Madre Fiume, a bordo della Oriental Queen un panfilo da crociera di 45 metri, attraverso l’estesa pianura coltivata a cotone e le ampie risaie fino a Bang Pa In, si arriva alla residenza estiva dell’imperatore, accolti in uno scenario mozzafiato, dove la natura, ricondotta nelle figure di una geometria essenziale, suggerisce all’emozione l’armonia del Yi (cinese): il raffinato estetismo del pensiero suscitato dalla contemplazione della perfezione.
E' altresì meraviglioso ammirare architetture finemente decorate in una mescolanza di stili nelle forme originali di pagode e padiglioni estivi finemente studiati con meticolosa cura, che “compongono il sublime giardino della vita”, tali, da non suscitare alcun dubbio sulla loro dislocazione armoniosa con la natura circostante, dove infine: “la bellezza penetra l’occhio a poco a poco” e s’incanta. Il culmine di questa raffinatezza è rappresentato dal Sawan Thi Paya, il padiglione a giorno posto al centro di un piccolo lago, in cui l’imperatore era in uso isolarsi in meditazione, e in cui, in verità, si è sopraffatti dal desiderio di pace e di raccoglimento come in nessun altro luogo: come mondi vorticanti nella spazialità dell’anima di cui il mondo è prigioniero; quasi che l’enigma costante dell’essere materializzi infine ciò che è l’irreale: come contemplare il proprio volto riflesso nell’acqua.
Qui, la musica degli strumenti è lontana, se non per il tintinnio delle campanelle appese negli altri edifici, e che al massimo raccolgono il vento che scende dalle montagne che si stagliano distanti, a rappresentare “tutte le montagne del mondo in una sola pietra”:
"... qui Udorn veniva con i propri musici per fare serenate per lei, abbigliata nelle sete più belle del mondo. I menestrelli cantavano le poesie d'amore che Lui stesso aveva composto e le melodie dei compositori di Ayuthia, famosa per la sua musica. E faceva venire danzatori nel nostro giardino per rallegrarla. La sua voce s'innalzava pura e dolce; e gli inni assumevano una forza nuova".
Attraversata una vasta pianura, raggiungiamo in pullman la zona archeologica di Ayuthia, le cui imponenti rovine, semicoperte da una imperiosa vegetazione, offrono una visione davvero suggestiva. Gli scavi, tutt’ora in corso, continuano a riportare alla luce gran parte degli edifici e dei monumenti che in passato la fecero grande e contribuirono a renderla leggendaria fino ad attribuirle l’epiteto di Città del Paradiso: una città splendida e vivace sotto il sole, con le sue trecentosessanta cupole d'oro slanciate verso il cielo, “un bagliore d’oro nelle menti di coloro che la videro nella sua gloria”. Capitale di un regno antichissimo e culla della cultura buddhista almeno per gli ultimi cinquecento anni della sua storia, Ayuthia fu più volte conquistata e distrutta dai Birmani che s’impossessarono dei tesori in essa contenuti e spogliarono i suoi numerosi Wat ricoperti d’oro le cui guglie riflettevano alla luce del sole.
Qui era conservato il favoloso Buddha in piedi, alto 16 metri e ricoperto di 263 kg. d’oro, posto al centro della Cappella Reale, e che, quando la città cadde definitivamente nel 1767 ad opera dei Birmani, venne incendiato e fatto colare l’oro che lo rivestiva, distruggendo insieme ad esso ogni cosa del grande monastero Phra Sri Sampet in cui erano raccolte le documentazioni più antiche del buddhismo e della storia della gente Thai, nonché le testimonianze dell’arte provenienti da tutto il regno. All’interno della zona archeologica è comunque possibile ammirare numerosi templi ed edifici di pregevole valore artistico, recuperati alla vegetazione che li ha tenuti nascosti, talvolta inglobandoli nei tronchi degli alberi, nel corso di appena un secolo. Non è inusuale vedere una statua del Buddha contenuta in una selva di arbusti o nel tronco di un albero secolare che gli è cresciuto attorno.
Sono gli alberi, infatti, dalle fogge e dai colori incredibili che, in qualche caso, sono tenuti in gran considerazione dalle genti Thai che li venerano come sacri, legando ai loro rami centinaia di piccole striscioline di carta colorate in rappresentanza di desideri, malinconie, richieste di vario tipo, per lo più amorose; e che svolazzando emanano al leggero vento che s’alza verso l’imbrunire una sorta di “musica” pacata, paragonabile a una ninna-nanna muta e sottile che la natura circostante accoglie in sé prima di addormentarsi e che racchiude le ombre dell’arcano splendore di una civiltà tramontata per sempre.
Non rimane che rimetterci alle pagine di una scrittrice raffinata e attendibile come Han Suyin che, nel suo libro più famoso dal titolo “L’incantatrice” (2), ha ricostruito quanto della storia di questa città è andato perduto nel corso dei secoli: “Risalimmo il Menam, con un vento mite che gonfiava le vele delle nostre giunche, con i barcaioli che cantavano le loro leggende e facevano doni, perché il nostro viaggio non avesse intoppi. (..) Un pomeriggio inoltrato, mentre il sole si addolciva e i bufali acquatici risalivano languidamente la riva, apparve Ayuthia, risplendente con le sue trecento cupole d’oro, una fiabesca città incantata che mi fece gettare un grido di gioia. (..) Mai avevo visto una simile meraviglia, e perciò era molto ambita. (..) Intorno a essa il Menam incontrava i suoi tributari, e la cingeva con una grande fascia d’acqua. Un vero prodigio!”.
“Più di tre secoli addietro, dove il fiume si divideva per cingere Ayuthia, sorgeva il grande Wat Phanang Cheng, per metà cinese e per metà thai. (..) Il Wat era immenso, al centro troneggiava una statua di Buddha che risaliva al 1320. Il volto era illuminato dalle lampade accese al tetto e alle altissime colonne che lo attorniavano. Era ricoperto d’oro, e le foglie d’oro si agitavano nel vento delle candele sulle centinaia di statue più piccole allineate lungo le pareti e intorno all’altare principale. A fianco del Wat c’era un santuario taoista, con le porte che raffiguravano il simbolo ying-yang, il principio maschile e il principio femminile, mezze spirali eternamente avvolte l’una all’altra, indivisibili. E c’era un piccolo sacello aperto dedicato a Tien Hou, regina dell’Oceano, con un’ancora, un remo e un rotolo di corda tra le candele e i bastoncini d’incenso che bruciavano”.
“Al di la del fiume, attraversando l’imperiosa cintura d’acqua per raggiungere i moli interni, la porta cinese, chiamata Nei Kai, si aprì davanti a noi. I bastioni erano traforati da porte, e sotto ogni porta c’era l’acqua che collegava al fiume le vie-canali della città di Ayuthia., che attraversammo su di un’imbarcazione lunga e agile, con quattro rematori e la prua ornata da una testa di animale. (..) Quasi tutte le vie erano canali, eccettuato un ampio viale centrale, le spianate davanti ai palazzi, e un labirinto di vicoletti affollati che univano l’acqua alla terraferma. (..) All’interno, le lampade brillavano nelle sale dal tetto basso, avvolte da veli di garza variopinta e sete. Dalle finestre giungeva la dolce brezza del fiume. C’era un sentore di rose e di cinnamomo che impregnava di profumi i nostri indumenti”.
“Dormii tra il gracidio di innumerevoli rane, mi svegliai al canto di una moltitudine di uccelli , mi lavai con l’acqua di una grande giara di ceramica e andai in giardino. le ancelle ornavano di ghirlande il sacrario dello spirito Phya Phum. Era di marmo, eretto su una colonna, e tutt’intorno c’erano le offerte. Resi omaggio anch’io allo spirito tutelare, (..) avrei dovuto offrirgli qualcosa per propiziarmelo. (..) Era quello il giorno del porpora, ad Ayuthia ogni giorno aveva il suo colore, favorito dai corpi celesti. Così la domenica era rossa, il lunedì giallo, il martedì rosa, il mercoledì verde, il giovedì arancione, il venerdì marrone, il sabato porpora”.
“C’erano donne che facevano il bagno nel fiume, con i lunghi capelli sciolti e la pelle dorata. Camminavano con passo elegante, girando nude fino alla cintola, con indosso un sabai, un drappo di stoffa pieghettato e gettato con noncuranza sulle spalle. Il pajong krabane, la gonna, era un altro drappo avvolto intorno ai fianchi o passato tra le cosce, con i lembi fissati davanti e dietro in modo da somigliare ad ampi calzoni che lasciavano scoperte le gambe fino al ginocchio. (..) Le risate fiorivano senza vergogna sulle loro labbra, mentre in gruppi coloratissimi gettavano sorrisi e fiori ai nostri piedi. (..) Sono molto volitive, ma non crediate che siano donne facili. (..) Qui il peccato della carne si mescolava alle ghirlande dei fiori, dei gladioli rossi e gialli da offrire nei wat, champaca e tuberose e gelsomini dal profumo dolcissimo. Ma qui la carne era bella, era gentile!”.
“Il suo magico splendore è rimasto, nonostante Ayuthia oggi non esista più. (..) Un verdeggiare languido, alberi immensi e dolci che incurvavano le pesanti fronde come per una benedizione; un orizzonte verde di colline ammantate di foreste e di fiori. E ancora fiori sulle terrazze delle case di legno di teak e di bambù, erette sulle palafitte che affondavano nel letto del fiume e si protendevano nell’acqua. (..) Ogni abitazione aveva il suo sacrario su palafitte, coronato da una guglia: era quella la dimora del Phya Phum, o Spirito della Terra, più antico di Confucio e di Buddha, più antico del Vecchio Immortale Tao. Apparteneva a quell’epoca dell’uomo in cui gli alberi, le pietre e l’acqua parlavano. (..) Qui persino le inondazioni erano generose, e arricchivano le risaie in abbondanza. (..) E oro, Ayuthia è coperta d’oro, che persino le pareti e i soffitti del palazzo del re, le stalle per i suoi elefanti bianchi (sacri) e i suoi cavalli, sono ricoperti d’oro. (..) Qui, nella foresta fatata si sprigionava il suo canto, qui i sogni erano validi, gli spiriti si manifestavano. Tutto trovava una sua collocazione, perché non esistevano barriere tra il mondo degli spiriti e il mondo dell’uomo”.
Ci spostiamo ora a Chiang Mai sulle rive del fiume Mae Nam Ping detta a ragione la “Rosa del Nord”, chiusa fra le colline boscose in un clima mite che favorisce le culture d’oppio e del riso, nonché di quel fiore di loto che riporta all’invito del Buddha alla meditazione, divenuto simbolo della trascendenza filosofale dell’Oriente. Centro nazionale dell’artigianato, la città è il cuore del commercio nazionale con i suoi manufatti e le attività artistiche, vi fioriscono le aziende di tessitura della seta e del cotone, la lavorazione del teak e della porcellana, del corallo e dei gioielli di straordinaria fantasia e raffinatezza. Nonché manufatti di pelle di serpente, di coccodrillo, di elefante. Una tappa importante per gli acquisti di oggetti di lacca lavorati a mano secondo tecniche antichissime, manufatti in legno e, soprattutto degli utensili da lavoro, degli strumenti musicali tipici e dei tradizionali ombrelli dipinti su carta cerata che costituiscono una tentazione irresistibile per signore che vogliono ripararsi dal sole e fotografi in cerca di immagini suggestive.
La visita ai templi assume qui l’importanza di un rito secolare, di ascensione al sacro monte della spiritualità, proprio per la collocazione dio questi in cima a ripidissime scalinate che ascendono a volte fino alla sommità collinare. Ma anche, per la pace che vi si respira, dove il tempo sembra intriso di una serenità incontaminata, crinata anche qui, dal suono delle mille campanelle a vento che adornano i tetti dei templi, profumati d’incenso e di aromi profumati che i fedeli bruciano ai rispettivi déi. Il Wat Chedi Luang, costruito nel 1297, è forse il più noto per il Buddha di Cristallo che in esso è conservato. Ma è salire al Wat Prathat Doi Suthep che più si fa sentire il peso di una religiosità carica di maestosità. Costruito nel 1383 per custodire una reliquia del Buddha il tempio si erge grandioso in cima a una scalinata di 300 gradini che, nello slancio verso l’alto sembra volgere al cielo.
Ecco, io mi fermo qui, ove sul finire della storia ogni realtà s’arresta, quando ci si accorge che tutto questo mondo Thai è qualcosa di diverso da qualsiasi altra, che non rientra nello schema delle cose conosciute. Infine: “… è una delizia pensare che una cosa così fantastica possa esistere su questa terra. (..) Questi templi Siamesi sono di una bellezza molto raffinata che loro stessi dicono essere riservata a una visione che le distingue infinitamente, come le linee di un’architettura fantastica i cui estremi s'incontrano quasi per gioco. Come di un luogo fantastico dove sette strade s'incontrano, in cui l'immaginazione riesce a fare di un viaggio, un itinerario spensierato e inaspettato, che s'illumina dell'irrealtà di una commedia musicale. Alla fine, può sembrare che non ci abbiano dato nulla ma quando si lascia questa terra s’avvalora il sentimento che non hanno tenuto alcun segreto per te viaggiatore nel tempo, ma che forse hanno conservato qualcosa di tuo, quel cuore che fin'ora ti era appartenuto".
Non sono parole mie, appartengono a un altro viaggiatore che nel 1920 si è trovato a visitare questo lembo di mondo: William Somerset Maugham (3), chi può dire di non conoscerlo. Anche per me, il ricordo di questo viaggio si conserva nella sospensione del sogno che il tempo non potrà mai cambiare. Quando nell’intimo di una natura serena, tra le nuvole bianche di questo cielo che osservo dal finestrino dell’aereo che mi riporta a Roma, porto con me, come bagaglio appresso, il ricordo di una magnifica esperienza che valeva la pena di essere vissuta.
Note:
(1)W. Warren, “The House on the Klong” – J. Weatherhill Inc. – Tokyo 1968.
(2)Han Suyin, “La Incantatrice” – Sperling & Kupfer Edirori – 1986.
(3)W. Somerset Maugham, “The Gentleman In The Parlour, che parla di un viaggio in Birmania, Siam, Cambogia e Vietnam”; "A writer's notebook", estratti dei suoi diari di viaggio, episodi di varia qualità, essi coprono più di 50 anni della vita dello scrittore e contengono molto materiale che gli studiosi e gli ammiratori di Maugham trovano di grande interesse.
Discografia consigliata:
“Thailandia”, in Musical Atlas / Unesco – a cura di Alain Danielou – Emi Odeon.
“Melody of Thai” – Siam Grammophone.
“Musiche e Tradizioni d’Oriente: Thailandia, Lao, Cambogia, Viet-Nam” – Baren-Reither.
*
 - Musica
- Musica
Etnomusicologia 5 - Oriente
ETNOMUSICOLOGIA 5
“ORIENTE: Introduzione all’ “altra” musica”, di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RAI – Radio Tre).
Ormai da qualche tempo, l’etnomusicologia non figura più una disciplina dal nome pretenzioso e dalla fisionomia complessa, come era per i processi dell’antropologia culturale (1), mediante i quali creatività, volontà umana e costrizioni materiali, plasmavano le così dette tradizioni. Tuttavia ciò non toglie che essa s’impone come uno dei saperi strategici per affrontare il nostro tempo. In merito, se da una parte è emerso un diffuso interesse teorico ed epistemologico verso i risultati e le procedure da questa utilizzate; dall’altra si è usufruito dei linguaggi e delle categorie da questa individuate ed evidenziate, per alimentare, legittimare e commentare sistemi di ricerca rivolti all’identità e alle pratiche di multiculturalismo. Va inoltre ricordato che se l’antropologia di per sé fa capo all’esperienza mentale, emotiva e fisica del contatto diretto con un mondo spesso sconosciuto, l'etnomusicologia si avvale di materiali già esistenti che sono frutto di ricerca e che messe a confronto con il metodo comparativo, più spesso ne studia gli approcci significativi sul territorio, in ciò che un tipo di musica ha preso e/o ha lasciato sul territorio stesso, e/o in una data cultura.
Pertanto, la dedizione antropologica rivolta allo studio dell'etnomusica dev'essere a sua volta estesa a tutti i popoli, nei luoghi e nei modi in cui essi vivono, riconoscendola infine come un’irrinunciabile conquista della sensibilità contemporanea che viene rivolta agli altri. A tutti quei popoli diversi e distanti tra di loro che potranno così, seppure per la prima volta e grazie alle testimonianze raccolte in primis dagli antropologi e successivamente dagli etnologi, entrare e contribuire alla discussione in corso sulle potenzialità e i limiti della specie umana, nonché sui rapporti tra le forme di vita e i modi di pensare rilevati nelle diversità culturali in cui si sono formati. In questo modo, concetti come “cultura”, “relativismo”, “etnocentrismo”, “etnografia” e di conseguenza “etnomusicologia”, sono oggi parole chiave anche per altre discipline e, più in generale, categorie inequivocabili basate su insiemi distinti di studi e ricerche che riflettono di raggruppamenti sociali accertati dall’antropologia linguistica e non solo.
“Sono ormai alcuni decenni che filosofi e storici della scienza hanno riservato un’attenzione speciale ai testi di antropologia, e da più parti si è intravisto nel fare antropologico, nel modo stesso di condurre la ricerca etnografica, nella pratica del dialogo, nel coinvolgimento del ricercatore, nella tradizione interculturale, uno stile scientifico non solo efficace, ma forse in grado di traghettare le scienze sociali oltre il modello, per lungo tempo egemone, avanzato dalle discipline naturali” (2).
Si consideri che fino a ad alcuni decenni fa si immaginava che il complesso delle scienze etno-antropologiche, diversamente chiamate anche a seconda delle tradizioni nazionali: etnologia, antropologia sociale o culturale, demologia, folklore, storia delle tradizioni popolari, sembrava destinato a scomparire dalla scena conoscitiva, poiché ancorato a un programma scientifico di documentazione di culture in via di estinzione, ciò non è più vero. L’odierna antropologia è stata capace di sviluppare, pur nei distinguo delle diverse discipline, una sua rilevanza fattiva nel campo della ricerca, aperta e razionale, che va oltre la semplice testimonianza di culture millenarie, esotiche e popolari, o la salvaguardia di patrimoni culturali. Bensì giocando un ruolo fondamentale nella comprensione del pensiero sociale moderno, con l’annuncio della fine delle differenze esistenziali, facendo esplodere il pluralismo delle interpretazioni, localistiche e identitarie, con il riconoscimento di nuovi soggetti sociali, per così dire “protagonisti” instabili o definitivi della nuova realtà sociale diffusa dal “multiculturalismo”, in senso di appartenenza e convivenza civile.
“Di questo scenario sfaccettato, complesso, particolarmente dinamico, l’antropologia è oggi alimento, bersaglio di contestazioni, fonte minuta di documentazione, risorsa interpretativa; fornisce il sapere e il linguaggio della differenza e dell’appartenenza culturale, recupera memorie, costumi, patrimoni e classificazioni che il tempo e le strategie politiche tendono sovente a naturalizzare, a trasformare in complessi monumentali, in eccellenze da contrapporre nel conflitto tra identità (..) entro una sintesi chiara, sistematica e aggiornata, e quella sensibilità così attenta a valorizzare l’incontro etnografico, soprattutto di quegli approcci interpretativi a cui va il merito di aver rinnovato il campo antropologico, coltivando un’esplicita disaffezione verso il positivismo e avviando il ripensamento radicale dei modi di fare e di raccontare la pratica scientifica” (3).
Un’inedita focalizzazione questa, che segna un cambio di marcia nell’analisi antropologica, che va dai comportamenti ai significati, dalla cultura come sistema di adattamento alla cultura come configurazione di simboli, permettendo agli stessi soggetti coinvolti di mutare immagine e compiti: “all’etnografo di perdere l’illusione di potersi rappresentare come puro sguardo e, al nativo, da passivo portatore di cultura, quale era considerato fin’ora, di rivelarsi quel sensibile interprete delle proprie risorse culturali e dei rapporti veicolari”, rivolti a determinare i modi nei quali comunicazione linguistica e interazione sociale si costituiscono a vicenda. Per cui “la comprensione dell’altro culturale – per molti versi in Italia anticipata dagli studi di Ernesto de Martino – è costruita utilizzando elementi tratti dal sistema culturale sia dell’antropologo che dell’informatore”, onde nel riaffermare il significato del sé culturale dell’altro, scopriremo in parte il significato della nostra identità.
C’è da augurarsi che il lettore possa qui ritrovare quella sensazione vitale avvertita da Claude Lévi-Strauss che in Tristi Tropici (4) riferiva: “il mio pensiero sfuggiva alla soffocazione che la pratica della riflessione filosofica mi causava. All’aperto, l’aria nuova mi rinvigoriva, mi inebriavo di spazio mentre i miei occhi abbagliati misuravano la ricchezza e la varietà degli oggetti”, cui mi permetto di aggiungere la bellezza delle immagini, la fantasmagoria della natura dei luoghi, la meraviglia che mi è data di vedere.
Quello che qui di seguito viene offerto è un viaggio itinerante attraverso il tempo e lo spazio che porta ad avvicinare alcune esperienze della cultura dell’Estremo Oriente, tanto distante dalla nostra e dal nostro punto di osservazione, vuoi per sensibilità e filosofie diverse, che pure, in realtà, non si distacca molto da quella che di fatto è la funzione collettiva della musica universale, fonte infinita di bellezza e di armonia, da sempre veicolo di importanti informazioni culturali. Ciò, nell’intenzione di trovare una possibile chiave di lettura che ci permetta di penetrare il contenuto formativo di un tessuto mitologico e trascendentale, non già in modo comparativo, poiché il confronto tra Oriente e Occidente, mai come in questo caso, trattandosi di tradizioni musicali estemporanee, non si rende possibile e, a mio avviso, potrebbe risultare del tutto inutile.
Bensì, utilizzando, per la prima volta, una diversa forma di lettura, cosiddetta “evoluzionistica” (5), cioè utilizzando il metodo di ricerca più noto come “osservazione partecipante”, basilare per l’antropologia culturale e per l’interpretazione umana in genere. Una chiave diversa, quindi, allo scopo precipuo di rivivere insieme, seppure in poche e sfocate fotografie che non vogliono essere testimonianze del tempo, le esperienze della cultura musicale dell’Oriente, in qualche modo capace di affascinare e creare stupore, la cui meravigliosa realtà sopravvive nei popoli che la esercitano nel quotidiano e la mantengono viva.
“Sawasdee!”, le mani congiunte sul petto e il capo chino, onorati del dono di una ghirlanda di preziose orchidee e profumatissimi gelsomini, è questo il più gradito “benvenuto” che l’Oriente offre al visitatore, in tutta la sua floreale bellezza e la naturale cortesia del suo popolo: la Thailandia, nome attuale di quello che un tempo fu il favoloso impero del Siam. Una civiltà profondamente imperniata sulla religione e tradizioni che hanno resistito nei secoli, il cui splendore sembra non conoscere tramonto. Appena giunti a Bangkok, la sua capitale, si è immersi in una natura regale che accende incensi odorosi agli angoli delle strade, in onore degli innumerevoli Buddha d’oro e di giada, di bronzo e di pietra, che la religiosità popolare celebra con grande partecipazione: dalla tradizionale festa per l’arrivo della primavera, alla purificazione della casa, ai pellegrinaggi ai templi, alla donazione delle nuove tonache ai monaci del Wat-Po, il più grande e dalle guglie più splendenti, che si stagliano meravigliose nell’azzurro del cielo.
È la primavera, infatti, il periodo dell’anno migliore in cui visitare quella che è ancora oggi ritenuta la “Porta dell’Oriente”, cresciuta attorno a quello che è il fiume sacro per eccellenza, il Menam Chao Phraya (o semplicemente Menam) (in thailandese แม่น้ำเจ้าพระยา, dove Menam, da แม่ (mèe)=madre e น้ำ (naam)=acqua, significa appunto fiume. E Chao Phraya, termine onorifico feudale traducibile con eccelso, è uno dei due principali fiumi della Thailandia, che scorre nella pianura alluvionale da esso e dai suoi affluenti formata. In questa stagione si tiene infatti la regata detta Tot-Kathin, che da inizio ai festeggiamenti annuali, in occasione delle cerimonie e delle processioni solenni, con il supporto di riti e preghiere, danze, canti e fuochi d’artificio, ma anche di musica e colori che la tradizione, lontana dalle influenze occidentali, ripropone ogni anno in tutta la sua magnificenza di colori e di festa.
Colori che la natura lussureggiante di questa terra distribuisce con ampia generosità, in un’atmosfera più sognata che reale, dove il tempo sembra scorrere più lentamente che altrove, sospeso tra presente e passato, per una sosta riflessiva all’interno di un giardino di delizie, profumato di mille essenze aromatiche, saporoso di mille frutti unici e bizzarri, arricchito di fiori multiformi e meravigliosi fra i quali abbandonarsi, sorpresi dello splendore e della bellezza dei luoghi, e infine perdersi per effetto di un costante dualismo, nell’armonia della sfera delle forme ideali. Qui, lontani dai nostri lidi europei, si può restare abbagliati dalla luminosità degli spazi, dalla lucentezza dei colori, dalla varietà degli scenari che si presentano davanti ai nostri occhi e dalle diversità delle situazioni cui siamo abituati.
Allora lasciarsi trascinare su una giunca fino al “mercato galleggiante” o raggiungere le assolate spiagge del Sud; o spingersi sulle alture del montuoso Nord, attraverso piccole cittadine pullulanti di vita e di lavoro; oppure condursi alla scoperta di antiche città abbandonate, nascoste nella vegetazione, è di per sé un viaggio dei sensi. Così come lasciarsi iniziare all’oppio in una fumeria nel quartiere cinese; o farsi praticare sul corpo il tatuaggio di un grande drago, o di un pesce volante dai poteri magici. Oppure, e perché no, trovare un adeguato rilassamento alle sofisticate “delicatezze” di un massaggio, nelle apposite “case del relax” e scoprire i misteri di quell’arte raffinata e accurata dell’ “amore per il corpo”, in modo autentico e avvolgente, lontano dalle implicazioni dei legami formalizzati.
D’importanza fondamentale, per una introduzione alle tradizioni musicali della Thailandia di oggi, è necessario risalire a quelle che erano le formazioni strumentali dell’antico Siam. Un regno travagliato da mille guerre di sudditanza tra le altrettanto numerose fazioni ereditarie degli Imperatori che vi si sono succeduti, e che hanno incrociato le armi sul terreno della storia, provenienti dalla Birmania (Kmer), dalla Cambogia, dal Laos e, in parte, dalla Cina. A tal punto che le sovrapposizioni e le contaminazioni, delle une sulle altre, non sono quasi più avvertibili, poiché derivanti da una stessa fonte religiosa buddhista / induista, verosimilmente derivata dall’India arcaica e profonda, il cui repertorio è comune a tutta l’area musicale e abbraccia le regioni limitrofe dell’Indocina.
Usata in genere nelle corti e durante le cerimonie religiose nei monasteri, la disposizione orchestrale ancora in uso, risale all’epoca delle dominazioni Kmer nel XIII secolo: due xilofoni siamesi “banard”, detti khong-wong e khong-wong-lek, precisamente una doppia versione dello stesso strumento, formato da due file di piccoli e medi gong, posti su un supporto circolare di bambù che ne permette la particolare vibrazione; due oboe pi-nai; due tamburi orizzontali a due membrane, detti kloang-thad e klong-jao-thou anche usati nelle cerimonie; due piccoli tamburi a una sola membrana, detti ramaha; ed alcuni cimbali piccoli, detti ching, e due più grandi, detti chap, di cui si fa uso continuato nei motivi a ritmo. Uno strumento di fattura complessa è l’ang-klung, unico nel suo genere, composto da alcuni legni che vengono battuti con le due mani.
Molte, come si è visto, sono le percussioni utilizzate, tuttavia non mancano gli strumenti a corda, sebbene occupino un posto di importanza relativa all’utilizzo per accompagnamento al canto: la viella a due corde d’importazione cinese; il solung a tre corde della famiglia dei liuti, in due versioni, dette jakae-saw e jakae-duang, e un particolare tipo di “viola da gamba” di dimensioni ridotte, denominata can spesso utilizzata in a-solo che ricorda da vicino la voce cantilenante dei monaci raccolti in meditazione. Particolare interesse rivestono invece gli strumenti a fiato, anche se alcuni vengono suonati soltanto in speciali occasioni rituali: fluti di bambù a sei fori, detti khluy; i già citati oboi pi-nai, e uno speciale tipo di “organo a bocca”, formato da canne di diversa lunghezza che ricevono aria da un solo bocchettone posto al centro, originario della Cina dove prende il nome di sheng. Altri strumenti a fiato che somigliano alla nostra zampogna e al flauto a canne contenuto in una rapa essiccata, vengono usati da gruppi di musicisti improvvisati che accompagnano le festività popolari, soprattutto nel Nord del paese, nella regione montana di Chiang-Mai.
Un’orchestra così concepita, costituita di soli strumenti tradizionali, o di antichi strumenti risalenti ai regni di Laos e Birmania, modificati e perfezionati dall’artigiano attento, si trovano oggi ad affiancare i gruppi più moderni che hanno ceduto all’elettrificazione e alle mode occidentali. Tuttavia è ancora possibile ascoltare l’autentica musica tradizionale in particolari occasioni e cerimonie rituali o nei volumi (Lp) che raccolgono “registrazioni sul campo” eseguite in illo tempore da studiosi e musicologi, tra cui spiccano le collane curate da Alain Danielou “Musical Atlas Unesco Collection” (6).
La musica che mi accompagna in sottofondo mentre scrivo, è tipica della forma Liké, tratta dall’album dedicato alla “Thailandia”, usata nell’accompagnamento delle leggende siamesi espresse in musica e danza che danno forma a una sorta di rappresentazione in cui la voce del protagonista, qui usata in forma monodica, quando non vengono usate preghiere corali collettive, si snoda al pari del suono prolungato di un flauto. L’armonia che l’accompagna è basata sulla composizione modulare ripetuta all’infinito, come all’infinito sono quasi sempre proiettate i racconti noti in tutta l’Indocina. Un’altra forma tradizionale di musica e danza, entrata a far parte del patrimonio tradizionale del teatro Thailandese, è quella detta Khon, una delle tre forme secolari che la compongono, insieme al Lakon e al Rabam. Un dramma danzato risalente al XV secolo con accompagnamento vocale e strumentale, derivato dal teatro detto “delle ombre” cambogiano con la successiva sostituzione delle marionette con gli attori, in origine ricordato come teatro di maschere.
Oggi gli attori hanno il volto scoperto e copricapo appuntito, a forma di piccola pagoda, che ne caratterizza i ruoli. I movimenti, per lo più, sono sincronizzati alla recitazione del testo, mentre il racconto si rifà al “Ramakien”, versione thailandese del noto poema “Ramajana” (7), illuminata dal riflesso dell’eroe epico Rama e delle sue lotte intraprese con il demone Ravana, definito tra i più seducenti e meravigliosi dell’Oriente, assimilativo delle importanti culture quali quella cinese e quella indiana. Altro aspetto eclatante è indubbiamente la danza, legata alla rappresentazione del testo, talvolta sostitutivo delle azioni stesse, oggi maggiormente studiato per i riferimenti dirette a partiture più antiche da dove, sembra, siano state separate. Le danze offrono uno spettacolo coreografico di grande richiamo per appassionati e non, ma soprattutto per l’autenticità dell’arte mimica, qui elevata a vera arte.
È questa un’arte antica, raffinata ed elegante, che si basa sui canoni rigorosissimi delle figurazioni contrapposte e le volute fantastiche delle dita e delle mani, “quasi poesia del movimento”, entrata nell’iconografia popolare di cui bisogna conoscere i significati nascosti per poterla gustare appieno. I danzatori e le danzatrici, infatti, vengono selezionati fin dalla più tenera età, e iniziati al cosi detto “teatro”: insieme di recitazione, mimica, danza, e musica. Discipline queste che permetteranno alla fine del percorso, di assumere quella sincronicità di movenze “aggraziate e leggere” del corpo, necessarie all’apprendimento dell’arte con quel che ne concerne.
Fatto rilevante in questa forma d’arte è che i danzatori (uomini) non si toccano mai fra loro, eccetto per una qualche speciale rappresentazione, bensì sfilano con grazia in elaborati e sfarzosi costumi filigranati d’oro e d’argento, completi di maschere fantasiose e copricapo regali. Le danzatrici si scambiano normalmente i ruoli, pur tuttavia è sempre all’uomo che spettano le personificazioni del re scimmia o i suoi demoni orrendi.
Una danza tra le più pittoresche è la “bamboo dance”, ovvero delle canne di bambù, entrata nell’uso anche nelle Filippine e in Malesia. La particolarità di questa danza è dovuta all’attenzione che i danzatori devono mettere per rispettare il ritmo, scandito da quattro grosse canne che si intersecano e che vengono battute l’una contro l’altra con cadenza ritmica. Si danza in coppia e diventa maggiormente piacevole, come un gioco, se la si effettua in molti. Bisogna solo fare attenzione a non lasciare uno dei piedi fra le canne. A essa si fa ricorso in occasione di giochi comunitari e feste iniziatiche, inclusa quella per l’arrivo della primavera.
La “danza delle spade”, tipica di tutti i popoli guerrieri, risale all’antico periodo delle guerre contro il nemico birmano e che insanguinarono questa terra per secoli. Si tratta di un aspetto dell’arte marziale che ritroviamo in molte tradizioni orientali e non solo, che qui assume la forma di intrattenimento coreografico. Altre danze provengono invece dai paesi confinanti come il Laos e la Birmania, tipiche delle genti Iko e Meo, abitatrici delle regioni montane che vivono secondo leggi ancestrali nel rispetto delle proprie tradizioni e ancora non assoggettate alla realtà culturale del paese che le ospita.
Fa parte del folklore locale, oltre alla danza, anche la “Thai boxing” per metà danza e per metà autentico sport che si gioca con molta partecipazione in ogni regione. Oltre ai pugni vengono tirati anche calci e ginocchiate, ammessi dal regolamento, mentre un’orchestra di flauti, tamburi e cimbali, scandiscono ritmicamente la lotta che si fa sempre più veloce e pericolosa. Caratteristica che distingue queste danze è da considerarsi la scioltezza del gesto, non legato a schemi preordinati o rappresentativi, e normalmente accompagnate con strumenti di fabbricazione locale e artigiana.
Fra le danze popolari che meglio mettono in evidenza la grazia femminile, la “finger nail dance”, o delle unghie lunghe, è indubbiamente quella che da più risalto all’incontrastata bellezza delle danzatrici Thai che, per l’occasione, ricoprono le loro unghie con lunghi petali d’oro. La musica per questa danza prevede numerose figurazioni e giochi con le mani in accompagnamento a passi molto flessuosi del corpo. Ogni regione ha le sue danze tipiche e molte sono quelle che danno risalto alla grazia femminile, ispirata e strettamente legata alla grazia dei fiori.
Ed è proprio ai fiori cui fare riferimento nel visitare quello che per eccellenza è considerato il Suan Sam Pra che ci permette di apprezzare la poesia racchiusa nell’arte della danza, come del resto lo è del canto e della musica: il “giardino delle rose”, a 30 km. da Bangkok dove, per l’appunto, vengono coltivate le rose più stupende che si siano mai viste sulla faccia della terra, e tutte le specie di orchidee, divenute il simbolo per eccellenza dell’accoglienza e dell’ospitalità thailandesi. Ancor più vi si coltivano il sorriso e la felicità, e non solo quella degli occhi, poiché è qui che ancora oggi è possibile fare un incontro con la vera tradizione, grazie alle scuole ci conservazione e di preparazione all’arte musicale tipicamente Thai.
È ancora qui che vengono conservati gli insegnamenti della tradizione nella loro forma originale, quel secolare patrimonio culturale, fatto di eleganza e giovialità, nello splendore della natura che ci circonda, e che qui trova una sua ragione d’essere, nel costume e nella prodigiosa creatività delle sue forme e dei suoi colori, delle sue profumazioni e dei suoi sapori. All’interno del Suan Sam Pra, infatti, si trovano una Scuola di Danza Thai, un’azienda manifatturiera della seta, e ancora, una Scuola per la creazione dei costumi e delle maschere tradizionali, ancora oggi in uso durante le sfilate e le cerimonie rituali annuali, tra le quali trova grande riscontro l’avvento della primavera, per eccellenza la stagione dei fiori, del sole tiepido e del vento amico che soffia costante ma leggero, il più adatto a far volare gli aquiloni.
È sufficiente spostarsi nel Phra-Mane Ground di Bangkok, il parco più grande della città, al quale fanno da sfondo le guglie dorate dell’antico Palazzo Reale. su questo spiazzo verde si svolge ogni anno, ogni giorno festivo incluso tra Febbraio e Giugno, la più curiosa festa del mondo: la “guerra degli aquiloni”. Qui migliaia di giovani Thai accorrono da ogni parte per celebrare l’arrivo della bella stagione. È così che il cielo si riempie di nuove fiori “come stelle” multicolori, raffiguranti draghi e farfalle, pesci e uccelli fantastici, rombi e trapezi con lunghissime code inanellate, che si sciolgono nel voluttuoso vento. A sera, quando il cielo tende all’imbrunire, qualcuno prende a suonare sui tamburi, una musica percussiva che accelera l’ansia dello scontro che avviene quando ognuno tenta di riguadagnare la propria stella che, immancabilmente, va a cozzare contro un’altra e un’altra ancora. Ne scaturisce un’autentica guerra stellare, la meno costosa della storia, dove l’indomani, bastano pochi spazzini municipali a raccogliere i resti di una battaglia festosa e innocente.
Note:
(1) E. A. Schultz e R. H. Lavenda, “Antropologia Culturale”, Zanichelli – Bologna 1999.
(2-3) Ibidem - Prefazione all’edizione italiana di Vincenzo Padiglione.
(4) Claude Lévi Strauss, “Tristi tropici”, Il Saggiatore – Milano 1960.
(5) “evoluzionismo”: caratteristica della prospettiva antropologica che impone agli antropologi di collocare le osservazioni su natura, società e passato dell’uomo in una cornice temporale che tenga conto del cambiamento nel corso del tempo.
(6) “Musical Atlas Unesco Collection” – Emi-Odeon – Collana discografica curata da Alain Danielou: (Neuilly-sur-Seine, 4 ottobre 1907 – Lonay, 27 gennaio 1994) è stato uno storico delle religioni e orientalista francese. Stabilitosi in India per 15 anni studia filosofia, musica e sanscrito nelle scuole tradizionali locali. Viene iniziato all'induismo śaivaita, impara a suonare la vina e adotta l'hindi come lingua quotidiana. Partecipa attivamente alla vita politica e alla lotta per l'indipendenza indiana diventando membro del Bharatiya Jana Sangh, un partito tradizionalista hindu. Diventa docente all'università hindu di Benares, poi passa a dirigere un'importante biblioteca di manoscritti sanscriti a Madras. Negli anni finali della sua vita torna in Europa per compiere studi comparati sulla musica prima a Berlino e poi a Venezia “Fondazione Cini”.
Opere: “Shiva e Dioniso”, Astrolabio, Roma
“Storia dell'India” (tradotto da Alessandra Strano), Astrolabio-Ubaldini editore, Roma, 1984.
“La Via del Labirinto, ricordi d'Oriente e d'Occidente”, CasadeiLibri.
(7) Traduzioni italiane di questa importante opera:
“Il Ramayana”, a cura di G. Gorresio, 3 voll., Fratelli Melita, Genova 1988
“Il Ramayana”, a cura di R. K. Narayan, Guanda, Milano 1991 (nell'originale è una riduzione in inglese del capolavoro della letteratura classica).
*
 - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusicologia 4: Egitto
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGICA 4 - EGITTO
“Egitto: il culto della bellezza”, di Giorgio Mancinelli, con la consulenza di Paolo Rovesti cosmetologo e Fabrizio Felici Ridolfi, egittologo.
(Da “Folkconcerto” programma realizzato per Radio 3 – Rai; altri testi tratti da “Il canto della terra”, trasmissione radiofonica in due puntate messa in onda da RSI –Radio della Svizzera Italiana); e brani tratti da “Miti di Sabbia: racconti perduti del Sahara” di Giorgio Mancinelli – edito da ilmiolibro.it).
Un viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio, quello che mi accingo a narrare, che si spinge all’estremo margine di una realtà che potrebbe non essere stata, in cui il Sahara, nel suo divenire agente interagibile del sogno, travalica il limite posto dalla memoria e si conduce dove tutto si posa e tutto si ridesta – come per una visionaria sequenza d’immagini in cui si fondono i costrutti e i timori di un’esperienza iniziatica, che solo di rado riaffiora nel presente, per il suo ridestarsi dalla memoria ancestrale. Un viaggio al seguito del vento del deserto attraverso i suoni e le vibrazioni di una natura ostile e meravigliosa, in cui ogni accadimento, pur nella sua incombente realtà, sembra valicare l’estrema soglia dell’immaginario, nel costante coinvolgimento di silenzio e stupore, di rapimento e di paura, in cui la vita si risveglia dalle sabbie dei primordi, per poi farvi magicamente ritorno, sorprendente e terrifica, sconvolta da accadimenti straordinari, tormentata da ineffabili presenze.
Un viaggio alla ricerca delle usanze e dei costumi, dei racconti e dei canti, degli strumenti e della musica di popoli entrati nella leggenda, che per effetto dell’eterna sospensione del tempo, si trovano ancora oggi ad attraversare il “vuoto cosmico” del Sahara. Vuoto in cui, l’immaginario previene il determinarsi di un universo di per sé mutevole, in netto contrasto con l’apparenza delle cose, che si pone come la sola realtà possibile, dentro il tempo del sogno in cui noi tutti ci conduciamo, capace di scandagliare nelle profondità del sublime e dell’orrore, del passato, del presente e del nostro addivenire. Come scrive Paul Bowles (1): “Non appena giunti nel Sahara, sia la prima o la decima volta, è la sua calma immobilità ad accogliervi. Qui, persino la memoria scompare e altro non resta, se non il respiro e il vostro battito del cuore”.
Recitano i versi d’inizio di una poesia d’amore . . .
“Desiderava il mio cuore vedere la bellezza di ciò . . .” (2), allorquando, sospinta dal vento, la feluca sollevò un mormorio dell’acque e i papiri frusciarono sommessi sulla vicina sponda, come un insieme misterioso di “voci”, simile a lamento di supplici, che improvviso si leva e aggiunge una vaga inquietudine allo scorrere lento e maestoso del Nilo. L’approdo avviene in una lieve insenatura sabbiosa coperta di giunchi e canne piumate, e allorché disceso, mi soffermo ad ascoltare quel remoto lamento che il vento ben presto disperde dentro un tranquillo incolmabile silenzio. In quel medesimo istante, un ibis sacro solca il cielo di una sottile linea azzurra e si spinge lontano, nei luoghi che per primi accolsero il loto odoroso, emblema dell’amore supremo, e la ninfea bianca, simbolo dell’opalescente bellezza, che un tempo avevano rischiarato la cosmica armonia. Nell’immanenza di questa visione, una sorta d’amoroso afflato sospinge il mio sguardo verso la sfera raggiante del sole, e in quello sfolgorio di luce, in cui la concretezza infine scolora, ogni altra cosa si disperde nello smalto splendente dell’aere, come immagine che improvvisa si sfoca.
Come se quel momento appartenuto all’eterno, ad esso facesse ritorno, entro una metamorfica luminescenza che indicava nell’astro del Sole il corpo visibile di Râ, la sua germinazione, la sua veemente creazione, nel divenire ciclico del Tempo. Râ, che la divina madre Nut ascosa nella notte del cielo, faceva rinascere ogni giorno alla vita e lo restituiva alla Terra in tutta la sua fulgente bellezza (3):
. . .
Lode a Te Amon - Râ signore di Karnak.
Principe in Tebe.
. . .
Lode a Te, che sollevasti il Cielo
e distendesti la Terra.
Più in là, superata la striscia lussureggiante della vegetazione, il Nilo prosegue il suo viaggio lento e possente entro gli argini di un presente solo apparentemente senza memoria. Là, ha inizio il Sahara, un continuo cromatico di sabbia ricco di sfumature contrastanti: dal verde intenso delle ultime terre coltivate, all’ocra bruciata delle dune, all’oro pallido delle colline calcaree, al bruno rossastro dei massicci montuosi che sullo sfondo, costituiscono le estreme propaggini di un improbabile orizzonte. Vi giungo sospinto dal desiderio di ampliare la mia conoscenza attorno a quella lontana civiltà sorta sulle sponde del fiume, che tanto mi aveva affascinato, quando ancora studente, ne avevo sentito per la prima volta il richiamo poderoso che mi aveva portato a tessere di sogno l’illusione di poter giungere, un giorno, alla sua piena identificazione. Un sogno che molte volte avevo provato a sollecitare, e che adesso, per un’apprezzabile ordinanza del destino, si rivelava così prossimo alla grandezza dello spirito, da rendermi incapace, quasi, di apprezzare quanto di meraviglioso mi era dato osservare.
Riflessa nello specchio appena increspato dalla corrente, la feluca sospinta dal vento, si allontana leggera sul filo dell’acqua, scomposta in una doppia immagine riflessa, mentr’io, per una qualche inspiegabile concomitanza, con lo sguardo, l’una non ancora lascio che l’altra colgo, come se il presente, non fosse altro che un effimero contemplativo in cui ritrovo ciò che è l’oggetto del mio desiderio, e il futuro di fatto, compreso nel passato che appartiene ormai alla memoria. Ma tutto ciò non dura che un attimo, il tempo necessario a fermare la sua fuggevole visione dentro un battito del cuore. Chi mai può dire se stiamo andando oppure tornando dall’eterno oblio? Mi viene da chiedermi, pur sapendo che qualunque sia la risposta in questo momento, non può che suscitare in me soltanto un possibile dubbio, un’ulteriore inquietudine, che evito di cercare. La mia feluca veleggia leggera lungo il più generoso dei fiumi, e io la conduco oltre un lontano orizzonte d’acqua, per la durata incommensurabile di un abbaglio (4):
. . .
Salute a Te, o Nilo che sei uscito
dalla Terra
i prati ridono, le rive fioriscono
gioiscono gli uomini
il cuore degli dèi si esalta.
. . .
Tu che la Terra adorni
prospero è il Tuo venire, o Nilo!
E come in un sogno ove ogni cosa si specchia e si moltiplica, vedo rifulgere i primevi bagliori d’ogni Sole, la bianca opalescenza d’ogni Luna, i cieli che erano e che sarebbero stati sempre, le acque già defluite che tornano a scorrere ancora, le sabbie incontaminate dei primordi sollevarsi nel turbinio del vento – quasi che l’essenza della vita nel suo fluire cosmico, faccia ritorno entro le spire dell’eterno.
Questo è l’Egitto arrivando dal deserto, una magica parola che spalanca le porte della fantasia su un fiume rigoglioso e immenso, dalle rive fruscianti di papiri mossi dal vento, e dalle sponde fiorite di loto profumatissimo, culla del sole primordiale della creazione. Un grande loto uscito dalle acque primordiali, pegno d’amore offerto al Faraone, insieme divinità e re, e per questo detto “signore delle due terre” dell’Alto e Basso Egitto. E che ritroviamo effigiato nelle pitture murali all’interno delle tombe, scolpito nelle architetture dei templi e dei palazzi, nelle belle forme delle colonne e dei pilastri nate dall’idea di un mazzo di ninfee in boccio.
Quello stesso fiore che fu anche usato come mezzo di paragone poetico per declinare la bellezza della donna, sia essa madre o moglie che rispondeva a un unico ideale d’amore, e che poteva somigliare soltanto al “lanufar”, il fiore di loto, appunto.
Recita un canto d’amore rinvenuto in un frammento di papiro della XIX dinastia (5):
“Il canto di colui che adoro,
mi ha detto una sola parola: vieni!
E io, che rinnovo a ogni ora la mia toletta per piacergli,
sono andata bianca come la luna,
profumata come l’acacia,
fresca come un fiore di loto”.
Sono questi i versi delicati e armoniosi trovati nel corredo funebre di una principessa egiziana, insieme con le gemme, i balsami, le ghirlande, gli alimenti, le anforette dei profumi e le molte altre suppellettili, che la sabbia del deserto ha conservato per così lungo tempo. Come per incanto di poesia, questa esile ragazza libra i suoi versi sui millenni, cantando l’eterno rapporto tra l’avvenenza e l’amore. E così che quelle che sembrerebbero soltanto “memorie di un fascino antico” tornano ad animarsi, attraverso la visione di immagini imperscrutabili e altere, sospese nel tempo, che recuperano, non senza un certo stupore in chi le osserva oggi, lo splendore di una civiltà che ci affascina e ci sorprende.
Proiezione suprema dell’estetica corporea, il culto della bellezza raggiunse nell’antico Egitto il più alto grado mai sfiorato nell’arte primitiva, sublimando il senso realistico di ogni forma e di ogni simbolo utilizzato a questo scopo, per divenire infine astrazione, meta da perseguire in vita prima di affrontare l’al di là.
Gli Egizi avevano, comunque, capito l'importanza dell'igiene. Durante il giorno, si lavavano spesso le mani, e facevano la doccia giornaliera, con acqua versata dalle brocche. Curavano l'igiene di bocca e denti che veniva effettuata con bicarbonato. Anche unghie e capelli erano lavati quotidianamente e poiché non esisteva il sapone venivano usati oli profumati e complessi unguenti che rendendo la pelle integra, e quindi non screpolata, impedivano l'introduzione, nell'organismo, di germi e batteri. Oltre alle brocche per la doccia, vi erano anche le vaschette per pediluvi raffigurate anche, come geroglifico vero e proprio, che venivano anche deposte nel corredo funerario, vi era l'usanza di togliere i sandali per entrare nei templi che nasceva dall'esigenza di non introdurre impurità dall'esterno. Questa regola valeva anche per il sovrano, così come è possibile vedere nella Tavolozza di Narmer, in cui un uomo porta in una mano i sandali del re e nell'altra una piccola brocca con acqua.
“In epoca relativamente media, oltre al bagno quotidiano sappiamo che veniva praticato il massaggio del corpo, con particolare cura per le mani e i piedi. L’uso di una raffinata cosmesi, rappresenta il vertice di quest’arte come non la si ritroverà mai più. Maschere cosmetiche e un trucco facciale appropriato all’andamento aggraziato delle figure, sia nella donna che nell’uomo, quale è altresì possibile ammirare nelle preziose pitture delle tombe e dei templi, permettono qui di elencare quelle che erano i componenti “naturali” della cosmesi utilizzata. Si va dall’incenso, mirra, opoponax, olio di legno di cedro, fino allo zafferano, cannella, cinnamomo, tutte materie prime di comune impiego per oli profumati e cosmetici, di gran lunga a tutt’oggi usati” (6).
“In particolare per gli occhi, venivano usati due tipi di belletto colorato, uno verde a base di polvere di malachite, l’altro, il nero, a base di solfuro di piombo o di antimonio, usato per le sopracciglia e le palpebre. La malachite verde del Sinai e la galena nera, oggi chiamata kohl, utilizzate dopo averle impastate con l'acqua. Inoltre, utilizzando un estratto dalle foglie di ligustro le donne si dipingevano unghie e capelli, mentre come ombretto erano solite utilizzare il nero dell'essenza estratta dalla galena. Era diffusa l'arte di truccarsi gli occhi e, grazie all'uso di particolari bastoncini o cucchiaini, potevano scurirsi sopracciglia e ciglia” (7).
Quella che leggiamo qui di seguito è una poesia d’amore relativa alla XIX dinastia (8):
“Il tuo occhio così dipinto diventa più grande,
Il tuo occhio contiene più amore quando mi guardi,
Nel tuo occhio mi perdo come in un cielo incantato,
nel tuo occhio si concentra il mio desiderio come una febbre,
nel tuo occhio così grande c’è tutta la bellezza del tuo corpo
e della tua anima”.
“I cosmetici facevano parte dell’uso quotidiano, un po’ come le bevande e i cibi, da riuscire indispensabili sia alle classi altolocate che a quelle meno abbienti. Persino gli operai e gli artigiani dipendenti, ricevevano, oltre alla razione di cibo, anche quei prodotti cosmetici necessari per la pulizia personale e il massaggio d’uso, come un diritto costituito. Tra le terapie vi erano anche i massaggi, per lenire numerose patologie il cui sintomo principale era il dolore. Era conosciuta la tecnica delle inalazioni che erano composte da mirra, resine, datteri e altri ingredienti. Ma per i morsi velenosi dei serpenti, gli Egizi, non avevano altra cura se non quella di affidarsi alle dee Iside e Mertseger recitando le litanie magiche” (9).
Sebbene nella statuaria vediamo un’appendice molto simile a una barba riccioluta e annodata dietro la nuca, questa era un simbolo di distinzione del faraone, poiché era considerato incarnazione stessa della divinità, aveva diritto di applicarsi al mento una barba posticcia, sottile, ondulata, a volte tempestata di lapislazzuli, che metteva solo nelle grandi occasioni dove si mostrava al popolo. Così come non appariva mai a testa nuda, e probabilmente neppure nell’intimità della sua casa, il Faraone si faceva radere i capelli molto corti in modo da poter cambiare parrucca e acconciatura secondo l’occasione. Infatti, nella donna, ma in certi casi anche nell’uomo, era in uso portare la parrucca, ritenuta altamente estetica, che rimandava a un altro uso, quello di radersi il volto e la testa e depilarsi completamente, per dare così massimo risalto alle linee del corpo e al viso.
“L'utilizzo di parrucche semplici si diffuse a partire dalla V dinastia presso i dignitari e le loro famiglie. In seguito divennero sempre più comuni, cambiando anche il modello; nel Medio Regno ad esempio si portava un modello più lungo, con due ciuffi a ogni lato, di cui uno era lasciato ricadere sulla spalla. Le parrucche divennero successivamente sempre più elaborate. Erano composte o da sottili treccine di capelli veri, che venivano raccolte utilizzando spilloni di vario materiale come legno, osso o avorio, oppure erano formate da fibre vegetali; vi si aggiungevano poi degli ornamenti ed erano in ogni caso espressione del rango sociale di appartenenza”(10).
In realtà gli egizi erano attenti alle loro acconciature; i bambini portavano i capelli molto corti o rasati con l'eccezione di una parte che veniva raccolta in un ciuffo per poi farlo ricadere sulla spalla destra; così facendo veniva coperto l'orecchio. Il ciuffo veniva poi tagliato all'età di dieci anni, quando diventavano adulti; le bambine portavano semplicemente i capelli corti. Gli alti dignitari avevano piccoli ricci che coprivano le orecchie formando una curva dalle tempie alla nuca. Le donne portavano inizialmente i capelli molto corti, poi le acconciature si allungarono sempre di più. Tant’è che era fatto divieto all’uomo di portare la barba, fatta eccezione per i baffi impomatati, che però, in tal caso, portavano i cortigiani. I sacerdoti avevano l'obbligo di radersi completamente testa e corpo: un segno di purificazione necessaria per l'accesso ai sacri templi. Anche la lametta per la barba cambiò materiale con il passare del tempo: inizialmente costituita da una selce con manico in legno, divenne poi di bronzo.
In molte delle immagini dipinte si nota spesso un cono portato sopra la capigliatura, composto di essenze profumate solidificate con grasso, che col calore si scioglieva lentamente, e intrideva le spalle e il corpo in modo da mantenerlo a lungo fresco e profumato. Ciò ci permette di constatare come questi usi erano ben lontani dal semplice “fatto estetico” fine a se stesso. All’occorrenza, venivano utilizzati oli e profumi per la cura dei capelli e tinture per nascondere i capelli bianchi. Dai rilievi delle tombe rinvenute si osserva come la caduta dei capelli fosse ritenuta un problema. La perdita iniziava dalla zona frontale della testa e con il passare del tempo si arrivava fino alla parte posteriore. Come ipotetici trattamenti, rinvenuti nel papiro medico o Papiro Ebers, venivano utilizzati i grassi di molte specie di animali (leone, ippopotamo, coccodrillo, gatto, serpente e stambecco) e provate diverse misture, come quella a base di miele e dente d'asino. Si conoscono numerose ricette a base cosmetica scoperte nei trattati medici egizi utilizzati nelle diverse epoche, fra cui quello riservato all’imbalsamazione, l’uso che questi avevano di conservare materialmente il corpo del defunto mediante il processo di mummificazione. La mummia adornata di gioielli e profumata, aveva la funzione di fornire il supporto indistruttibile al “ka” (11), e garantire la conservazione eterna di quella “bellezza” che l’egizio aveva perseguito nella vita terrena.
“I numerosi papiri che ci sono pervenuti e lo studio sistematico delle mummie, con le moderne tecnologie mediche, consentono di fare un quadro preciso sulle patologie degli Egizi e le relative terapie. Gli egizi non identificavano le malattie bensì cercavano le cause dei sintomi specifici, che secondo loro erano addebitabili, per lo più, ad agenti esterni che le loro cure tentavano di distruggere o di estromettere; questo modello eziologico era legato sia alla concezione dell'origine del mondo sia alle credenze sulle influenze delle forze superiori. L'esame delle mummie ha rivelato malattie quali arteriosclerosi, carie, artrite, vaiolo e tumore ma anche dalle raffigurazioni è possibile dedurre alcune patologie. Tra i minerali, usati in medicina, troviamo il natron, chiamato neteri cioè il puro, il sale comune e la malachite che curava le infezioni agli occhi ed era usata sia come farmaco che come cosmetico nella profilassi”(12).
I medici egizi visitavano il malato accuratamente ed una volta fatta la diagnosi prescrivevano la terapia contro il dolore, come ci dice il testo del "Papiro Edwin Smith". La maggior parte dei testi è scritta in ieratico, come il "Papiro Chester Beatty"; altri in demotico ed alcuni sono scritti su ostraca. Molte medicine sono state identificate ed erano costituite per la maggior parte da vegetali quali sicomoro, ginepro, incenso, uva, alloro, e cocomero. Anche il salice, tkheret in egizio, secondo il "Papiro Ebers" era usato come analgesico mentre del loto veniva usato sia il fiore che la radice ed era somministrato come sonnifero. I frutti della palma servivano per curare le coliti, allora molto frequenti; con l'orzo, si faceva la birra che serviva come eccipiente, o diluente, e con il grano veniva fatta la diagnosi di gravidanza. Gli Egizi usavano anche elementi animali quali la carne per le ferite, il fegato e la bile per lenire il dolore agli occhi. Di quest'ultima è stata attestata l'efficacia anche di recente. Il latte, sia di mucca,sia di asina che di donna, era integrato come eccipiente e il principio attivo più usato era di sicuro il miele che per le sue tante proprietà serviva per le patologie respiratorie, ulcere e ustioni, come recita il "Papiro medico di Berlino".
È scritto nel “Libro dei morti” (13):
“Sebbene la morte del faraone (Sethi I) non fosse giunta inaspettata, il dolore fu grande. In segno di lutto tutte le donne d’Egitto scoprirono i seni e corsero lamentandosi per le strade del regno, col fango del Nilo sul viso e il capo cosparso di terra. Per settanta giorni la terra delle Piramidi trattenne il respiro, cioè, per tutto il tempo necessario al processo di mummificazione che avrebbe conservato l’eterna bellezza del dio-re defunto”.
“Ed ecco, si aprono i chiavistelli della porta, che si schiude sui misteri del mondo inferiore …”, e sul duro lavoro dell’imbalsamazione, al fine di assicurare al defunto d’intraprendere il viaggio nell’al di là. Dal Papiro “Cha” conservato al Museo Egizio di Torino (14) leggiamo:
“Possa io entrare nella tua dimora, Osiride, con un aspetto più bello possibile, il più vicino possibile al Tuo, di suprema bellezza, e possa io vedere come tu vedi e udire come tu odi”.
Ed ecco, davanti ai nostri occhi perplessi, passano in sequenza le immagini ben delineate di tanti dipinti tombali scolpite nel basalto o sul duro porfido, e in tanti oggetti sacri come le tavolette dello scriba, e sui papiri. Di là dall’essere ieratiche, fissate nell’immanenza della morte, vediamo queste figure oltremodo vive, nitide come istantanee, intente nell’azione che stanno compiendo da millenni. In esse, la stretta associazione dell’idea della morte con la continuità della vita, si pone in assoluto, pertanto il concetto egizio della mummificazione va considerato concetto stesso della bellezza, oltremodo preziosa di un apparato estetico superiore, sviluppatosi insieme e in contrasto con la concezione religiosa che poneva nell’oblio la fine di ogni cosa; pressoché timorosa della morte al punto di lottare contro di essa fino allo stremo della sua genialità, e di riscattarla, infine, con la mummificazione del corpo.
La stretta associazione dell’idea della morte con la continuità della vita si poneva quindi in assoluto, come integrante dello spirito da cui si dipartiva ogni investigazione sull’esistenza terrena: (15)
“Celebra la bellezza che incontri ogni giorno, con ognuno dei tuoi sensi attenti e coscienti, e non stancartene mai. (..) Una delle più grandi gioie del mondo è la bellezza. Cercala e riconoscila dov’è. cercala ed esaltala dove non c’è. impiega cosmetici della tua donna, ornamenti e profumi per chi deve compiere il grande viaggio. Corone di fiori per gli dei. Se la bellezza ti sarà compagna sarai sempre felice”.
Il canto sopra riportato, è stato trovato su una tavoletta appartenuta a un’arpista del Medio Regno. Quello che più ci colpisce è il modo semplice, eppure profondo, dell’investigare nello spirito umano che, l’amico Fabrizio Felice Ridolfi (16), egittologo, inquadra: “nella concezione filosofico religiosa che investe tutta l’arte egizia, che non ha per fine di elevare l’anima verso il divino e neppure di suscitare un qualche piacere solo estetico, bensì, il precipuo scopo di agire e servire, perché, ed è questo il caso specifico, l’arte in Egitto, esercita un’azione creativa. Ancora più evidente se osserviamo la ricercatezza delle costruzioni e delle suppellettili tombali, le maschere funerarie e i ritratti statuari quali simulacri permanenti dei defunti”.
Tornando al primario significato di 'bellezza' secondo gli Egizi, apprendiamo che in egiziano antico “bello” si dice “nefer” (che è anche un nome di persona), e si scrive con un geroglifico che rappresenta uno strumento musicale, una sorta di liuto. Se per gli Egizi la musica fosse l’arte “bella” per eccellenza, non ci è dato sapere, perché è dovuto a una possibilità di omofonia della parola stessa. Come pure il plurale di Nefer comprende ciò che la bellezza rappresenta nel suo insieme e si combina in “nefru”, quale concetto stesso della bellezza contemplata. Il termine, infatti, significa contemporaneamente bello e buono, l’ideale quindi della bellezza abbinato a un valore etico che concorre a formare il “maat” (17), termine di difficile interpretazione, che racchiude in sé i significati “ordine, verità e giustizia”. In una parola: l’armonia cosmica. Pertanto, utilizzando l’energia mitica che lo animava, l’artista egizio ricreava oggetti e figuri a somiglianza della realtà secondo una concezione razionale dell’estetica delle forme, da cui l’estrema stilizzazione delle linee e degli spazi, che si rivelava, comunque, prodotto di un’azione creativa. E sempre, apponeva, accanto all’oggetto o alla persona, il nome lo identificava, allo scopo di prolungarne l’esistenza. Poiché dare un nome alle cose e alle persone, tramite la recitazione di una formula, significava “farle vivere” indefinitamente.
Come abbiamo avuto modo di apprendere, il concetto del “bello” presso gli Egizi, si concretizzava nel culto della bellezza corporea, finalizzata ad offrire se stessa in questa come nell’altra vita, davanti allo sposo o all’amante, e al cospetto di Osiride (18), dio e giudice del mondo ultraterreno, la cui intercessione avrebbe aperto il cammino verso l’eternità. Un esempio di come la cosmesi riempiva tutti gli spazi possibili nella vita come nella morte è data dalla maschera funeraria. Tra le più note spicca quella d’oro del faraone Tutankhamon, rinvenuta insieme ai paramenti faraonici nel 1922 da Lord Carnarvon e Howard Carter. Il ricco tesoro contenuto nella tomba, ritrovata intatta, ha permesso di conoscere le ragioni religiose da cui è derivato l’uso della maschera funeraria. Una prima maschera, eseguita per mezzo di un calco in gesso o argilla sul cadavere, serviva agli orafi e scultori per le loro opere. Della stessa fattezza doveva essere il canopo, il vaso che avrebbe contenuto le parti degli intestini e organi interni. Una maschera successiva, forse la più importante, riproduceva il volto del defunto con la sua espressione da vivo, interamente riprodotta e dipinta con creme cosmetiche, oli ed essenze profumate.
Il ritratto così abbellito del faraone Tutankhamon, trova una sua sbalorditiva somiglianza col dio idealizzato nella maschera d’oro ricoperta di pietre semipreziose; gli occhi di quarzo e ossidiana, mentre le orecchie presentano il lobo perforato per l’apposizione di orecchini. Sulla fronte, spiccano le teste del cobra e dell’avvoltoio emblemi della sovranità del Basso e l’Alto Egitto. Sul retro, la maschera, presenta incisa una formula magica, la sua acconciatura è di smalto vetrificato a imitazione del lapislazzulo, mentre l’estremità del pettorale è incrostata di veri lapislazzuli, quarzi e ossidiana, composti insieme in tanti piccoli boccioli di loto. Inoltre sono state trovate nella tomba anche tutte le parti del corpo riprodotte in oro, splendide creazioni orafe per la loro fattezza, addirittura le mani sono uno dei pezzi migliori di questo meraviglioso tesoro, eseguite a dimostrazione di quanto già detto, della maestria artistica cui gli “artigiani” egizi erano giunti.
L'antico popolo della Valle del Nilo ci ha lasciato più di mille ricette ma di sicuro qualcuna è solo molto fantasiosa come quella che, per combattere l'incanutimento consigliava l'uso di un topo bollito nell'olio. Olio di palma, ovviamente, perché l'ulivo arriverà molto più tardi, con la dinastia tolemaica. In Egizio il medico era detto sunu; il primo e più famoso fu di sicuro Imhotep e anche i sacerdoti potevano occuparsi di medicina come Sabni, che godeva del titolo di "Medico capo e scriba della parola del dio". Troviamo anche Hesyra, il primo medico dentista con il titolo di "Capo dei dentisti e dei medici" nonché scriba, come scritto nella sua tomba a Saqqara.
Nel tempio di Kôm Ombo, nell'Alto Egitto, vicino ad Assuan, sono raffigurati, sulla parte nord del recinto esterno, strumenti medici e chirurgici quali bendaggi, seghe, forbici, bisturi, forcipi e contenitori vari per medicamenti. Ma recentemente si è ipotizzato che fossero solo attrezzi rituali per cerimonie religiose. Accanto allo strumentario, vi sono alcune ricette mediche con tanto di componenti e dosi. Ma la chirurgia, non si sviluppò come la medicina. Forse per scarse conoscenze fisiologiche e per carenza di guerre. A conferma di ciò, sia il "Papiro Ebers" che il "Papiro Smith", detto anche "Libro delle ferite", citano solo dati clinici, pur molto precisi, ma non descrivono interventi chirurgici. Incredibilmente, vista la pratica religiosa di imbalsamare i morti, vi era scarsa conoscenza dell'anatomia e della chirurgia specialistica. Gli Egizi, infatti, intervenivano chirurgicamente solo in piccole patologie, come foruncoli o ascessi, o direttamente con l'amputazione di arti. Inoltre, pur avendo un'apparente rigorosità, tutte le pratiche mediche dovevano essere accompagnate da specifiche formule apotropaiche.
Nelle liste delle offerte che spesso accompagnavano i defunti figurano tipi diversi di oli cosmetici e belletti colorati all’interno di vasetti finemente cesellati o dipinti, che venivano posti accanto alla mummia. In alcuni papiri si trovano ricette per la preparazione di cosmetici a dir poco incredibili, come ad esempio quella contro l’imbiancamento precoce dei capelli che la regina Snesh, madre del faraone Teti, prescrive: una gamba di lepre, un nocciolo triturato di dattero, uno zoccolo d’asino contuso, e di far cuocere il tutto con olio in un vaso (djadia), e di massaggiare fortemente il cuoio capelluto. Un’altra ricetta prescrive invece di mescolare sangue di bue nero con olio per far tornare neri i capelli grigi. Le stesse proprietà erano attribuite alle ceneri ottenute dalle ossa di certi uccelli mescolate ad erbe aromatiche. Non mancavano ricette a base di solfuri di arsenico e calcio per far cadere i capelli alle donne rivali e far diventare vecchia e rugosa la loro pelle. Una ricetta per diminuire le rughe del viso impiegava resina di terebinto, cera, erba di Cipro e olio di meringa fresco.
Non possiamo parlare dell’ideale della bellezza senza nominare quelle regine che con la loro personalità e il loro fascino , in qualche modo hanno fatto la storia dell’Antico Egitto: Hatshepsut, Nefertiti e Cleopatra il cui gusto raffinato, la cura che avevano dei loro corpi e dei loro volti, lo sguardo ammaliante degli occhi allungati e dipinti, e lo splendore delle loro vesti ancora ci meravigliano. Maestri orafi arricchivano col loro operato la le numerose suppellettili, ornamenti e gioielli che le avrebbero accompagnate nell’al di là. Poeti dal verso delicato e ricolmo d’amore hanno immortalato le loro fattezze e la loro bellezza (19).
“L’anima creativa dell’Egitto è tutta plasmata in un panorama immutabile di arte, pensiero, forme, abbigliamento, oreficeria, scultura e pittura, erano dominate della concezione statica della bellezza, sublimata, invariabile nel suo aspetto esteriore, nel suo ritmo eterno. In realtà, la religione, fondata sul culto dell’eternità della vita, rimasta invariata nelle fondamenta per millenni, impediva all’egiziano di subire trasformazioni radicali”.
Guerre, vittorie, sconfitte, festeggiamenti, lutti: tutto sottostava a imperativi religiosi profondi, che fecero degli Egizi un popolo religiosissimo, secondo Erodoto, “il più religioso del mondo”. Ogni atto della vita era contrassegnato da un cerimoniale molto impegnativa che iniziava dall’organizzazione d’insieme, e riservato in primis al Faraone, e a seguire ai nobili e ai guerrieri, ma vietato al popolo che invece assisteva sbalordita. Davanti a tanto affollamento di dèi antropomorfi ma con fattezze zoomorfe, la variante della religione egizia, proiettava il credente verso quell’immortalità cui aspirava, avviandosi alla sopravvivenza ultraterrena. Ben per questo templi e palazzi, piramidi e tombe erano costruiti di sì fatte dimensioni colossali, era quello un modo per oltrepassare, superare il muro pur esistente tra la vita e la morte, un modo per resistere al costante devastazione del tempo e della storia.
Tornando a parlare della bellezza della donna possiamo affermare che la mitologia egiziana personificava la regina moglie del faraone in Iside (20) la bella dea “dal volto di luce”, vestita di una tunica di lino finissimo, spesso plissettato,con maniche a pipistrello, cintura molto alta portata sotto il seno, collo adornato con molteplici giri di collane più o meno preziose. Questo era definito un abbigliamento pudico, sempre che le regine egizie ne conoscessero il senso. Tanto che Nefertiti veniva spesso ritratta con indosso una tunica trasparente, aperta dall’ombelico in giù, sopra un esiguo perizoma. Un altro esempio è possibile ammirarlo nelle stupende figure delle “danzatrici”. Queste, di fatto, usavano depilarsi completamente, ed eseguivano le loro danze portando solo un’esile cintura fatta di perle e oro che sottolineava la loro nudità levigata.
“Il trucco, doveva essere adatto al proprio tipo – ne più ne meno come dovrebbe essere oggi e non lo è – soltanto che nel’Antico Egitto non poteva essere applicato da altri che non da se stessi. Ogni donna, infatti, aveva a sua disposizione tutti gli accessori e gli strumenti adatti a questo scopo e, ancor più, essa conosceva l’arte di mescolare e impastare le creme e le polveri e come ricavare le essenze necessarie. In poche parole, conosceva l’arte della cosmesi. Dapprincipio spalmava un fondo tinta bianco del tipo biacca, quindi tracciava il contorno delle labbra con un pennello sottile e riempiva gli spazi di rossetto colorato, che dava anche, in modo leggero, sugli zigomi e sulle tempie. La parte che richiedeva più cura e maggiore dispendiosità di tempo, erano indubbiamente gli occhi. Questi, erano allungati e ingranditi con un tocco di kohl nero, ombreggiato sulle palpebre con una polvere di colore verde, forse malachite, accentuati verso le sopracciglia con polvere grigia di antimonio o scura di galena, spesso arricchiti con arabeschi proiettati fin sopra le guance” (21).
Il grande “Occhio di Horus”, che possiamo ammirare in molte riproduzioni, era un simbolo di chiaroveggenza che favoriva la fecondità e tutelava la salute, ancor oggi visibile in forma di amuleto, divenuto simbolo programmatico di un futuro celeste, e non ne è rimasto affascinato? Ancor più ammaliato dalle testimonianze visibili della bellezza delle regine che sopra ho citato, a cominciare da Nefertiti (22), in egiziano antico: “la bella che qui viene”, consorte del faraone Akhènaton, vissuta nel medio Regno, e che a tutt’oggi rappresenta un enigma dell’archeologia. L’egittologo tedesco Richard Lepsius (23) che per primo rivelò la sua esistenza, rimase folgorato del suo meraviglioso aspetto al punto che si appassionò nel cercare di risolverlo, decifrarne ogni minima iscrizione parietale, fino a rintracciarne alcuni reperti della massima importanza per la storia e l’arte egizia, che il tempo non aveva del tutto cancellato: (24)
“La Bella e stupenda coronata di piume”
“La grande principessa ereditaria a palazzo”
“Immensa la gioia di chi ode la sua voce”
“Padrona d’ogni grazia”
“Massima favorita”
“Donna che dà letizia al Signore delle Due Terre”
“Da lui amata è la grande consorte reale”
“Amante della felicità”
“Bella è la bellezza del sole”
“La Bella che qui viene, viva in eterno”
È evidente che le iscrizioni a null’altra erano riferite che alla amatissima regina Nefertiti, che ben due generazioni di archeologi, con maggiore o minore successo, si sono sforzati di cercare. In realtà non si conosce l’esatta ubicazione della sua tomba che non è mai stata trovata, tuttavia il suo bel viso era destinato a diventare celebre. Gli egittologi sono oggi tutti concordi che il celebre busto del Museo di Berlino, rappresenta la regina Nefertiti all’età circa di venticinque anni. È comunque interessante conoscere i particolari del ritrovamento che permise di risalire alla grande regina. Ludwig Burkardt (25) che ne scoprì il busto, così lo racconta:
“Se dovessi descrivere questo ritrovamento com’è avvenuto, con i suoi scombussolamenti, le sue speranze e anche se sue piccole delusioni, il lettore sarebbe confuso come lo fui io. (..) La preziosissima opera d’arte era conservata in maniera quasi perfetta. Le orecchie erano leggermente scheggiate e le mancava l’occhio sinistro”.
Voglio qui dire della bellezza di un’altra regina, Hatshepsut (26) che più d’ogni altra può essere considerata il prototipo della donna egiziana. Figlia del Faraone Thutmosi I°, mentre era ancora in vita il padre, ne condivise il trono. Successivamente regnò accanto a Thutmosi II°, suo fratellastro nonché suo marito e, alla sua morte governò il paese per altri ventidue anni. Per obbedire alla tradizione che imponeva al Faraone una discendenza divina, Hatshepsut fece circolare una leggenda sulla sua nascita che la vedeva figlia di Ahmasi e del dio Amon. Decise inoltre di cambiare sesso pretendendo di essere chiamata “Figlio del Sole” e “Signore delle Due Terre dell’Alto e Basso Egitto”, titolo che spettava esclusivamente al Faraone. Tale fu la sua imposizione che si fece raffigurare sui monumenti ufficiali priva del seno e applicandosi al mento la barba posticcia della nobiltà. A lei si deve l’apertura di nuove vie di commercio con l’estero, l’organizzazione di spedizioni nelle terre lontane dove crescevano l’incenso, la mirra, l’opoponax, l’ebano. Regnò e assicurò al suo popolo un lungo periodo di pace. La sua tomba, scavata nella roccia, è tra le più imponenti dell’Antico Egitto, si trova a Deir el Bahari accanto a quella pure grandiosa di Ramesse II.
Della regina Cleopatra (27) è stato detto che, “se avesse avuto un altro naso, forse il corso della storia sarebbe stato diverso”. Un ennesimo riconoscimento dell’importanza determinante dell’estetica e della cosmesi, giunte con questa regina all’apice della raffinatezza. Famosa per la sua pelle morbidissima data dai continui bagni di latte di mandorle cui si sottoponeva, si vantava di impiegare tutti i prodotti cosmetici del “Papiro Ebers” (28), il più antico pervenuto. Abbellita dai cosmetici e adornata di gioielli e profumata Cleopatra viene ricordata per le sue doti sensuali e voluttuose, e per la sua sfrontata audacia che la vide opporsi allo strapotere romano facendo innamorare di lei ben due Cesari. L’immagine scultorea che la ritrae, al British Museum, ancora oggi è ammirata per la sua affascinante bellezza. Galeno di Pergamo (29) cita alcune sue ricette cosmetiche contro la calvizie a basa di zolfo e ceneri di animali. Plutarco rammenta le sue composizioni di oli e unguenti profumati che dovevano mantenere giovani. E quando Ippocrate passeggiava con i suoi adepti nell'isola di Coo, disquisendo sui mali dell'umanità, altro non faceva che trasmettere il sapere degli Egizi che, con i loro papiri, hanno tramandato i primi fondamenti della medicina e chirurgia.
Poiché è la musica che ci interessa, riporto qui i versi di un anonimo arpista del Medio Regno (30):
“Celebra la bellezza che incontri ogni giorno
Con ognuno dei tuoi sensi attenti e coscienti,
e non stancartene mai”.
La musica dell'Antico Egitto ha origini molto remote. Fu tra le prime civiltà di cui si hanno testimonianze musicali. Per gli egizi la musica aveva un ruolo molto importante: la leggenda vuole che sia stato il dio Thot a donarla agli uomini. Intorno al V millennio a.C. vennero introdotti i primi strumenti musicali, quali bacchette, tavolette e sonagli, utilizzati in rituali totemici. Le danze erano soprattutto propiziatorie alla caccia, magiche, di fecondazione e di iniziazione. Nell'Antico Regno si creò l'usanza dell'orchestra composita, comprendente vari flauti, clarinetti e arpe arcuate, con un'ampia cassa armonica. Si trovano poi i crotali, il sistro, legato ad Hathor, la tromba, utilizzata in guerra e sacra ad Osiride, i tamburi, il liuto ed il flauto, sacro ad Amon.
Durante il Medio Regno si introdussero il tamburo, la lira e alla danza rituale si aggiunse quella definibile professionale ed espressiva, in quanto aveva lo scopo di intrattenere lo spettatore. Il tipico strumento egizio, il sistro vide, in questa epoca, un allargamento del suo utilizzo. Strumenti più sofisticati dovettero attendere più a lungo. I primi ad apparire dopo le percussioni furono gli strumenti a fiato (flauto, corno) e a corde (lira e cetra), di cui esistono testimonianze greche, egizie e mesopotamiche anteriori al X secolo a.C. Queste civiltà conoscevano già i principali intervalli fra i suoni (quinte, quarte, ottave), che erano usate come base per alcuni sistemi di scale. Da uno studio di Oliver Sachs (31) sull'accordatura delle arpe è emerso che gli Egizi utilizzavano una scala pentafonica discendente e che conoscevano la scala eptafonica. Purtroppo non è stata rintracciata nessuna notazione musicale, quindi poco o nulla si sa sulle melodie dell'antichità egizia.
Va qui ricordato che l’arpa è forse il più antico strumento costruito dall’uomo pervenutoci al mondo, alcuni esempi di arpa sono stati rinvenuti nelle tombe faraoniche, come quella splendida facente parte del tesoro di Tutankhamon. Al suono dell’arpa, mentre dalle rive del maestoso Nilo sale il mormorio del grande fiume, come un lamento, come un canto, siamo certi di aver colto, almeno in parte, il segreto dell’incantesimo della bellezza. Lì dove l’immagine si propaga, nella luce rarefatta delle sabbie, si posa lo sguardo al lontano passato dell’Egitto faraonico, cui l’esigenza estetica appartiene ai grandi ideali del passato.
Oggi il senso estetico è soltanto diverso da quello di ieri, appare scomparso solo a chi considera il “nuovo” nemico dell’antico e guarda al futuro come una minaccia nei confronti del passato, anziché come una promessa di traguardi più avanzati. Se si considera che fin dal Medio Regno il clima dell'Egitto era molto più caldo rispetto a quello attuale e consentiva quindi di vestire poco e assai semplicemente, è facile comprendere come, per parlare di intrattenimento musicale e alla danza di allora, potesse far riferimento a un uso libero dell’abbigliamento. Farsi notare o meglio, esprimere se stessi creando un effetto visivo, sembra essere stata da sempre l’esigenza più importante della moda in ogni epoca. Non da meno gli egizi consideravano l’abbigliamento della massima rilevanza estetica.
“Nell'Antico Regno gli uomini usavano un perizoma oppure un gonnellino dall'estremità sovrapposte che durante le dinastie si trasformò allungandosi fino alle caviglie e caratterizzato da pieghe e trasparenze. Il torace era coperto con una stola di tessuto: molto usato era il colore bianco e il tessuto di lino mentre la lana non era gradita per motivi religiosi, in quanto la pecora come animale vivo era considerato impuro. I nobili usavano adornarsi con gioielli e usavano sandali in papiro o legno di palma con lacci di cuoio, come quelli recentemente trovati nella tomba di Henu. Le donne usavano tuniche aderenti lunghe con una o due bretelle. Successivamente divennero ornate di complessi disegni e colorate ma la maggior caratteristica fu l'impiego del sottilissimo trasparente lino, chiamato bisso, e delle cinture. Sempre durante il Medio Regno si incrementò l'uso di gonne lunghe e di stoffa a pieghe sul busto lasciando le braccia scoperte” (32).
Fu proprio durante il Medio Regno che l'abito, divenuto più complesso, acquisì svariate fogge atte ad individuare la classe sociale di appartenenza come si evidenzia nelle immagini funebri. Le donne rappresentate sulle stele funerarie sono sempre a piedi nudi al contrario degli uomini che invece portano i sandali. Entrambi usavano nelle cerimonie un cono profumato sulla testa e le donne si ornano con un fiore di loto. Anche il sovrano portava sia il gonnellino che la gonna lunga ma di suo uso esclusivo era il nemes. Poteva portare pettorali in oro con pietre e smalti, la corona e lo scettro. I sacerdoti usavano una veste di lino e la caratteristica pelle di leopardo. La testa era rasata e spesso coperta con copricapo di cuoio.
I militari usavano un perizoma con una protezione triangolare in cuoio pesante davanti all'addome. La testa era protetta dal sole con un copricapo di stoffa e in caso di battaglie con semplici elmi di cuoio. Stavano generalmente a torso nudo ma per proteggersi potevano indossare una camicia. Il popolo ovviamente si abbigliava in maniera diversa dai nobili, sia per motivi economici che pratici. Semplici calzoni, gonnellini, quando addirittura non lavorassero nudi, sia uomini che donne. I giovani fino alla pubertà erano nudi e con la caratteristica treccia di capelli laterale. È da notare che la nudità, di adulti e ragazzi, era costume abituale come ancora oggi avviene in molte etnie.
*
ETNOMUSICOLOGIA – 4 *
ETNOMUSICOLOGIA – 3 *
QUADERNI – 3 La comunicazione vocale. Biografia: *
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGICA 2 - di Giorgio Mancinelli. *
*
ETNOMUSICOLOGIA – 2 “La teorizzazione del paesaggio sonoro è stata sviluppata da diversi elementi, come le toniche (keynote sounds), i segnali (sound signals) e le impronte sonore (soundmarks)”. Nella terminologia elaborata dal World Soundscape Project per “tonica” s’intende un termine musicale riconducibile all’armonia tonale che indica sia la prima nota di una scala, sia una funzione armonica di stasi, e sta a indicare un suono della natura: il vento, l’acqua, le foreste, gli uccelli, gli insetti, gli animali, che potrebbe non essere sempre udito coscientemente, ma che pure evidenzia il carattere delle persone che vivono in quel luogo. Per Segnali s’intendono tutti quei suoni in primo piano, uditi coscientemente, come dispositivi d’allarme, campane, fischietti, corni, sirene, ecc.; mentre per Impronte sonore è la rilevazione di un suono caratteristico di un’area: una volta che un’impronta sonora è stata identificata, meriterebbe di essere protetta, perché le impronte sonore rendono unica la vita acustica di una comunità". *
QUADERNI DI ETNOMUSICOLOGICA *
ETNOMUSICOLOGIA – 1
Voglio però chiudere con una provocazione: che cosa ci diversifica da questi nostri progenitori nilotici? È questo un tema che si potrebbe affrontare per una ulteriore ricerca che non vuole essere solo di costume, rifletteteci e scrivetemi. Come ha detto Emilio Pucci (33): “La moda del nostro tempo è moda che prende coscienza delle diversità del nostro pianeta e polarizza elementi e temi tipici di paesi lontani. Una volta esauriti i temi esotici le differenze che ancora distinguono civiltà e località geografiche diverse, la moda del nuovo cittadino del mondo metterà in valore quelle esigenze di espressione individuale che sono proprie dell’essere umano quando è libero di affermare il proprio pensiero e la propria personalità”.
Bibliografia:
Evelyn Rossiter “The Book of The Dead” – Liber – Fribourg Genève 1979.
Gianfranco Nolli “Canti d’Amore dell’Antico Egitto” – Ediz. Civiltà Uomini Paesi -
Franco Cimmino “Vita Quotidiana degli Egizi” – Rusconi - Milano 1985.
Sergio Donadoni “L’Uomo Egiziano” – laterza – Bari 1982.
Anna Maria Donadoni-Roveri “Civiltà degli Egizi: La vita quotidiana” – Museo Egizio di Torino – Electa 1987.
Anna Maria Donadoni-Roveri “Civiltà degli Egizi:Le Credenze Religiose” – Museo Egizio di Torino – Electa 1987.
Anna Maria Donadoni-Roveri “Civiltà degli Egizi:le Arti Della Celebrazione” – Museo Egizio di Torino – Electa 1987.
Fondazione Memmo – The Getty Conservation Institute “Nefertari: Luce d’Egitto” –Catalogo della Mostra – Leonardo Arte 1995.
Marilina Betrò, Valerio Simini, “Sono venuta correndo a cercarti. Canzoni e musica nell'antico Egitto”, Edizioni ETS, Pisa 2010.
Discografia:
“Ancient Egypt”, a tribute composed and performed by Ali Jiad Racy,Lyrichord 7347 – New York – 1977. ricerca su papiri e pitture egizie, intesa alla ricostruzione degli antichi strumenti e alla postura delle mani da parte dello studioso A. Racy, per questa unica registrazione di brani ispirati all’antico Egitto. Contiene canti funebri e lamentazioni, inni e straordinari brani musicali veramente ispirati.
“Egitto : Epica1”, Haib H. Touma – Fonit Cetra – I suoni 1980. Contiene narrazioni epiche della letteratura egiziana, la struttura poetica, i vari tipi di esecuzione.
“The Egyptian Music”, Soliman Gamil, Touch 1987, contiene brani di ispirazione melodica, dedicati al Nilo.
“Charcoal Gypsies”, The Musicians of the Nile – Real World LC 3098 1996, contiene brani di musica egiziana, delle tribù nomadi.
“Nubian Travels”, Mahmoud Fadl e The Drummers of the Nile, contiene brani di musica strumentale, soprattutto percussioni. - Piranha 2001.
“Danse égyptienne classique”, Ro-He – EUCUD 1082 – 1988.
Note:
(1)Paul Bowles, “Il tè nel deserto” – Sugar 1965.
(2-3-4-5) Edda Bresciani “Letteratura e Poesia dell’Antico Egitto” – Giulio Einaudi Edit. Torino 1969.
(6-7-8-9-10) Paolo Rovesti “Alla ricerca dei cosmetici perduti” – Blow Up Milano.
(11) “ka” in “Dizionario dell’Antico Egitto”, a cura di Guy Rachet - Newton Compton Ed. Roma 1991. Ka, è la forza vitale, principio di vita e potenza, l’essere, la persona, l’individualità, è uno dei concetti spirituali egiziani di cui più difficilmente si può offrire una spiegazione. Infatti, il senso che veniva attribuito a questa parola ha subito nel corso dei millenni una serie di variazioni ed ha presentato la tendenza ad arricchirsi di significazioni nuove. Di conseguenza ha talvolta assunto i caratteri di genio, dio protettore e doppio spirituale, una “proiezione vivente e colorata della figura umana, un doppio riproducente fin nei più infimi dettagli l’immagine intera dell’oggetto o dell’individuo a cui appartiene” (Maspero). Per altri studiosi invece, il ka, (il cui omofono era il toro), esprimeva la potenza generatrice e la forza sessuale, ma anche principio di vita e di potenza, la forza vitale a supporto della vita fisica e spirituale. Per gli Egiziani morire significava ricongiungersi al proprio ka, in cui si è potuto scorgere anche “l’aspetto di un genio della razza, che preesiste all’individuo, cresce con lui e poi, senza morire, riceve il defunto nel suo seno” (Moret). Ogni individuo ne era dotato alla sua nascita, come delle sue caratteristiche personali e del suo destino.
(12) Boris de Rachewiltz “Il Libro dei Morti degli Antichi Egizi”, Papiro di Torino – Mediterranee – Roma 1958.
(13) Mika Waltari “Sinuhe L’Egiziano” – Rizzoli - Milano 1950. (La Storia di) Sinuhe, sorta di autobiografia romanzata di Ammenemes I (primo faraone della potente XII dinastia), e personaggio del noto racconto pervenuto attraverso numerosi papiri e alcuni frammenti conservati su ostraka (conchiglia, coccio di ceramica), su cui venivano redatti lettere e addirittura copiate opere letterarie di ogni genere.
(14) Maat, è la regola eterna, anteriore alla specie, incarnazione della giustizia umana, destinata a sopravviverle. È rappresentata sotto forma di donna dal capo ornato da una piuma ( la piuma è il simbolo del suo nome nei geroglifici). La teologia ne faceva la figlia del Sole (Râ), dio “a cui nulla sfugge” e padre del faraone, nonché dispensatore della giustizia in questo mondo. Era Maat ad essere offerta dal re durante il culto divino ed era lei, o per meglio dire la piuma che la simboleggiava, a costituire il contrappeso del cuore sulla bilancia interpellata da Anubis in occasione del giudizio di Osiride. Maat rappresentava anche l’ordine universale, la legge grazie alla quale il mondo sussisteva nell’armonia, la forza per la quale la creazione di Râ, suo padre, non sarebbe mai più ricaduto nel caos primordiale.
(15) Osiride, divinità salvatrice e sotterranea dai molteplici attributi, tra i quali quelli di “Giudice Supremo delle anime” e “Sovrano del Regno dei Morti”. Nel corso dei millenni, la personalità di Osiride si è alimentata di tanti e tali elementi da pervenire ad esiti estremamente complessi, pur se coerenti nella loro linea di sviluppo, ma comunque sempre compatibili con la sensibilità di popoli che vivevano una religione salvifica fondata su un uomo-dio che aveva conosciuto una “passione”, e l’aveva fatto tra gli altri uomini”. Ci si è sforzati di vedere in questa figura un personaggio storico, forse il primo che, durante il periodo predinastico abbia unificato i clan del Delta o persino l’Egitto intero. Osiride è in relazione con le acque del Nilo, alle quali il suo corpo dona la forza fecondatrice. In alcune versioni del culto osiriaco egli infatti, invece di discendere il Nilo in una bara di fortuna, viene direttamente annegato nel fiume. Dio fecondatore, Osiride è anche signore della vegetazione e, come questa, muore nel periodo dell’inondazione per rinascere a primavera, dopo aver soggiornato sottoterra come il grano seminato. Inoltre la leggenda eliopolitana ha fatto di Osiride un dio cosmico. Tale concezione si spiega solo se si ammette che, fin dal predinastico il sovrano defunto fosse assimilato a Osiride. Alla fine dell’Antico Regno Osiride venne anche assimilato al “Dio Grande”, celeste, come prima di lui il dio Horo., e quindi possessore di un carattere ctonio che ha contribuito a consolidare il mito.
(16) Gianfranco Nolli, in “Canti d’Amore dell’Antico Egitto” – Ed. Civiltà Uomini Paesi -
(17) Edda Bresciani, op. cit.
(18-19) Fabrizio Felici Ridolfi, egittologo socio emerito del Museo Egizio di Torino: “Scritti inediti” relativi alle conferenze sull’Egittologia tenute presso il Centro Culturale – Ambasciata d’Egitto a Roma.
(20) “Iside – Il Mito Il Mistero La Magia” – Catalogo Mostra. Electa - Milano 1997.
(21) Paolo Rovesti, op. cit.
(22) Karl Richard Lepsius, fu uno dei pionieri dell'egittologia e della moderna archeologia. uno dei primi allievi di Jean-François Champollion. Inoltre viaggiò in tutta Europa, visitando le collezioni egizie e perfezionandosi in litografia e nello studio delle incisioni. Fu professore di Egittologia all'Università di Berlino e Direttore del Museo Egizio della città. Tra le sue opere: Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät. 13 vol. Berlin: Nicolaische Buchhandlung. (Ristampato Genève: Éditions de Belles-Lettres, 1972) ritenuto il capolavoro di Lepsius in 12 volumi sulle iscrizioni dell'antico Egitto e della Nubia; ancora utile oggi. Nel 1842 Karl Richard Lepsius guidò una esplorazione nel Basso Egitto ed elaborò una lista di tutte le piramidi esistenti. Lepsius le numerò partendo dal nord, iniziando da Abu Rawash. In seguito è stato dimostrato che alcune di queste strutture non erano vere piramidi, però tuttora la lista di Lepsius fornisce la base per la catalogazione delle piramidi egizie.
(23) Edda Bresciani, op. cit.
(24) Johann Ludwig Burckhardt, è stato un esploratore e orientalista svizzero, noto anche con il nome francese di Jean Louis (da lui preferito) e con quello inglese di John Lewis. I suoi scritti, raccolti in 350 volumi, e la sua collezione di 800 manoscritti orientali sono stati lasciati in eredità all'Università di Cambridge, diversi dei quali sono stati raccolti e pubblicati postumi. Tra le sue opere: Travels in Nubia. (con memorie biografiche) (1819), Travels in Syria and the Holy Land. (1822), Travels in Arabia. (1829), Arabic Proverbs, or the Manners and Customs of the Modern Egyptians. (1830), Notes on the Bedouins and Wahabys. (1831)
(25) Phlilipp Vanderberg “Nefertiti” – Sugar - Milano 1985.
(26) Hatshepsut, Nella seconda metà del XX secolo,con lo sviluppo del movimento femminista, le donne con un ruolo preminente nell'antichità vennero alla luce e la loro vita venne enormemente pubblicizzata. La biografia di Hatshepsut, scritta da Evelyn Wells, offre un'immagine romanzata, dipingendo la regina come una bellissima donna, pacifista, definendola «la prima grande donna nella storia» distaccandosi quindi decisamente dall'immagine maggiormente accreditata nel XIX secolo, che voleva Hatshepsut come una strega, una matrigna che aveva usurpato il trono di Thutmose III. Cimmino, Franco - Dizionario delle dinastie faraoniche - Bompiani, Milano 2003 - Hasepsowe e Thutmosis III. Gardiner, Alan - La civiltà egizia - Oxford University Press 1961 (Einaudi, Torino 1997) - Hayes, W.C. - Egitto: la politica interna da Thutmosis I alla morte di Amenophis III - Il Medio Oriente e l'Area Egea 1800 - 1380 a.C. circa II,1 - Cambridge University 1973 (Il Saggiatore, Milano 1975). Wilson, John A. - Egitto - I Propilei volume I -Monaco di Baviera 1961 (Arnoldo Mondadori, Milano 1967)
(27) Philipp Vanderberg “Cesare e Cleopatra” – Sugar - Milano 1985.
(28) Dal "Papiro Ebers" apprendiamo che, come droga, si usava l'oppio, chiamato shepen e importato da Cipro, sia per il dolore che per il pianto dei bambini. In alcune raffigurazioni della tomba di Sennedjem, è stata riconosciuta la mandragola, in egizio rermet, usata come sonnifero e per le punture d'insetto. Esisteva anche la cannabis, shenshenet, che veniva somministrata, in particolare per via orale e per inalazione, ma anche per via rettale e vaginale, mentre l'elleboro era usato come vero e proprio anestetico, ma in maniera empirica e con dosaggi errati tanto che spesso il malato passava direttamente dalla narcosi alla morte.
(29) Galeno di Pergamo, (129 – 216) fu un medico greco antico, i cui punti di vista hanno dominato la medicina europea per più di mille anni. L'autorità di Galeno egemonizzò la medicina, in tutti sensi, fino al XVI secolo. La maggior parte delle opere greche di Galeno sono state tradotte da monaci nestoriani nel centro medico e universitario della sasanide Jundishapur, in Persia. Gli eruditi musulmani le tradussero presto in arabo, assieme a quelle di molti altri classici greci, trasformando la sua opera in una delle fonti principali per la medicina islamica e per i suoi migliori esponenti quali Avicenna e Rhazes. Tali opere raggiunsero dunque l'Europa occidentale sotto forma di traduzione latina dei testi arabi. I suoi seguaci, nella convinzione che la sua descrizione fosse completa, ritennero inutili ulteriori sperimentazioni e non procedettero oltre negli studi di fisiologia e di anatomia, un campo nel quale il primo serio cambiamento avverrà solo con Vesalius. Saranno proprio le indagini anatomiche di Andrea Vesalio, a dimostrare l'inesistenza nell'uomo della rete mirabile, facendo cadere uno dei cardini della sua fisiologia e dando inizio alla confutazione e al superamento del suo impianto teorico. L'avvento della iatrochimica, infine, contribuì ulteriormente al declino della medicina galenica. Galeno si occupò anche di religione. A proposito, ad esempio, di ebrei e cristiani ritiene che essi siano dei filosofi, ma ritiene anche che manchino loro gli strumenti di conoscenza perché non avevano ancora elaborato il contenuto della loro fede. Su di lui: Nicoletta Palmieri, L'antica versione latina del 'De Sectis' di Galeno. (Pal. Lat. 1090), Ets, 1992. D. Manetti (curatore), Studi su Galeno. Scienza, filosofia, retorica e filologia. Atti del Seminario svolto a Firenze (13 novembre 1998), Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Danielle Gourevitch, I giovani pazienti di Galeno. Studio per la patogenesi dell'impero romano, Roma-Bari, Laterza, 2001 (trad. C. Milanesi). F. Adorno, T. Gregory, V. Verna, Manuale di Storia della Filosofia 1, Laterza, 1996. Galeno, Trattato sulla bile nera, a cura di Franco Voltaggio, Nino Aragno Editore, 2003. Jean De Maleissye, Storia dei veleni. Da Socrate ai giorni nostri, Bologna, Odoya, 2008.
(29) Edda Bresciani, op. cit.
(31) Oliver Sachs,
(32) Paolo Rovesti, op. cit.
(33) Emilio Pucci, presentazione a “La moda nei secoli” di Mila contini – Mondadori –Milano 1969. - Musica
- Musica
Etnomusicologia 4 - Maschere e Body Art
“MASCHERE & BODY ART” di Giorgio Mancinelli con la partecipazione di Paolo Rovesti.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto: Maschere Rituali”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RAI Radio Tre; per “Il canto della Terra” su RSI radio della Svizzera Italiana).
In apertura di questo capitolo di ricerca scientifica dedicato alla maschera e al tatuaggio, non posso fare a meno di ricordare il professor Paolo Rovesti (1), già Presidente d’Onore del Comitato Internazionale di Estetica e Cosmetologia della Società Italiana dei Chimici Cosmetologi (di cui è stato fondatore) e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti; Membro dell’Accademia Italiana di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma, dell’Accademia di Dermatologia di Parigi e di numerose altre associazioni scientifiche italiane e straniere. Al quale, in passato, sono stato legato da profonda amicizia, e che ricordo con stima e grande affetto. Le ragioni che mi spingono a questo sono molteplici, legate soprattutto alla collaborazione prestatami nell’organizzare la serie di trasmissioni radiofoniche “Maschere Rituali” (2), cui egli prese parte attivamente con suoi scritti e intervenendo personalmente in più di un’occasione. Inoltre si rende qui necessario citare almeno due delle sue opere “importanti” per la nostra ricerca sul campo. “Alla ricerca della cosmesi dei primitivi” (3), e “Alla ricerca dei profumi perduti” (4) che, in qualche modo, hanno fornito le basi per la ricerca “antropologica” da cui si è partiti.
Così egli scrive (quasi il buon vecchio che ci racconti una bella fiaba): “La giungla intatta dei primordi, con la sua flora spontanea, fitta e polimorfa, con i suoi grandi alberi ombrosi, con la sua fauna squittente e scattante, coi suoi straordinari colori, era l’ambiente predominante dell’uomo primitivo che vi si trovò immerso nel suo cammino per la sopravvivenza. Con grande cautela, sgrovigliando ramaglie e sterpi che ostacolavano il suo cammino, egli cercò di dilatare il suo spazio vitale nella ricerca di procurarsi del cibo. Ed ecco, in una pausa della sua polivalente attività, sorgergli accanto un fiore d’ibisco, rosso come il sole e vivo come la fiamma, a dirgli che non era solo, che la silenziosa compagnia di un piccolo fiore, talvolta, andava considerata come un piccolo dono che la natura fantasmagorica di colori, di aromi, e di suoni, sarebbe stata con lui, per la sua gioia e il suo immenso piacere. L’incontro con le misteriose solitudini della natura quindi, c’era stato, adesso egli avrebbe dovuto scoprire tutto quanto rimaneva da scoprire, e la natura si sa ha i suoi lati oscuri. Era ancora troppo sconosciuta per non incutere in lui quel timore riverenziale e quell’angoscia carica di preoccupazione di cui egli difficilmente si sarebbe liberato”.
È vero, poche cose nella vita hanno un carattere di eternità quanto la bellezza che ci accompagna, con i suoi costrutti, le sue premure ma anche con la sua fragilità, tuttavia ricolma di cosmica armonia. L’esigenza estetica nasce da questo, come un istinto cosciente rivolto all’armonia, nel voler dare un aspetto e una forma migliore alle cose, disporle a proprio gusto e piacimento, dare alla “bellezza” che pur esiste già nella natura, un ordine, una tendenza, una sollecitazione capace e intuitiva.
“I primitivi – scrive ancora il prof. Rovesti – furono i soli a lasciarsi guidare dall’intuizione nella scelta degli adornamenti e dall’estro estetico della natura, dal proprio senso istintivo della bellezza. Le terre, i fiori, i frutti, i semi, essendo reperibili in forme e colori diversi, vennero utilizzati per ogni tipo di ornamentazione: collane, ghirlande e bracciali di champaca, gelsomino, frangipani, basilico selvatico, vaniglia e gardenia, fresie etc. “importanti” non solo per i loro colori ma anche per i loro profumi. Anche le conchiglie e altri prodotti del mare, abbondantemente reperibili sulle spiagge e lungo gli anfratti costieri, come la madreperla, il corallo, il guscio di conchiglie, si sono rivelati preziosi nella creazione di oggetti ornamentali per gli usi più diversi. Tra i più apprezzati spiccano i denti di squalo e le ossa di balenotteri spesso usati come amuleti per forme diverse di superstizione. Penne di uccelli e pelli animali, da sempre sono fatte oggetto di adornamento per i nativi aborigeni delle grandi foreste, per le gamme multicolori e la varia lunghezza, monocrome e variegate, a ciuffo o piane, ricche di sfumati e brillanti colori che hanno rivestito, in modo davvero affascinante, i corpi nudi delle popolazioni indigene”.
È detto nella strofa di una canzone Sasak: (vedi discografia)
“Splendono nel cielo uccelli multicolori / con le loro penne mi sento come loro / più leggero e più bello / per danzare con la mia tribù”.
Lo stesso accadeva con le pelli di animale, a chiazze, a strisce, in tinta unita, con pelo folto o rado, con morbidezze cangianti, cui erano attribuiti significati magici di una certa rilevanza. Ma era la pelle di felino, giaguaro, puma, tigre, leopardo, a essere considerata portatrice di forza e coraggio; mentre quella di serpente significava astuzia e quella di scimmia agilità. Utilizzati per scopi diversi gli amuleti ricavati dalle zanne e dalle ossa di questi animali sono per lo più entrati a far parte della vasta gamma degli “amuleti” integrativa del costume dei primitivi, spesso legati a riti tribali di oscura provenienza con motivazioni propiziatorie e animiste. Per lo più vengono indossati nella foggia di orecchini, anelli nasali, ciondoli e collane, ma anche come cavigliere e sonagli, altresì usati a supporto di estensioni del corpo e come strumenti di chirurgia, come ad esempio nelle scarificazioni (5).
Riporta una tradizione orale del Borneo:
“Questo fiocco di cordicelle colorate per contarle e guardarle, farà perdere del tempo allo spirito maligno che vorrebbe colpirmi, e tutti questi denti e spine e schegge di ossa, saranno per lui come una siepe irta che non gli permetterà di passare”.
“Questi oggetti – ci dice ancora il prof. Rovesti – insieme con altri manufatti più complicati, sono entrati in seguito a far parte dell’abbigliamento quotidiano dei primitivi, come parti essenziali di un mascheramento più complesso con implicazioni religiose e mitiche che, per una peculiarità prettamente psicologica, richiedono di coprire tutto il corpo facendo anche uso di maschere facciali e copricapo molto elaborati. Fibre vegetali e paglia intrecciata, diversi tipi di legno inciso i pirografato, tela e argilla, liane intessute, teste di animali sono di gran lunga le materie utilizzate per questa vestizione che si rivela poi come vero e proprio mascheramento dell’uomo nelle sembianze dell’animale che rappresenta, e comunque della natura che lo circonda. Allora si ha l’uomo-giaguaro, il “dio” della foresta, il “dio” dell’acqua; oppure l’uomo-albero, l’uomo-vento ecc., e sempre il risultato è sorprendente, anche quando i mascheramenti raffigurano qualcosa di spaventoso”.
Numerosi studi antropologici hanno rilevato che l’uso del mascheramento, o con maschere, anche solo basato sul travestimento, trova riscontro nella forma di comunicazione tipica di ogni tradizione orale, cioè sostitutiva di un dialogo linguistico che non poteva esserci e che andava rammentato. Non c’era miglior modo quindi che trasformare il linguaggio vocale in linguaggio visivo, allo scopo della memorizzazione. L’interpretazione di un costume riferito a un mito rappresentava il mito stesso che s’incarnava nel quotidiano, in mezzo alla collettività che era chiamata a partecipare. Poiché ogni aspetto della vita tribale doveva necessariamente rapportarsi con la realtà sociale/tribale di questo o quel gruppo l’utilizzo di maschere tipiche usate a scopo rituale non era semplicemente una forma d’arte come la possiamo intendere noi, bensì era tutt’uno con la realtà che la comunità si trovava a vivere, anche se, e questo accadeva molto spesso, la miticizzazione di questo o quell’aspetto degli eventi naturali risultavano trasformati, che noi diremmo, concetti astratti.
La “magia” quindi, utilizzata per sopperire a ciò che in astratto non era spiegabile con le parole, è la nascita della rappresentazione visiva, della musica in funzione dell’accompagnamento al rito, alla nascita del mito dell’eroe, della tragedia (casuale o necessaria) che l’incombe nel suo divenire mito. Potremmo finanche dire che siamo di fronte alla prima forma di comunicazione collettiva che, passando attraverso “l’arte” (canto e musica, pittura decorativa e abbigliamento, maschere e ornamenti, cosmesi facciale e body-decorated), si rappresenta all’interno di un linguaggio universale che ci accomuna e ci rappresenta. È la scatola magica del cinema e della televisione di oggi, il cui linguaggio più affermato è rappresentato dalla pubblicità.
Al fine della nostra ricerca è questo l’Eldorado che stavamo cercando. È nella prospettiva del ritrovamento di un linguaggio accomunante che la ricerca assume una dimensione assai più ampia, che fuoriesce dagli schemi di un programma precostituito, atrofizzato dentro etichette e didascalie polverose, che diventa percezione, riflessione, stimolazione dei sensi, sollecitazione. L’aprirsi di spazi non convenzionali, nella nuova ottica di veicolo di scambio e di comprensione. Molti sono i segni dell’attualità soprattutto fra le nuove generazioni che spesso vediamo adottare riti e d espressioni dei costumi del passato, e non solo. Non ne sono avulse certe scienze umanistiche che hanno riposto certe perplessità e che rivolgono maggiore attenzione alle culture orali e comunque primitive. Vuoi per una nuova lettura più approfondita, forse mancata a suo tempo, e che oggi si propongono come innovatrici nella ricerca di temi “etnologici” che hanno sempre avuto sotto gli occhi.
Il tema del mascheramento e dell’utilizzazione delle maschere è uno dei più dibattuti e interessanti nello studio antropologico ed etnologico per le interazioni che ha subito nel tempo e presso i diversi popoli. Ancor più, perché porta all’analisi della personalità dell’uomo e dei suoi tabù, di quelli che sono i suoi “problemi atavici”, preconcetti e illogicità compresi. Quelli che Ernesto de Martino (6) definisce “ancestrali incertezze” e che hanno dato luogo al dramma della “crisi della presenza” riconducibile all’età “magica” dei cosiddetti primitivi. “Un’età – scrive De Martino – in cui l’uomo subì il rischio di essere annullato dalle forze naturali, incommensurabili e incontrollabili”. E che l’uomo, a incominciare proprio dall’uomo primitivo, ha rappresentato nelle forme della sua arte e che si presenta a noi ricco di stimoli e di tensioni importanti per la ricerca qui avanzata, nelle espressioni pittografiche e scultoree del passato ma, ed anche, del canto e della musica, così come nella pittura decorativa e nell’abbigliamento, nelle maschere e negli ornamenti, nella cosmesi facciale e nel body-decorated. Ma andiamo con ordine.
“Lo studio della maschera – prosegue il prof. Rovesti durante l’intervento in trasmissione – possiede un grande fascino, soprattutto perché, come allora, il suo utilizzo esalta la fantasia. Sono state ritrovate maschere che rendono un’espressione sorridente oppure tragica, altre spaventevoli, legate ai culti di divinità demoniache che ancora oggi mantengono il loro “spirito” malefico, ovviamente dettato dalla loro espressione rivolta all’uomo. Altre invece sembrano più rassicuranti e, guarda caso, sono quelle che prendono a soggetto la natura e gli animali. Il che starebbe quasi a che l’uomo è il contenitore del male mentre ciò non riguarda la natura che lo circonda”.
Una dicotomia, quindi, come per dire che la maschera è la rappresentazione di spiriti del male o di esseri protettori dell’uomo?
“Psicologicamente parlando, chi indossa la maschera o la disegna sulla pietra, o ancora la raffigura nell’argilla, che sia con il ferro o il legno, con la stoffa o la paglia, si esalta nella sua funzione, non in ciò che essa rappresenta. Tuttavia è cosciente di non incarnare ciò che appare alla vista altrui; ma in quanto portatore o attore, egli entra nella sfera del sacro e se ne sente responsabilmente partecipe. Talè è la forza che possiedono certe maschere nella psicologia tribale, ad esempio dei neri d’africa”.
Una forma di intermediazione tra l’uomo e la divinità o l’essere mitico che rappresenta?
“Difficile rispondere, forse sì, è così, la maschera mette a diretto contatto l’’umano col soprannaturale, utilizzando una lingua complessa ricca di simbologie, di cui solo gli iniziati riescono a comprenderne il profondo significato che essa pure gli trasmette”.
Ciò vale ad affermare ciò che qualcuno ha stereotipato in “Io non sono io, sono un altro!”?
“È in questa dimensione che lo sciamano che appare sullo spiazzo del villaggio o dell’accampamento provvisorio, per dare inizio a una danza “magica” non è in realtà lui”.
Cioè non è più la stessa persona che tutti conoscevano come “l’uomo medicina”?
“Di certo non è la persona di prima in virtù della maschera. Facendo uso della maschera, egli appartiene ad un’altra sfera di percezione, entra in contatto con le forze misteriose che regolano l’universo. È qui, che noi contemporanei ci perdiamo, nella nostra incredulità”.
Ci vuole fare un esempio?
“Ecco, i fanciulli e le donne Papua delle piccole isole Kiwai, credono fermamente che gli attori mascherati, siano realmente gli spiriti dei defunti. E gli anziani fanno tutto il possibile per rafforzarli nella loro credenza raccontando loro anche menzogne a riguardo. Resta il fatto che gli stessi anziani prendono molto sul serio quello che a prima vista potrebbe sembrare un gioco. Per loro, se gli attori non sono gli spiriti dei morti, poco importa, perché gli spiriti stessi sono però presenti alla cerimonia”.
All’origine di ogni forma di mascheramento sta, come si è detto, la determinante necessità da parte dell’uomo , di sentirsi partecipe delle forze che animano il mondo, e la peculiarità di dover collaborare con esse, sfruttarne e sublimarne così le proprie facoltà istintive. L’uso che si fa delle maschere e spesso di “idoli” ad esse connessi in cui l’aspetto terrificante, talvolta unito all’uso di sostanze allucinogene, permette alle comunità che ne fanno uso, la suggestione collettiva, stimolata ed esercitata dallo sciamano sugli iniziati dell’intero gruppo. Chi la indossa spesso riesce ad esternare la virtù segreta che la maschera custodisce in sé e di trasmettere un particolare messaggio, sia esso di culto o di origine mitica su cui è improntata la loro vita sociale e che regolamentano la loro la loro esistenza dalla nascita alla morte.
Professore ci dica qualcosa riguardo l’autosuggestione (7).
“Indubbiamente occupa un posto predominante su tutto l’apparato rituale da e totemico nei riti d’iniziazione. In breve, è codificato entro un’iconografia tradizionale tramandata oralmente di generazione in generazione, con maschere e l’uso di cosmetici di grande effetto decorativo, eseguiti in onore degli idoli cui sono rivolti, e officiati con riti sacrificali, canti e danze con grandi effetti coreografici. Che talvolta però, si caricano di fin troppa atmosfera magica, come ad esempio nel voodoo haitiano o nella macumba brasiliana, in cui la presenza “divina” non è possibile eliminare senza svuotare di significato il rito stesso. Soprattutto, cosa che non è ancora stata detta, la maschera o il mascheramento in sé, è il mezzo che permette la presa di contatto con il mondo soprannaturale”.
Non ricordo però di aver visto vere e proprie maschere nella macumba brasiliana, non so se nel woo-doo haitiano…?
“Come abbiamo già detto il mascheramento, qualunque esso sia è già la maschera, e allo stesso modo richiede l’osservanza di regole precise e atti rituali inderogabili. Atti che sono per lo più autorizzati dai capi spirituali o dagli sciamani che di solito presiedono all’investitura nei riti iniziatici, cosiddetti anche “riti di passaggio” (8) e che, di solito, si presentano sempre dipinti nel corpo o mascherati”.
Questo fenomeno è verificabile in tutte le cerimonie religiose di qualsiasi rito anche oggigiorno: si veda il Sindaco della Città con la fascia, il sacerdote sull’altare di qualsiasi confessione ecc. Giovanni Vignola (9), in “Riti magici di ieri e di oggi” sottolinea questa particolarità scrivendo: “Se l’officiante, il sacerdote, il pastore, il bonzo o il muezzin, non avessero uno o più segni distintivi che li fanno diversi dagli altri, o che li rendono idonei alla funzione cui sono chiamati a svolgere, e che li abilitano e li autorizzano a fare da intermediari fra due mondi diversi, non soltanto la cerimonia cadrebbe nel ridicolo ma perderebbe la sua intrinseca efficacia”.
Che cosa ci dice professore?
“Astraendoci da una qualsiasi locazione geografica precisa, l’uso della maschera o il mascheramento, compare nella storia dell’umanità fin da epoche relativamente remote, in diretto rapporto tra esigenza magico-religiosa e necessità quotidiana della ricerca di evasione, nell’esperienza di esistenze diverse, come pure, non dimentichiamolo mai, nell’identificazione con le forze della natura, nel connubio uomo-animale e uomo-divinità”.
Quindi torniamo di nuovo sul piano psicologico!
“È inevitabile, del resto lo dice anche il Vignola (sopracitato), dove appunto egli scrive: … la maschera offre l’opportunità per l’evasione, quasi un alibi direi per evadere; permette che l’evasione si completi nello spirito e nella figura … . In effetti cosa succede quando guardiamo una maschera? La nostra prima impressione è proprio che dietro di essa non si nasconda un uomo in carne ed ossa, con un corpo come il nostro, con gli occhi, il naso e la bocca come i nostri, ma una creatura mostruosamente fantastica, che ci riempie di curiosità e di sgomento, ma anche di timore, non è forse così?”
In definitiva, dobbiamo ammettere che la maschera è principalmente un mezzo per occultare noi stessi, come dire, per non essere riconosciuti dagli altri?
“Il principio è sicuramente quello, anche se nella civiltà contemporanea questa tendenza si è andata affievolendo, anche perché la così detta “mascherata” è nata a scopo di divertimento e di piacere, prima di divenire occasione di gioco riservato ai bambini”.
Già, i grandi preferiscono il travestimento.
“Piuttosto, direi che i grandi hanno perduto il gusto di recitare una parte che in realtà poi recitano, talvolta anche nel peggiore dei modi, facendo in modo che gli altri non se ne accorgano, o meglio fanno finta di non accorgersene, solo perché recitano anche loro. È altrettanto chiaro che tutto questo porta a una grande solitudine, a quella “solidào” che i brasiliani, più d’ogni altro popolo, sentono e trasmettono nella loro musica”.
Del resto, come rileva Franco Monti (10) – “… la maschera è sempre attuale e i suoi molteplici usi investono ogni attività dell’uomo di ogni epoca, pur senza trasgredire a l’ordine iconografico che la raffigura; essa non rappresenta l’emozione del singolo, non descrive figurativamente l’uomo che teme, che combatte o che muore; è essa stessa il “timore”, “la guerra”, “la morte” … nella sua identificazione con le forze universali divine o demoniache la maschera rende sempre più incerti i confini che separano l’uomo dalla natura o dall’animale, o dallo spirito che si trova a perpetuare che lo rende simile alla divinità”.
Lasciamo il mondo delle maschere vere e proprie per introdurre il prossimo contesto della nostra ricerca improntata sul “tatuaggio” che prima di far parte della body-art va riferito a una forma di cosmesi intuitiva sul filo di situazioni ambientali e psicologiche all’interno di differenti realtà tribali. Come e in quale misura i popoli primitivi abbiano impiegato alcune materie prime e quali mezzi tecnici hanno escogitato per creare forme di bellezza diverse, e di rilevanti scoperte fatte dall’etno-cosmesi. Tematiche queste che saranno di volta in volta illustrate dal prof. Paolo Rovesti e che ci permetteranno di conoscere come la maschera cosmetica dei primitivi si sia inserita nell’evoluzione dell’arte, certo in maniera effimera, nella moderna cosmesi.
“Tattoo & Scarificazioni”
Alla base di questa ricerca comparativa che vuole anche essere un’inchiesta sulle diverse forme di comunicazione visiva e artistica, e la gestualità e i modi comportamentali, dall’uomo primitivo a quello moderno, del perché ci si tatua, la psicologia del tatuaggio e i suoi significati, del perché ha influenzato intere generazioni su scala mondiale e abbia influenzato nel profondo il comportamento sia degli uomini che delle donne. A incominciare dai cosi detti “mosaici” corporali ottenuti con l’ausilio di minuscole tessere lisce di legno o di pietre colorate che vengono applicate sulla pelle preventivamente preparata con disegni rituali e fissate con sostanze adesive, usate nelle feste e nelle cerimonie iniziatiche e, particolarmente, per segnare il numero dei figli o degli adepti di una setta, o nel caso di amputazione e forme di mutilazione tribale. Un esempio lo sono la limatura dei denti incisivi nelle popolazioni dell’Africa e l’uso di incastonare pietre di solito preziose o semipreziose, sullo smalto dei denti dell’ultima moda, già praticata in India e da alcune popolazioni sud sahariane.
È noto che l’immagine del proprio corpo da sempre ha provocato un effetto considerevole sui comportamenti degli uni verso gli altri. Alcuni studiosi hanno rilevato l’importanza per i due sessi di stabilire le loro prerogative sentimentali e sessuali: il sesso maschile, quella di possedere un sesso di più grandi dimensioni; quello femminile di possederne uno più piccolo, ma dotato di seni e glutei più grandi, anche se indubbiamente sono cambiate molte cose. È evidente che esiste una correlazione fra l’autovalutazione del proprio corpo e la ricerca di giudizio positivo da parte del sesso opposto. Non a caso molte persone sono considerate più attraenti di quanto esse stesse credono e viceversa.
Così amuleti, costumi e ornamenti finiscono con l’essere sotto controllo di chi li indossa a scopo apotropaico, cioè servono ad allontanare o ad annullare influssi magici maligni, in modo da ottenere particolari effetti negativi provenienti dagli altri, e che invece oggigiorno vengono esposti per una forma di narcisismo. A questo desiderio di comunicare, che è considerato esigenza primaria dell’uomo, fa riscontro un desiderio più grande che è quello di esprimersi. Scrive Edmund Husserl (11): “Fra ciò che veramente mi appartiene io trovo solo il mio corpo che si distingue da tutti gli altri per una particolarità unica. È il solo corpo all’interno dello strato astratto ritagliato da me nel mondo, al quale, conformemente all’esperienza, io coordino, in modi diversi, campi di sensazioni”.
Desmond Morris (12) nel suo famoso “L’uomo e i suoi gesti” rileva quanto segue: “L’indossare abiti è soltanto uno dei modi in cui l’animale uomo si adorna . Ma oltre a vestirsi, egli si può incidere la pelle, forare la carne, tagliare i capelli, profumarsi, dipingersi gli occhi e le labbra, incipriare la faccia e limare i denti, truccarsi, mettersi parrucche, travestirsi con forme di abbellimento che operano come importanti esibizioni umane, che indicano lo stato sociale, la condizione sessuale, la disponibilità individuale, l’alleanza di gruppo”. Ma si tratta di ornamenti per lo più temporanei. Le decorazioni costanti, quelle che comportano qualche forma di mutilazione fisica, sono forse quelle più tipiche del linguaggio visivo che danno l’avvio alla nostra ricerca improntata come si è detto sul tatuaggio.
Il progredire del senso estetico porta successivamente al compiacimento di sé, a un incipiente narcisismo che fa scoprire nuovi mezzi naturali per arricchire sempre più il proprio corpo con colori, ornamenti e forme estetiche originali. Creatività che raggiunge valori e livelli notevoli nel tatuaggio, un’espressione cosmetica usata per gli scopi più diversi. Ci dice il professor Rovesti: “Per le figurazioni più semplici la reazione cutanea è di solito poco dolorosa, ma per quelle più estese si può verificare una reazione edematosa più o meno intensa e dolorosa che però scompare in pochi giorni. Se i tatuaggi sono limitati a pochi punti, di solito costituiscono solo segni di riconoscimento fra tribù, ma quando interessano tutto il corpo significa che si perseguono scopi ben diversi, estetico, religioso, propiziatorio, medico, magico”.
Può farci degli esempi?
“I tatuaggi più complessi e appariscenti li troviamo tra i melanesiani e i polinesiani; tatuaggi che occupano nei capi e nelle persone di maggiore importanza nella tribù, quasi la totalità del corpo. Si conoscono diverse preferenze di tatuaggio che in un certo senso segnano la diversità tra i vari popoli anche dello stesso continente”.
Quali parti del corpo sono prevalentemente sottoposte al tatuaggio?
“Sono preferite le spalle e le natiche, il volto, il petto negli uomini nel caso si tratti di etero tatuaggi, mentre gli auto tatuaggi di preferenza sono l’avambraccio, le cosce, la zona palmare sinistra, le dita della mano sinistra. In realtà è più nella simbologia e nella grafia che si trovano queste differenze. Nelle isole Cook, ad esempio, troviamo numerosi i tattoo sugli organi genitali maschili; mentre nelle isole Ponape troviamo in prevalenza tattoo sugli organi di riproduzione femminili. Curiosa può risultare l’usanza di farsi tatuare la lingua dalle vedove nelle isole Sandwich, o di farsi tatuare il cranio calvo dei vecchi nelle isole Marchesi. Mentre invece a Tahiti troviamo quasi esclusivamente tatuaggi sui seni e i glutei femminili con uccelli, lucertole, pesci, mani maschili. Nelle isole della Sonda alcune ragazze adornano la loro bocca con corone di fiorellini tatuati. Nelle Caroline, appena una fanciulla diviene donna si fa tatuare un triangolo sul basso ventre più o meno vistoso, senza il quale, nessun uomo l’avvicinerebbe”.
Non si pensi che mi sia dimenticato della nostra ricerca primaria riferita all’etnomusicologia applicata. Se la tematica sembra non dover lasciare spazio alla musica o al canto, è solo perché in questa specifica trattazione scritta, non c’è lo spazio materiale per l’ascolto, in cui l’ascoltatore è chiamato a partecipare della ricerca musicale che accompagna i testi. Cercherò di rimediare con un’ampia sezione discografica di riferimento, di cui ci si potrà avvalere per indurvi all’ascolto di alcuni brani che ho scovato nell’ampia discoteca che ho raccolto nei miei frequenti spostamenti in giro per il mondo. Come in questo caso del brano “saka” registrato nell’isola di Bellona in Melanesia, cantata durante il tattoo di una isolana per distrarre la sua mente dal dolore. La canzone, più semplicemente “canto per il tatuaggio” è stata composta da un esponente di questa cultura dal nome originale “Mautikitiki” (13). L’accompagnamento è costituito dal suono di un bastoncino che scandisce il picchiettio dell’ago a imitazione del tatuaggio reale. Una pratica interrotta solo da pochissimi anni.
Esistono quindi diverse tecniche di esecuzione del tatuaggio? – chiedo al professor Rovesti.
“Il tattoo per infissione è certamente quello più diffuso nei paesi che ce lo hanno trasmesso, quali l’Oceania, Melanesia, Nuova Guinea, Tasmania e in alcune zone centrali dell’Australia dove, ancora oggi, sopravvivono un gran numero di popolazioni allo stato aborigeno. Mentre in Africa è maggiormente in uso la scarificazione, in India e nei paesi arabi troviamo il tatuaggio per puntura sulla fronte, sul mento e sulle mani, e solo raramente si sono visti casi di tatuaggio totale, come ad esempio presso alcuni popoli della Siberia”.
Immagino si riferisca al rinvenimento archeologico dell’uomo tatuato di Pazyryk nel massiccio montuoso dell’Altai?
“Certamente, anche se non ho sufficiente documentazione per parlarne”.
Ho raccolto alcune notizie stampa e sono venuto a conoscenza che si tratta di uno dei più importanti ritrovamenti d’interesse antropologico del secolo, avvenuto tra le sepolture della vallata da cui ha preso il nome. Il corpo completamente tatuato, sembra appartenesse a un capo o forse uno stregone di una tribù nomade risalente addirittura al IV° V° secolo a. C. giunto fino a noi grazie alla protezione del gelo che lo ha mantenuto in buono stato di conservazione, insieme agli animali e gli oggetti con cui era stato sepolto. A Pazyryk (14) nella regione dei monti Altai (Siberia - Russia) è presente un gruppo di circa 40 tombe preistoriche rinvenute dall' archeologo Rudenko nel 1920. Queste tombe (del quinto secolo avanti Cristo), quasi tutte violate durante la storia, fin’ora hanno restituito 3 corpi, imbalsamati, ben conservati e, quasi incredibile a dirsi, ricoperti di splendidi tatuaggi. I Pazyryk erano cavalieri con la passione per la caccia, pastori pronti a combattere per aggiudicarsi i pascoli migliori ed artisti erano a stretto contatto con il mondo naturale - un mondo che comprendendo leopardi della neve, aquile, renne - favoriva in questi artisti la propensione a rappresentare animali fantastici.
Uno di questi corpi apparteneva quasi certamente ad un capo, un uomo dalla corporatura possente, intorno ai 50 anni. Sul suo corpo, disegni vari che rappresentano una varietà di creature fantastiche e non. I tattoo ancora riconoscibili ci mostrano un asino, un ariete, cervi stilizzati dalle lunghe corna ed un feroce predatore sul braccio destro. Due bestie mostruose decorano il torace e sul braccio sinistro si intravedono figure che sembrano rappresentare due cervi ed una capra. Dal piede al ginocchio si dipana il disegno di un pesce, un mostro sul piede sinistro e sul polpaccio quattro figure di arieti in corsa si uniscono a formare un solo disegno. Sul dorso piccoli cerchi in corrispondenza della colonna vertebrale. Si tratta dunque di una ridda di animali fantastici che sembrano “in movimento” su quel corpo come esseri viventi: “una moltitudine di animali reali e immaginari, saltanti sulle prede, galoppanti, scalpitanti o fuggenti, che corrono alla rinfusa sulle due braccia, su una parte della gamba destra, sul petto e sul dorso. I motivi erano stati ottenuti per mezzo di punture nelle quali veniva iniettata della fuliggine. Una tecnica già conosciuta che è rimasta per lo più la stessa da allora.
Un altro rinvenimento di cui si è molto parlato, risale al 1993, anno in cui l'archeologa Natalia Polosmak (15) scoprì la tomba di una donna soprannominata poi "La Dama di Ghiaccio". Sotto i corpi di 6 cavalli sacrificati all'occasione, la dama giaceva in una tomba ricavata da un tronco di larice. La tomba è decorata da immagini di cervi e leopardi delle nevi intagliate nel cuoio. Il corpo, adagiato come se si fosse dolcemente addormentato, apparteneva ad una ragazza sui 25 anni dai capelli biondi, alta circa 1,65 m. Anche la dama presenta diversi tatuaggi (di un blu intenso) sulla sua pelle chiara: creature dotate di lunghe corna che si compongono in immagini floreali. Due anni dopo il marito dell'archeologa, Vyacheslav Molodin (16), scopriva il corpo di un altro uomo, con un elaborato tatuaggio raffigurante un alce, due lunghe trecce, sepolto con le proprie armi.
Si pensa che, come nel caso di Oetzi (17), nelle Alpi italiane dove, nel 1991 è stata trovata una mummia databile al IV millennio a.C.. con bellissimi tatuaggi, il che lascia pensare che anche queste antiche popolazioni adoperassero il tatuaggio a scopi lenitivi, ma in questo caso ottenendo allo stesso tempo risultati dalla grande valenza artistica. Non si conosce come venissero eseguiti i loro tatuaggi, ma è probabile si servissero degli stessi finissimi aghi utilizzati per creare tessuti e tappeti, arte nella quale erano maestri.
“Come vediamo dalle date se ne ricava che la storia del tatuaggio inizia con la storia dell'uomo in epoca preistorica (uomo di Cro-Magnon, 35000 – 10000 a.C., e Neolitico, VIII – IV millennio a.C.). Grazie ad alcuni ritrovamenti di statuette con segni geometrici sul corpo, si suppone che gli uomini, dotati dell'abilità di ricavare colori da minerali e vegetali, utilizzassero strumenti appuntiti per realizzare segni permanenti sul corpo”.
Ma c’è un altro fatto da prendere qui in considerazione ed è il mondo dell’immaginazione e la raffigurazione legato ad animali fantastici, come motivo ricorrente nel tatuaggio. Rammento che in una mostra che poi ha fatto il giro dell’Europa sugli “Ori degli Sciti” gli animali fantastici e “straordinari” vi erano frequentemente raffigurati: leoni con la testa di bue, grifoni rampanti, tutti resi nella dinamica del movimento.
“Ancor più ne troviamo nei tessuti e nel cuoio, o parzialmente ricoperti d’oro che oggi abbelliscono corpetti, giubbe e selle delle popolazioni siberiane. E che non sono soltanto belle a vedersi ma riflettono di una cultura che richiederebbe però uno studio più approfondito nell’ambito dell’artigianato e dell’arte”.
Ma che dobbiamo rimandare ad altra sede e in un altro momento. Per adesso soffermiamoci ancora sull’aspetto, come dire, cosmetico del tatuaggio. Cosa ci dice in proposito?
“Non si tratta di un accessorio cosmetico inutile o di pura e semplice decorazione occasionale, bensì che riveste un significato profondo e importante, come quello che si è dimostrato in alcuni popoli con diversa cultura dalla nostra, addirittura lontana migliaia di anni da noi contemporanei che lo facciamo quasi per metterci alla prova. Si pensi il dispendio di tempo, di pazienza, di sacrificio e di dolore fisico che chi vi si sottopone deve affrontare. Ovviamente chi vi si sottopone lo fa con convinzione di aver accolto in sé qualcosa che gli altri non hanno, una sorta di “tesoro” di bellezza che porterà per sempre sulla propria pelle”.
A questo proposito ho scovato i versi di un ritornello polinesiano che dice:
“Ho imprigionato bellezza nella mia pelle e nessuno potrà mai rubarmela, nemmeno gli spiriti del male”.
Passiamo quindi alla scarificazione e la mutilazione, in uso ancora oggi anche fra i popoli civilizzati, e dovute a pratiche segrete di casta e di culto, quando non appartengono a residui di stregoneria legata alla magia. Professore, vuole dirci di cosa si tratta?
“La scarificazione è in fondo una forma di tatuaggio ben più dolorosa, praticata in certe regioni dell’Africa Centrale che, dato il colore della pelle scura, non permette tatuaggi colorati. Si praticano piccoli tagli sulla pelle per mezzo di coltelli di osso, conchiglie assottigliate, o pietre aguzze affilate, con una lama molto bassa, su disegni lineari o curvilinei non complicati, spesso geometrici, formati da punti che si rincorrono, lineette oblique, ecc., in modo da lasciar penetrare polveri di sabbia o di cenere o sostanze irritanti ricavate da piante, in modo che dopo alcuni giorni formano cicatrici sottocutanee che riproducono i disegni e le forme desiderate”.
Però non si notano tagli o cicatrici visibili, talvolta sembrerebbero dei piccoli semi a fior di pelle, è così?
“A vista d’occhio si, ma la pratica richiede un accorgimento speciale alfine di ritardare la guarigione immediata delle cicatrici, provocando la formazione di cheloidi rilevate e dure per irritazione continua delle ferite, e che porta al risultato ben visibile e tattile cui molte popolazioni africane non possono fare a meno, per loro sarebbe assai difficile essere ammessi all’interno del proprio gruppo tribale”.
C’è qualche altro pratica che vuole illustrarci?
“Si, un altro metodo è l’ustione, praticata con punte roventi in modo da provocare ferite superficiali che lasciano cicatrici in superficie molto evidenti che, provocano dolore più che qualsiasi altra pratica. Chi vi si sottopone fa spesso uso di allucinogeni per ridurre la sofferenza”.
Lo stesso immagino valga anche per la mutilazione?
“Esempi di quelle che sono considerate specie di mutilazioni si riscontrano presso tutti i popoli distribuiti sulla terra, anche fra i più sperduti delle isole del Pacifico, come ad esempio gli “orejones” dell’Isola di Pasqua più conosciuti col nome di “uomini dai lunghi orecchi. Una pratica che prevede l’introduzione di ossicini o pezzetti di legno sempre più grandi nel lobo forato degli orecchi. Addirittura di portare grossi pesi che col tempo permettono l’allungamento della cartilagine. A questa pratica non viene risparmiato neppure il naso o addirittura le labbra e la conformazione della bocca, e non solo a scopo ornamentale”.
Vuole farci degli altri esempi?
“Gli accessori che fanno da ornamento al naso, specialmente in India, in Nuova Guinea e in Papuasia, ma anche in Africa e in Polinesia, sono indicativi di una casta sociale o talvolta religiosa. Si tratta di ossicini o di anelli inseriti nel foro anche di grandi dimensioni, praticato all’interno di esso nello spessore che separa le narici. Ad esempio, in Nuova Guinea e nelle Isole Salomone è in uso inserirvi un osso trasversale così lungo da coprire l’ampiezza del viso. Per quanto riguarda le labbra e la bocca, si conoscono mutilazioni del tipo degli anelli labiali portati dalle donne di alcune tribù africane: si tratta di dischi di legno mobili che deformano le labbra e che all’occorrenza servono anche come piatto per il cibo. Presso alcune tribù Padang si usa inserire anelli metallici o rivestiti di perline colorate al collo delle bambine, sempre più grandi man mano che crescono, fino ad allungarlo all’inverosimile, le quali, addirittura, non potranno mai più toglierselo perché si è impedito lo sviluppo della muscolatura del collo, per cui, in mancanza di questo supporto non riescono a mantenere il peso della testa”.
E riguardo alle mutilazioni vere proprie?
“Se consideriamo mutilazioni anche le pratiche di circoncisione relative ai riti d’iniziazione e religiosi, la depilazione totale del corpo eseguita presso gli egizi, o il taglio dei capelli rasato, o il rifacimento del seno e dei glutei dell’odierna chirurgia plastica, possiamo ben dire che la mutilazione vera e propria ha avuto inizio in età preistorica per non essere ancora giunta alla fine. L’espianto degli organi interni è rintracciabile fin dai tempi preistorici; mani dipinte che presentano mutilazioni sono visibili nelle caverne preistoriche in Francia e Spagna; deformazioni del teschio erano praticate tra gli Egiziani, i Maya, gli Aztechi; l’impedimento della crescita dei piedi in Cina e Giappone ecc.”.
E dire che si voleva parlare della bellezza e trovare in essa l’ispirazione al canto e alla poesia che ha ispirato moltissima letteratura e, in campo musicale, una certa linea canzoni ad essa riferite. Ma troveremo il tempo per parlare anche di quelle. Per adesso mi limito a parlare di poesia in quanto il tatuaggio, incredibile a dirsi, nasconde o esterna, come preferite una sua forza poetica nel contrasto armonioso dei colori sulla sfondo della pelle, con l’ambiente e spesso con il clima tropicale in cui viene esposto. Ma è soprattutto poesia la sintonia del tatuaggio con il suo padrone, talvolta con la sua ingenuità, con la padronanza che ha di sé, o come segno di riconoscimento e tale è la sua motivazione che rivela il suo modo di essere e di pensare.
Canta una ragazza polinesiana: (vedi discografia)
“Mi sono scelta i miei compagni / che nella loro casa dentro la mia pelle / non mi lasceranno mai sola. / Sono uccellini e fiori dai vivaci colori. / E quando abbraccio il mio amore / mi sembra di sentire sommessamente / sulla mia pelle / con le sue carezze, i cinguettii e i profumi squisiti dei fiori”.
Sorge evidente che la pratica del tatoo non serve soltanto a trasferire segni sulla pelle, ma ha motivazioni diverse e complesse. Mentre per i primitivi, di cui ne abbiamo dimostrato la necessità, facciamo ricorso al fatto che lo praticavano come norma di costume, e che quindi mantenevano una certa purezza d’intenzione e una loro poesia di fondo, possiamo ben intuire come a confronto, prevale in noi moderni una certa sofisticazione riferita alla moda, grazie anche a fatto che l’evoluzione tecnologica ha ridotto di molto l’effetto dolore. Dobbiamo ammettere che la pratica del tatuaggio oggi si pone in disaccordo con la natura, sia con l’ambiente urbano che ci circonda, sia con l’abbigliamento che lo nasconde, e ancor più con quella poesia, talvolta benevola, altre oscura, nell’uso discutibile che ne fa la moda. Non è invece da considerare solo una moda la pratica del “piercing”, tornata in auge in occidente al seguito dell’esperienza in musica del punk. In parte autentica e in parte mimetizzazione di un coraggio di cui andare fieri, l’uso di spilli, barrette, anelli, infissi nelle guance e nel naso, nelle orecchie e le sopracciglia, sulle labbra e sulla lingua, colorazioni indelebili del viso, lenti a contatto di diversi colori, e altri accessori da falsare le ciglia o le palpebre degli occhi, è espressione di un disagio profondo in cui il nostro corpo non ci basta più, la nostra sicurezza interiore necessita di prove per essere poi messa al bando a fronte di un vuoto culturale che non ha eguali.
Colgo l’occasione per farvi leggere il bellissimo racconto di un pescatore somalo il quale porta tatuato sul petto, il volto della sua ex ragazza.
“Questa è Liré, la mia ragazza scomparsa in mare non più di un anno fa. Qui ride col capo rovesciato all’indietro, come faceva quando le parlavo d’amore. la sua vera tomba è qui, dove pulsa il mio cuore, dove ella può ancora vivere il dolce ricordo. E qui, si anima della luce del sole, del moto che faccio quando esco in mare, dell’argento lunare che la rendeva adorabile, delle mie parole e dei miei baci. Da un lato all’altro del viso ci sono i fiori che lei amava tanto; sopra e sotto i pesciolini d’argento che ora le tengono compagnia nel profondo del mare” (18).
Sembra di leggere un ingenuo Lee Masters, tanto è limpida la sua dimensione poetica raccolta nel tatuaggio che porta nel cuore. È il canto di un uomo nudo, solitario che osserva il mare, quanto mai ricco di un gioiello sentimentale che oggi può venerare al pari di un idolo. A questo proposito si potrebbe parlare della superstizione che accompagna il tatuaggio che vede la sua creatura incontaminata da sovrapposizioni fantastiche, quanto invece infervorata da un profondo credo. Il tatuaggio (in generale), porta con sé un retaggio favoloso di tradizioni estetiche e rappresenta l’esempio più toccante di una tradizione artistica mai venuta meno. È indubbiamente una forma dell’arte naturalistica, spontanea come solo può essere una sorgente, per dire una trasfigurazione della realtà in una zona viva come la pelle.
Non c’è dubbio che molti tatuaggi vanno attribuiti alla superstizione latente che stenta a scomparire e che ritroviamo nella riproduzione di “ferri di cavalli”, “corna”, “chiavi” ecc. usati contro il malocchio e la iattura, così come anche ve ne sono detti di scongiuro a forma di “stella”, “lampada”, “fiore”, “bandiera”; o di vendetta come di “teschio” o di “testa recisa”, di “cassa da morto”, di “cuore morso dal serpente” o “trapassato dal ferro di un pugnale” con l’aggiunta spesso di motti e scritte di difficile interpretazione, ma è proprio qui, nel messaggio che si rappresenta, nella veridicità della sua funzione, che il tatuaggio esprime il suo linguaggio poetico e virtuoso, tutta la sua forza comunicativa che le parole, talvolta, non possono o non riescono a esprimere.
Formule magiche di sicura origine onomatopeica, fonosimbolica e imitativa, accompagnano spesso i disegni e le figurazioni propiziatorie contro le influenze del male. Fra questi vanno ricordati i tatuaggi dei pastori della Lombardia e dei pellegrini al santuario di Loreto, che consistono in una croce sovrapposta a una sfera o a un cuore, a una stella, e riferiti all’immagine del sacramento, al santo Patrono, ai simboli della Passione. In altre regioni, come la Romagna e l’Abruzzo, ad esempio, è in uso il monogramma di Cristo, spesso ridotto a una H maiuscola. C’è però un altro tipo di tatuaggio di cui vorrei qui parlare, ed è quello a scopo erotico/indicativo. Che ne dice professore?
“I tatuaggi con soggetti erotici e comunque eseguiti su quelle parti del corpo cosiddette erogene, tanto scarsi fra i primitivi, sono invece frequenti fra i marinai, i soldati, i carcerati, i delinquenti, e solo recentemente fra la gente comune. Vi figurano ideogrammi riferiti a prove d’amore, e piccole poesie amorose dedicate ora a questa o quella donna, ma solo raramente, immagini di lussuria e oscenità, che vanno riferiti a promesse fatte o a giuramenti”.
A quale simbologia si rifanno?
“Per lo più, possiamo dire che dimostrano “un carattere osceno” distinto dagli altri dato dalla loro estensione ma, anche, perché spesso sono eseguiti in parti invereconde. Diversi da altri che si contraddistinguono in specie che sono di “castigo” o di “sfregio”, o come abbiamo già detto, di “vendetta””.
Vi sono poi quelli di tipo informativo.
“Soprattutto nelle associazioni criminose, dove il tattoo serve a indicare i gradi gerarchici, così come, ad esempio, avveniva nella vecchia Camorra in cui, una lineetta e un puntino servivano a indicare il giovanotto onorato; una lineetta e due puntini il “picciotto”, una lineetta e tre puntina il camorrista vero e proprio. Il tatuaggio allora chiamato in gergo “devozione”, così detto perché suppliva al santino che suggellava la sua spavalda identità, il gusto spacconesco, l’estro picaro della Camorra”.
E ovviamente quelli per così dire “a ricordo”.
“Sì, che vengono eseguiti in onore di una persona cara perduta, un animale prediletto scomparso, ecc. allo scopo di indicare, almeno presso i primitivi, che l’iniziato tatuato era maturo per la vita sociale e pronto per la vita sessuale. Presso alcuni popoli invece era indicativo della tribù d’appartenenza, in altre semplicemente un segno d’onore o sanciva un patto di sangue, o anche per distinguere i capi, i sacerdoti, gli sciamani. In alcuni casi il tattoo esposto informava dei nemici uccisi, delle bestie feroci catturate, delle imprese memorabili compiute, che ne facevano, agli occhi degli altri, quasi un eroe”.
Diverso è invece il tatuaggio strettamente simbolico di tipo “totemico” di non facile interpretazione, la cui funzione magica, fa parte del retaggio di una tradizione artistica e devozionale che attribuiscono al tatuaggio una funzione magica, che pur se lontano, “ricondurranno l’anima del defunto alla sua terra e al suo popolo”. L’esempio più eclatante che ci viene in mente, lo stavamo appunto dicendo con il professor Rovesti – è quello descritto da Herman Melville in “Moby Dick” (19), lì dove parlando del ramponiere Quiqueg, ravvisa: - “Con una stravaganza bizzarria, egli adibì ora la bara a cassetta e, vuotandoci dentro il sacco di tela degli abiti, ve li ordinò. Trascorse molte ore libere a intagliarne il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi, e pareva che con ciò cercasse di riprodurre, nella sua rozza maniera, parti dell’intricato tatuaggio del suo corpo (..) opera di un defunto profeta veggente della sua isola, che per mezzo di quei segni geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un mistico trattato sull’arte di conseguire la Verità, cosicché Quiqueg era nella sua persona stessa un enigma da spiegare, un’opera meravigliosa in un volume, i misteri della quale però neanche lui sapeva leggere benché sotto vi pulsasse il suo cuore vivo. Questi misteri erano quindi destinati a perire alla fine insieme alla pergamena vivente dov’erano tracciati e così restare insoluti fino all’ultimo. E doveva essere stato questo pensiero che suggerì ad Achab quella sua fiera esclamazione, un mattino mentre si voltava ad osservare il povero Quiqueg: «Oh, diabolica tentazione degli dèi!».
“Maschere & Body Art”
Propongo qui la lettura di una poesia: “Paradiso Africano” di Francis E. Kobina-Parkers (20), poeta del Ghana, che rende con forza il significato della musica e dei canti, ma anche l’atmosfera che vige nelle feste rituali legate al culto degli antenati, in cui fanno la loro apparizione un gruppo di maschere tribali e la visibilità di corpi e volti dipinti:
“Datemi anime nere / che siano nere o cioccolata bruna / Datemi tamburi / diciamo tre o anche quattro / e che siano neri / sudici e neri: / di legno o pelle secca di pecora / e poi facciamoli rullare / rullare forte, brontolare / poi smorzati. / Che vengano introdotte le maschere rituali. / Rullino i tamburi / risuonino sfrenatamente. / Aggiungete voci di donne / e quelle basse di uomini / e grida di bimbi. / Che vengano i danzatori / neri dalle spalle ampie / che pestano il suolo coi piedi nudi / a ritmo. / E quando in cielo il sole è al tramonto / siano ammessi gli spettatori / possono essere bianchi o neri / che possono udire i nostri canti nativi / e il rullo dei tamburi / e possano godere / del nostro Paradiso Africano”.
Niente di più appropriato per proseguire nella nostra ricerca sull’uso delle maschere in Africa, tuttavia, come sono solito fare, ritengo opportuno fare un passo indietro e come sempre mi affido all’antropologia e all’arte, che a un certo momento si sono fuse nell’esperienza formata dalle tradizioni e dall’espressione artistica dei rispettivi popoli. Non mi sembra di aver affrontato ancora, in queste pagine, il concetto relativo alla definizione di “primitivo” che pure si rende necessaria al fine di comprendere di cosa andiamo parlando: “appartenente alle età o alle popolazioni preistoriche o a livelli di cultura caratterizzati da un’estrema semplicità e rozzezza, con riferimento agli uomini e alle opere” (21). Per alterazione o derivazione si è preferito utilizzare il termine primitivo rispetto a selvaggio, per definire sia lo stadio evolutivo primigenio dell'Umanità, che quello che veniva considerato l'oggetto di studio delle scienze etno - antropologiche. A tutt'oggi, l'antica ambiguità insita nell'uso del termine primitivo non è stata risolta dagli antropologi ed il termine ha finito per connotarsi degli stessi significati che aveva selvaggio (inferiorità, razzismo, etnocentrismo, ecc.). Ed è per questo che riferendosi a primitivo, «...attualmente esso viene usato solo convenzionalmente, e spesso tra virgolette, nella letteratura antropologica» (U. Fabietti).
Molti obiettano che spesso questi gruppi sono perfettamente adattati all'ambiente naturale, come nelle selve equatoriali, o nella banchisa artica (dove non esiste né legno, né minerali, né pietre per costruire templi, ne ovviamente la possibilità di arare un terreno) e che possono averci insegnato molte cose, come l'impiego di piante medicinali, p.es il curaro (che oggi si adopera negli interventi chirurgici), oppure la vincristina (che si utilizza correntemente nella terapia dei tumori). Inoltre la mentalità magico-religiosa, in passato considerata caratteristica distintiva dei primitivi (L. Lévy-Bruhl), è un concetto screditato dai successivi approcci teorici dell'antropologia. In molti, come Marcel Griaule, hanno sottolineato la continuità tra una visione del mondo che poteva venire etichettata come primitiva e le religioni, superstizioni e le credenze delle persone che abitano le metropoli contemporanee. In definitiva, è ad oggi largamente accettato nella comunità scientifica il carattere di costruzione del concetto di primitivo, utilizzato dall'antropologia dell'Ottocento e di gran parte del Novecento per individuare il proprio oggetto di studi (The Invention of Primitive Society, Adam Kuper, 1988).
Detto ciò, affrontiamo con serenità l’aspetto più critico della ricerca affidandoci a quelli che vengono considerati i “documenti” lasciati dai primitivi riguardanti l’uso di indossare maschere durante la caccia, che sono le incisioni e le pitture rupestri presenti in alcune zone della terra in modo più concentrato che in altre, trovate al seguito di scoperte archeologiche, e che sono oggi patrimonio sia dell’archeologia che dell’etnografia, sia dell’antropologia che dell’etnomusicologia lì dove appaiono strumenti musicali, danzatrici e danzatori ecc. Una testimonianza che ha valore sia documentario che artistico è rappresentata dalle incisioni rupestri che si possono vedere in Brasile (Lajedo de Soledade), come in Italia (Valle Camonica), nel Tadrart-Acacus, come nel Sinai e in Giordania; o le pitture rupestri ritrovate in Francia (Lascaux), in Spagna (Altamira) e nell’area montuosa del Sahara (Aggar e Tassili), dove rupestre sta per grotte o pareti rocciose.
Si tratta per lo più di “segni” scalfiti sulla pietra grezza, che lasciano pensare ad una sorta di scrittura ideografica (incisioni), il cui scopo, poteva essere commemorativo della presenza di particolari animali, o indicativo di sorgenti d’acqua. Nella simbologia tribale potrebbero aver avuto significato religioso o curativo ad uso degli sciamani. Pertanto detti luoghi assumevano una sorta di sacralità, rispettata dagli appartenenti alla tribù. Segni che ritroviamo e sui manufatti come ceramiche e utensili d’uso quotidiano e, soprattutto, sui tessuti e nel decorativismo del tatuaggio e del decorativismo corporale che rappresentano la loro espressione artistica in termini di fantasia e creatività. Un discorso diverso va fatto per la pittura rupestre eseguita su pareti lisce naturali o su superfici precedentemente levigate, e talvolta pregne dei colori rosso od ocra, ricavati da terre o da spremiture di frutti e radici, probabilmente a scopo divulgativo o, come qualcuno ha detto, commemorativo di particolari azioni di caccia, o di raccolta del bestiame, tendenti a sacralizzare il luogo (caverna, anfratto, ecc.), forse, come centro di raccolta della comunità, ove trasmettere le tradizioni e i miti riferiti all’attività tribale.
Penso qui di poter fare riferimento alle cerimonie di quasi tutte le tribù disseminate nel cuore dell’Africa Centrale poiché presentano almeno due prerogative comuni: quella di dare inizio ai propri riti con danze propiziatorie di tipo magico-mistico, scandite dal ritmo preponderante delle percussioni; e quella di vestire o portare in processione le maschere rituali. A proposito di quanto scrive Giovanni Vignola (22): “Si può studiare il tipo di civiltà o un periodo della civiltà stessa attraverso la produzione e l’uso delle maschere, come si fa per la produzione di utensili, vasi, tessuti ecc., poiché questo studio ci mette in contatto diretto con la vera e più intima immagine del mondo”.
“Infatti – ci dice il nostro amico e gradito ospite professor Paolo Rovesti – nel suo significato arcaico, la maschera rappresenta di solito un eroe o un antenato, il totem della tribù, o lo spirito della vegetazione o della pioggia, come, ad esempio, erano il “serpente piumato” Quetzalcoatl degli Aztechi o, Amon-Rà il sole degli Egizi. Chi in realtà indossa una maschera subisce una sorta di “trasformazione unificatrice”, in quanto elimina il divario esistente fra il mondo reale e quello soprannaturale. Un altro esempio ci è dato dalla raffigurazione della morte che troviamo in molti riti, in cui la morte è strettamente legata al mondo degli spiriti. La sua funzione principale è appunto quella di creare una certa relazione tra l’essere che rappresenta e colui che la porta. In certi casi, il portatore della maschera è, in quel momento, una sintesi del visibile che compenetra l’invisibile, un vivo-morto e, per contro, un morto-vivo, realizzando materialmente una delle più grandi aspirazioni umane”.
Così a proposito della maschera figurativa della morte, Otto H. (23) scrive: “L’uomo che porta ritualmente la maschera subisce l’impressione della grandezza e della dignità di coloro che non esistono più. Egli è se stesso ma, al tempo stesso, è altro”, l’ha sfiorato la follia, qualcosa del dio furente, di quello spirito dell’esistenza doppia che vive nella maschera. È lo spirito del divino morto che ritorna, non come larva, come ombra o spettro, ma come potenza del vissuto.
Scrive Umberto Galimberti (24) nel suo “Paesaggi dell’Anima”, probabilmente riferendosi a qualcos’altro, che tuttavia mi è sembrato si sposasse perfettamente col nostro discorso: “..il suo punto di vista si colloca là dove prende avvio la coscienza umana nel suo emanciparsi da quella condizione animale o divina che l’umanità ha sempre avvertito sullo sfondo, e da cui, pur sapendosi in qualche modo uscita, ancora si difende temendone la sempre possibile irruzione”. E aggiunge: “Quando la natura cede il suo segreto mostra il suo volto che, irrispettoso delle differenze che la ragione ha faticosamente guadagnato, si offre indifferenziato, e perciò carico di quell’aspetto minaccioso che non distingue e non separa, ma tutto mantiene in quella contrazione simbolica così poco rassicurante che gli uomini, non potendola eliminare, hanno espulso in quella sfera non-umana che è il mondo degli elementi naturali, degli animali, degli dèi, e nella forma ben più drammatica del divino e del sacro”.
Col passare del tempo certi riti tragici di ieri sono andati perduti, ci restano a tutt’oggi alcune maschere, ma l’impressione che ancora ne traiamo, è che esse esprimono più mistero, più impenetrabilità, che sacro terrore. È sufficiente accennare, come, ad esempio, il passaggio dalla maschera tragica rituale e sacra di ieri, alla maschera carnevalesca, caricaturale e canzonatoria di oggi, per comprendere che è avvenuta una certa dissacrazione del soggetto “mascherato” e, non in ultimo, si è giunti al dissolvimento del suo significato iniziale. L’esempio musicale che qui di seguito vi propongo, vede i Pigmei del Gabon (25) impegnati in una cerimonia del culto Mbiri che sta a significare “la religione del mondo”; messo a confronto con un altro culto ancora vivo alla stadio tribale, detto Bwiti “la religione dell’al di là”. La registrazione, unica nel suo genere, mostra come entrambe si sviluppano attorno all’albero totem detto Adzap che presenta incisioni zoomorfe e maschere stilizzate.
Questo albero simbolico è il pilastro centrale della capanna eretta appositamente per le suddette celebrazioni tribali dei due gruppi riunitisi per l’occasione. Rilevante come questo culto presenti allo stesso modo le sue linee originali, con due aspetti diversi: la riesumazione della “religione del mondo” in cui si vive (culto Mbiri), e la “religione dell’al di là” (culto Bwiti), quale rappresentazione degli aspetti fondamentali della vita e della morte, della creazione e dell’annientamento. La musica che accompagna entrambi i culti ha una funzione “viva”, di happening, e rappresenta l’anima stessa del culto. Uno dei brani, pensate, parla della “strada della morte e dell’annientamento”.
Dice Paolo Rovesti: “Come per altre culti tribali, anche nella musica africana è fatto uso di piante dalle spiccate qualità psicotrope di cui i Pigmei fanno grande uso, come ad esempio “l’eboga” una pianta che cresce nella foresta equatoriale, e che ha il potere di accrescere la resistenza fisica. Si vuole che presa uno o due volte a dose massicce, procura frequenti visioni che permettono agli iniziati di compiere il cercato “viaggio nella terra dei morti” e verso i sognati “altopiani della savana”. Ma quali sono gli effetti che l’eboga procura agli iniziati, ricevuta attraverso la maschera totemica, e perché di questa esigenza, il professor Rovesti è qui a dirci qualcosa.
“È solamente con la forza psicologica datagli dalla droga che gli iniziandi riescono ad affrontare la natura complessa e, in certi casi, ostile, che troveranno sul loro cammino. Grazie ad essa essi riescono a mutare quello che è considerato il “male” in qualcosa che gli sia meno nocivo, in modo che la metamorfosi, sollecitata e avvalorata dal gruppo, si trasforma in ipnosi collettiva”.
Ragione per cui il primitivo sente quasi “istintivamente” l’unicità fisica della disponibilità del suo corpo in senso squisitamente collettivo. Sente nascere in sé il desiderio di adornare, di abbellire, di usare forme e colori che rendano più attraenti le sue superfici corporee.
“Va ricordato che la prima e più semplice tela che un pittore primitivo ha a sua disposizione è la pelle del suo corpo. Egli raramente l’apprezza al suo stato naturale per la sua levigatezza, la sua glabrezza, la considera troppo nuda, troppo sola e insignificante” – aggiunge Rovesti.
Si tratta quindi di vera e propria opera d’arte?
“Di una vera e propria opera di cosmetica artistica, non solo per le motivazioni sopraddette, bensì la ricerca dell’ammirazione dell’altro sesso, una maggiore accettazione di sé e da parte degli altri, oltre a quanto è stato detto per il tatuaggio”.
In Africa le maschere cosmetiche che spesso si estendono a tutto il corpo sono cambiamenti che permettono di assumere personificazioni di fantasia per altrettanti motivi di ordine magico e rituale, da guerra e da spettacolo, come danze e canti collettivi e rappresentazioni, con transizioni difficilmente classificabili. Non a caso i soggetti più frequentemente raffigurati sono fiori e alberi, animali, paesaggi e simboli astrali, presi a prestito per attrarre l’attenzione e, al tempo stesso, la volontà di sentirsi parte del creato.
“Nel volersi immaginare diverso, il primitivo, diversifica il suo stato d’essere, in un certo modo, per non essere riconosciuto dagli spiriti maligni, o anche per semplice gioco, per il piacere di cambiare se stesso sul filo della fantasia, con un senso di compiacimento estetico che spesso ha dato luogo a vere e proprie maschere cosmetiche pari ad altrettante opere pittoriche”.
Oggi, in occidente, l’uso di adornare il volto con materie coloranti è relativo alla moda e alla moda è soggetto. Può dirsi lo stesso tra i primitivi?
“Nei primitivi è sempre stato un’espressione originale autentica, con una sua unicità fedele ai suoi requisiti base”.
Sappiamo che il desiderio istintivo di “dipingersi” il volto o il corpo nasce spontaneo in quasi tutti i popoli, ma per nessuno di questi le maschere cosmetiche hanno raggiunto una concentrazione, una icasticità e una espressività così profonde sul piano estetico come nei primitivi africani, è così?
“Dipingersi la pelle è sempre stato molto meno impegnativo e invasivo del tatuaggio o della scarificazione, tuttavia, oltre al truccarsi più o meno diffusamente il viso, si complica in figurazioni diversissime nella cosmesi del corpo. I mezzi usati sono semplici, ricavati da pigmenti minerali impastati dopo fine macinazione e lacche adesive e poco olio, o con semi oleosi oppure olio di termiti. La decorazione è spesso eseguita su disegno preventivamente delineato sulle zone interessate, ma altrettanto spesso viene eseguita in modo estemporaneo, come dire, di getto”.
La pittura del corpo, talora semplice quanto efficace, altre volte invece miniata, parziale o totale, è compresa nei trattati di etnologia del costume e dell’abbigliamento, possiamo ora inglobarla nella storia della medicina e della cosmesi?
“Per maggior precisione si tratta di cosmesi artistica del corpo, praticata dai primitivi in occasione di feste e cerimonie tribali, rituali, spesso riservata a capi e sacerdoti o agli stregoni, in riti totemici e religiosi, rivolti a sacrifici talvolta misteriosi e crudeli (inumani), legati a “società segrete” di origine oscura. È indubbio che i loro mascheramenti siano quelli più complessi anche artisticamente parlando”.
Si può dire che a molte “società segrete” oggi per lo più ridotte di numero, sono fortunatamente sopravvissute solo le maschere e non certi riti sanguinari, le quali, una volta staccate dal cerimoniale che le accompagnava, si offrono all’osservatore nei musei, non più come oggetti di culto, bensì nella veste dell’estetica e della forma d’arte. È indubbio che qualcosa hanno perduta, ed è la forza magica che da esse scaturiva in funzione del loro aspetto apparentemente temibile. Con la danza detta della maschera della società “Lò” presso i Senufo della Costa d’Avorio, che raggruppa solo individui di sesso maschile, approntiamo qui di parlare di un culto oscuro che si avvale della “maschera dai due volti”, così detta, che rappresenta due aspetti dello stesso volto, uno soprastante l’altro, e termina con due grandi corna , a significare entrambi gli aspetti del bene e del male che si sovrappongono nell’essere umano.
Un’altra maschera, sempre d’origine Senufo, e quella denominata “sputa fuoco”, trovata nella regione dei Korhogo. Oggi è visibile in legno naturale ma un tempo sicuramente colorata, essa riunisce in modo fantastico l’elemento umano con elementi presi da svariati animali, nell’intento di creare immagini mostruose o demoniache, tali da incutere paura e spavento. Un’arte, questa, che esprime concetti animistici legati a credenze religiose sovrapposte, in cui la “magia nera” è espressa nel senso più alto e terrifico della sua mediazione tra il mondo della natura e quello soprannaturale.
Evitiamo di proposito di parlare di certi aspetti terrificanti della “magia nera” praticata in alcuni riti dell’Africa Centrale, per tornare al discorso più significativamente musicale, lì dove appunto la ricerca etnomusicologica trova un ampio materiale di studio e di soddisfazione. A questo punto non può mancare una escursione in quelle che sono le danze e gli strumenti e i canti che le accompagnano. Va detto che danza è elemento fondamentale della vita tribale africana presso tutti i popoli conosciuti, o meglio rappresenta il fluido nascosto che scorre in tutti gli esseri e che segna, al pari del ritmo in musica, il magico punto di contatto e di partecipazione dell’uomo con la natura. La danza quindi come elemento mobile che regola e rende comprensibili i fatti ineluttabili della sua vita.
“È anche in funzione di questo che il mascheramento dei popoli africani e certe maschere in particolare sembrano create per essere in movimento. Si può ben dire, anzi, che la danza in Africa è il completamento necessario per la totale comprensione delle maschere ” – ribadisce il prof. Rovesti.
Propongo qui, ad esempio, una “danza delle maschere delle regine” riferita a un personaggio leggendario: la regina Aura Poku (26) che regnava sui Bàule della Costa D’Avorio, presenti anche in Ghana. In essa si narra dell’avvenuta scissione di questi dalla tribù degli Akan (oggi presenti solo in Ghana). I quali nel loro peregrinare si spinsero fino ai confini della Costa d’Avorio, ma che vennero fermati dall’impervio fiume Comoé, il cui spirito apparso loro in circostanze sconosciute, gli intimò di sacrificare ad esso un giovane della tribù. Fu così che la regina Aura Poku sacrificò il proprio figlio e il fiume permise infine il passaggio dei fuggitivi salvandoli dal possibile genocidio. Questo spiega la posizione predominante della regina al centro della vita religiosa di questi popoli e come il “culto” a lei riservato abbia condizionato la vita politica e sociale, nonché religiosa attorno ad essa.
Danze e canti in onore di Aura Poku accompagnano presso il villaggio di Sakasso questo rito rimasto inalterato nel tempo, in cui è fatto uso di maschere composte di vestiario fine e di delicati colori, i cui volti riproducono visi femminili ovali e levigati, dipinti con “maschere cosmetiche” di un bellissimo blu-azzurrino e in parti di rosso, ricavate da minerali e terre colorate, uniche in Africa. Proviene invece dal Dahomey il rito dell’offerta ai re Tohossou, capi spirituali e reincarnazione dei defunti re, principi e dignitari del paese. In questa cerimonia religiosa, ripetuta in tutti e venti i templi dedicati a questo culto presenti nel paese. La cerimonia si avvale di una formazione strumentale di tre tamburi lunghi, interamente ricavati nel legno di alberi, che vengono battuti con alcuni bastoni da un lato e con la mano dall’altro dagli uomini, e di tre campane di ferro battute con stecchi dai bambini, mentre tutt’intorno il coro delle donne fa clangore con sonagli attorno al cerimoniere che avanza, sotto il tipico ombrello che sempre lo accompagna, suonando una speciale campanella dal suono vivace e canta una melopea di tipo responsoriale.
Le ragazze invece, prescelte per reincarnare le defunte principesse, indossano abiti multicolori e gioielli, orecchini di perle, braccialetti di conchiglie colorate e altri oggetti di valore, e abbelliscono il proprio viso con l’uso di sostanze cosmetiche. Esse seguono la processione che si snoda all’aperto attraverso le capanne del villaggio fino a giungere presso l’albero ritenuto sacro, il Baobab, dalle enormi dimensioni, e tutti insieme cantano e suonano al vento, portatore degli spiriti Tohossou, personificati da due danzatori nelle vesti di un principe e una principessa. È questo il momento in cui vengono esposte le maschere rituali che raffigurano i defunti re, davanti alle quali si svolge il sacrificio (un tempo cannibalesco) di un toro, le cui carni e sangue, vengono poi spartite tra i presenti.
Riuscite a immaginare l’effetto coreografico della cerimonia e la magica visione delle maschere rituali in questo momento? Non è possibile immaginare, è terrificante!
Non sono le sole maschere ad essere in qualche modo così terrificanti, talvolta sono invece i riti che le accompagnano ad esserlo di più. Va anche detto che ve ne sono anche di molto belle e che raggiungono un’alta espressione artistica in senso pieno. Quelle ad esempio dei Tomà dell’Alto Volta, dei Dògon del Mali, del Benin e tantissime altre.
“Potresti dirci della maschera che accompagna la “danza dell’uomo uccello” presso i Tomà, ad esempio” – chiede il prof Rovesti.
Lo faccio volentieri, anche perché ha una maschera fatta di piume colorate molto bella che raggiunge, nel copricapo, un’eleganza altamente ricercata. soprattutto perché ha un nome inconfondibile: “Ouénilégagui” (27), e si svolge con grande effetto coreografico. La tradizione vuole che il portatore della maschera dipinga le parti che restano scoperte del corpo, come la faccia e gli arti, di bianco e si rivesta delle piume più belle che sia dato trovare nella foresta. L’uomo-uccello appare soltanto in occasioni tragiche, per la morte di un capo dignitario o quella di uno stregone ecc. di cui è simbolo ammonitore. La sua danza è accompagnata dal suono di un piccolo tamburo che il suonatore batte con una stecca da entrambe le parti, nel mentre il tamburo “parlante” indica ai danzatori le figure che devono eseguire da accompagnamento alla danza dell’uomo-uccello. La cerimonia si conclude con una sorta di “canto del cigno” e infine e l’uomo-uccello s’invola, scomparendo nel folto della foresta.
L’uso delle percussioni è praticato in tutto il continente africano in diversi modi, ma è la voce del Tam-tam che risuona cupa nella notte come un richiamo, per questo si è parlato e si parla di “tamburi parlanti” (28).Il suo suono, al pari della voce, sprigiona una tale forza evocativa portatrice di mistero tale, che è ritenuto uno strumento sacro, avente la forma tangibile della divinità. Non si è mai riusciti a scoprire l’origine di questa forza nascosta che da esso scaturisce, al pari di una forte emozione, talvolta di gioia ma anche di dolore, quasi che col suono si distribuisse una potente droga che stordisce e che rende gli uomini che l’ascoltano succubi di forze soprannaturali. Tant’è che studiosi e missionari arrivarono perfino a proibirne l’uso.
Ricavato da dal tronco di un albero particolare, precedentemente scelto, che cresce nella savana, il Tam-tam viene scavato all’interno di una fessura più o meno grande, praticata su un lato, e scolpito in forme di animali diversi, talvolta dipinti e ornati come avviene per le maschere. Sotto questa forma, infatti, il Tam-tam assume il ruolo sacro che gli compete, quindi, degno di culto da parte di tutti i componenti la tribù che conoscono il modo di suonarlo e la prerogativa di recepire la parola o la frase che il tamburo trasmette, e che solo riesce a comprendere. È spesso usato per trasmettere anche messaggi a lunga distanza.
“Anche per questo i Tam-tam distribuiti in varie regioni, sono ripetutamente suonati durante la notte, perché l’umidità della notte è buon trasmettitore di suoni. Essi, infatti, ripetono il messaggio, che viene così divulgato fino a coprire tutto il territorio” – aggiunge il prof. Rovesti.
Qui siamo giunti, e qui ci fermiamo poiché l’Africa coi suoi sterminati territori, la savana, il deserto, le sue montagne i grandi laghi, i fiumi e le cascate, i suoi molti popoli e suggestivo, ricco di innumerevoli tradizioni, riti, culti, religioni, civiltà antiche e nuove, è un continente immenso dove potremmo perderci. Rimando pertanto ad altre possibilità d’incontro su temi specifici che spero vogliate anche suggerirmi e invogliarmi a scandagliare. Tuttavia penso che potreste farlo anche voi lettori, nessuno escluso, sotto l’egida, e qui mi ripeto, che: “È nello scoprire il fascino “ancestrale” della musica dei popoli, che la infinita ricerca di “noi stessi” si amplia di nuovi e importanti capitoli, che vanno ad aggiungersi alla macroscopica “storia universale” che noi tutti stiamo scrivendo. Soltanto nello scoprire “noi stessi” saremo in grado, un giorno, di conoscere il mondo in cui viviamo” (29). E magari lo salvaguarderemo!
Del resto: “Tutto su questa terra è una mascherata, ma Iddio ha stabilito che la commedia si debba recitare a questo modo”.
(Erasmo da Rotterdam, Elogio alla follia).
Discografia:
(in preparazione)
Bibliografia:
(in preparazione)
Note:
(1) Paolo Rovesti si è laureato in Chimica e Farmacia all’Università di Genova nel 1925. Dalla direzione tecnica di diverse industrie chimiche, farmaceutiche ed essenziere, è passato in seguito a quella della Società Imprese Africane e della Compagnia per la Valorizzazione della Flora Etiopica e, infine, a industrie alimentari estrattive. Fondatore dell’Istituto di Ricerche sui Derivati Vegetali, è autore di oltre 500 pubblicazioni di carattere sperimentale sulla fitochimica, gli olii essenziali, le piante medicinali e la cosmesi funzionale. Universalmente riconosciuto come il padre della Fitocosmetica. Tuttora, a diversi anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1983, la figura e gli studi del prof. Paolo Rovesti nel mondo accademico e industriale rimangono un importante punto di riferimento umano e scientifico. L’Istituto Paolo Rovesti, a lui intitolato, è nato nel 1984 per iniziativa di un gruppo di collaboratori. La grande mole di documentazione (oltre 15.000 testi), le pubblicazioni originali (e anche inedite) di Paolo Rovesti sono la base scientifica e culturale di questo Istituto. Ma la ricerca è continuata, per scoprire nuove materie prime e principi attivi, per la messa a punto di nuove formulazioni innovative, legate alle piante ed all’erboristeria, sia nel campo cosmetico che farmaceutico. L'Istituto ha sviluppato una serie di attività di ricerca di base investigando le proprietà degli ingredienti vegetali per applicazione nel campo cosmetico, farmaceutico e veterinario da poter consultare sul sito info@istitutorovesti.it che, di volta in volta, provvede agli aggiornamenti sulle pubblicazioni "storiche" e scientifiche “nuove” . Inoltre è possibile consultare una sezione di proposte legate ai nuovi filoni di ricerca dell’Istituto, che possono trovare interesse anche economico da parte degli operatori del settore.
(2) “Folkoncerto: Maschere Rituali”, RAI – Radio 3, programma di Pierluigi Tabasso e Landa Ketoff – testi, ricerche musicali e materiali fonografici di Giorgio Mancinelli.
(3) Paolo Rovesti, “Alla ricerca dei cosmetici dei primitivi” 3 vol. – Blow-Up – Milano 1977
(4) Paolo Rovesti, “Alla ricerca dei profumi perduti” 3 vol. – Blow-Up Milano 1979.
(5) La scarificazione (in Wikipedia Enciclopedia), è una deformazione cutanea a scopi decorativi e protettivi, collegata a molte motivazioni. In passato, era praticata soprattutto da parecchie etnie africane, e spesso coincideva col rito iniziatico del passaggio dall'infanzia all'età adulta. Determinante era che il soggetto sottoposto a questa pratica molto dolorosa, e che poteva far perdere sangue in abbondanza, sopportasse le incisioni in stoico silenzio. La sofferenza è un elemento fondamentale della cerimonia, in quanto dimostra il coraggio e il valore del ragazzo che entra nell'età adulta: il popolo Nuer (Sudan meridionale e zona occidentale dell'Etiopia) ancora oggi si fa tagliare col rasoio, sei larghe strisce sulla fronte. L'operazione è molto pericolosa, in quanto la recisione di un nervo frontale può portare alla morte, nonostante i tentativi di arginare l’emorragia. Dopo un lungo periodo di convalescenza l'iniziato è ammesso alla tribù con grandi feste. Consiste in incisioni, tagli della pelle (con coltelli, rasoi, conchiglie, pietre affilate, ecc.) bruciature, allo scopo di produrre cicatrici permanenti. Ogni cicatrice viene soffregata varie volte con polveri e prodotti coloranti e lasciata a lungo aperta, finché la particolare pelle cheloide dei popoli africani non si cicatrizzi con forte evidenza plastica. I motivi preferiti sono solitamente di tipo geometrico, ma a volte vengono incisi animali stilizzati. Ogni etnia aveva i propri simboli. Sovente le donne avevano imponenti scarificazioni sul ventre, che ne costituivano anche l'attrazione sessuale. Come il tatuaggio e la mutilazione, la scarificazione era considerata segno di qualificazione sociale, e parecchie donne affermavano che senza quei segni non si sarebbero mai sposate. Una importante documentazione di questa pratica si trova nelle fotografie di Leni Riefenstahl, che eseguì vari servizi fotografici in Africa attorno agli anni Settanta del secolo scorso. in particolare presso il popolo dei Nuba. Nonostante sembrino intollerabili a noi occidentali, le scarificazioni femminili erano fortemente attrattive per i gli uomini dei vari clan, che non sopportavano la pelle liscia, ma preferivano accarezzarne le escrescenze. Impropriamente identificata con il tatuaggio, la scarificazione è diffusa soprattutto in Africa centrale ed in Nuova Guinea, sebbene molti governi locali le abbiano proibite. Le tecniche di scarificazione sono varie e ognuna dà un messaggio diverso. Il significato delle scarificazioni, come per i tatuaggi è: di tipo estetico; di tipo apotropaico; di tipo onorofico; di tipo religioso (frequente tra gli indigeni convertiti al cristianesimo). In Etiopia molti indigeni abissini possono avere croci marcate a fuoco sulla fronte, o scarificazioni col numero delle messe cui hanno assistito; di tipo informativo, ossia a quale clan si appartiene, lo stato sociale. Ad esempio gli Shilluk dell'Alto Nilo hanno sulle arcate sopraccigliari caratteristiche scarificazioni dette "a grani di rosario" che vengono eseguite sia sugli uomini sia sulle donne e dipinte con terra bianca per evidenziarle. In una tribù musulmana dell'Alta Etiopia era usanza di scarificare sul dorso le pene inflitte ai colpevoli di qualche reato: ho rubato una mucca, ho commesso adulterio, ecc. La scarificazione di tipo totemico era legata ad un animale in cui ci si identificava. I boscimani infatti, praticavano una serie di incisioni sulla fronte dentro a cui cucivano microscopici frammenti di carne di antilope, animale di cui erano convinti di acquisire la velocità.
(6) Ernesto De Martino, “Il Mondo Magico” – Bollati Boringhieri – Torino 1973, studioso di etnologia e folklore si è dedicato allo studio poco coltivato in Italia delle società primitive. Professore di storia delle religioni alla Università di Cagliari dal 1959 alla morte, de Martino è autore tra l’altro di “Sud e magia” (1959) e “La terra del rimorso” (1961). Con questo libro, che è la sua opera più profonda e celebre, de Martino intese dare una ricostruzione dell’età magica come momento di sviluppo della storia dello spirito. Essa è un’epoca in cui i confini tra uomo e natura, tra soggetto e oggetto sono ancora incerti. Ma anziché risolversi in una partecipazione mistica, come riteneva l’etnologia d’ispirazione irrazionalistica, questa incertezza crea un dramma: quello della «crisi della presenza», del rischio per l’uomo di essere annullato da forze naturali incommensurabili e incontrollabili. La magia appare così come un insieme di tecniche per riscattarlo da questa crisi e rassicurarlo del proprio «esserci». Attraverso un’accurata scelta di reperti etnografici, De Martino rievoca plasticamente, in pagine indimenticabili, i momenti di tale dramma. Egualmente distante da irrazionalismo e razionalismo, che diversamente rimuovono il carattere storico di tale dramma, de Martino mostra come il soggetto umano sia esso stesso un prodotto storico la cui genesi si situa appunto nell’età magica. La posizione teorica di de Martino, al crocevia tra idealismo, esistenzialismo e marxismo e affacciata sui problemi della parapsicologia e della psicoanalisi, è talmente ricca di stimoli e di tensioni che mantiene ancora oggi intatta la sua forza di suggestione.
(7) L'autosuggestione, in psicologia, è una forma di comunicazione mediante la quale in un individuo - senza che egli avverta imposizione né comando alcuno, in assenza di razionale e libera scelta oltre che di consapevolezza - è indotto ad un'autoconvinzione, un pensiero od una condizione esistenziale senza che egli voglia opporvisi né avverta la ragione di farlo neppure su altrui pressione.
(8) Arnold Van Gennep, “Riti di passaggio” – Bollati Boringhieri – Torino 1985, professore di Etnologia all'Università di Neuchàtel, studiò i problemi generali dell'etnologia e del folklore, stabilendo metodi di investigazione che lo accomunano a etnologi quali Frazer e Tylor . Si occupò soprattutto di folklore francese, ma lasciando anche contributi importanti di carattere etnologico. Oltre al presente volume, la sua fama è legata a "Religions, moeurs et légendes" (1908-14) e al "Manuel du folklore français contemporain". «Riti di passaggio» è una formula famosa, impiegata non solo nel gergo degli etnologi e degli antropologi, ma anche in quello di sociologi, psicologi, etologi. Pubblicato nel 1909, il libro di Van Gennep gode ormai del riconoscimento di testo classico. Il fatto di non aver selezionato uno specifico materiale etnografico, proveniente da un numero ristretto di società, e il fatto di aver spaziato in tutti i continenti e in diversi periodi storici attribuiscono all'opera un carattere di ampia generalità, che la rende disponibile per diverse, interpretazioni. E tuttavia, affinché questa dilatazione di prospettiva non dia luogo ad assimilazioni acritiche o affrettate, a procedimenti puramente analogici, occorre non perdere di vista i caratteri differenziali, ovvero ciò che conferisce ai fenomeni rituali umani la loro indubbia specificità. Per questo è indispensabile non dimenticare i contributi di analisi dei rituali umani offerti dalla ricerca etnologica e antropologica di cui questo libro è uno degli esempi più suggestivi.
(9) Giovanni Vignola, “Riti Magici di ieri e di oggi” - Milano : De Vecchi, 1972.
(10) Franco Monti, (ricerca sulla maschera), apparso in Vignola op. cit.
(11) Edmund Husserl, “Introduzione generale alla fenomenologia pura” - filosofo e matematico austriaco naturalizzato tedesco, fondatore della fenomenologia e membro della Scuola di Brentano. La corrente filosofica della fenomenologia ha influenzato gran parte della cultura del Novecento europeo e non solo. Oltre a Max Scheler ebbe un profondo influsso sull'esistenzialismo e Martin Heidegger, ma indirettamente il suo pensiero ha influito anche sulle Scienze cognitive e sulla filosofia della mente odierne (secondo Hubert Dreyfus, Husserl è da considerarsi il "padre delle ricerche contemporanee nella psicologia cognitiva e intelligenza artificiale"). Opere: • Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis (1901). "Philosophie als strenge Wissenschaft" in Logos, I (1911). In italiano: Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, a cura di Enrico Filippini, tr. Giulio Alliney, Torino: Einaudi, 1950, in 2 volumi, Introduzione generale alla fenomenologia pura, con introduzione di Elio Franzini, Torino: Einaudi, 2002. Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione; La fenomenologia e i fondamenti delle scienze, Torino: Einaudi, 1982.
(12) Desmond Morris, “L’uomo e i suoi gesti”, zoologo ed etologo inglese – Mondadori Electa – Milano 2005.
(13) “Mautikitiki” (vedi discografia).
(14) Tatuaggi di Pazyryk, (per i riferimenti vedere il sito http://www.hermitagemuseum.org/).
(15) Natalia Polosmak, archeologa russa, nel 1993 scopriva la tomba di una donna soprannominata poi "La Dama di Ghiaccio". Sotto i corpi di 6 cavalli sacrificati all'occasione, la dama giaceva in una tomba ricavata da un tronco di larice. La tomba è decorata da immagini di cervi e leopardi delle nevi intagliate nel cuoio. Il corpo, adagiato come se si fosse dolcemente addormentato, apparteneva ad una ragazza sui 25 anni dai capelli biondi, alta circa 1,65 m. Anche la dama presenta diversi tatuaggi (di un blu intenso) sulla sua pelle chiara: creature dotate di lunghe corna che si compongono in immagini floreali. Alcune tombe femminili in Asia Centrale sono state attribuite a principesse sciamane dalle archeologhe Natalia Polosmak e Jeanine Davis-Kimball. La principessa Ukok (5° secolo BCE) fu sepolta con un abito adorno dell’Albero della vita, con felini dorati e uccelli sui rami. Simili ritrovamenti sono stati rinvenuti a Ussun, Kazakistan del sud, e in Ucraina nel bacino del Tarim, anch’essi con i temi ricorrenti dell’Albero della Vita sui copricapo, oltre ad amuleti, incensi, borse mediche e specchi sacramentali. Specchi analoghi sono stati trovati anche nella regione Bactrian in Afghanistan e si ritiene fossero strumenti iniziatici utilizzati dalle adepte in Tibet. Le incredibili dee mikogami in Giappone detenevano lo ‘specchio sacro’ della dea del sole, Amaterasu. La presentazione visiva “Woman Shaman” include una sequenza di immagini femminili che cambiano forma, trasformandosi in animali o in sella a destrieri sciamanici. Questi temi sono ricorrenti in molte tradizioni e vivacemente illustrati nella moderna arte artica dell’incisione. Un’ incisione in avorio della tribù degli Aleut (circa 1816) mostra una sciamana che indossa un maschera di animale.
(16) Vyacheslav Molodin, archeologo, nel 1995, scopriva il corpo di un altro uomo, con un elaborato tatuaggio raffigurante un alce, due lunghe trecce, sepolto con le proprie armi. Uno di questi corpi apparteneva quasi certamente ad un capo, un uomo dalla corporatura possente, intorno ai 50 anni. Sul suo corpo, disegni vari che rappresentano una varietà di creature fantastiche e non ... i tattoo ancora riconoscibili ci mostrano un asino, un ariete, cervi stilizzati dalle lunghe corna ed un feroce predatore sul braccio destro. Due bestie mostruose decorano il torace e sul braccio sinistro si intravedono figure che sembrano rappresentare due cervi ed una capra. Dal piede al ginocchio si dipana il disegno di un pesce, un mostro sul piede sinistro e sul polpaccio quattro figure di arieti in corsa si uniscono a formare un solo disegno. Sul dorso piccoli cerchi in corrispondenza della colonna vertebrale.
(17) Oetzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio, ed il suo equipaggiamento rappresentano naturalmente il fulcro dell'esposizione. L'intera vicenda, la scoperta, il recupero, le successive campagne di scavi, gli esami clinici, è illustrata dettagliatamente con l'ausilio di pannelli esplicativi, foto, filmati e stazioni multimediali interattive. Una mostra temporanea dal titolo "Ötzi" dal 1 marzo 2011 al 15 gennaio 2012 al Museo Archeologico dell'Alto Adige dedicata al ventennale del ritrovamento dell'Uomo venuto dal ghiaccio. Vengono illustrate le più recenti scoperte scientifiche presentando numerose curiosità sulla mummia dell'Età del rame.
(18) “Canto di pescatore somalo” (vedi discografia).
(19) Herman Melville, “Moby Dick”, Adelphi Edizizioni – Milano 1987.
(20) Francis E. Kobina-Parkers (born 1932, Korle Bu, Gold Coast [now Ghana]), journalist, broadcaster, and widely anthologized poet whose style and great confidence in the future of Africa owe much to the Senegalese poet David Diop. His poetry, a rhythmic free verse with much repetition of words and phrases, tends to romanticize and glorify all that is African, from the blackness of African skin to indigenous music, dancing, and ritual. He recalls his continent’s past sufferings, exhorts the reader to do something about the oppression of blacks, and criticizes world powers for their concern with war and technology rather than with human needs. He admonishes colonial administrators of the past for the legacy they have left behind them. Parkes displays a great faith, similar to Diop’s, in the ability of Africans to bring about a glorious future through their own efforts. From the early 1970s Parkes worked for the Ministry of Information in Accra. Although a number of his poems have been collected in anthologies of African and Ghanian poetry—most notably Messages (1971) and Katchikali (1971)—Songs from the Wilderness is Parkes’s only published volume of poetry.
(21) “primitivo”, concetto, in (Dee Voto-Oli Dizionario della Lingua Italiana). E in Fabietti U., Remotti F. (a cura di), Dizionario di antropologia. Zanichelli, Bologna 1997.
(22) Giovanni Vignola, “Riti di iniziazione magici, sessuali e religiosi” - Milano - De Vecchi, 1972.
(23) Otto H. Pesch, “Liberi per grazia. Antropologia teologica” – Queriniana – 1988.
(24) Umberto Galimberti “Paesaggi dell’Anima” – Mondadori, Milano, filosofo, psicoanalista e docente universitario italiano.
(25) “Gabon”, (vedi discografia).
(26) “Aura Poku: danza delle maschere delle regine”, è il nome di una regina che regnava sui Bàule della Costa D’Avorio, presenti anche in Ghana, si tratta forse di una leggenda entrata nella tradizione (vedi discografia).
(27) “Ouénilégagui” (vedi discografia).
(28) Tam-tam - “tamburi parlanti”, articolo apparso in …………… (vedi discografia)
(29) Giorgio Mancinelli, dalla presentazione collana “Musical Atlas” -UNESCO, di musica tradizionale diretta da Alain Danielou e realizzata per il Consiglio Internazionale della Musica dall’Istituto Internazionale di Studi Musicali Comparati Fondazione Cini – Isola San Giorgio Maggiore - Venezia; prodotta da EMI.Italiana.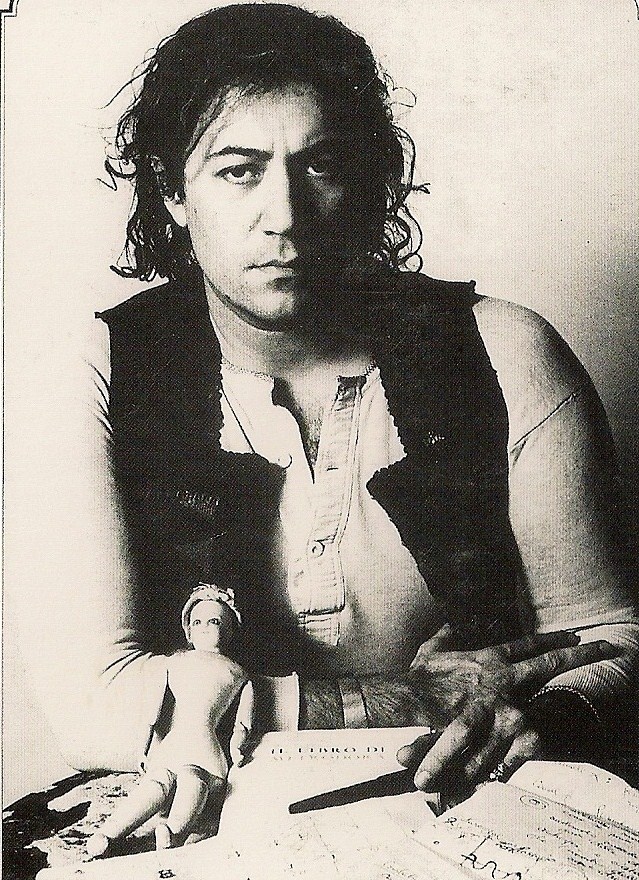 - Musica
- Musica
Etnomusicologia 3 - Le meraviglie della voce umana
“LEMERAVIGLIE DELLA VOCE UMANA” e “LA VOCE VISIVA”, di Giorgio Mancinelli.
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RAI – Radio Tre, e apparsi in numerosi articoli sulle riviste: Big, Super Sound, Musica & Dischi, Nuova Scienza, L’Annuario Discografico, Hi-FI, Audio Review).
L’uomo, al principio della sua storia, si è trovato immerso in un universo di suoni e in alcune antiche leggende si trova ancora il riflesso del suo ancestrale stupore, di quel senso di magico potere che il suono gli comunicava, di un desiderio sconfinato di conoscerne tutti i segreti significati. È questo l’inizio di una favola ideo-sociologica che non ci è dato sapere da quanto tempo e fino a quando durerà, tuttavia, filosoficamente parlando, sulla base di una frammentata introduzione alla sociologia della musica siamo giunti a conoscere alcuni aspetti inusitati, la cui interpretazione ha volutamente trascurato la comunicazione vocale nelle sue forme, per poi affrontarla nei suoi molteplici aspetti, al seguito di quanto esposto in “La voce: che cos’è e come funziona” dal prof. Antonio Ottaviani (1), direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Milano. “È il risultato di una complessa azione simultanea e coordinata dall’apparato respiratorio che fornisce dai polmoni l’aria necessaria per mettere in vibrazione le corde vocali situate nella laringe, e di un sistema di risonanza costituito dalla struttura anatomica soprastante che caratterizza il timbro ed il colore della voce. A questi aspetti tecnici, vanno poi aggiunte le caratteristiche psico-affettive di ciascun individuo, maschio o femmina che sia, allo stesso modo uguali e diverse, per via della diversa modificazione della laringe stessa, cosiddetta “muta”, che avviene nella pubertà e che è molto più evidente nel maschio. La scatola laringea maschile aumenta maggiormente e assume una posizione diversa, ne consegue che la voce dell’uomo è più profonda e più potente”.
Una specifica necessaria per conoscere le diversità e capire il perché di certe differenziazioni vocali e non solo, diversità che si connotano anche nell’uso di strumenti (per lo più a fiato), che richiedono una certa possanza per essere determinati: vedi l’uso primitivo del corno di bufalo, o la conchiglia di mare, così come oggi il sassofono o il trombone, che, pur non richiedendo particolari sforzi sono pressoché usati dai soli uomini. La voce è quindi il più importante strumento che l’umano ha a disposizione per comunicare, altresì è anche una caratteristica individuale significativa che, nella gerarchia dei valori che ciascuno attribuisce ai propri simili, occupa un posto preponderante. “In questo senso – afferma la psicologa Claretta Aymone (2) uno dei quattro assiomi fondamentali che regolano la comunicazione umana, stabilisce che al suo interno esistono due aspetti distinti – la voce è infatti una «meta-comunicazione», cioè una comunicazione sulla comunicazione, che si spinge al di là della nostra stessa volontà: il primo, riguarda la notizia, il contenuto oggettivo del messaggio che segnala gli stati d’animo momentanei: gioia, malinconia, ansia, angoscia, nonché problemi di una concreta gravità; il secondo, chiamato aspetto di comando, e che determina il tipo di reazione che si desidera instaurare con l’interlocutore”. Una sorta di “rivelatore psico -emozionale” che tiene conto non tanto i contenuti trasmessi, quanto le modalità d’uso. Trattandosi della voce quindi il timbro, il tono, il volume. In alcuni casi addirittura il contenuto diventa del tutto secondario, perché non è attraverso di esso che passa il messaggio: un esempio per tutti, la seduzione.
Anche la classica distinzione tra suoni e rumori è legata all’analisi della voce, quando è usata consapevolmente. Secondo questa concezione un suono è una nota semplice (sinusoidale) oppure una nota semplice accompagnata da alcuni suoni parziali d’intensità (nel parlare); un rumore è invece l’insieme di note più alte prodotte dalla stessa sorgente (le corde vocali), in cui, tra il suono fondamentale (talora bassissimo) e suono prolungato (dello strillare) vengono emesse prevalenze marcate. Naturalmente questa distinzione non è mai stata considerata netta, nemmeno prima che la voce umana entrasse a pieno diritto a far parte della musica. Non in ultimo la voce costituisce un enorme patrimonio sul quale investire la professione e magari anche la vita, bisogna però distinguere. Ad esempio, attori, cantanti, speaker televisivi e pubblicitari, hanno molte possibilità a disposizione per potersi esprimere con la voce in relazione della loro immagine, del loro corpo fisico, mentre i doppiatori, e gli speaker radiofonici, solo la propria voce, e questo fa la differenza. In quanto non possono comunicare nel modo che gli è più naturale, ma si trovano spesso a dover imitare al meglio l’attore cui prestano la voce, o mettere a disposizione della professione le loro emozioni.
La voce è dunque e sempre più spesso molto più che una funzione primaria, e poiché la si studia (impostazione, dizione, recitazione), risente a livello “emozionale” di tutte le sfumature dei sentimenti. E le emozioni sono una realtà molto complessa e, in gran parte, ancora misteriosa, nonostante nel corso dei millenni siano state esplorate da filosofi e letterati, e studiate scientificamente in modo sistematico da oltre un secolo a vari livelli (biologico, soggettivo, relazionale, culturale). Scrive Keith Oatley (3): “La complessità delle emozioni dipende essenzialmente dal fatto che esse, congiuntamente, hanno profonde radici neurobiologiche nel nostro organismo, sono un’esperienza soggettiva carica di importanti significati, hanno una valenza sociale nelle relazioni con gli altri e sono definite dalla cultura di appartenenza. Aspetti che interagiscono fra loro e s’influenzano a vicenda, con la conseguenza che le emozioni costituiscono esperienze multiformi, anche conflittuali e ambigue, che attraversano tutto il nostro organismo”. Aspetti questi frutto di indagini approfondite che la psiche si propone di indagare seguendo il percorso che la voce ha tracciato nell’immaginazione umana.
Da sempre la voce è stata considerata un ponte tra il mondo che noi abitiamo e il regno dell’invisibile, entro una realtà fin troppo misteriosa e sfuggente, che quasi è impossibile trascriverla nei termini del linguaggio discorsivo alla base della personalità. Qui il discorso sulla voce si intreccia a quello della musica con quello della psiche e alla pratica analitica, in un gioco di analogie situato sull’arduo confine che divide ciò che è da ciò che non lo è. Per una migliore comprensione di quanto qui affermato è però necessario fare un salto indietro nella storia, a quando il suono, che fondamentalmente è un “segnale acustico” prima di diventare linguaggio (gutturale) e comunicazione sociale, cominciò a svilupparsi nell’essere umano le proprie corde vocali anzitutto per via d’imitazione poi di onomatopee (mugugni, strepiti e suoni discordi), assimilando i rumori e le modulazioni del vento, dello scroscio delle acque, del boato delle valanghe, del ruggito delle fiere, tradotte sincronicamente in emozioni-suoni-messaggi, quali la gioia, la paura, l’angoscia, il dubbio, ecc. Con un salto forse di millenni, si verificò quello che è stato definito dallo storico Marino Serini (4): “..il passaggio dal suono originario inarticolato a quello associato che portò dalla causa oggettiva determinatrice, all’espressione verbale, ossia alla parola”.
Il suono umano, presupposto del linguaggio, è quindi un suono sociale e il mondo del suono umano è un mondo sociale, svincolato dalla percezione isolata e indipendente del singolo individuo e comparato con la percezione dell’altro, se ne scoprì un contenuto comune, un fatto sociale, appunto. Ce ne da conferma Alexei A. Léontiev (5) uno specialista in materia di linguistica e psicologia: “Affidare ad un suono (voce) un significato speciale vuol dire fissarlo, ripeterlo, diffonderlo, constatare di momento in momento il suo valore nello scambio di un’idea. Significa, in un processo ininterrotto, poter unire due (o più) suoni della cui significanza comune si è certi, e far nascere la parola, aprirsi al discorso”. (..) Da questo momento in poi, la parola, volendo designare una variante, si combina con gli altri suoni all’interno della sua stessa evoluzione. Poi, ecco che a lato del mondo della parola, sorge ancora un altro mondo: quello della comunicazione ad altri dei propri sentimenti. È ciò che avviene tramite forme che l’uomo si è create appositamente a questo scopo: la pittura, la scultura e infine la musica”.
Per quanto riguarda l’origine della musica, le opinioni degli scienziati divergono. La teoria più comune è che l’uomo abbia imitato i suoni della natura ma, in natura non esistono differenze chiaramente distinguibili nell’altezza del suono (6), che è poi il criterio di cui si sarebbe servito l’inventore della prima scala musicale che, guarda caso, nei primi esempi di notazione musicale, l’altezza dei suoni non è neppure riportata. A questo punto lo stesso Léontiev (7) si domanda e ci domanda: a quale scopo l’uomo primitivo avrebbe dovuto “fissare” nella memoria un suono di un’altezza determinata per poi paragonarlo ad altri? La risposta è ancora nell’aria, sebbene egli abbia cercato di dare una qualche riscontro: “Sembra più probabile che i primi suoni di un’altezza fissata siano stati quelli del linguaggio (parlato), che avevano già un senso per l’uomo. E non è senza ragione che i musicologi che studiano la musica dei popoli contemporanei di cultura arcaica (gli aborigeni della Terra del Fuoco, o i Vedda dello Sri Lanka) ricordano che presso questi popoli il canto è l’unica forma di musica che sia loro familiare e che c’è una sorprendente somiglianza nella struttura musicale dei loro canti”. L’esempio sembra davvero calzare alla capacità sistematica che si è sviluppata in seguito nella voce man mano con lo sviluppo della musica stessa, quest’ultima non essendosi mai separata interamente dalla parola.
“Esiste – prosegue Léontiev (8) – una gran quantità di lingue in cui solo le differenze di altezza del suono permettono di distinguere differenti parole o persino le differenti sillabe una dall’altra. È il caso del lituano e del serbo-croato, dello svedese e del norvegese, del giapponese e dell’aino, di numerose lingue dell’Africa e indiane d’America, del cinese, del vietnamita, del thai, del birmano, di lingue australesiane e di numerose lingue papuasiche. (..) Ma non esiste lingua, anzi non esiste parola, in qualsiasi lingua, che sia senza accento. L’accento è un frammento residuo del suono-discorso primitivo, rivolto ora ad una nuova funzione che prima non esisteva” – forse oggi rivolto a una comunicazione più veloce, e uno sviluppo più dinamico – (..) Tuttavia il discorso non è unicamente una somma di vocaboli. Le parole si uniscono in una enunciazione che ha un senso e, quel che designa la sua specificità (interrogazione, esortazione, esclamazione) e permette di mettere in evidenza la parte più importante è ancora il suono, questa volta rappresentato dall’intonazione (quindi la voce) di colui che parla. (..) Anche l’intonazione è una reminiscenza del suono primitivo, probabilmente anche animale. Non è senza ragione che gli animali «sprovvisti di parola» ed incapaci di imitarla, talvolta imitano l’intonazione umana. Dell’eredità animale nel linguaggio dell’uomo resta anche quella che si chiama l’interiezione : suoni inarticolati (onomatopeici) che permettono di esprimere senza parole le emozioni più semplici come lo spavento, la sorpresa, la gioia, la tristezza, l’ammirazione. Suoni (come voci) che si somigliano da una lingua all’altra, anche se non coincidono”.
Ora noi sappiamo che la fonte sonora più antica e spontanea che sia stata scientemente indagata è la voce umana, come pure sappiamo che il fattore essenziale nella produzione del suono è il moto che nasce da un corpo in vibrazione che genera onde di compressione-rarefazione nell’aria. La voce umana si comporta secondo lo stesso principio, rinforzato dalle cavità della bocca, del naso e della testa che fungono da casse di risonanza; che l’altezza del suono prodotto dipende dalla tensione delle corde vocali che, più sono tese più il suono da esse prodotto è alto e viceversa; e che il timbro della voce dipende dalla qualità e flessibilità di dette corde. Ed anche che alla base del sistema dei suoni di una data lingua, si trova la particolare immagine del mondo che in tale lingua si esprime, prima di diventare segnale, messaggio e comunicazione sociale. Se vogliamo, la meraviglia della sua evoluzione è tutta racchiusa in questo breve passaggio alla base della vita sociale di ogni popolo e che ne caratterizza ogni espressione di vita: la ricerca di comunicazione, sia in senso visivo, artistico e letterario, sia musicale con l’emissione dei suoni tramite strumenti. Donde la voce umana come esperienza delle simbiosi cosmiche che regolano lo svolgersi della funzione comunicativa, regolata a sua volta dalla natura terrestre, fonte esistenziale della ragione sociale che la determina.
Una volta divenuto sociale e comune a tutti gli uomini, il suono della parola, è divenuto indispensabile e la caratteristica dell’umanità. Attraverso il suono della parola ci appropriamo di tutta la ricchezza del sapere e dell’esperienza sociale. Con il suono – il suono della musica – arricchiamo il mondo delle nostre emozioni. A conferma di quanto affermato prima che “il suono umano è dunque un suono sociale ed il mondo del suono umano è un mondo sociale”. Dacché si è passati dall’emissione della voce “parlata” alla voce “cantata” (per caso, per gioco, per imitazione o forse le tre cose insieme), che in principio poteva somigliare a una sorta di cantillazione (riscontrabile in molte cerimonie religiose), l’andamento della sua evoluzione in corso è dimostrato inarrestabile. In seguito si trasformò nella modulazione della voce nella forma vera e propria del canto a “una sola voce”, intendendo con ciò non che a cantare fosse necessariamente una sola persona, ma che una o più (anche moltissime) persone cantano all’unisono, ossia cantano le stesse note con gli stessi intervalli e lo stesso ritmo. In termini musicali si chiama monodia, cioè di un canto espressione del singolo che da il via, cui gli altri si associano. Una forma che da principio ha valorizzato molto la melodia, e che solo successivamente, con il sostegno armonico degli strumenti, ha permesso il crearsi del vero canto come noi adesso lo intendiamo. Solo in tempi relativamente recenti, attorno al Mille, si è pensato di far cantare alcune voci all’unisono, note diverse ma tali da accordarsi armoniosamente insieme, e fu la nascita del coro così detto polifonico. Sebbene la parola: polifonia, dal greco polùs (molto) e foné (voce) è conosciuta fin dall’antichità e sta a significare un procedimento concomitante e simultaneo di più voci e parti della forma cantata. Rilevante importanza nella polifonia assume l’interazione acustica fra i timbri dei diversi suoni, siano essi prodotti da più voci, da voci e strumenti, o da più strumenti insieme.
La voce dunque, come strumento, il primo strumento musicale in assoluto, oltre che il principale strumento di comunicazione sociale che conosciamo. Tuttavia, prima ancora che assumesse l’aspetto di rilevanza estetica che il formarsi delle lingue gli hanno conferito, va considerata nel rapporto inter-linguistico che ha permesso l’incontro e lo scambio fra i popoli di origine e di lingua diversi. Ciò, per dire che dobbiamo considerarla alla stregua di una merce (preziosissima) di scambio culturale a livello internazionale che ha permesso, inoltre, di riappropriarci delle nostre origini primitive, e se vogliamo ancestrali, cui dobbiamo tutta la nostra conoscenza. Una sorta di involuzione attraverso la quale la voce umana fa ritorno al suo stato più puro , se vogliamo, più incontaminato, nell’universo cosmico del suono che ci circonda. Assimilare questa nuova immagine, sempre originale, sempre meravigliosa, richiede di saper guardare questo mondo dal di fuori e comprenderlo, cosa che ci regala ancora una grande felicità, oggi accessibile ad un numero maggiore di persone. Sempre che lo si voglia.
Discografia e altro:
In molte composizioni, soprattutto di autori del Novecento, torna a fare la sua apparizione quella che era la voce narrante o recitante conosciuta nell’antica tragedia greca, e che introduceva il mito e narrava gli avvenimenti della storia inerenti alla rappresentazione. Nulla di nuovo quindi se non che la voce narrante è parte imponente di una vasta cultura etnografica e musicologica che la vede partecipe in tutte le manifestazioni di carattere collettivo fin dai primordi: nella rappresentazione coreutica della danza, nel teatro, nella trasmissione di leggende mitologiche, di fiabe e racconti, e nella definizione musicale. Le sue radici in Etnomusicologia si inoltrano ovunque, in ogni luogo geograficamente conosciuto, fino alle isole più lontane sperse negli oceani e le oasi dimenticate dei deserti, nelle capanne dei pastori come nelle dimore dei re di biblica memoria, in cui la narrazione è manifestata dalla voce di un narratore o narratrice che attraverso di essa ci rende partecipi di qualcosa che è stato o che sarà, non importa. Ciò che invece importa è la sua funzione di strumento di esposizione, trasmissione e divulgazione della conoscenza; che sia un griot, o un silatigi, o un cantastorie nostrano, ma anche un filosofo o un maestro che insegna ai suoi alunni, un cantautore di strada, tutti contribuiscono alla grande storia che l’umanità va scrivendo sul libro dell’universo dei suoni a testimonianza della propria esistenza.
In veste discografica cito qui la “Histoire d’u Soldat” di Jgor Strawinsky, La “Giovanna d’Arco al rogo” di Honegger, “Un sopravvissuto di Varsavia” di Schoenberg, in cui la voce recitante si inserisce nel contesto vocale e strumentale generalmente con inflessioni ritmiche o melodiche (indicate dal compositore), presupposto di un radicale rinnovamento dello stile vocale utilizzato per la prima volta da Schoenberg nel più famoso “Pierrot Lunaire”, e che va sotto il nome di Sprechgesang (sprechen- parlare; gesang – canto), e in seguito da Berg nel “Woizzeck” ed altri compositori con intento declamatorio, consistente in una declamazione intonata a metà tra il canto e la recitazione.
Inerente all’argomento qui trattato propongo l’ascolto del “Mosè e Aronne” ancora di Schoenberg dove si narra di Mosè che, depositario dell’idea assoluta, non può comunicarla perché gli manca la “parola”, mentre Aronne, possiede la “parola” ma la tradisce nel momento in cui la traduce in azione, e che bene evidenzia il contrasto esistente fra ideologia sociale, religiosa e politica, e l’azione che dovrebbe realizzarsi nella rappresentazione.
Di più facile ascolto segnalo “Visage” di Luciano Berio, interpretato da Cathy Berberian, della quale va ricordato lo strepitoso “Stripsody” un brano di sua composizione, commissionatogli dalla Radio di Bremen per il Festival di musica contemporanea (1966) dove la cantante mette in risalto le sue molteplici possibilità vocali.
“EclogaVIII” di Krzysztof Penderescki, eseguito con maestria dal gruppo polifonico dei Kings Singers.
“Alleluiah!” di W. A. Mozart interpretato da Sherley Verret, un’interpretazione unica.
“Maori Songs” canzoni in lingua Maori interpretate stupendamente da Kiri Te Kanawa.
“Chuncio: le creature della foresta” dalla “incredibile” voce dell’artista peruviana Ima Sumac, capace di far scorrere un brivido per la sua straordinaria esecuzione.
Più vicina al nostro tempo “La Mort Musik” di Beatrice Tekielski, più nota come Mama Bea, in cui la voce torna ad avere l’importanza primaria che gli avevano restituito Berio e Schoenberg, ma ancor più Cage e Stockausen nel ricondurla negli spazi cosmici originanti. Più che un cantare, quello di Mama Bea è un gridare in rock tutta la rabbia del mondo, che con la sua voce finisce per vivisezionare, smaterializzare nella sua sostanza vitale, e trasformarla in eco interplanetaria.
Bibliografia:
“The New Oxford History Of Music” vol.1 – Oxford Press – London - per l’Italia Garzanti-Feltrinelli – Milano 1991.
“Enciclopedia della Musica” – Garzanti, Milano 1996.
“The Larousse Encyclopedia of Music” – The Hamlyn Publishing Group – London 1978.
“Syntactic structures” – Chomsky, N., 1970, The Hague, Mouton, trad. it. “Le strutture della sintassi”, Laterza, Bari; 1969-1970.
“Aspects of the Theory of syntax”, Cambridge, Mass., MIT Press, trad. it. “Aspetti di una teoria della sintassi”, Boringhieri, Torino.
“Language and mind”, New York, Harcourt Brace Jovanovitch.
Note:
(1) Antonio Ottaviani, direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Milano.
(2) Claretta Aymone, psicologa
(3) Keith Oatley
(4) Marino Serini
(5) Alexei A. Léontiev, specialista in materia di linguistica e psicologia
(6) altezza del suono :
(7-8) A. A. Léontiev, op. cit.
“La “voce” visiva”.
“L’udito è un senso tanto sottile quanto arcaico, confinato in gran parte allo stadio fetale” – scrive Michel Chion (1) e da questa frase riprendiamo a occuparci della nostra ricerca sui significati della voce, certamente uditiva ma, come in questo caso, anche “visiva”, nello spettro più ampio del suo significato. Come abbiamo fin qui appurato, esistono specifiche correlazioni fra le capacità cognitive e apprendimento linguistico e musicale, riferito al quale apprendiamo ancora da Alessandro Bertirotti (2), quanto segue: “Musica e linguaggio sono atti creativi che possono essere interpretati alla luce di una soddisfacente teoria della mente. Sviluppo del linguaggio e sviluppo della musica sono il risultato di una complessa attività neuronale, strutturata ed organizzata. I risultati del Congresso Mondiale (New York, 2000), The Biological Fundations of Music, pubblicato dalla New York Academy of Sciences, evidenziano come il sistema di elaborazione linguistica sia strettamente legato a quello di elaborazione musicale. Musica e linguaggio non hanno due dimensioni separate e separabili. Le unità linguistiche, come diversi livelli di comunicazione, interagiscono fra loro e dipendono dai dinamismi contestuali presenti nella comunicazione, oltre che dalle interazioni fra individui e culture. È possibile individuare attraverso la mappatura cerebrale se esistono e quali sono le aree adibite alle competenze linguistiche e a quelle musicali. Differenza fondamentale: il linguaggio possiede uno spazio referenziale “oggetto reale” mentre la musica è considerata autoreferenziale. Uno schema interpretativo nel quale collocare l’assunzione di abilità cognitive musicali deve tener conto dei diversi livelli di plasticità cerebrale poiché questo concetto può legare indissolubilmente le acquisizioni di abilità musicali e del linguaggio a quelle di abilità cognitive generali”.
Lo avevano ben compreso i “futuristi” aderenti e ispiratori del movimento letterario e artistico così detto Futurismo (3) sorto in Italia nel primo decennio del ‘900, e che si prefiggeva una nuova estetica e una nuova concezione della vita, fondate sul dinamismo come principio base della moderna civiltà delle macchine e della tecnica, in contrasto con ogni forma di tradizionalismo nelle arti. Padre del Futurismo fu F. Tommaso Marinetti (4), che ne pubblicò a Parigi il primo Manifesto nel 1909. In letteratura i futuristi anticiparono il dada, praticando una sorta di scrittura automatica, le “parole in libertà” (Palazzeschi,Govoni, Soffici, Folgore e altri); nelle arti figurative andarono oltre la staticità del cubismo, tentando di riprodurre il movimento, anche quello interno alla materia (Balla, Boccioni, Severini, Depero, Carrà, Prampolini e, in architettura Sant’Elia). Notevole l’influsso che il movimento ebbe su scenografia, balletto (Diaghjlev e i Balletti Russi), musica (vedi discografia Collana Futura) e cinema (Bragaglia). In campo musicale gli unici rappresentanti di rilievo furono Francesco Balilla Pratella, che nacque in un ambiente familiare favorevole alla pratica della musica e Luigi Russolo, pittore oltre che musicista. A Russolo in particolare si deve l'invenzione dell'Intonarumori, uno strumento che usava per mettere in pratica la sua teoria del rumorismo, ovvero di una musica nella quale ai suoni dovevano essere sostituiti i rumori. Essi erano formati da generatori di suoni acustici che permettevano di controllare la dinamica e il volume. La sua prima apparizione fu al teatro Storchi. Nei componimenti l'esaltazione del futuro e delle sensazioni forti associate alla velocità e alla guerra appaiono come unico modo per avere una speranza nel presente.
A teatro, i futuristi perseguono la rifondazione del concetto stesso di comunicazione teatrale. Essi focalizzano la loro attenzione sulla relazione essenziale che si sviluppa fra testo, attori e pubblico, per recuperare non soltanto i valori di ogni singola componente, bensì anche il senso globale dall'interrelazione fra gli elementi. Il teatro futurista promuoveva anche la commedia e la farsa, anziché la tragedia o il dramma borghese. Tuttavia, nelle serate futuriste non era inusuale vedere il pubblico adirato a causa di spettacoli fatti di azioni deliranti. Le cronache dell'epoca riportano notizie relative agli attori futuristi che sfuggono all'ira degli spettatori, spesso provocata ad arte secondo gli intenti espressi nel Manifesto futurista del Teatro di varietà. Al cinema, Nel 1916 venne pubblicato il Manifesto della Cinematografia futurista, firmato da Marinetti, Corra, Ginna, Balla, Chiti e Settimelli, che sosteneva come il cinema fosse "per natura" arte futurista, grazie alla mancanza di un passato e di tradizioni. Essi non apprezzavano il cinema narrativo "passatissimo", cercando invece un cinema fatto di "viaggi, cacce e guerre", all'insegna di uno spettacolo "antigrazioso, deformatore, impressionista, sintetico, dinamico, parolibero". Nelle loro parole c'è tutto un entusiasmo verso la ricerca di un linguaggio nuovo slegato dalla bellezza tradizionale, che era percepita come un retaggio vecchio.
Davvero interessanti sono le sperimentazioni sull’acustica, i rumori, i suoni, la voce: “Manifesto dei Musicisti futuristi”, (1911), e “La musica futurista-Manifesto tecnico”, (1911), di Francesco Balilla Pratella (5). “L'arte dei Rumori”, (1913), Russolo. È normale che il Futurismo, nascendo in un'epoca decadente, abbia avuto tantissime contraddizioni. All'immobilismo scolastico e accademico ereditato dalle "tre corone" della poesia decadente (Carducci, Pascoli e D'Annunzio) i futuristi oppongono la dinamicità, il distruttivismo e, all'armonia e alla raffinatezza, contrappongono il disordine delle parole. Secondo i futuristi, questi poeti devono essere completamente rinnegati perché incarnano esattamente i quattro ingredienti intellettuali che il Futurismo vuole abolire: la poesia morbosa e nostalgica, il sentimento romantico, l'ossessione della lussuria, la passione per il passato.
Va quindi considerato “atto creativo” un altro aspetto fin qui trascurato dalla nostra ricerca, ed è ciò che rende la “voce” in certo qual modo “visiva”, per usare un linguaggio figurativo o comunque visivamente ponderato che Eduard Hanslick (6) ha teorizzato nel suo famoso “Il bello musicale” con il quale rivoluziona l’estetica musicale e insegna a “saper udire” la musica per quella che veramente è: pura forma, al di là di qualsiasi rappresentazione sentimentale e psicologica. Un aspetto questo che va certamente studiato in sede musicologica, mentre noi affrontiamo qui la tematica, piuttosto insolita, della “voce” in rapporto alle immagini, focalizzata da Francesco Lamendola (7), per cui: “La voce umana, reca impresse inconfondibilmente le caratteristiche essenziali del carattere, del temperamento, della sensibilità di una persona, indipendentemente da ciò che viene detto; e questo, quanto e più del suo viso o del suo aspetto fisico, anche perché è difficile contraffarla e mascherare non tanto i sentimenti che essa esprime, quanto la natura spirituale e profonda di colui, o colei, cui appartiene. (..) La nostra voce è una parte di noi stessi, perfino più del nostro aspetto fisico: quest’ultimo, infatti, può essere modificato con svariati espedienti, mentre la voce, non appena incominciamo a parlare, dice molte più cose di noi di quel che vorremmo, che ci piaccia o no. (..) Un osservatore attento, e soprattutto una persona dotata di un certo grado di sensibilità, non fa fatica a leggere in una voce anche quello che essa non dice, quello che si trova a di là delle parole: può capire se chi sta parlando ha fiducia in se stesso, oppure no; se è gioioso o pessimista; se è superficiale o profondo; se è felice o infelice; se ama la vita oppure no. La voce è come la firma di una persona: come il suo modo di camminare, di guardare, di respirare. (..) Ridare valore al significato della voce umana, significa ridare valore al rapporto personale con l’altro: l’unica forma di comunicazione che meriti veramente tutta la nostra attenzione e la nostra sensibilità, perché l’unica che può renderci delle persone migliori: più attente, più oneste, più coerenti, più comprensive”.
Data pertanto la particolare evoluzione mediatica attuale, di grande sviluppo tecnologico, in cui Lamendola (8) si trova ad affrontare questa tematica, da un certo punto di vista forse superata, ma ugualmente interessante, fa riferimento alla voce come non un semplice mezzo sonoro o di comunicazione, bensì alla sua resa visiva: “Le voci della pubblicità, in particolare, sono spesso accompagnate da immagini (tranne quelle radiofoniche); tuttavia, anche se tale sinergia crea un effetto assai potente, che sfugge alla coscienza della persona comune, è la voce in se stessa, più ancora dell’immagine, a poter suscitare in noi misteriose e profonde rispondenze, proprio per la maggior carica di suggestione emotiva che la voce umana possiede rispetto alla pura e semplice percezione delle immagini. (..) La voce umana è un mezzo di comunicazione estremamente «caldo», mentre le immagini, anche le più ben studiate per colpire e suggestionare lo spettatore, sono in se stesse «fredde»: al fascino sottile delle immagini si può resistere; a quello di una voce, quasi mai. Si può rimanere ossessionati da una voce più facilmente che da una immagine televisiva: perché la voce, anche se giunge da una fonte artificiale e se si rivolge indifferentemente a milioni di individui, evoca comunque la fisicità di colui che la emette; mentre l’immagine, se non è fruita direttamente, ma attraverso uno schermo elettronico (televisione, cinema, computer), per quanto coinvolgente possa essere, non riuscirà mai a dissipare interamente la consapevolezza che non si tratta di qualcosa di reale, ma di fittizio. (..) Bisogna osservare, infatti, che la voce umana, di per se stessa, è molto più di un semplice mezzo di comunicazione, come può esserlo la scrittura: i fogli di una lettera, per quanto possano contenere frasi e parole emozionanti, non arriveranno mai a suscitare quelle emozioni profonde, a volte sconvolgenti, che può produrre la voce di un altro essere umano, anche se questi non è fisicamente presente, purché si tratti di una comunicazione di carattere personale”.
Va qui detto, però, che anche la comunicazione radiofonica è in grado di esprimersi per immagini, nel senso che se sentiamo, ad esempio, una sgommata d’auto, subito immaginiamo un’auto che parte, al contrario una frenata secca, un’auto che arriva; così come il versare di un liquido ci fa immaginare un bicchiere o un contenitore che si riempie, e magari ci viene perfino sete. C’è però un mezzo che ancor più si avvale del suono e della parola contemporaneamente, il cinema, dove spesso la voce è nell’aria, per così dire fuori-campo, non solo come voce ma come suono, come ispirazione, appunto, “come immagine”. Per contro, i suoni e le voci vaganti sulla superficie dello schermo, vanno alla ricerca di un luogo ove stabilirsi, e spesso appartengono al cinema e soltanto a esso. Ma gli effetti prodotti dalla voce sullo spettatore sono tanto più inafferrabili e inquietanti in quanto si manifestano in un movimento, in un paesaggio, all’interno di un magma sonoro unico, allo stesso tempo reale e surreale. Un paesaggio sonoro che pur vive, in cui i suoni non si riducono a piatte argomentazioni delle immagini, ma acquistano una loro autonomia inserendosi nel racconto con una funzione metaforica e simbolica, onde stabilire una sorta di scala di percezione.
Un libro di Umberto Galimberti (9) dal titolo “Paesaggi dell’anima” trasferisce alla parola, filosoficamente parlando, immagini animate del nostro subconscio alla coscienza attiva, talvolta appena percepibili ma pur sempre rapportate alla dimensione occupata dai corpi che la emettono, riuscendo così a ottenere effetti al tempo stesso inquietanti e originali. Parafrasando questa formula possiamo dire che la presenza della voce umana ristabilisce l’unico contatto possibile con la realtà, nel senso che ridefinisce lo spazio sonoro che la contiene. La stessa cosa avviene per qualsiasi spazio sonoro, che sia vuoto o meno, se comprende una voce umana oppure no, inevitabilmente l’orecchio dell’ascoltatore vi si accosterà e, isolandola, organizzerà attorno ad essa la percezione dell’insieme; cioè tenterà di localizzarla e, se possibile, di identificarla come voce, e nel caso di un puro suono (o rumore), cercherà di estrarne il senso, il significato intrinseco. Così la nostra attenzione, pur in mezzo a un torrente di suoni, viene attratta innanzitutto da quel “doppio” di noi stessi che è la voce. Vale qui la pena sottolineare che tra una situazione visualizzata e l’altra, acusmatica (10), non è il suono a mutare natura, presenza, distanza, colore, cambia solo il rapporto tra ciò che si vede e ciò che si sente.
Per capire dove stia il nocciolo di questa differenza è interessante comprendere alcuni costrutti, non fosse altro per distinguere almeno due casi specifici: a seconda che si fissi o no un volto su di una voce. È come se la voce (fuori campo) vagasse sulla superficie dell’immagine, ora dentro ora fuori, in cerca di un luogo ove stabilirsi o, diversamente, quando ancora non è stato mostrato in quale corpo questa voce abbia dimora. Proprio perché la voce fuori-campo fa riferimento al soggetto del racconto, con il duplice significato di “ciò che accade” e “colui al quale ciò accade”, e perché pone il problema del sapere e del desiderio del soggetto, cioè dal suo punto di vista: “Ed è proprio questa la funzione che solitamente gli si attribuisce: un segreto mitico e cosmogonico”. Ciò vale per un corpo senza voce (muto) che, guarda caso riguarda strettamente il cinema muto, che si vede assegnare le stesse caratteristiche del suo opposto, da cui la voce senza corpo, la voce cosiddetta acusmatica, che è poi la voce di qualcuno che non si vede.
È il dubbio che il cinema muto lascia aperto sul proprio sapere e potere ( e anche sul sapere e sul potere degli altri), a definire la sua collocazione nella struttura del racconto (filmico). Dubbio che si riferisce soprattutto ai limiti: corpo senza voce e voce senza corpo sembrano ugualmente non avere limiti definiti. Quasi che l’attore del muto (o colui che non ha voce), avesse la possibilità di essere ovunque e in nessun luogo, dappertutto e in nessuna parte, quasi fosse un archetipo del doppio. Come anche la sua coscienza, come complice, come ombra e strumento di rimprovero morale, per evidenziare un dubbio o una finzione, un vuoto o una mancanza (ma anche una presenza), come una maschera la cui unica funzione è quella di evidenziare il nulla, o forse il tutto. Come di colui (l’interprete di noi stessi) che osservando il silenzio subito è proiettato nel vuoto, è trasformato nell’esecutore (della voce), che osserva l’infinito. Ma sarebbe un errore affermare che acquistando “voce” essa cada in un destino comune. Al contrario, proprio per il fatto di perpetuare se stessa in forme sempre diverse sul modello dei mezzi di comunicazione che gli sono contemporanei, e soprattutto su tutti i fuori-campo che gli è dato attuare, la “voce” permette di interpretare quell’assoluto che guida gli uomini sui sentieri della creatività.
E “musica dal silenzio” è considerata oggi tutta quella musica che è alla base del messaggio che forma il repertorio della concezione filosofica e di introspezione, di libertà espressiva totale, di amore per la purezza e la semplicità, che ritroviamo nell’esperienza della cosiddetta New Age. Musica pensata, suonata e interiorizzata, fatta soprattutto da chi ascolta e che permette di compiere un viaggio lungo e misterioso attraverso i suoni del silenzio, al seguito della concezione del filosofo indiano Osho (11), per cui: “il silenzio di chi suona s’incontra con il silenzio di chi ascolta all’interno di una dimensione che porta a scoprire uno spazio vastissimo nell’io profondo”. Un silenzio che in fondo ci permette di andare alla riscoperta del “primitivo” qui inteso come rivisitazione di quello che doveva essere in principio il paesaggio sonoro che lo circondava. Un mondo di profondo silenzio, in cui la natura giocava il suo ruolo fondamentale, preparandosi a ricevere l’uomo e la sua oralità.
Ecco un brano “storico” che possiamo anche definire “un classico” della letteratura che apre a un altro aspetto, inusitato, della nostra ricerca: “L’odore dell’India”, di Pier Paolo Pasolini (12).
“Così arriviamo sotto la Porta dell’India, che da vicino, è più grande di quanto sembri da lontano (..) e, nella penombra dell’arco, si sente un canto: sono due, tre voci che cantano insieme, forti, continue, infervorate. Il tono, il significato, la semplicità, sono quelli di un qualsiasi canto di giovani che si può ascoltare in Italia o in qualsiasi paese dell’Europa: ma questi sono indiani, la melodia è indiana. Sembra la prima volta che qualcuno canti al mondo. Per me: che sento la vita di un altro continente come un’altra vita, senza relazioni con quella che io conosco, quasi autonoma, con altre sue leggi interne, vergini. Mi pare che ascoltare quel canto di ragazzi sotto la Porta dell’India, rivesta un significato ineffabile e complice: una rivelazione, una conversazione della vita”. Così descrive il suo incontro con l’India, nelle note autobiografiche del suo viaggio avvenuto nel 1961, con genti e costumi tanto diversi e tanto remoti che pure lasciò un segno indelebile nella sua fantasia di poeta. Oggi, a distanza di tempo, “L’odore dell’India”, mantiene intatta la sua azione comunicativa che va oltre il tempo e le cose. La scelta significativa dell’India vuole qui sottolineare l’importanza di una così vitale iniziativa che andrebbe ripresa in molti campi della ricerca scientifica e culturale.
Straordinariamente interessante è la ricerca etnomusicologica svolta da Fabrizio Cassano (13) in “Per le strade dell’India” e successivamente in “Impressioni di un viaggio in Nepal”, che l’autore ha sottotitolato “fotografie sonore”. In realtà si tratta di due dischi live che raccolgono il “paesaggio sonoro” di luoghi impervi e lontani con cui l’autore attrae l’attenzione sia dell’ascoltatore improvvisato, quanto dell’avventore, ossia di quel viaggiatore attento, capace di comprendere attraverso i suoni e le voci, la manifestazione di un vivere spirituale che è ancora oggi considerata tra le forme più antiche della ritualità trascendentale. “Attualmente – scrive Cassano – le mie ricerche hanno come punto focale i vari rituali, comuni e non, propri dei popoli indo-nepalesi, forse gli ultimi ancora a mantenere un rapporto intimo con le forze della natura”. Sonorità di una processione al tempio, di celebrazioni rituali, canzoni di strada e melodie classiche, momenti di vita quotidiana, le voci di venditori, i canti dei contadini, la preghiera in una lamaseria, la storia narrata di un griot nepalese, il frammento di una banda musicale che fa uso di strumenti originali, sono qui raccolte sul campo a Delhi, Benares, Jaipur e nei villaggi sperduti della catena dell’Himalaya: “Nel tentativo – egli afferma – di comprendere, attraverso la ritualità della musica e gli innumerevoli spazi del pensiero, quelle verità trascendentali che sfuggono a noi europei. Nell’intento di portare alla mente dell’ascoltatore, attraverso la semplice documentazione sonora, le immagini come realmente i miei sensi le hanno recepite, che è poi ciò che più mi affascina nel lavoro di ricercatore”. Ed ecco che la musica captata da Cassano, assume la sua vera dimensione per fuoriuscire dal solito programma itinerante, per divenire sollecitazione, riflessione, stimolo, percezione; musica come ricordo e comunicazione e, non in ultimo, come veicolo di scambio tra le diverse culture.
Come abbiamo avuto modo di vedere Etnomusicologia non riguarda una sola materia polverosa e stantia ma abbraccia tutto il mondo della conoscenza e coinvolge moltissime discipline “altre” che ci hanno permesso di spaziare nelle così dette “scienze” ufficiali, ma non è tutto qui, ben altri sono i campi di applicazione che in parte abbiamo scandagliato, e comunque visitato, in questo percorso certo riduttivo della materia etnomusicologia. Spetta a ognuno di noi continuare la ricerca avviata e inoltrarci se possibile anche in altre dimensioni “parallele” in cui la materia etnologica e musicologica possa trovare la sua pertinenza, all’interno e all’esterno dei “mondi” in cui viviamo: la religione, la magia, la superstizione, i miti vecchi e nuovi, le tradizioni dimenticate, i viaggi.. ma questi sono solo alcuni dei molti suggerimenti che potrei darvi e in cui potreste avanzare una ricerca.. Basta volerlo! Ogni suggerimento, apporto, commento, purché ponderato e accrescitivo della conoscenza è ben accetto, e va inserito nell’apposito spazio riservato ai commenti. Grazie per avermi seguito fin qui e, a presto! Vi aspetto.
Discografia e altro:
“Il bello musicale”, di Eduard Hanslick Giunti martello – Firenze 1973. Su questo famoso libro, tradotto in tutte le lingue europee, si è orientata la cultura musicale contemporanea.
“Il Futurismo”, Maurizio Calvesi, Milano, 1969.
“Musica Futurista”, Antologia sonora a cura di D. Lombardi. Testo introduttivo di L. Rognoni 2Lp Cetra FDM 0007 – 1986.
“Marinetti e il Futurismo”, LP EMI 3C-065 17982/A – con la voce di T. Marinetti.
“Futura: Antologia storico-critica della poesia sonora” – AAVV – Cramps - 1978
“I poeti futuristi”, a c. di M. Albertazzi, con i saggi di G. Wallace e M. Pieri, Trento, La Finestra editrice, 2004. - L'opera contiene in appendice i manifesti futuristi.
“Lettura di un’immagine” di L.Romano – Einaudi, Torino 1975.
“Per le strade dell’India” e “Impressioni di un viaggio in Nepal”, due Lp di Fabrizio Cassano, Ducale FD.
“La Voce: tecnica e storia dal canto dal gregoriano al rock”, libro di Francoise E. Goddard - F. Muzzio Edit. Padova 1985.
“Il linguaggio delle immagini in movimento” –di Virgilio Tosi – Armando Editore Roma 1986.
“Le sorgenti della musica”, con una introduzione di Diego Carpitella, libro di Curt Sachs – Boringhieri – Torino 1979.
Note:
(1) Michel Chion, “La voce nel Cinema”, Pratiche Editrice – Parma 1991.
(2) A. Bertirotti (dispense a.a. 2001-2002 del Seminario Etnomusicologia e antropologia della musica tenuto all’interno del Corso di Etnologia – Università agli Studi - Firenze).
(3) “Futurismo & Futurismi”, Catalogo Mostra a c. di P. Hulten, Milano, Bompiani, 1986.
(4) Filippo Tommaso Marinetti “Opere” – Meridiani Mondadori - Milano
(5) Francesco Balilla Pratella compositore e musicologo, allievo di Mascagni, nel 1910 aderisce al Futurismo redigendone i manifesti musicali. Dello stesso anno è, infatti, il “Manifesto dei musicisti futuristi” a cui seguiranno il “Manifesto tecnico della musica futurista” (1911) e “Distruzione della quadratura” (1912). Collabora con la rivista fiorentina “Lacerba” dove pubblica nel 1914 il testo musicale “L’aviatore Dro, op.33” e l’articolo “Gl’intonarumori nell’orchestra” che rappresenta la sua adesione al manifesto di Russolo “L’arte dei rumori”. Nel 1918 collabora con il quotidiano bolognese “Il Resto del Carlino” e dal 1919 al 1921 al “Popolo d’Italia”, su invito personale di Mussolini. Compone gli intermezzi musicali del dramma di Marinetti “Il tamburo di fuoco” e dal 1923 al 1927 compone le sue opere più felici “Ninna nanna di bambole, op.44”, “Dono primaverile, op.48”, “Il fabbricatore di Dio, op.46”, “Popolaresca”, composta per gli spettacoli del Teatro della Pantomima futurista. In questi stessi anni non tralascia l’attività di saggista per molti periodici culturali, tra cui il “Pensiero musicale” di Bologna, di cui assumerà la direzione. Significativa la sua attività di etnografo e raccoglitore di canti romagnoli che si inserisce nell’ambito della generale riscoperta del patrimonio musicale nazionale, in linea con l’ascesa del fascismo. Nonostante il male incurabile che lo porterà alla morte, riesce ad ultimare l’“Autobiografia” che sarà pubblicata postuma, a Milano, nel 1971.
(6) Eduard Hanslick “Il bello musicale”, Giunti martello – Firenze 1973. Su questo famoso libro, tradotto in tutte le lingue europee, si è orientata la cultura musicale contemporanea.
(7- 8) Francesco Lamendola, in www.ariannaeditrice.it 2009: (sito di Arianna Editrice).
(9) Umberto Galimberti dal titolo “Paesaggi dell’anima”
(10) acusmatica: L'arte acusmatica è un tipo particolare di musica elettronica, creata per essere ascoltata tramite altoparlanti. Il termine musica acusmatica è stato coniato dal compositore francese Pierre Schaeffer, nel suo libro Traité des Objets Musicaux (1966), e deriva dal termine acusmatico e dall'akusmatikoi, la scuola pitagorica i cui discepoli udivano il maestro parlare dietro ad un velo. Nell'arte acusmatica, il velo è una metafora dell'altoparlante. Le opere che ne risultano sono opere su supporto: esse non si manifestano se non attraverso la lettura del supporto sul quale sono state registrate, fissate in forma definitiva (su dischi flessibili alla fine degli anni quaranta, poi sul nastro magnetico dei magnetofoni e oggi sulla memoria dei calcolatori).
(11) Osho, autore di più di seicento testi dove parla di oriente e occidente, di magico e reale, di mistero e scienza, di spiritualità e materialismo, dell’esperienza del Tao in funzione anche della musica. “Un’esperienza determinata dall’incontro di musicisti di diverse nazionalità e formazioni musicali, alcuni provenienti dal mondo del rock, altri da quello del jazz, dal classico e dalle tradizioni folk. Musicisti alla ricerca del “soundless sound”, cioè dal suono che nasce dal silenzio, mediatori attratti dalla magia delle sonorità e creano una musica di fusione universale, integrata nelle tecniche di meditazione” – scrive Marcella Damon in un articolo apparso su New Age Sounds. Tra gli altri vi figurano Hari Deuter, Carlos Santana, Terra Incognita, Hariprasad Chaurasia, Swami Amareesh, Sambhodi Prem, Alice Coltrane, Cat Stevens e moltissimi altri.
(12) Pier Paolo Pasolini, “L’odore dell’India” - Longanesi - Milano 1978.
(13) Fabrizio Cassano, musicista e ricercatore etnico, si è rivelato negli anni ’80 con 2 album di grande interesse culturale per la ricerca sul campo (vedi discografia). Nel 2007 ha svolto una ricerca approfondita sulla cultura musicale in Cambogia: “Il compito di un ricercatore é quello di offrire alle persone cui si rivolge un numero di dati atto ad aumentare la loro conoscenza”. - Musica
- Musica
Quaderni di Etnom. 3 - La comunicazione vocale
“Demetrio Stratos: alla ricerca della voce perduta”, di Giorgio Mancinelli, apparso su "Vita", 10 febbraio 1979 e su "Nuova Scienza" n.4 -1979.
(Altri brani tratti da “Folkoncerto: La voce come strumento di comunicazione”, andato in onda su RAI Tre.
Che la voce in quanto segno distintivo che da sempre rende diversi gli 'umani' dagli altri esseri viventi è stato più volte detto, ma che proprio per questo oggigiorno continua ad affascinare studiosi e ricercatori forse no. Ed ecco arrivare la risposta a una domanda che ancora non ci siamo posti, sul 'mistero' che la voce ci distingue l'uno dall’altro. Certamente sì! Perché è unica, individuale e profondamente soggettiva. È, per così dire, il nostro marchio, come un’impronta digitale, una singolarità del DNA. Tuttavia: “Parlare della voce è sempre difficoltoso a qualunque livello..” – scrive Laura Pigozzi (1) del Movimento Psicanalitico Nodi Freudiani, studiosa delle connessioni tra psicanalisi ed espressione vocale su cui ha scritto numerosi saggi, nonché autrice di un prezioso libro dal titolo significativo “A nuda voce”, letto il quale, mi sono reso immediatamente conto di non avere niente altro da aggiungere, alla sua davvero ampia e persuasiva trattazione. “Il mistero della voce – scrive – è il marcatore che ci differenzia dal mondo animale e ci distingue l'uno dall’altro: è unica, individuale e profondamente soggettiva. Ma non può essere solo per questo che la voce ci cattura: lo sanno gli insegnanti quando cercano di far distinguere agli allievi i vari suoni che possono produrre o quando vogliono insegnar loro a crearne di nuovi; lo sanno i cantanti quando sono in difficoltà a descrivere il rapporto con la propria voce, soprattutto nei momenti in cui tale relazione entra in crisi”. (2)
“Per poterne dire, infatti, si usano metafore spesso prese da altri campi: dal registro del visivo, quando si parla del colore di una voce, della sua brillantezza o opacità, o persino dal repertorio del gusto, quando diciamo di un suono rotondo o pieno, aspro o dolce, quasi si trattasse di un buon vino. La metafora è, quindi, la forma di discorso più adatta per cogliere qualcosa della complessità della voce, della quale bisogna imparare ad accettare il difetto – che è pure la qualità che la rende interessante - di sfuggire sempre un po’, quasi fosse un amato o un’amata che mai si possiede fino in fondo. (..) Il rapporto che la lega al soggetto è sempre un po’ ambivalente, ambiguo, fatto di luci e ombre. (..) Ci sembra, infatti, di non possedere mai veramente la nostra voce, come quando, ascoltandoci in registrazione, non la riconosciamo come nostra. Tradizionalmente molte discipline hanno tematizzato la voce, da quelle artistiche a quelle mediche, ma la psicanalisi intrattiene con essa un rapporto di lunga storia che riguarda la nascita stessa di quest’arte: innanzitutto l’analisi è una talking cure, come l’ha giustamente definita la famosa paziente Anna O., al secolo Berta Pappenheim, in seguito diventata sociologa di rilievo”(3).
“Inoltre, la voce, e non solo la parola, acquista una rilevanza speciale nel rapporto tra paziente e analista: la voce del paziente cambia durante il percorso analitico e i momenti di trasformazione sono segnalati da caratteristici picchi di modificazione vocale. Per questo motivo al perdere la voce saranno dedicate molte riflessioni sulle voci familiari si aprirà articolandosi appunto intorno a tale interrogativo. Qual è la nostra vera voce, allora? Si capisce allora quanto, per parlare di voce, la metafora risulti indispensabile: infatti, c’è come un indicibile nella voce e per questo l’indagine psicanalitica deve occuparsene, dal momento che la psicanalisi si occupa, appunto, di indicibili. Benché esistano aberrazioni come il lifting vocale, peraltro di dubbia efficacia, fortunatamente il timbro individuale non è modificabile, come accade invece nella chirurgia plastica del polpastrello che può cambiarne l’impronta”. (..) Più in generale, possiamo dire che dalla voce viene la possibilità di trasmissione di ogni sapere che riguarda intimamente l’uomo nel suo difficile, e per nulla scontato, percorso di umanizzazione: nessuna formazione autentica, infatti, ha potuto o potrà mai affidarsi alla sola parola scritta. Occorre una voce che faccia da legame, da cuore del transfert, perché qualche frammento di verità passi tra un maestro e un allievo”(4).
“La voce, infatti, è implicata nella stessa possibilità della psicanalisi di trasmettersi e di creare un movimento: la psicanalisi, che per sua natura non può essere scolastica, ha bisogno del mezzo più vivo possibile, della voce, dunque, per il legame indissolubile che quest’ultima intrattiene con il lavoro dell’inconscio. E’ la voce, infatti, la voce e non solo il linguaggio – ad aprire l’accesso all’inconscio. La voce è l’inconscio, che si relaziona con i suoi colori, con le inaccessibilità del soggetto che, inaspettatamente, s’insinuano nel suo dire. La voce non è mai solo sostegno della parola; essa è – parafrasando Paul Valéry – come la poesia: un’esitazione prolungata tra suono e senso. Tra loro c’è l’inconscio, c’è la voce”. L’autrice si pone una domanda davvero molto interessante: “Ma perché le voci sono tutte diverse? – e ci offre anche una risposta plausibile – Certamente non solo per motivi anatomici. Il fatto è che la voce è anche e soprattutto memoria: la sua musica conserva le tracce della nostra storia che, a partire dal soffio iniziale, ne ha formato la trama, il timbro, il colore, la pasta. La voce è fondamento della soggettività”(5).
È ancora la linguistica, nello specifico la glottologia (detta anche linguistica storica, o linguistica diacronica), la disciplina che si occupa dello studio strutturale delle lingue e delle loro famiglie etimologiche e grammaticali, a venirci in aiuto nella comprensione del processo di evoluzione linguistica. L'obiettivo è tracciare lo sviluppo e le affiliazioni genetiche delle lingue nel mondo, e di comprendere le lingue cambiano nel tempo. Una classificazione di tutte le lingue in alberi genealogici è al tempo stesso un risultato importante ed uno strumento necessario di questo sforzo. Quelli che una volta erano dialetti della stessa lingua possono eventualmente divergere abbastanza da non essere più intercomprensibili, e da essere considerati lingue separate. Lo studioso di glottologia è il glottologo. Gli strumenti principali della glottologia sono l'analisi dei ricordi storici e la comparazione delle caratteristiche interne – vocabolario, morfologia e sintassi – di lingue attuali ed estinte.
L'obiettivo è tracciare lo sviluppo e le affiliazioni genetiche delle lingue nel mondo, e di comprendere le lingue cambiano nel tempo. Una classificazione di tutte le lingue in alberi genealogici è al tempo stesso un risultato importante ed uno strumento necessario di questo sforzo. Quelli che una volta erano dialetti della stessa lingua possono eventualmente divergere abbastanza da non essere più intercomprensibili, e da essere considerati lingue separate. Lo studioso di glottologia è il glottologo. Gli strumenti principali della glottologia sono l'analisi dei ricordi storici e la comparazione delle caratteristiche interne – vocabolario, morfologia e sintassi – di lingue attuali ed estinte. Come ormai è d’abitudine in questa ricerca, un passo indietro nella storia ci aiuta alla comprensione: “Uno dei metodi per illustrare la relazione tra lingue così divergenti eppure imparentate, è di costruire alberi genealogici, un'idea introdotta dal glottologo ottocentesco August Schleicher (7). La base è il metodo comparativo: le lingue che si presumono imparentate vengono confrontate, e il glottologo cerca corrispondenze fonetiche regolari basate su ciò che si sa del cambiamento linguistico, e le usa per ricostruire l'ipotesi migliore sulla natura dell'antenato comune da cui discendono le lingue attestate. L'uso del metodo comparativo è validato dalla sua applicazione a lingue il cui antenato comune è noto”.
Il metodo comparativo può essere usato per ricostruire lingue di cui non esistono testimonianze scritte, o perché non è stata preservata alcuna testimonianza: “È importante notare che il metodo comparativo si propone di distinguere la derivazione cosiddetta genetica - cioè il passaggio di una lingua di padre in figlio attraverso le generazioni – da somiglianze dovute a contatti culturali tra lingue contemporanee. Una volta che sono stati stabiliti i vari cambiamenti nei rami discendenti, e si è compreso una buona parte del vocabolario fondamentale e della grammatica della protolingua, allora gli studiosi generalmente concorderanno che una relazione di parentela genetica è stata dimostrata. Ad esempio, circa il 30% del vocabolario persiano viene dall'arabo, come risultato della conquista araba della Persia nell'VIII secolo e di importanti contatti culturali successivi. Eppure il persiano è considerato una lingua indoeuropea — per via del vocabolario fondamentale, che generalmente ha corrispondenze indoeuropee (mâdar = madre), e per molte caratteristiche grammaticali tipicamente indoeuropee”(8).
Poiché è così difficile supportare relazioni genetiche distanti, ed il metodo comparativo per trovarle e dimostrarle non è ben stabilito, il campo delle parentele più remote abbonda di controversie accademiche. Nondimeno, la tentazione di inseguire parentele remote resta un'attrazione potente per molti studiosi – dopo tutto, il protoindoeuropeo (9) doveva sembrare un'ipotesi piuttosto azzardata a molti quando fu proposto inizialmente. Ma come sappiamo, ormai accettato ampiamente. La linguistica comparativa, dunque, è uno studio che si sviluppa entro i confini dell'evoluzione storica e le fasi che ne contrassegnano i momenti di cambiamento e di differenziazione. Un sistema comparativo, appunto, che analizza il sovrapporsi dei vari stadi di trasformazione della lingua attraverso le contaminazioni che via via si accumulano nel tempo sotto la spinta di successivi mutamenti morfologici e fonematici. Donde il valore significante assume, di volta in volta, significati nuovi che sostituiscono quelli precedenti e si innervano nella nuova struttura antropologico - culturale che le ha generate.
Abbandoniamo qui la scienza linguistica per tuffarci nella letteratura scientifica più inerente alla nostra ricerca e lo facciamo con un’affermazione di Norman D. Hogikyan (10), direttore del Vocal UM Health Center, che ci ricorda non solo a pensare la salute vocale, ma i modi in che la voce umana influenza le nostre vite e ci unisce: "La voce comunica molto di più che semplici parole, ci lega tutti insieme e ci aiuta a definire come esseri umani. (..) Avete mai avuto l'esperienza del viaggio in un paese dove non si parlava la lingua e sembrava ancora in qualche modo di comunicare? Mentre agitando le mani e puntare il dito può certamente aiutare con le indicazioni, la voce umana comune permette rapidamente di discernere, che è un nuovo amico pronto a fornire assistenza e con i quali ci si può collegare vocalmente. Anche in questa epoca di sms, e-mail, Facebook e Twitter – egli dice – la parola rimane la principale modalità di comunicazione in tutto il mondo per la maggior parte delle persone - una vera comunicazione e non solo la diffusione di informazioni o supporto. Anche un individuo che utilizza spesso la comunicazione elettronica hanno avuto l'esperienza di aver bisogno della parola per chiarire un punto o risolvere un conflitto che si è sviluppato nel corso di un testo mal interpretato, e-mail o inviando. La comprensione reciproca che passa attraverso la voce umana non può essere duplicato. Mentre le parole di una canzone può essere fonte di ispirazione o di cuore, non si ha realmente bisogno di capire la lingua viene cantata per essere spostato? Non è la bellezza della voce umana stessa che ci si muove attraverso il canto?”.
Ed eccoci giunti al punto “focale” del problema che qui più si vuole affrontare più che altro in termini musicologici, e lo facciamo con Demetrio Stratos (11) andando alla “ricerca della voce perduta”, così come, il ricercatore piuttosto che l’artista, l’ha sperimentata “dal vivo” nel breve corso della sua vita che, ricordiamo tutti ancora con apprensione, e di cui ci ha lasciato il ricordo dei suoi importanti studi sulla voce, non ancora teorizzati, incentrati perlopiù su sperimentazioni e ricerche vocali. Il suo studio della voce come strumento lo portò a raggiungere risultati al limite delle capacità umane: nella sua massima esibizione raggiunse i 7000 Hz (un tenore "normale" può arrivare mediamente a 523 Hz, mentre un soprano - quindi una donna - può raggiungere i 1046 Hz) ed era in grado di padroneggiare diplofonie, trifonie e quadrifonie (due, tre e quattro suoni contemporaneamente emessi con la voce). Infatti, progressivamente inoltratosi nel misterioso mondo dei suoni riprendendo ed ampliando un vasto discorso sul significato della voce a partire dalle civiltà orientali (tecnica Pansori(12)) e medio - orientali (tecnica di vocalizzazione palatale), quando nel 1978 lasciò gli Area per dedicarsi esclusivamente alla ricerca vocale, e non solo, molti musicisti sperimentali, già vedevano in lui il loro esponente di spicco, tanto da rimbalzare in vari programmi mediatici, solitamente non avvezzi alla musica alternativa, con la sua sproporzionata (e quasi soprannaturale) capacita vocale, che possiamo ancora apprezzare incisa sui dischi fonografici, purtroppo di non facile reperimento.
“Cantare la voce”(13), registrato dopo lunghe prove, senza ausili meccanici o elettronici, nel maggio del 1978, è un disco molto particolare, interessante per chi è attratto dalle potenzialità del corpo umano, pur richiedendo un ascolto reiterato per esser apprezzato nel suo insieme, un vero e proprio studio sulla teoria della musicalità della voce, capace di produrre suoni senza strumenti. Non un disco di musica in quanto la musica è assente, semplicemente registrato in base a studi e sperimentazioni di escursioni vocali, vocalizzi, suoni, che paiono e sono, grugniti mescolati ad acuti elevati, umanamente inconcepibili, nonché gargarismi, grovigli e peripezie vocali capaci di produrre suoni simultanei che si sovrappongono. Una molteplicità di suoni che lascia letteralmente esterrefatti chi ascolta in quanto le monodie tipiche vengono letteralmente “sostituite” da vocalizzi che rappresentano e sostituiscono a tutti gli effetti delle piccole orchestrazioni, più suoni emessi contemporaneamente e chiaramente distinguibili. Stratos è visceralmente attratto dalle potenzialità della voce che non smette di esercitare nella sperimentazione del proprio corpo come strumento: «L’ipertrofia vocale occidentale ha reso la voce pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandola nel recinto di determinate strutture linguistiche. È ancora molto difficile scuoterla dal suo processo di mummificazione e trascinarla fuori da consuetudini espressive privilegiate e istituzionalizzate dalla cultura delle classi dominanti, e che si spinge al recupero della dimensione primordiale in cui la sacralità della voce introduceva l’ascoltatore in una dimensione magica capace di curare l’anima» (14).
Scrive Gianni Sassi (15): “Spezzando la barriera che tiene prigioniera la vocalità nelle sue strutture linguistiche e psicologiche Stratos ha elaborato un sofisticato progetto di liberazione della «voce cantata» dagli «ideologismi» della cultura e della politica. Un progetto sorretto da grandissime capacità vocali e da complesse ricerche tecniche teoriche, che l'hanno portato dai palcoscenici del pop all'Istituto di Glottologia dell'Università di Padova, dalle performance nelle gallerie d'arte europee ai musei di tutto il mondo e in particolare a quel Roundabout Theatre di New York che vanta la direzione tecnica di John Cage di cui Demetrio è stato l'inimitabile interprete dei suoi più recenti lavori a partire da “Mesostics”, ne esiste una superba versione discografica del 1974. Se la «militanza» con gli Area ha dato al pop italiano le sue più belle bandiere, da “Arbeit macht frei” del 1973 a Maledetti del 1978, (gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano) è, tuttavia, la collaborazione con Cage in musica, con Cunningham nella danza, con Balestrini nella poesia, con gli psicoanalisti della scuola lacaniana nell'indagine fenomenologica della voce che ha dato vita a tutta una serie di esperienze interdisciplinari di estrema attualità aprendo la strada a nuovi risultati vocali di cui possiamo scorgere gli ultimissimi echi nella lettura di Artaud per la rassegna “Poesia ininterrotta» organizzata a Parigi da France Culture, o nel pezzo “Le Milleuna”(16), di Balestrini con il concorso mimico di Valeria Magli”.
Ricordo, in occasione dell’uscita del suo primo disco sulla voce, “Metrodora” (17), di avergli chiesto se la voce non comunica più nulla qual è la natura del problema? Stratos rispose: «Semplice. Oggi, con il declino della vecchia vocalità cantata, si tende ad usare la voce come tecnica di espressione. Io voglio spingere la mia ricerca più in là, fino ai limiti dell'impossibile. Faccio esperimenti sui suoni più acuti e sono arrivato fino a 7000 hertz. Cerco di prendere tre o quattro note alla volta, di lavorare sugli armonici. Tutto questo non ha nulla a che vedere con la tecnica di espressione, è più che altro una tecnica di controllo mentale, è un microcosmo ancora da scoprire». Forse è questo che lo convinse nell'anno accademico 1978/79 a tenere un ciclo di lezioni sulla voce al Conservatorio di Milano e di discutere con gli studenti dei suoi studi di etnomusicologia. Credo che non ci rendesse davvero conto del grado di difficoltà affrontato da Stratos nelle sue triplofonie e della qualità di suono a cui era arrivato, le sue sperimentazioni lo avevano già portato alle soglie delle quadrifonie, un limite varcato da pochi nell'intera storia della musica.
Il processo di ricerca e sperimentazione è totale: catturato dalla “fase di lallazione” della figlia Anastassia, nata nell’ottobre del ’70, osserva i suoni vocali farsi gradualmente parola. Qui lamenti, flautofonie, criptomelodie infantili, investigazioni vocali, canti delle sirene e sonorità “altre” dall’ordinario e dai canoni commerciali della musica, di primo acchito disorientano, spiazzano, poi inondano e trasportano l’ascoltatore capace di farsi rapire a mitiche vette di una comunione pre-linguistica. Una «voce piena – come osserva Paul Zumthor (18) – che rifiuta qualsiasi ridondanza, esplosione dell’essere in direzione dell’origine perduta, del tempo in cui la voce era senza parola». Quello che interessa l’artista è realizzare appieno il concetto di “voce-musica”, una voce-suono non vincolata dalla parola, capace di recuperare le origini e la libertà d’espressione primordiali, e in grado, attraverso un lavoro di consapevolezza del mezzo vocale, di introdurci ad una dimensione ontopoietica della realtà.
E Stratos: “eroe in possesso di una dimensione ai limiti delle viscere dell’essere umano” – il critico musicale scrive Eduardo Peñuela Cañizal – ci riesce perpetrando ad ogni ascolto il richiamo ad una dimensione sonora originaria e magica come al tempo di Esiodo in cui le storie, affidate all’oralità, erano capaci di intervenire sullo spirito. Viscere perché? – viene da chiedersi. Ce lo spiega ancora una volta Laura Pigozzi (19), nel suo già citato “A nuda voce”, dove la vocalità incontra l’inconscio e la sessualità: “Anche un’altra ragione porta la psicanalisi verso una riflessione sulla voce: essa riguarda la relazione profonda che la voce intrattiene con la sfera della sessualità. L’approccio psicanalitico, appunto, si distingue da ogni altro approccio della psiche proprio per la posizione cruciale che destina alla sfera sessuale. Può forse sembrare ardito avvicinare vocalità e sessualità, eppure chi canta sa bene che c’è un legame tra laringe e zona genitale, e non solamente dal punto di vista della nevrosi isterica, che pur fornisce moltissimi contributi intorno a questo tema, come dimostra la ricchissima analisi di Dora, famosa paziente di Freud che soffriva di afonie, e di cui diremo. Infatti, in foniatria è normale parlare della laringe come organo sessuale secondario, cosa peraltro molto evidente in un particolare momento dell’esistenza: l’adolescenza. In questo periodo, difatti, la laringe si ingrandisce notevolmente, soprattutto nei maschi la cui muta vocale è marcatamente più accentuata che nelle femmine. Lo sconvolgimento ormonale dell’adolescenza riguarda la maturazione delle ghiandole sessuali, situazione che può comportare una difficoltà psichica a riconoscersi nel nuovo corpo in traumatica trasformazione e nella nuova voce che si carica di echi mai uditi, gravi e misteriosi. Gli adolescenti si trovano di fronte, contemporaneamente, ad una nuova identità sessuale e ad una nuova identità vocale”.
Pertanto non potremmo, a nessun livello, né psicanalitico, né didattico, né foniatrico, dire qualcosa di significativo sulla voce umana, se dimenticassimo il legame che essa intrattiene col sessuale che abita ogni soggetto: “Nella proposta teorica di associare la voce alla sessualità - aggiunge la studiosa - ha giocato anche la riflessione per cui la voce sembra proprio porsi come corpo della parola, e, per essere più precisi, come il sessuale della parola: rispetto ad essa la voce, in quanto suono, è il suo eccesso libidico, il suo erotismo, il suo godimento”. Nel capitolo sulla voce e l’amore riflette sulla circostanza per la quale una voce: - una su tante e proprio quella - ci può catturare irrimediabilmente: “è l’effetto di ciò che definisco il timbro blu – riprendendo la note bleue di Chopin - per indicare la voce, quella sola, che ci ammalia. La vicenda umana di Kandinskij che, si può dire, “sposò una voce” e la novella di Pirandello che racconta dell’innamoramento di un cieco per una voce, ci aiuteranno ad attraversare questo enigma” (20).
Alla voce come canto, incanto e incantamento, sono dedicate diverse pagine di questo studio: l’indagine sulla voce delle Sirene, a partire dal testo omerico, ci racconta dei suoi movimenti e della sua sapienza, che si gioca nel dramma del godimento e in quello del desiderio che muove ogni avanzamento umano: “La voce, da sempre, è congiunta all’amore. Dall’amore tra amanti, all’amore di transfert tra analista e paziente, a partire dall’amore che istituisce il legame vocale tra madre e bambino. La madre nutre il neonato, ancor prima che con il latte, con il flusso sonoro della sua prosodia vocale, ossia della musica che le sue parole intonano. Il figlio risponde con ecolalie e lallazioni, invenzioni sonore che sono una risposta alla madre ma anche un primo tentativo di individuazione di sé e di separazione da lei. La voce è il primo gioco del bambino, è la colonna sonora dei primi passi verso la costituzione della sua soggettività. La voce del padre racconterà della funzione strutturante, reperibile nell’aspetto ritmico del vocalico, così come ci si rivelerà in quanto voce - shofar che, mentre ricorda un patto, produce quel suono animale che, nel rituale ebraico, rende presente la voce di Dio” (21).
In questo lavoro si incontrano due arti a cui, da anni, l’autrice si dedica, la psicanalisi e lo studio della voce e del canto: “A chi non ha esperienza del pensiero psicanalitico potrebbe forse sembrare curioso accostare la psicanalisi all’arte, eppure questo era ciò che riteneva Freud quando - lui che era medico - si augurava che la psicanalisi fosse condotta anche e soprattutto da non medici. Lo psicanalista francese Jacques Lacan (22), dal canto suo, pensava alla psicanalisi come un “terzo” tra arte e scienza, un “terzo non ancora classificato … da un lato accostato alla scienza, mentre dall’altro prende la grana dell’arte”. La psicanalisi, come l’arte, rende conto dell’originalità umana: il suo approccio è, infatti, lontano dalla medicalizzazione del sintomo. Dall’altra parte, in analogia alla scienza, essa ritrova nel soggetto alcuni minimi ordini di regolarità che raccontano qualcosa di essenziale dell’essere umano e dei suoi meccanismi psichici. (..) In quanto arte, allora, la psicanalisi si avvicina alla soggettività vocale con un ascolto nuovo - eventualmente da affiancare agli interventi più classici sulla voce – che può segnalare quei comportamenti che, sul piano psichico, possono disanimare e pietrificare una voce, spogliandola della sua potenziale ricchezza”.
Introduzione a “La Milleuna”, di Gigliola Nocera, (vedi discografia).
Se è vero che ambigua è l’arte del “dire”, e che con tale ambiguità hanno fatto i conti tutti, dagli antichi rétori ad oggi, è vero che Demetrio Stratos è stato di questa ambiguità esploratore solitario, ma forte e audace quant’altri mai. Le Milleuna (e già mi chiedo: come definirlo, questo testo?) nasce esso stesso all’insegna di un’identità volutamente ambigua: non perché negata, ma perché multipla, stratificata, diversa. Sappiamo già che Le Milleuna, testo da “dire”, si origina da una sintesi quanto mai unica di tre diverse funzioni: la scrittura, il suono, il movimento. Tre diverse funzioni che sono tre diversi modi di articolare il linguaggio, la comunicazione: cento parole scritte da Nanni Balestrini su richiesta di Stratos che si moltiplicano, nel “dire” di Demetrio, fino a diventare dieci volte tanto, fino a diventare mille e una parola.; diverse tutte, tra loro, tranne che per l’iniziale lettera “s”, tranne che per quell’unico filo che lega tutte in un sibilo, un sospiro, un sussurro senza sosta. Accanto ed intorno a mille e una parola, a mille e un modo di “dire”, ecco mille e un modo sperimentati da Valeria Magli per muovere il proprio corpo di ballerina. Questa la sintesi, questo l’unicum che Le Milleuna ha rappresentato per noi e per tutti coloro che – dall’anno della sua creazione, il 1979, pochi preziosi mesi prima della morte di Stratos – hanno assistito alla sua performance nei teatri di tutto il mondo. Ma adesso Le Milleuna è tutto qui, è voce sola, è solo dire: e proprio a partire da questo bisogna rifare i conti (sempre aperti, come con tutta la produzione di Stratos), con l’apparente frantumazione che questo testo subisce nel suo farsi solamente suono, o – pronunciamola, la parola – disco. Ed è qui, finalmente, che a mio parere si verifica la felice liberazione dell’ambiguità: la voce di Demetrio, che ripete e moltiplica in parabola sonora le cento parole di Nanni Balestrini, e che non è più accompagnata da mille corpi di Valeria Magli, non è superstite di un trittico felice, non è naufraga di un viaggio in compagnia, non è un relitto. La voce di Demetrio che scandisce Le Milleuna, testo nato già in partenza come audace impresa trinitaria, sa e vuole essere qui audacemente una e trina. Lo scopriamo adesso, grazie a questo disco, e ci si apre dinanzi un abisso inquietante in cui l’ambiguità si fa ricchezza, e la voce – il suono, il “dire” – si fa con rinnovata impetuosità, scrittura e movimento. Ancor più che lo spazio magico di un palcoscenico teatrale che Stratos, Balestrini e Magli avevano voluto quasi disadorno affinché su di esso – grazie a pochi oggetti e a semplici e reiterati colpi di luce – spiccassero il suono e il movimento, è l’astratto palcoscenico di un disco che ci fa scoprire la capacità diabolica della voce di Demetrio Stratos. Stratofonia, voglio chiamarla, e dire che essa sa essere suono che si fa corpo, corpo che si muove, e che muovendosi crea e semina la traccia di una scrittura che vive a sua volta in un nuovo suono. così per mille e una volta, in un giro senza fine che non si riveste di alcuna voluta ossessività alla Erik Satie, ma che si fa incanto fabulatorio come quello di Shéhérazade. E chissà che per Stratos la figura antica leggendaria, venuta da un ignoto oriente, della bella che narra e narra per non morire, non abbia costituito un punto di riferimento profondo, forse un esorcismo inconscio: un’ennesima S da cui le mille parole di Balestrini, tutte inizianti per s come sesso, prendono nome e vita. Sesso e dunque Eros. Ed è allora nell’infinita iterazione di una parola che si fa Eros che Shéhérazade e Stratos trovano forse la chiave per esorcizzare Thanatos, e non morire più. A questo punto è la Voce che sa essere motore trinitario, che sa fare delle allitterazioni di Balestrini un gioco di sussurri tanto quanto di impetuose sonorità, e creare un corpo di ballerina che salta, e sale, e scende, e scivola dentro e tra le parole non tralasciando di essere corpo anche quando si fa silenzio. Sì, Le Milleuna, è un grande corpo sonoro, erotico soprattutto perché eretico, e per il quale nessuno vi porgerà amabilmente un lasciapassare. Forse Le Milleuna è Stratos, che ci consegna sé stesso attraverso un gioco rischioso, attraverso un percorso labirintico, ma incantatore e sinuoso, come quello della lettera S dal corpo di sirena.
Daniel Charles scrive di lui in “La Milleuna” (vedi discografia).
Innanzitutto, come non ricordarsi di lui se non come un gigante della musica pop? Demetrio si era dedicato a questa musica, letteralmente e profondamente sua. Il gruppo I Ribelli era già lui, negli anni sessanta – con quella foga che l’aveva fatto conoscere al pubblico. Ma dal ’72 in poi viene consacrazione vera e propria quando costituirà il gruppo Area e cominceranno le registrazioni per la Cramps Records. La sua voce, una forza e generosità fenomenali, l’audacia dei suoi interventi strumentali ed i suoi arrangiamenti, lo catapultano all’improvviso nell’estrema avanguardia. A Milano, lavora con Juan Hidalgo e Walter Marchetti, cioè con il gruppo Zaj, accanto a loro si inizia al pensiero e all’opera di John Cage. Nel ’74 elabora un’affascinante versione per la soloa voce dei Mesostics re Merce Cunningham, del Maestro di Stone Point; la cui incisione presso la Cramps farà epoca. La frequentazione di poeti (Balestrini), danzatori (V. Magli, M. Cunningham), scrittori (Simonetti), lo porta a New York dove le serate da lui organizzate al Roundabout Theatre lo consacrano sul piano internazionale. Contemporaneamente a ricerche sofisticate nell’ambito della poesia fonetica e sperimentale, inizia un lavoro mirante a liberare la voce da qualsiasi dipendenza dalle tecniche sterilizzanti, in modo da restituirle il suo spessore perduto. I suoi esperimenti in concerto, indimenticabili, si trovano fissati per sempre nelle sue due registrazioni Metrodora e Cantare la Voce. Saltano tutti i registri (..) soprattutto in questo mediterraneo che si vuole, si sente, si sa orientale, la monodia viene polverizzata dalla demoltiplicazione dello spettro acustico e dai suoi vocalizzi che, da soli, costituiscono delle vere e proprie micro-orchestrazioni, al di fuori di qualsiasi amplificazione tecnologica. Quale docente all’Università di Padova poi di Milano, si appassiona – e appassiona i suoi studenti – per l’etnomusicologia e la psicanalisi. E tutto ciò, senza mai dimenticare l’originaria cultura pop da cui è partiti, testimoniano che non è arte né poesia genuina se non insita nel canto profondo dell’uomo.
Demetrio Stratos nasce ad Alessandria d'Egitto da una famiglia di origine greca. Tredici anni di vita li passa ad Alessandria d'Egitto studiando pianoforte e fisarmonica al prestigioso Conservatoire National d'Athènes. Nel 1962 si trasferisce a Milano dove si iscrive alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. È in questa città che, nel 1966, si unisce come voce solista e pianista al gruppo beat de I Ribelli con i quali registra alcuni 45 giri di successo, come “Pugni chiusi”, “Chi mi aiuterà” e “Oh Darling!”, ed un LP. Dopo quest'esperienza pubblica nel 1971 un 45 giri per la Numero Uno di Lucio Battisti, e fonda nel 1972 il gruppo degli Area che si afferma in Italia e all'estero sulla scia della fusion e del rock progressivo. A lato della discografia ufficiale degli Area, per cui Stratos è ricordato, non bisogna dimenticare la discografia solista, perlopiù centrata su sperimentazioni e ricerche vocali. Il suo studio della voce come strumento lo portò a raggiungere risultati al limite delle capacità umane: nella sua massima esibizione raggiunse i 7000 Hz (un tenore "normale" può arrivare mediamente a 523 Hz, mentre un soprano - quindi una donna - può raggiungere i 1046 Hz) ed era in grado di padroneggiare diplofonie, trifonie e quadrifonie (due, tre e quattro suoni contemporaneamente emessi con la voce). Inoltre, Stratos compì ricerche di etnomusicologia ed estensione vocale in collaborazione con il CNR di Padova e studiò le modalità canore dei popoli asiatici. Grazie ai suoi già notevoli requisiti, alle tecniche acquisite ed agli studi del Cnr riuscì a raggiungere risultati ancora ineguagliati. Nel 1974 prese parte a tournée e festival in Francia, Portogallo, Svizzera e Cuba; a Cuba ricevette l'invito dal Ministero della Cultura ad incontrarsi con la Delegazione di musicisti della Mongolia per partecipare a un dibattito sulla vocalità dell'Estremo oriente; Stratos si era infatti progressivamente inoltrato nel misterioso mondo dei suoni riprendendo ed ampliando un vasto discorso sul significato della voce nelle civiltà orientali e medio-orientali. Nel 1978 lasciò gli Area per dedicarsi esclusivamente alla ricerca vocale. In quest'anno accrebbe la sua fama internazionale partecipando, su invito di John Cage, a concerti tenuti al Roundabout Theatre di New York; è proprio di questo periodo "Event" con Merce Cunningham e la Dance Company, eseguito con la direzione artistica di Jasper Johns, quella musicale di Cage e la collaborazione di Andy Warhol per i costumi. Morì prematuramente al Memorial Hospital di New York all'età di 34 anni affetto da una leucemia dirompente (causa della morte fu un collasso cardiocircolatorio) il 13 giugno 1979, il giorno precedente al grande concerto di Milano che era stato promosso per raccogliere fondi da utilizzare nella costosa degenza. La sua morte sconvolse tutto il mondo dello spettacolo e non solo i musicisti sperimentali, che vedevano nell'artista il loro esponente di spicco, tanto da rimbalzare in vari programmi mediatici solitamente non avvezzi alla musica alternativa. La sua salma è conservata nel cimitero del piccolo borgo di Scipione Castello, frazione di Salsomaggiore Terme (PR), che dal 2000 organizza tutti gli anni un week end di concerti dedicati all'artista. A Demetrio Stratos è intitolato l'auditorium degli studi di Radio Popolare, a Milano.Dal 1996 si tiene ad Alberone di Cento (FE) una Rassegna di Musica Diversa in omaggio a Demetrio Stratos alla quale partecipano numerose band underground italiane.
Discografia:
“Arbeit Macht Frei” – Area – Cramps -1973
“Caution Radiation Area” – Area – Cramps 1974
“Crac!”- Area – Cramps 1974
“Are(A)zione” – Area – Cramps 1975
“Maledetti” – Area – Cramp 1976
“Cantata Rossa per Taal al Zaatar” – Edizioni di Cultura Popolare VPA 113 - 1976
“Metrodora “- Collana DIVerso – Cramps 1976
“Anto/Logicamente” – Area – Cramps 1977
“O'Tzitziras O'Mitziras” – Collana Futura – Cramps 1978
“Cantare la voce” – Collana Nuova Musica - Cramps 1978
“1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano! – Ascolto 1978
“Recitarcantando” – 1978
“Parco Lambro” – Laboratorio 1978
Mauro Pagani – Ascolto 1978
“Carnascialia” – Mirto 1979
“Rock'n roll exhibition” - Cramps 1979
“Le Milleuna” – Cramps 1979
“Event ‘76” – Cramps 1979
Collaborazioni, anche importanti, si trovano in occasione di interventi singoli di altri autori.
Cinema e DVD:
“Suonare la Voce”, Demetrio Stratos Box: 1DVD + 1 Libro – Cramps.
“1979 Il concerto” (Omaggio a D. Stratos), AAVV – Box: 1DVD + 2CD + 1 Libro – Cramps.
"La Voce Stratos" il film-documentario di Luciano D'Onofrio e Monica Affatato.
Altro sull’argomento “Voce”:
“Una Voce” romanzo di Anais Nin - Bompiani, 1999.
“La voce umana”(1948), film di Rossellini, interpretato da Anna Magnani, episodio incluso nel film “L'amore”, nel quale la Magnani si cimentò in un appassionato ed angoscioso soliloquio, un grande pezzo di bravura interpretativa, la telefonata di una donna abbandonata dall'amante.
“La voce umana" (1959) (titolo originale: La voix humaine) tragédie lyrique in un atto unico del compositore francese Francis Poulenc, derivata dalla piéce omonima di Jean Cocteau, che firma il libretto. L'opera fu scritta nel 1958 e fu messa in scena per la prima volta il 6 febbraio 1959 da Denise Duval alla salle Favart del Théâtre National de l'Opéra-Comique di Parigi.
“La voce umana” (1967), film di Ted Kotcheff, con Ingrid Bergman - Gran Bretagna.
“La Voix humaine”, versione per pianoforte di Francis Poulenc, con il soprano Anne Béranger e il pianista Setrak (1982 - Le Chant du Monde), nell'opera, della durata di circa 40 minuti, la suoneria del telefono prevista dal testo di Cocteau viene resa attraverso uno xilofono. L'opera, in forma di monologo, prevede lunghi passaggi di canto senza accompagnamento musicale.
“My Fair Lady”, film - musical del 1956 di Alan Jay Lerner, autore del libretto su musiche di Frederic Loewe, adattato dall'opera Pigmalione di George Bernard Shaw. Diretto da Moss Hart, con costumi di Cecil Beaton e scene di Oliver Messel. Nel cast, capeggiato da Rex Harrison e Julie Andrews, c'erano Stanley Holloway e Robert Coote. Il cinico professore di fonetica Henry Higgins (Rex Harrison) accetta la scommessa di riuscire a far apparire l'incolta e rozza fioraia Eliza Doolittle (Julie Andrews) come una signora degna dell'alta società. Vincerà la scommessa e scoprirà di saper provare anche lui dei sentimenti.
“Farinelli: La voce regina”. un film del 1995 del regista belga Gérard Corbiau, di produzione italo-francese, sulla vita del celebre cantante castrato del XVIII secolo Carlo Broschi, in arte Farinelli. Un elemento centrale del film sono le presunte avventure erotiche di Farinelli, che non hanno alcuna base storica e sono anzi altamente improbabili. Un elemento centrale del film sono le presunte avventure erotiche di Farinelli, che non hanno alcuna base storica e sono anzi altamente improbabili. L'attore Stefano Dionisi, che interpreta il protagonista, recita le battute di dialogo, mentre nelle parti cantate, per riprodurre la particolarissima voce di un castrato, sono state registrate separatamente le voci di un soprano donna, Ewa Małas-Godlewska, e di un controtenore uomo, Derek Lee Ragin, e poi mixate insieme con mezzi digitali.
“Il discorso del re” (The King's Speech), film diretto da Tom Hooper, interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Guy Pearce. La storia ruota attorno ai problemi di balbuzie di Re Giorgio VI e al rapporto con il logopedista che lo ha in cura. Il film ha vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival; 5 British Independent Film Awards 2010, e ha ottenuto 7 candidature ai Golden Globe 2011: (una ha fruttato il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico al protagonista Colin Firth), ben 7 BAFTA incluso miglior film dell'anno e miglior film britannico, nonché 4 premi Oscar su 12 candidature: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale.
Note:
(1-2-3-4-5-6) Laura Pigozzi vive e lavora a Milano. Fa parte del Movimento Psicanalitico Nodi Freudiani.Si occupa del rapporto tra psicanalisi e modernità, con particolare riferimento al tema della perversione e dei nuovi sintomi del femminile. Tra i suoi interessi le connessioni tra psicanalisi ed espressione vocale, su cui ha scritto numerosi saggi. Canta jazz e tiene corsi di formazione vocale per cantanti, insegnanti, attori. “A nuda voce” non è il suo unico libro sull’argomento……
(7-8) August Schleicher, linguista tedesco. La sua opera principale, Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen (Compendio della grammatica comparativa delle lingue indoeuropee, 1861-1862) ha rappresentato una delle pietre miliari della linguistica indoeuropea. Fu il primo a proporre il modello ad albero genealogico che individuava ed esemplificava le parentele fra lingue e gruppi linguistici e la loro appartenenza ad una determinata famiglia. Le Teoria dell'albero genealogico rappresentò il principale contributo di Schleicher alla linguistica comparata ed ebbe una profonda influenza sull'indoeuropeistica tra fine XIX ed inizio XX secolo, nonostante le numerose difficoltà che presentava e che vennero via via evidenziate.
(9) protoindoeuropeo: All'interno di una singola lingua, il metodo consiste nel raffrontare sistematicamente vari elementi simili all'interno di un idioma, per determinarne le regolarità e, di conseguenza, le leggi di evoluzione. Un esempio di questo genere di applicazione è la Legge di Grimm, che descrive l'evoluzione dal protoindoeuropeo al protogermanico delle consonanti occlusive. A conferma di ciò la linguistica comparativa, si sviluppa entro i confini dell'evoluzione storica e le fasi che ne contrassegnano i momenti di cambiamento e di differenziazione. Un sistema comparativo, appunto, che analizza il sovrapporsi dei vari stadi di trasformazione della lingua attraverso le contaminazioni che via via si accumulano nel tempo sotto la spinta di successivi mutamenti morfologici e fonematici. Così il valore significante assume, di volta in volta, significati nuovi che sostituiscono quelli precedenti e si innervano nella nuova struttura antropologico-culturale che le ha generate.
(10) Norman D. Hogikyan, direttore del Vocal UM Health Center, In riconoscimento del World Voice Day il 16 aprile, MD, professore di otorinolaringoiatria presso l'Università del Michigan Medical School e Hogikyan.
(11) Demetrio Stratos (vedi biografia e discografia)
(12) “Pansori: Korea’s Epic Vocal Art & Instrumental Music” – CD - Nonesuch Explorer - 1972: Il p'ansori (판소리) è una forma teatrale coreana unica nel suo genere, nella quale viene raccontata una lunga storia mediante il canto e la narrazione. Questo dramma musicale viene interpretato da una sola persona, un maestro cantore (myŏngch'ang 명창 名唱), solitamente una donna, che ha studiato per anni per raggiungere la voce ideale, la quale interpreta tutta le parti utilizzando le varie tonalità vocali. La staticità del p'ansori viene evitata dal ch'anggŭk, che è un dramma musicale basato sul p'ansori, ma che utilizza cantanti diversi per i vari ruoli e questi, invece di raccontare la storia, oggi la rappresentano, come avviene in un'opera teatrale. Va qui considerato la performance “epica” dura dalle cinque alle otto ore aiutandosi con pochi e stereotipati gesti. La sua tecnica richiede comunicativa e ricchezza mimica tale da suggestionare il pubblico che l’ascolta. Verso l'inizio del XVIII secolo nacque un nuovo tipo di narrativa, il p'ansori (P'ansorigye sosŏl). La parola p'ansori o pansori può essere suddivisa in due: pan significa “un posto dove si radunano le persone” e sori significa “suono”. I pansori erano inizialmente un tipo di poesia epica che si tramandava oralmente e trattava tematiche della vita reale, basandosi su un'alta espressione musicale mescolata ad un pizzico di umor. Sebbene sia nato come tipo di musica tradizionale, fa parte della narrativa fu considerato da molti un genere drammatico. La sua origine non è chiara, probabilmente proveniva dai canti degli sciamani di Chŏlla, infatti alcuni elementi che si possono ritrovare nel pansori tradizionale si assomigliano. I primi erano molto semplici per quanto riguarda la forma e il contenuto, ma in seguito la musica fu arricchita per attirare l'attenzione del pubblico durante le performance. A noi sono arrivati solo dodici pansori raccolti da Song Mansŏ nel "Kwanyujae", di questi dodici però solo cinque ne sono rimasti con la partitura. Gli altri sette ci sono arrivati come storie in prosa. Lo scopo dei pansori era quello di far ridere e piangere contemporaneamente il pubblico che guardava la performance, mentre l'elemento più interessante era l'uso di vari livelli del discorso, l'interlocutore mostrava come il linguaggio cambiava in base alle circostanze o alla persona a cui si rivolgeva.
(13) “Cantare la voce” Demetrio Stratos (vedi discografia)
(14) “Demetrio Stratos” di Mario Giusti – U. Mursia Edit. – Milano 1979 – “Questo libro è dedicato a Demetrio e a tutti i Demetrio Stratos del mondo. Alla loro opera ed al coraggio di usarla per affermare la nostra libertà”.
(15) Gianni Sassi (in Laboratorio & Musica, Anno I n.4, settembre 1979)
(16) “Le Milleuna” Demetrio Stratos (vedi discografia)
(17) Intervista rilasciata al teatro Alberico di Roma dopo la performance per l’uscita dell’album “Metrodora”. Demetrio Stratos (vedi discografia).
(18) Paul Zumthor, critico letterario svizzero, che si è occupato specialmente delle letterature del Medioevo romanzo. Ha insegnato presso l'Università di Amsterdam, dove per vent'anni ha diretto l’Institut des langues et littératures romanes; dal 1968 a Vincennes e dal 1971 a al 1980 a Montréal. Tra le sue opere più importanti, che offrono una visione d'insieme della tradizione letteraria medievale, si possono ricordare l'Histoire littéraire de la France médiévale (VIe-XIVe s.) del 1954, Langue et technique poétiques à l’époque romane (XI-XIIIe s.) del 1963 (Lingua e tecniche poetiche nell'età romanica, Bologna 1973), il celebre Essai de poétique médiévale (1972; Semiologia e poetica medievale, Milano 1972) e Langue, texte, énigme (1975; Lingua, testo, enigma, Genova 1991). Fondamentali gli studi di Zumthor sulla poesia orale: Introduction à la poésie orale (1983; La presenza della voce: introduzione alla poesia orale, Bologna 2001) e La lettre et la voix ou De la "littérature" médiévale (1987; La lettera e la voce. Sulla "letteratura" medievale, Bologna 1990).
(19-20-21) Laura Pigozzi op. Cit.
(22) Jacques Lacan, Séminaire inédit, Les non-dupes-errent, le 9 avril 1974, lezione reperibile all’indirizzo web http://perso.orange.fr/espace.freud/topos/psycha/psysem/nondup/nondup11.htm Passo citato anche da A. Didier-Weill, Invocations, Calmann-Lévy, Pris, 1998, p.13,. - Musica
- Musica
Quaderni 2: Amazzonia - seconda parte
“AMAZONAS: testimonianze di una cultura in via di estinzione”, (seconda parte).
(Dalla ricerca per “Folkoncerto: Maschere Rituali”, trasmissione radiofonica in due puntate messa in onda da RAI-Radio3, e inoltre “Il Canto della Terra” e “Itinerari Folkloristici”, reportage trasmesso dalla RSI – Radio della Svizzera Italiana).
Romano Battaglia (1) scrive:
“Stupirsi di fronte a ciò che vediamo, (che ascoltiamo), non basta: bisogna avere il tempo per meditare, altrimenti è come non vedere dove stiamo andando, perché troppo preoccupati a cercare la via per arrivarci. Non devi aver fretta, il buon camminatore arriva ovunque. Tirando lo stelo delle piccole piante, il mais non cresce prima del tempo. Bisogna avere pazienza e guardare la lenta crescita di ogni creatura. La foresta, per essere conosciuta, esige una profonda riflessione perché è il cuore del mondo, regala la libertà di pensare solo a se stessi ed alle proprie paure”.
In queste frasi che sfiorano la liricità del canto, si nascondono in vero, perle di saggezza che sembrano sciogliersi come gocce nelle nostre mani davanti allo spettacolo costante e meraviglioso della natura allo stato “selvaggio” che si apre davanti ai nostri occhi posati ancora una volta sulla foresta amazzonica, da con le quali ho voluto aprire questa seconda parte della mia ricerca etnomusicologica, dedicata, come recita il titolo, all’Amazzonia, alla ricerca delle testimonianze della cultura degli Indios che la abitano intendo dire – erano completamente assenti. Per non tediarvi, inizio col raccontare una preziosa scoperta antropologica fatta da un italiano, un alpinista vicentino, Franco Perlotto (2) che, dopo un lungo viaggio con gli indios Yanohami, è riuscito ad avvicinare i Kunapumatheri, la tribù più misteriosa dell’Amazzonia:
“Risalivo il rio Marauià fino alla sua sorgente dove, credendo d’essere da solo, avrei fatto qualche arrampicata. Quando, d’improvviso, sono apparsi dal nulla decine di Indios. Non ero solo, dunque, ma non posso nascondere che provai quantomeno una certa preoccupazione nel vederli. E poi, mi aveva colpito una loro stranissima particolarità. Era un gruppo formato esclusivamente da ragazzi giovanissimi e da uomini anziani, le persone di mezza età erano completamente assenti. I miei timori, comunque, erano infondati. Poco dopo, ricongiuntomi con gli altri, ci portarono al loro villaggio e riuscimmo a capire che ci spiavano da oltre quattro ore, spesso emettendo versi di animali. Ancora, però, non sapevamo a quale tribù di Yanohami appartenevano. La risposta arrivò al nostro ritorno al villaggio di Marauià. Ed era una risposta che avrebbe lasciato stupiti gli stessi Karawethari che ci ospitavano e per i quali stavamo lavorando. Quei selvaggi senza … l’età di mezzo che ci avevano spiato e poi bloccato alla sorgente del rio, erano Yanohami Kunapumatheri; i più restii a fermarsi in qualsiasi luogo: nomadi che hanno avuto scarsissimi contatti con l’uomo bianco e, pre questo anche detti “la tribù invisibile”.”
Di loro si sa poco o nulla, certamente, però, fra le tribù Yanohama, è quella che ha mantenuto più a lungo i segreti della vita di villaggio, degli usi, dei costumi e delle tradizioni, dediti alla caccia e alla raccolta. Favoriti dal loro essere a uno stato nomade, i Kunapumatheri hanno sempre mantenuto la loro caratteristica tribale, davanti all’incessante avanzata della civiltà delle macchine. Vissuti sempre all’interno della foresta amazzonica da nomadi, non si conoscono e non è possibile prevedere i loro spostamenti, né si conosce il numero esatto dei quanti la compongono. Ed è proprio per questo che anche tra gli altri Indios che la abitano è considerata la “tribù del mistero”. Aggiunge ancora Perlotto (3) – “Raramente dissero di averli incontrati e, sempre i Kunapumatheri, erano scomparsi nel nulla, dopo una breve apparizione. Riuscivano a dileguarsi come se la vegetazione li avesse assorbiti, o forse, ingoiati, per riapparire, quando erano certi che non si avevano intenzioni ostili nei loro confronti. E lo facevano improvvisamente, in folti gruppi, al punto che non si riusciva a capire come avessero potuto nascondersi così bene e a lungo. Si può solo immaginare che il loro vagabondare per la giungla sia dettato non solo dalla ricerca di cibo ma dalla consapevolezza di non avere un posto sicuro dove vivere, edificare capanne e stabilirsi come una vera e propria comunità”.
Ma andiamo alle notizie che si hanno di loro. Questa piccola e arcaica tribù costituisce insieme ad altre un mosaico difficilmente quantificabile fatto di nomi sconosciuti e di intrecci tra gruppi, talvolta molto diversi tra loro. Si calcola che siano presenti almeno 170 differenti tribù che parlano qualcosa come 270 dialetti. Tra esse, quelle ancora sopravvivono vanno certamente annoverati gli Yanohama (circa 10.000 nell’area brasiliana, e 22.000 in tutta l’Amazonas). Inoltre c’è da considerare che la situazione dei gruppi etnici presenti su tutto il vastissimo territorio amazzonico è, purtroppo, in continuo movimento mantenendo comunque una drammatica costante: la lenta ma progressiva diminuzione della popolazione delle varie tribù. Molte di esse sono ormai date per scomparse del tutto e quasi sempre la causa è stata il contagio da malattie portate dagli occidentali (soprattutto dai cercatori d’oro). L’entità del genocidio nei confronti degli Indios emerge chiaramente da questo dato: erano circa 5 milioni nel 1500, sono poco più di 200.000 oggi, considerando anche quelli semicivilizzati.
Una nota più che dolente, di cui forse un po’ dovremmo vergognarci, ma sarebbe comunque troppo poco. Tuttavia questa lunga chiacchierata contribuisce a darci la dimensione che la ricerca avviata, in qualche modo, sta dando i suoi frutti. Ed è lo stesso Perlotto (4) a darcene conferma. Infatti, quella che sembrava solo una straordinaria avventura di viaggio, si trasforma in una grande festa di tutta la tribù: “Il “wahamou” che fu celebrato quella sera stessa in nostro onore, è un rito di amicizia che si svolge durante tutta la notte, una sorta di canti e nenie nelle quali si racconta le gesta e la storia della tribù, difficile da riportare in tutti i suoi gesti, le parole, gli idiomi che l’hanno caratterizzata. Inutile dire che, oltre al piacere di essere stati coinvolti in qualcosa di irripetibile, c’era in noi la soddisfazione di essere venuti a contatto con una delle più sconosciute fra le tribù Yanohami che, per la loro stessa nomade, ci sarà molto difficile poter incontrare ancora”.
Ma la ricerca non si ferma qui, per capire fin dove essa può spingersi, ho pensato di farvi partecipi di alcune leggende orali relative alla vita tribale, di cui va riconosciuta la capacità rituale, e che ho qui intervallato con le pagine di un personale “Diario di viaggio” (5) un po’ sconnesso, e che servono da introduzione alla scoperta delle tradizioni di alcune tribù indigene da me realmente incontrate.
Leyenda antes, (o del mito de la creación). (6)
“In principio regnava nell’universo l’oscurità, perché non vi erano né il sole né il giorno. Quando albeggiava, era come una notte di luna. Eppure, nei tempi dell’oscurità, già esisteva Yaya, il nostro Gran Padre Iddio. Egli, nostro padre, creò l’uomo, plasmando la sua forma con la terra. perché tutti avessero il gran dono dell’esistenza, plasmò la creta e generò i runas (i futuri Indios); li fece eretti e sul loro capo soffiò l’alito divino, così essi divennero esseri pensanti. L’uomo modellato da Dio, nostro Padre, viveva, camminava, pensava e parlava. Vi era anche un demonio, il supay, il quale, per imitare Dio, prese anch’egli della terra e tentò di modellarla. Ma invece del runa, formò una wangana. Più volte rinnovò i tentativi, il supay, ma tutti fallirono. Nostro Padre Iddio invece così fece: mise della terra in un recipiente e lo chiuse con del cotone. Poi: “Apri!” disse al figlio. Il figlio lo aprì e ne uscirono tanti omettini, “migliaia di verdi creature dai lunghi capelli”, piccoli ma vivi, dotati del giudizio, che parlavano e camminavano. Così, avvenne la creazione dei runas, i primi esseri viventi,e di alcune razze animali che per prime si mostrarono alla vista uscendo dall’acqua, e che presero a camminare sopra la Terra”.
In realtà tutto ciò che riguarda l’Amazzonia può essere raccontato in chiave di leggenda, poiché tutto è estremamente aleatorio, e le parole lo sono più d’ogni altra cosa. È questo il regno del silenzio, seppure lo si ascolta scorrere, mormorare, gridare, cantare e suonare come nessun altro luogo. Dove finanche gli Indios che l’abitano, “allo stato di natura”, appaiono e scompaiono nel folto della foresta a loro piacimento, quasi fossero esseri invisibili, facendosi raramente avvicinare anche dagli abitanti degli altri villaggi. Alcuni gruppi dimoravano già vicino ai grandi fiumi della foresta amazzonica, e lì vivevano indisturbati sotto la protezione di Yaya (il Sole), e di Killa (la Luna) e delle altre stelle, cacciando, pescando, coltivando e raccogliendo i frutti selvatici che una natura generosa produceva per loro.
Probabilmente generati da quegli stessi vegetali che crescevano copiosi e che avevano dato luogo al “grande verde” delle origini, i “runas” erano strettamente legati agli elementi vitali della natura, quali la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco, e ai supremi “spiriti” che loro stessi avevano creato. Molto tempo prima della loro comparsa c’era soltanto Yaya (il Sole), divinità suprema che aveva generato la Pacha Mama (la Terra) con un semplice soffio, scagliandola nell’infinito ove dimora. Questa scivolò nello spazio come nebulosa infuocata e continuò a bruciare fino a che il dio Tuono ordinò che vi cadessero sopra mille anni di pioggia che la sommersero completamente, confinando il dio Fuoco dalla cresta allagata della Terra e penetrando nelle sue viscere, dove risiede in eterno.
E poiché la Terra era così diventata molto fredda, il dio Tuono chiese al Sole di tornare a illuminarla e riscaldarla di tanto in tanto, dando inizio così alla successione del giorno e della notte. Dacché i fiumi e i laghi si colmarono di pesci e nacquero i primi vegetali che ben presto si trasformarono in molteplici piante e una gran quantità di fiori dalle forme variegate e moltissimi colori. Le piante e gli alberi tutt’intorno si riempirono di uccelli dalle piume variopinte e di scimmie barbute che insieme facevano un’indicibile gazzarra; e coccodrilli, api, ragni, serpenti, iguane, tartarughe, tapiri, giaguari e un numero esorbitante di farfalle colorate che s’inoltrarono a cercare riparo nella folta vegetazione che cresceva a dismisura sopra la linea dell’orizzonte, offuscando, talvolta, l’azzurro del cielo e i raggi del Sole imperioso.
Poi, all’improvviso, i giorni si fecero scuri, e le notti nella foresta divennero fredde. Il dio Tuono era tornato, irato non si sa per quale motivo, apparentemente senza una ragione, con tuoni che esplodevano uno dopo l’altro e che spaccavano il cielo facendolo precipitare verso il basso. Il diluvio che ne seguì, sconvolse ogni cosa, i grandi fiumi e i laghi, i mari e gli oceani, per cui i pesci si nascosero nelle profondità lontane degli abissi. Distrusse gli uomini e le cose, l’intera foresta e la selvaggina, fino a spegnere tutti i colori, fino a raccogliere in un unico frastuono, tutti i suoni, nell’urlo infuriato dell’uragano. Fu così che gli Indios sopravvissuti alle ansie apocalittiche, divennero i protagonisti di un’avventura umana che, attraversando il luogo impervio e inaccessibile della foresta, s’incamminarono attraverso il cuore verde del mondo: “la terra dove non si muore”.
Dal “diario di viaggio”: 23/24/25 Giugno 1986.
È appena terminata la stagione delle piogge e i grandi fiumi che attraversano l’Amazzonia sembrano aver rallentato la folle corsa che fin dal mio arrivo mi aveva impressionato per l’eccezionale portata d’acqua, il cui rombo sommesso, sembrava infuriare spaventosamente. Quasi che la “grande anaconda verde” – così gli Indios chiamano il Rio delle Amazzoni – stesse per uscire dall’alveo primordiale in cui è confinata, per inondare la terra che la circonda, e volesse strappare, con la sua furia impetuosa, la folta vegetazione della foresta e travolgere ogni essere vivente, umano e animale che avrebbe incontrato sul suo cammino, apparentemente senza fine. Il rumore emesso dall’enorme massa d’acqua in movimento sovrasta quello del piccolo battello a motore sul quale viaggiamo, dal nome surrealistico quanto fatuo, la Estrella de Azul che, solo più tardi, avrei scoperto essere riferito ad altro nome con cui gli Indios sono appellati, “il popolo delle stelle”.
Il battello quasi arranca da sembrare, in certi momenti, fermo nel mezzo della massa d’acqua che si oppone alla ferrea volontà dell’imbarcazione, ostinata più che mai, a risalire la corrente. Tutt’attorno, i luoghi sono quelli sconosciuti e certamente straordinari che attraversano la più grande distesa verde del mondo, ricca di colori vivacissimi che esplodono improvvisi, e di richiami melodiosi di uccelli e di versi di animali sommessi, nascosti alla vista, che altrettanto fulminei irrompono nel silenzio come grida. Una natura lussureggiante che erompe dagli argini e si getta nell’acqua di un colore verde smeraldo in cui si sprigiona tutta la forza del creato che, secondo la profondità del fondale e alla pendenza scoscesa del fiume, trascina tutto con sé, fino a diventare una sorta di via maestra verso l’ignoto.
Qui il silenzio, se si esclude il rombo sommesso del fiume, è profondo, quasi che neppure l’aria abbia consistenza alcuna, tale da procurare fastidio finanche il solo voltare la pagina del quaderno dove appunto le mie impressioni di viaggio, e tutte le altre cose “meravigliose” che fanno di questa mia “avventura” un prezioso riassunto di quello che d’ora in avanti vado a descrivere. Dove anche quelli che sono i racconti e i particolari usi che apprendo oralmente, e che Horacio, la guida del gruppo di cui faccio parte, traduce per noi direttamente dal racconto diretto di alcuni Indios più anziani, che incontriamo durante una prima sosta in un villaggio costiero, e che accoglie un numero esiguo di indigeni per lo più appartenenti a tribù diverse, sopravvissuti allo sterminio programmato, che li ha ridotti a poche migliaia, e costretti alle ristrettezze di una vita di stenti, all’interno della riserva del Parco Nazionale dello Xingu, cosiddetto dall’altro grande fiume che s’inoltra nella foresta amazzonica.
Si tratta di racconti mitici riguardanti la cosmogonia amazzonica, in cui si narra di luoghi che potrebbero essere o, essere stati reali, da qualche altra parte, in un altro tempo, forse lontano, molto lontano dalla civiltà di cui tutti noi “altri” facciamo parte. E di figure e personaggi fantastici, di eroi semi divini, animali della foresta e spiriti buoni e malvagi significativi delle inquietudini, delle speranze e dei terrori che albergano nell’animo di queste popolazioni tribali che pure, conservano un patrimonio culturale molto considerevole, da ritenersi solo per certi aspetti “primitivo”, quanto dettato invece dall’esigenza primaria della sopravvivenza delle specie.
Ritenuti i discendenti di popolazioni autoctone precolombiane, gli Indios superstiti abitatori della foresta amazzonica, hanno mantenuto consuetudini e costumi del tutto distinte da quelle della moderna popolazione brasiliana, proveniente dall’Africa e dall’Europa e stabilitasi sul territorio in epoche più recenti, dando luogo a una sorta di gruppo etnico multirazziale. Si ritiene che la popolazione amazzonica si sia consolidata sull’attuale territorio, in successive epoche diverse risalenti fino a 14.000 anni fa. Tra le testimonianze più antiche vi sono alcuni manufatti in pietra, come armi e utensili dalle forme assai raffinate, risalenti a epoca precolombiana. Non sono mai oggetti grandi e non superano i 50 centimetri di lunghezza che rappresentano pesci, uccelli in riposo o in volo, e altri animali noti, come armadilli, tartarughe, rane, coccodrilli e pappagalli, imitati con sapienza dall’osservazione della natura. Spesso si sono trovate asce a forma di luna crescente con l’impugnatura riccamente ornata.
Altre testimonianze hanno valore sia documentario che artistico, e riguardano le iscrizioni rupestri che si possono vedere in diverse zone del territorio, in particolare sulle rocce e nelle grotte vicine alle vallate dei grandi fiumi. Si tratta di iscrizioni incise sulla pietra grezza tra i cui colori predomina il rosso sanguigno, spesso dipinte su superfici precedentemente levigate e che, a volte, indicano la presenza nei dintorni di sorgenti d’acqua, o di particolari animali. I segni impressi sono per lo più simboli commemorativi, o forse di significato religioso, le cui linee essenziali si ritrovano non di rado nelle pitture eseguite dagli Indios sul proprio corpo, nei tessuti come nelle ceramiche di loro produzione.
Dal “diario di viaggio”: 26/27 Giugno 1986.
Il tempo scorre assai lento e durante la navigazione ci ritroviamo spesso in balìa di spaventosi gorghi formati dalle acque dei tanti affluenti che si mescolano a quelle del Rio delle Amazzoni e che trovano in esso il loro condottiero audace, che le spinge alla conquista dell’Oceano. Un ostacolo, quello determinato dal tempo, che in questi luoghi sembra non aver ragione di essere, per il semplice motivo che alla fin fine i giorni sull’acqua sembrano tutti uguali, “persi nell’infinito verde”, alla ricerca di un possibile orizzonte che non si vede, forse solo perché non c’è. Capita invece di chiedermi se oltre quell’interminabile via d’acqua e quell’insormontabile vegetazione, il resto del mondo, che pure conosco, continua a esistere, oppure …? E se c’è, dove? Come pure, se lo scorcio di cielo che appare tra una riva e l’altra sia reale, e non sia invece lo spazio bianco di una tela che, per una qualche ragione che non conosco, si colori delle sfumature dell’azzurro e del verde abbagliante, come di riflessi di un incanto dorato che si trova e si perde nella luce accecante del giorno? E ancora, che fosse proprio a causa della durata incommensurabile del tempo, che in passato marchiò a fuoco gli occhi dei Conquistadores spinti nella ricerca furibonda di un Eldorado che forse avevano soltanto sognato nel segreto della mente, a farli impazzire? Tempo, dunque, colpevole e consapevole delle domande che, in mancanza di un orizzonte visibile, vengono a porsi come semplici interrogativi sull’infinito o l’onnipotenza di Dio, quando desideriamo comprendere lo spazio intorno a noi, il fluttuare delle ore, dei giorni e delle notti, dei mesi e degli anni, come se fossero minuscoli granelli di sabbia, o gocce di rugiada. Per dirla con William Blake, quando si vuole comprimere “… un mondo e un cielo in un fiore selvatico, tenere l’Infinito sul palmo della mano, e l’Eternità in un ora”.
Tanto più grande è il potere che ci arroghiamo, tanto più ci sentiamo capaci di far accadere cose impossibili, come spesso è narrato nelle fiabe amazzoniche che qui propongo, come una sorta di narrazione cantilenante che gli Indios verosimilmente inventano per intrattenere i bambini e non solo, e che spesso parlano di eventi straordinari che hanno come protagonisti i diversi animali della foresta. Infatti, in quasi tutti i popoli amazzonici è diffusa la credenza che la creazione degli animali e delle piante abbia preceduto quella umana e che, pertanto, gli uomini discendano da essi. L’anima, “Aya”, è essenza indefinita, e si presenta come divinità del raccolto, insegna ai runas a seminare e a coltivare, dona loro la manioca e il banano, alla base della dieta amazzonica. Interpretata in senso dualistico, nasce dalla credenza che il corpo e l’anima del runa appartengono non solo a lui, ma anche a un animale della foresta, e che tutto ciò che concerne la vita di quest’ultimo influisce sulla vita dell’uomo, compresa la morte.
Esiste un’altra credenza indigena secondo la quale certi animali posseggono il mama (potere magico) e ci si appropria di tale potere uccidendoli e ingerendoli nelle porzioni rituali o indossandone parti come amuleti; nella cerimonia di puma-tukuna, per fare in modo che gli yachak gli stregoni, divengano fieri come il puma, si sfregano i denti e gli occhi dell’iniziato con polveri di denti dell’animale e peperoncino e gli si fa bere una sostanza segreta (pumayuyu-tabaco, puma-piripiri). In questo modo nella foresta la sua anima crescerà nel corpo di un puma e che, alla morte dello stregone, continuerà a vivere nel corpo dell’animale, spaventandolo e mangiando gli uomini. È così che i miti e i racconti del Napo (abitanti delle rive del fiume) esprimono una lotta perenne tra spiriti-animali-uomini-morte e trovano un senso nelle difficili condizioni di vita della foresta, dove l’uomo è soggetto al rischio quotidiano di distruzione.
Leyenda tercera (o de los animales). (7)
Nel fiume Napo, in un luogo chiamato Macao, esisteva fino a poco tempo fa un gran mulinello. Molti runas vi erano spariti in maniera improvvisa, senza che nessuno avesse potuto sapere qualcosa di loro: i loro corpi non erano affiorati dal fondo del fiume né erano approdati a riva. Sembra che vivesse sul colle vicino al mulinello, nel punto più alto, un gran pappagallo Macao dalle piume rosso fuoco: questi sorvegliava attentamente il fiume e quando avvistava qualche canoa da lontano, lanciandosi dal colle, si tuffava nel mezzo del vortice. Le acque gli si chiudevano dietro e, quando arrivava il pescatore, il vortice si apriva tra spaventosi ruggiti, facendo apparire un boa gigantesco che lo divorava. Un giorno il boa scomparve e non è rimasta traccia del pappagallo Macao. Ha lasciato solo il suo nome in ricordo dei rivieraschi morti.
Un altro giorno, un runa che risaliva il fiume Maranon si capovolse con la sua canoa e venne mangiato da un boa chiamato Porahua. Quando l’uomo arrivò nel ventre del boa, vide molti animali: wangane, cervi, ogni sorta di uccelli e di pesci. Gli animali che dimoravano lì da più tempo avevano perso il pelo, mentre gli ultimi arrivati lo conservavano ancora lucente. Dentro vi era buio: tutto era scuro come nella selva. Il cuore del boa pulsava, nel mezzo del ventre, legato con una fune. Due uccelli, un passero e una gazza, dissero all’uomo: “Tu hai frecce e faretra, fratello, tu sei un runa. Se apri il fianco del boa Porahua, vi entrerà l’acqua del fiume e noi tutti affogheremo. Ma se fai un coltello con il bambù della faretra, potrai tagliate la fune che gli lega il cuore”. L’uomo allora fece un coltello molto affilato. La gazza e il passero salirono fin sopra e si posero nella bocca del boa per guardare fuori e dirigere le operazioni: videro che si stava avvicinando alla riva. Quando sentirono il ventre del serpente strisciare sulla rena, avvisarono l’uomo che tagliò la fune che legava il cuore del boa e gli aprì poi il fianco. Tutti gli animali ne uscirono: molti correndo, altri più lentamente, fiacchi e mezzi pelati.
Si racconta che all’interno della foresta, lungo il Rio delle Amazzoni, abita da tempi immemorabili il Curupira, uno strano genio, nano un po’ deforme e con i piedi a rovescio, che è il nume tutelare dell’immenso verde e l’autore di strani sortilegi. Può capitare infatti che, inoltrandosi nella foresta, all’improvviso tutto si confonda nel labirinto della vegetazione: dovunque alberi, muraglie vegetali, fantasmi evocati dai riflessi della luce e il ricomporsi continuo di nuovi arabeschi nel regno della perenne metamorfosi. La maledizione del Curupira, a questo punto, non perdona …”.
Dal “diario di viaggio”: 28 Giugno 1986.
Le leggende appena narrate rappresentano, in modo evidente, la proiezione simbolica di una lotta costante con l’ambiente, in quello che è ritenuto il più grandioso scenario d’acque e di foreste che esista sulla terra, l’Amazzonia. Oltre sette milioni di chilometri quadrati che racchiudono i due terzi di tutte le foreste tropicali del globo; concepito come un unico interrotto fiume lungo più di seimila chilometri, che con i suoi 1.100 affluenti forma il più grande bacino idrografico del mondo e scarica nell’Atlantico il 20 per cento delle acque dolci di tutto il pianeta. Decine di migliaia di specie animali e vegetali, molte ancora sconosciute, che rappresentano la testimonianza più concreta del nostro passato ancestrale.
Ce n’è abbastanza per concludere, con Euclides da Cunha, che l’Amazzonia rappresenta davvero «l’ultima pagina ancora da scrivere della Genesi biblica». Qui infatti la natura continua a sprigionare, con energia creativa continua, primordiali forme di vita che si accumulano caoticamente, e meravigliosamente, fino a rendere impossibile qualsiasi organizzazione (esplicita e mentale), a dar vita a una realtà talmente “eccessiva” da originare spontaneamente, nel corso del tempo, la scintilla della trasfigurazione mitica. Così quando la pororoca, l’onda di marea alta alcuni metri, risale con il suo rombo assordante il corso del grande fiume, gli Indios parlano di Ipupiara e del Cobra Grande, gli spiriti del fiume che si agitano nella loro dimora acquatica, mentre geni e divinità diverse abitano l’interno della foresta, là dove, protetto dal folto della vegetazione, l’uirapuru eleva il suo melodioso canto alla felicità.
Horacio è alle prese con alcuni Indios che abitano sulla costa, e sta cercando di concordare con essi di farci da guida nell’attraversamento dell’impervia palude equatoriale che si allarga nel tratto di foresta in cui il Rio Negro si immette nel Rio delle Amazzoni. Non c’è ragione di temere alcunché – dice – poiché le acque basse e meno turbolente di alcune vie d’acqua non rappresentano un pericolo, e per di più, si possono fare delle bellissime fotografie alle iguane che arrampicate sugli alberi s’adagiano agli ultimi raggi di sole. Ci trasferiamo sulle loro ubàs (canoe), così leggere che sembrano fatte di carta, e che gli Indios, uno per ogni imbarcazione, manovrano in piedi usando un solo remo, lentamente ma con destrezza, conducendole in silenzio attraverso un labirinto di arbusti e grossi tronchi che spuntano dall’acqua, facendo attenzione a non prenderci contro. Ed è proprio in questo silenzio arcano che la foresta sprigiona tutto il suo incantesimo arboreo e vegetale, che bulbi dalle dimensioni mai viste e fiori dai colori straordinari, sbucano improvvisi entro uno spazio esiguo; che il fogliame assume dimensioni inimmaginabili e s’arrampica sui fusti degli alberi, cui gli ibiscus cangianti fanno da corona.
L’Indio-runa che mi fa da guida, m’indica due iguane assopite al sole, sono enormi, magnifiche nella loro regalità … quasi appartengano al regno delle fiabe, quel mondo estremo che ci conduce dove l’eventuale impossibile e il probabile sono entrambi aspetti di una realtà/irrealtà sospesa nel colore dorato e trasparente del cielo che s’inchina al tramonto. Ferma la canoa! – chiedo al runa che penso comprenda la mia lingua – e lui lo fa, si siede sulla prua della canoa mentre io mi sollevo in piedi con entrambi gli occhi nel quadrante della Yashica - Matic pronto a scattare la mia foto ricordo, neppure che un obiettivo possa vedere più dei miei occhi incantati davanti allo spettacolo incredibile che mi offre la natura. Ce l’ho entrambe nella medesima inquadratura, sto per scattare la foto che il click s’inceppa, quando avverto dietro la mia testa e nell’orecchio scivolare dell’acqua che non è stata smossa, impossibile che fosse così vicina.
Tutto accade in un istante, con la coda dell’occhio vedo un tronco robusto su cui l’acqua scivola silenziosa, il boa Porahua (anaconda) è lì, emerso fuori dalla palude, pronto a stringermi nelle sue spire e trascinarmi nell’acqua torbida. Ho uno scatto istantaneo, come il click mancato della macchina fotografica che lancio verso l’alto con un grido, e poiché ce l’avevo legata al collo, mi ritorna sullo stomaco facendomi piegare in due sulla canoa. Il grido disumano, improvviso, risuona d’intorno come una nota acuta fuori del pentagramma, che gli animali e gli spiriti della foresta, colgono come un avvertimento di pericolo e subito s’allontanano. Finanche il boa Porahua, allorché il runa audace in bilico sulla canoa lo colpisce con il remo, si lascia cadere con un tonfo assordante nell’acqua e scompare. Ho appena il tempo di riprendermi che Horacio, sopraggiunto dietro di noi, mi consola dicendo che se fossi caduto in acqua avrei forse corso un altro pericolo più tremendo ancora, quello di finire in pasto ai famelici pirànas, in cerca di acque meno profonde e turbolente, ove depositare le loro uova.
Che anch’io sia incappato nella maledizione del Curupira?, arrivato a questo punto mi è cominciato a sorgere qualche dubbio … Dal ché si può ben comprendere la risposta che pure è racchiusa nel messaggio stesso. Due sono i modi di come si può affrontare un viaggio nella foresta amazzonica: uno esclusivamente pratico, che si presenta difficoltoso e oltremodo pericoloso se non si ha la possibilità di farsi guidare da un esperto conoscitore dei molti pericoli in cui si può incorrere, come: attacchi di animali, morsi di serpenti, punture d’insetti sconosciuti, febbri insane ecc., sfidando inoltre la possibilità di aggressioni feroci da parte di tribù agguerrite che fanno uso di frecce avvelenate col curaro, e per ciò che è rappresentato dalla quasi impossibilità di avere contatti diretti (del resto vietati dai vari stati) con gli Indios autoctoni delle regioni equatoriali più interne e quindi inavvicinabili. Il secondo modo, decisamente più insano, di fregarsene di tutto quanto è stato detto e quindi astratto, di affrontare l’impenetrabilità degli idiomi parlati, e avvicinarsi al loro modo di essere “primitivi”, schivi dei pericoli che la foresta può rappresentare e che vivono in stretto rapporto con la natura che li circonda. Andare alla ricerca, cioè, di quel “paradiso perduto” presente nella cultura di molti popoli, memori di un diluvio che li ha spazzati via e condannati a sopravvivere. Fino a quando?
Dal “diario di viaggio”: 29/30 Giugno 1986.
Costretti a nascondersi nei meandri più remoti della foresta e a vivere con rassegnazione all’interno delle riserve istituite dai karajana, come essi appellano i colonizzatori bianchi e in genere gli occidentali, gli Indios hanno subito a tutt’oggi, una decimazione sistematica da parte dei governi (e delle multinazionali) che si spartiscono il territorio amazzonico quasi senza interruzione dai tempi della Conquista, e tuttora, a seguito del taglio della grande arteria Transamazzonica che coinvolge una vasta regione, che va dal Perù, alla Colombia, al Venezuela, al Brasile, i cui governi, dopo l’assoggettamento occidentale, iniziato e mai terminato, sono tornati alla ribalta per l’importanza ch’essi ricoprono nell’ecosistema mondiale, e che permettono oggi, lo sfruttamento dei cospicui giacimenti minerari e l’estrazione del caucciù, vera e propria ricchezza del territorio.
Una recente stima, tuttavia molto approssimativa, ha rilevato la presenza di ingenti gruppi Indios allo stato nomade presenti lungo i corsi dei fiumi Xingu in territorio brasiliano e, dell’Orinoco in quello venezuelano, nonché di altri gruppi più esigui quali i: Karajà, Javahé, Juruna, Kraho, Tukuna, Shukarramae, Suyà, e molti altri ancora isolati nelle valli più interne, che vivono in condizioni pressoché precarie, lontani gli uni dagli altri, mantenendo scarsissimi contatti col mondo esterno e che, tuttavia, non mancano di occasioni di conflitto cariche di un’ostilità non soltanto micidiale e selvaggia, ma addirittura incessante. È questo il caso degli Yanoama dell’Orinoco, una popolazione eccezionalmente bellicosa e feroce, che ha permesso, ai ricercatori che vi si sono introdotti, un’occasione preziosa di poter studiare il fenomeno della violenza allo stato spontaneo. Tale che, se un gruppo, raramente formato di più di 200 persone, non riesce a trovare nessun indizio evidente di attacco da parte di un altro villaggio, escogita ragioni più sottili per contrattaccare ugualmente, per esempio, lamentandosi del fatto che il villaggio avversario ha provocato, mediante fatture stregonesche, malattie e accidenti vari ai propri abitanti.
Ogni villaggio costituisce un’entità politicamente indipendente, costantemente suscettibile di essere attaccata per ragioni diverse da uno qualsiasi dei suoi numerosi vicini, e che vanno dal furto di cibo, all’adulterio, all’offesa di mancanza di coraggio di qualcuno, ogni gruppo cerca continuamente di esibire la propria forza e ostentare la propria ferocia cercando di ispirare paura nei propri nemici. Tuttavia, poiché la situazione politica continuamente tesa è foriera di discordie, i combattimenti tra singoli rientrano a far parte integrante del quotidiano e, seppure lo stato di guerra cambia secondo i tempi e i luoghi, le circostanze sono ben definite e chiare per tutti.
Attualmente però, il grande dramma degli Yanoama dell’Orinoco che fanno paura, sembra essere scemato in atteggiamenti più vicini al vivere pacifico, anche a causa dei sopravvenuti problemi sociali e ambientali che si trovano ad affrontare, sia per le difficoltà legate alla sopravvivenza, portate dall’inquinamento e dai batteri che infieriscono sul loro stato di salute; sia dovute allo sfruttamento energetico perpetrato dalle multinazionali, interessate all’approvvigionamento del legname e quant’altro derivato dalla deforestazione, già causa dello depauperamento del territorio, che vede molte piante morire, molte delle quali già estinte, e che, non in ultimo, toglie agli Indios raccoglitori, quel sostentamento che la foresta fornisce loro. Fatti questi che minacciano, inesorabilmente, anche la sopravvivenza di migliaia di animali che in essa vivono e che si trovano ad affrontare sempre nuove difficoltà di conservazione, cosa questa, che arreca danni irreparabili all’equilibrio biologico che comprende anche tutti noi.
Leyenda cuarta, (o del espìrito natural). (8)
“All’inizio dei tempi accanto al dio Yaya, nostro Padre, vi era anche Yaya-Apustulu. Alcuni dicono che ce ne fosse uno, altri, due, altri ancora quattro o sei. Non si sa con certezza quanti fossero. A quei tempi Yaya-Apustulu andava in giro per il mondo; si dice che fosse veloce come il vento. Era quasi un dio, quasi come nostro Padre Yaya. Vi sono molti racconti che parlano di lui. Io ho sentito raccontare di due Yaya-Apustuli, che si resero visibili sulla nostra terra: erano due fratelli. Ascesero al cielo dopo aver insegnato ogni sorta di lavori ai runas della selva: forse ora sono con dio. Gli Yaya-Apustulu vissero all’inizio del mondo ai tempi di Killa, la luna; conoscevano tutti i tipi di alberi della foresta, soprattutto il cedro, chiamato “Albero Sacro”. Dal cedro si fabbricavano le immagini intagliate, dette “santi” forse perché il cedro fu benedetto dal dio, che decretò: “Questo è l’albero di Dio”. Le immagini di legno che gli Apustuli fabbricavano perché ci si ricordasse di Dio, oggi non ci sono più sulla terra: tutto è andato perduto. Allora vi erano anche gli spiriti o supays. Contro di loro gli Apustuli lottarono perché non dominassero su Dio. Li fecero fuggire molto lontano, in modo che vivessero appartati nella foresta. Alcuni di essi appaiono ancora come serpenti, scimmie o altri animali selvatici e, se li uccidiamo, incorriamo in gravi pericoli o moriamo.
Molto tempo dopo aver generato il popolo dei runas, Yaya disse: “Che farò adesso? Procurerò il cibo per nutrire il mio popolo; creerò il nutriente frutto del piwayo”. Deciso quest, creò una quantità di frutti commestibili: il piwayo e tanti altri, perché tutti avessero di che nutrirsi. Alla vista di tutto ciò, il supay, invidioso, tentò di imitarlo. Ma dai suoi tentativi uscivano solo palme wiririma, muru-muru, cioè piante spinose e prive di frutti commestibili. È infatti colpa dei dèmoni se vi sono spine nella selva. Un Apustulu volle provarci, ma non riuscì a fare che la chambira, un altro riuscì a creare solo chontilla e un altro ancora kuri-kiwa. Queste palme producono anch’esse dei frutti del tipo piwayo. Tutti questi spiriti, che all’inizio erano degli aiutanti di Yaya, non avevano però i divini poteri del dio e solo in parte riuscivano a imitarlo. Solo Yaya poteva fare tutto quello che voleva.
Un giorno Yaya se ne andava appoggiandosi a un bastone, che aveva ricavato dal legno di manioca , canna da zucchero, e si soffermò a guardare come la gente era in difficoltà. Andava in giro aiutando chiunque avesse bisogno e facendo tutto a vantaggio del popolo dei runas. Da questo arbusto nodoso tagliò dei pezzi che poi consegnava ai runas. “Prova a seminare questo, figlio – diceva – e mettilo nel mezzo del tuo campo”. Il runa lo seminava e il giorno dopo, di buon mattino, il campo appariva già pieno di frutti maturi, pronti per essere mangiati. Yaya stesso andava in giro seminando manioca e la pianta del piripiri, che serve per controllare le piogge e ha molti altri poteri magici. Per questo, quando seminiamo, ancora diciamo: “ Yaya, nostro padre, fai crescere la manioca sui nostri terreni! Ordina alla mia piccola pianta di crescere!”. Quando, nel momento della semina, pronunciamo queste parole, la pianta cresce bene e in abbondanza”.
Dal “diario di viaggio”: 1/2 Luglio 1986.
Oggi entriamo per la prima volta in un vero villaggio Tukuna, accolti dai runas con molti sorrisi ma che comunque nascondono una certa diffidenza. Al contrario dei più giovani che accennano a quelli che sembrano dei saluti di convenienza, le donne e i guerrieri della tribù ci osservano in silenzio, come fossimo nuovi animali di una razza che non conoscono, e che forse si aspettano di cacciare. I due anziani che ci vengono incontro, e che potrebbero avere da cento a mille anni, parlano con le guide indie, loro simili, o al massimo si rivolgono a Horacio che, essendo di pelle più scura della nostra, anche se ai loro occhi non può essere paragonato ai karajana, ma che si fa capire nella loro lingua. Noto che le abitazioni sono disposte in cerchio e differiscono tra loro per forme e misure, e ciò – spiega Horacio – avviene a seconda delle esigenze sociali, difensive, igieniche e religiose di ogni tribù o addirittura di ogni singolo gruppo linguistico. Il tipo di abitazione, oca o maloca, di un dato gruppo è il risultato di una lunga tradizione e dell’esperienza di vita in un determinato luogo, entrata a contatto con un terreno, un clima e una natura specifici.
Il linguaggio parlato dagli Indios amazzonici si fa risalire a quattro principali gruppi linguistici: Tupì, Aruak, Karib e Macro-Ge. Ognuno di questi comprende varie lingue e la loro influenza è presente nel portoghese parlato oggi in Brasile, specie nei nomi degli animali in genere, delle piante e degli oggetti domestici. All’interno di ogni tribù i gruppi di parentela dipendono dalle regole relative alla discendenza che possono riassumersi in tre gruppi principali: regole basate sulla discendenza patrilineare, cioè sul fatto che si considerano parenti solo coloro che hanno legami di sangue col proprio padre; regole basate sulla discendenza matrilineare che classificano come parenti solo quanti hanno legami di sangue con la madre; regole basate sulla discendenza bilaterale che riconoscono la parentela con i consanguinei di entrambi i genitori. Queste differenti regole dipendono dall’idea che un determinato gruppo tribale ha nella riproduzione biologica: secondo alcuni infatti il ruolo predominante nel concepimento spetta alla donna, secondo altri all’uomo e secondo altri ancora a tutti e due. Anche per quanto riguarda il matrimonio le regole variano da tribù a tribù. In alcuni gruppi ad esempio è permessa la poligamia, ovvero un uomo può sposare varie donne contemporaneamente, in altri è permessa la poliandria, cioè una donna può sposare più uomini allo stesso tempo, altri gruppi ancora permettono soltanto la monogamia e infine ci sono casi in cui un gruppo di uomini sposa un gruppo di donne e viceversa. Uomini e donne si suddividono il lavoro in parti uguali, ma dedicandosi ad attività nettamente distinte per gli uni e per le altre. I primi cacciano, pescano, puliscono il terreno, raccolgono il miele, preparano la cera utile ai lavori artigianali, si tengono sempre pronti per eventuali combattimenti. Le donne piantano la mandioca, il grano, le patate, il cotone, le spezie, le piante medicinali, raccolgono i frutti selvatici e spesso i lavori riservati a un sesso sono tabù, cioè sono severamente proibiti, per l’altro.
Dal “diario di viaggio”: 3/4 Luglio 1986.
Horacio ci ragguaglia sul luogo ove costruire un villaggio tipico che i Tukuna solitamente scelgono sulla base dei comuni interessi di sicurezza e di sopravvivenza, per lo più costruito con il sistema delle palafitte, al fine di risultare ben difeso dalle terribili piene del Rio delle Amazzoni. Dapprima si esamina la posizione strategica, la pendenza adatta o meno allo scorrimento delle acque piovane, la fertilità dei campi circostanti da riservare alla piccola agricoltura, la distanza dalla foresta, o mato, ricca di risorse vegetali e animali, la presenza di acqua potabile. Scelto il terreno, si passa al disboscamento per creare uno spazio abbastanza grande da costruirvi il villaggio. Una volta liberata la zona da cespugli e dalle erbacce e altri vegetali facile da estirpare, lasciano tutto a seccare. In un secondo momento danno fuoco all’area così circoscritta e alla fine restano sul terreno solo ceneri e i tronchi anneriti degli alberi più grandi. Attorno a questi ultimi riuniscono allora una gran quantità di rami secchi e accendono enormi falò, fino a distruggerli completamente.
Il disboscamento è in genere compito degli uomini, l’incenerimento delle piante è invece fatto da uomini e donne insieme. La costruzione dell’intero villaggio, in grado di ospitare complessivamente da 100 a 300 individui, è comunque il risultato di un intelligente lavoro collettivo e vi si accede mediante scale o piani inclinati sollevati dal suolo, e protetto all’esterno da una lunga e fitta palizzata che lo difende dagli animali e da ogni eventuale attacco nemico. Le abitazioni, poste in circolo, sono tutte aperte verso un’unica grande piazza centrale leggermente rialzata, in modo che nel periodo delle grandi piogge l’acqua scorra all’esterno del villaggio attraverso una sapiente rete di canalizzazione che evita l’impantanamento del terreno.
Solitamente, lo scheletro di ogni abitazione è costituito da grossi tronchi d’albero collegati tra loro con liane (cipò), ai quali sono appoggiati obliquamente dei lunghi rami flessibili e resistenti (vara) che formano il tetto e le pareti. La parte superiore di queste abitazioni è concava e coperta dall’alto in basso con foglie di un tipo di palma detta buritì. L’interno di ogni capanna, è privo di suddivisioni e vi si accede attraverso due porte molto basse, abitato da un certo numero di famiglie che vivono servendosi di un unico fuoco comune e, come al solito, le amache per dormire sono appese ai pali di sostegno, mentre dal tetto pendono oggetti di vario tipo e scorte alimentari.
Diverso è il villaggio degli Yanohàma (xapuno), una tribù che vive nell’alto Orinoco, altro grande fiume amazzonico, preso da Horacio a confronto, è formato da una serie di capanne costruite in cerchio che superano a volte i 100 metri di diametro, coperte ciascuna da un enorme tetto quadrangolare spiovente, prive di pareti e inclinate verso l’esterno in maniera da seguire la forma circolare o ovale della piazza centrale, capaci di ospitare un intero gruppo tribale. Le zone dove sorgono sono raramente esposte alle intemperie, il che spiega la loro elementare struttura che permette a loro di ridurre o ampliare le dimensioni del villaggio secondo le necessità, di grande importanza nel caso si debba ospitare qualche nuovo gruppo per motivi di difesa. Sempre per motivi di difesa il villaggio può essere circondato da una o più palizzate di protezione e inoltre, durante la notte, le sue entrate principali vengono sbarrate con rami spinosi per impedire agli animali di entrare.
Tra i diversi villaggi, quelli dei Tupinambà sono disposte in gruppi di quattro o al massimo di sette e sono costruite in genere nelle vicinanze di un fiume o in regioni coltivabili, difesi esternamente da una palizzata di tronchi d’albero conficcati nel suolo a breve distanza l’uno dall’altro, così da lasciare delle feritoie per gli arcieri pronti alla loro difesa. Sistemate in modo da creare una piazza rettangolare (ocara) dove trascorrere indisturbati la vita sociale della tribù, queste abitazioni sono quasi sempre rettangolari di grandi dimensioni, dai 50 ai 200 metri quadri in ampiezza, così da poter accogliere più famiglie tribali. Il piazzale centrale del villaggio infine, è un luogo comune a tutti dove si svolgono feste, ma anche competizioni sportive o riti religiosi, solitamente celebrati da uno sciamano (xamano).
Lo stile delle (chocas) abitazioni dalla forma conica, spesso decorate con pannelli ricavati dalle cortecce e dipinti a vivaci colori, varia ovviamente da tribù a tribù, e mentre alcune capanne hanno la base rinforzata da un cerchio di bassi tronchi, ve ne sono altre fornite di una specie di torretta utile per agevolare la ventilazione nei giorni più caldi. Altre ancora, con base circolare, sono costruite legando un certo numero di lunghi rami flessibili a un palo centrale e poi fissando con delle liane a questa struttura di base un fitto strato di foglie di palma. Nella parte interna delle abitazioni vi sono, ciascuno al centro dello spazio riservato a un singolo gruppo, i fuochi delle famiglie che vi risiedono. Sui fuochi vi sono spesso pentole di coccio dove bollono acqua e pezzetti di carne per il pasto quotidiano, mentre nelle vicinanze, infilzata in bastoni, viene messa a cuocere la carne di riserva. Alle pareti interne di ogni choca sono appese pentole di varie misure, frutta, carni e pesci essiccati, conchiglie, amuleti e accessori di vestiario. E inoltre, archi, frecce e altri utensili sono appesi a un’altezza superiore a quella dell’uomo e infine, pelli di giaguaro e di altri animali, oppure oggetti ornamentali, che scendono dal soffitto quasi fino al suolo.
Nella regione amazzonica dove le piogge sono molto abbondanti, le abitazioni sono invece di forma circolare, per difendersi meglio dalle raffiche d’acqua che le colpiscono e che potrebbero allagarle. È molto importante, per queste abitazioni, la scelta delle foglie di palma che servono a ricoprirle. La palma preferita è la paxiuba per la sua grande resistenza all’acqua. Gli Indios si siedono su stuoie o foglie di palma. Il letto è fatto con liane o fibre vegetali intrecciate a rete ed ha forma di amaca (rede). Può essere però anche fatto con quattro paletti di 30 o 40 centimetri di altezza che vengono fissati al suolo e sui quali si appoggiano delle assi, a loro volta ricoperte di foglie di buritì o di pelli di animali. Non manca poi chi dorme direttamente su pelli disposte a terra, vicino al fuoco.
Le tribù nomadi, per lo più formate da gruppi che vivono soprattutto di caccia e di quanto offre loro la natura, costruiscono abitazioni che sono spesso soltanto dei ripari temporanei contro le piogge e l’umidità della notte. Per crearsi questi ripari, gli Oiana, questo il nome di un gruppo esiguo, fissano al suolo due pali o usano due tronchi d’albero vicini che collegano con un palo orizzontale al quale appoggiano un tetto obliquo, fatto di foglie di palma e fissato con solide liane. A volte, se si trovano in zone paludose o sono minacciati dalle belve, costruiscono i loro rifugi tra i rami degli alberi, ben sollevati dal suolo.
Dal “diario di viaggio”: 5/6 Luglio 1986.
Non avendo conoscenza del tornio, che tanto facilita la lavorazione della creta, i Tukuna, come la maggior parte degli Indios dell’Amazzonia usano uno strumento di forma arrotondata che prima inumidiscono con la saliva. La cottura avviene in modo molto semplice: si scava nella terra una buca capace di contenere una grande quantità di pezzi, la si riempie con rami ai quali si dà fuoco e, quando resta soltanto la brace incandescente, vi si collocano sopra gli oggetti ben plasmati e si riattizza il fuoco. A cottura avvenuta non viene toccato nulla finché non si è raffreddato. Tra gli utensili di terracotta i più comuni sono le pentole che servono in primo luogo per preparare la mandioca. Questa va triturata premendola con le mani o con uno strumento particolare e a ciò si deve la forma più diffusa di pentola, non alta e dai bordi ben rinforzati. La grandezza di questi recipienti d’uso quotidiano arriva fino ad 80 centimetri di circonferenza e il peso si aggira sui 13 kg.
Già esistente in tutto il Sud America prima delle conquiste, si usa suddividere l’arte della ceramica in due grandi gruppi: la peruviana, prodotta oltre che in Perù anche nella regione occidentale del Brasile, in Argentina e in Bolivia; e quella amazzonico -messicana prodotta nel Messico, nelle Antille e nelle valli dell’Amazzonia, tra cui la più famosa è quella trovata nell’isola di Marajò alla foce del Rio delle Amazzoni. Sono essenzialmente le donne ad occuparsi della ceramica e le più famose sono quelle Waruara – una tribù di cui ci parla Horacio con cognizione di causa – che modellano nella terracotta, bambole e piccole immagini che vengono dette “santi”. Le più antiche sono singole e figurano quasi sempre in piedi. La capigliatura è rappresentata da un cono di cera e i disegni dai sobri colori riproducono la pittura che gli Indios usano fare sui propri corpi. Le statuette più recenti hanno due o tre teste, figurano spesso sedute nell’atto di compiere azioni quotidiane e i colori con cui sono dipinte sono molto vivaci.
Altre tribù si contendono però questo primato, per lo più che abitano in prossimità del fiume Botovì ricco di materie organiche – aggiunge ancora – usano una creta speciale arricchita con polvere di spugne. Questa creta, già di per sé particolarmente liscia, viene levigata con le foglie di una pianta dopo aver modellato l’oggetto che si è deciso di fare. Sulla superficie ben liscia si spalma poi un impasto fatto con un vegetale (urucu) e con olio di palma e subito si eseguono i disegni in rosso scuro, nero e bianco, passando nella parte interna dell’oggetto uno strato di fuliggine nera. Tra i tanti tipi di vasi, originali sono quelli zoomorfi, cioè a forma di animali. I loro bordi rappresentano le zampe, la testa, la coda di un dato animale che risulta così capovolto. Esistono anche recipienti di terracotta che servono da sonagli per i bambini o per le feste: dentro vi si mettono delle palline di terracotta che non possono uscire da nessuna delle sue parti.
Leyenda bastidor,(o de la primera canoa). (8)
“Yaya-Apustulu per prima cosa, si mise in cerca di un grande cedro. Prese poi l’arco magico che aveva il potere di tagliare gli alberi e, decise le dimensioni della canoa, conficcò una freccia nell’albero, all’altezza desiderata, traas!... la parte colpita divenne la prua. Indi tagliò l’albero e, mentre esso lentamente cadeva, corse avanti e se lo lasciò piombare sulla testa.. ta!... ta!... Ed ecco, dall’impatto, venne fuori una canoa ben delineata… senza molto sforzo. Decise così di insegnare questa tecnica al fratello minore, ma costui non seguì tutti i suoi suggerimenti: prese l’arco, colpì il cedro e cominciò a tagliarlo, ma quando iniziò la caduta egli, preso dalla paura, invece di rimanere ad aspettarlo e lasciarselo cadere sulla testa, si scansò e corse lontano. Il tronco allora cadde intero e non si trasformò più in canoa… Yaya-Apustulu lo rimproverò aspramente e predisse che mai più i runas avrebbero costruito canoe senza fatica, bensì sarebbe stato necessario un duroi lavoro con l’ascia, poiché anche l’arco perse gran parte del suo potere magico”.
Dal “diario di viaggio”: 7/8 Luglio 1986.
Presso la tribù Kamayuras, da noi raggiunta nei giorni successivi, e che vive più a nord risalendo il Rio delle Amazzoni, ho modo di assistere alla costruzione di alcune canoe che vedono l’utilizzo della corteccia dello jatobà (specie di cedro), un albero dal tronco largo, ben diritto e alto. Già durante la stagione delle piogge, in quanto è più facile staccare la corteccia dal tronco gonfio di umidità, gli uomini della tribù scelgono i tronchi che serviranno all’uso, secondo una conoscenza consolidata nel tempo. Quindi, staccano dapprima un pezzo di corteccia per vedere se vi si potrà ricavare una buona canoa; poi creano intorno all’albero uno spazio libero dalla vegetazione e infine aprono un solco lungo la parte centrale del tronco, partendo dalla base. Man mano che si arrampicano verso l’alto, gli uomini aprono altri solchi per formare il disegno della canoa da poppa a prua e costruiscono un’armatura d’appoggio (jirau) per poter procedere al lavoro d’intaglio. Dunque, collocano dei cunei di legno tra la corteccia e il tronco, e alla fine staccano la corteccia con l’aiuto di liane. Quando la canoa è a terra, la bagnano e correggono eventuali difetti, e definiscono le necessarie curvature. Una volta portata al villaggio, la canoa viene riscaldata in modo da far asciugare il grasso animale che ne conserverà l’impermeabilità e, una volta raffreddata, l’imbarcazione è pronta.
Diversamente, un’altra tecnica di costruzione delle canoe, consiste nello scavare l’interno del grosso tronco, bruciandone dapprima la parte non necessaria e poi completando il lavoro con l’ascia di pietra (machado). Entrambe le canoe così concepite, sono molto resistenti e non si spaccano, né al sole né alla pioggia, ai quali sono continuamente esposte. La loro poppa affusolata facilita la navigazione veloce e favorisce stabilità ed equilibrio. I remi usati sono anch’essi di legno e differiscono molto gli uni dagli altri, ma il più comune è quello a forma di lancia (pagaia). Si tratta di imbarcazioni molto agili difficilmente ribaltabili dalla corrente dell’acqua, sempre che le si sappia condurre, ovviamente, e in grado di intrufolarsi silenziosamente attraverso il dedalo intricatissimo delle numerose vie d’acqua che mantengono rigogliosa l’Amazzonia. Difficilmente l’Indio rinuncia alla propria canoa e, sebbene ve ne siano alcune adibite a uso della comunità, ne possiede una personale, talvolta più piccola, con la quale andare a pesca. Sono però gli Juruna, una tribù nota per l’attività agricola (estensiva e intensiva), con ricchi raccolti e che vivono sopra le grandi rapide che separano l’alto dal basso Xingu, davvero gli unici che sappiano attraversare le rapide con le loro robuste canoe e raggiungere le piane dove il fiume si placa e dove essi vanno a pescare.
La pesca è una delle attività fondamentali degli Indios che risiedono in zone ricche di acque. Tra le tante tecniche usate, è assai diffusa quella per cui si impiegano sostanze vegetali che hanno la proprietà di uccidere o stordire i pesci senza essere nocive per l’uomo, come il tinguì o il timbò. Questo tipo di pesca è sempre di carattere collettivo perché necessita della presenza di più persone. Gli uomini tagliano e legano in fasci di liane del timbò, poi le pestano con pietre o pali e infine le immergono nell’acqua al fine di impregnarla di succo vegetale. In un secondo momento, ponendosi in semicerchio, i pescatori smuovono con dei rami la superficie dell’acqua spaventando i pesci e facendoli fuggire in direzione dello sbarramento costruito in precedenza nel lago o nel braccio del fiume. Quando arrivano nella zona dove si trova il liquido del timbò, i pesci storditi seguono la corrente fino al punto dove li aspettano i pescatori, che però, difficilmente possono afferrarli a mani nude in quanto, benché storditi, una volta toccati guizzano via con violenza. Si usa perciò trafiggerli con frecce che hanno la punta d’osso o una punta di legno speciale (pau roxo) appositamente seghettato e tale da non lasciare la presa.
Quando le acque sono calme e trasparenti è possibile prendere il pesce con le frecce senza ricorrere a tossici speciali. In questo caso il pescatore aspetta pazientemente la preda dall’alto della canoa o su alberi i cui rami arrivano a toccare l’acqua e i cui frutti sono esche per i pesci. La pesca avviene di giorno, ma può avvenire anche nelle ore del tramonto o in quelle notturne. Di notte gli uomini pescano illuminando la superficie dell’acqua con una fiaccola che sostengono con la mano destra, mentre con la sinistra stringono l’arco tendendone la corda con la bocca e, sempre con la bocca, trattengono la freccia della lunghezza di un metro, pronta a scoccare. In altre occasioni però, costruiscono trappole ingegnose a forma conica, legate in cima a una lunga canna flessibile. Questa la si immerge sott’acqua e la si lega assieme all’esca ad un appoggio fatto con tre paletti. Il pesce per prendere l’esca deve entrare nella gabbia e fa così scattare il meccanismo che riporta la trappola all’esterno.
Una pesca particolare è quella che si svolge vicino alle cascate dove gli Indios costruiscono sbarramenti fatti di rami nei quali i pesci, trasportati dalla corrente, devono necessariamente incappare. Un altro tipo ancora di pesca è quello in cui si usano esche avvelenate che uccidono solo gli animali di sangue freddo e che sono fatte impastando dei pezzetti di carne con foglie di cunabim. I pesci vengono mangiati subito arrostendoli sul fuoco oppure, se si vogliono conservare, vengono moqueados, cioè messi a essiccare sopra una graticola speciale detta moquem.
Dal “diario di viaggio”: 10 Luglio 1986.
Oggi all’alba, seguiamo un gruppo di Indios a caccia del caititu, il cinghiale della selva amazzonica. È uso dei cacciatori eseguire riti magici di accompagnamento, come bere o spalmarsi il corpo con sostanze speciali ritenute di buon auspicio, fare molta attenzione a non offendere gli esseri soprannaturali, scrutare nei sogni per vedervi annunci di fortuna o di sfortuna. In tutte le società indigene la caccia è un’attività maschile primaria che può essere fatta sia individualmente che collettivamente. È ovvio però che non tutti i gruppi indigeni danno alla caccia la stessa importanza o la eseguono nello stesso modo. Canti iniziatici per la caccia sono lasciati alle capacità interpretative degli esecutori, piuttosto che a una sostanziale diversità di contenuto. Lo scopo ultimo è quello di portare al villaggio la selvaggina sufficiente al mantenimento del gruppo tribale. La notte prima della partenza per l’inizio della caccia, gli uomini della tribù improvvisano una danza rituale di tipo propiziatorio, a imitazione dell’animale che intendono cacciare l’indomani: ogni singolo cantore ripete dunque il verso dell’animale mentre gli altri del gruppo ripetono a mezza voce le sue parole. Si tratta di un canto “mormorato”, basato sulla cacofonia delle parole, senza accompagnamento di strumenti o sonagli.
Le tecniche della caccia dipendono in primo luogo dal tipo di animale che si vuole cacciare. Il caititu, simile al cinghiale, viene ad esempio atteso all’uscita dalla sua tana o stanato col fuoco. Per altri animali gli Indios si costruiscono dei rifugi o si arrampicano sugli alberi dove si appostano soprattutto di notte. Nella stagione piovosa, poi, l’allagarsi del terreno obbliga gli animali ad andare in luoghi asciutti dove è più facile catturarli. Una tecnica di caccia consiste nel circoscrivere col fuoco una zona fitta di vegetazione costringendo così gli animali a fuggire spaventati da un’apertura lasciata libera appositamente, la cui uccisione avviene nel momento della fuga.
L’attività della caccia impone agli Indios di sapere assai bene quali sono le abitudini degli animali e per questo essi conoscono i loro percorsi, i loro gusti alimentari, i loro rifugi preferiti. L’arco è sempre fatto con un legno molto duro e difficile da lavorare con strumenti rudimentali. La fatica che costa la sua fabbricazione spiega perché l’Indio è tanto attaccato al suo arco e perché solo di rado lo usa come merce di scambio. Il legno impiegato può essere quello di un albero che si chiama braùna scelto per la sua flessibilità, oppure quello di un tipo di palma che si chiama airi e che è duro, compatto, pesante, o ancora quello di una pianta che si chiama la begonia, anch’esso duro e compatto.
L’arco dei pescatori, a differenza di altri, è invece fatto con il gambo legnoso delle foglie di palma e c’è poi un particolare arco, detto bodoque, che serve per lanciare pietre o palle di terracotta. La grandezza degli archi è in genere di circa due metri, ma quello della tribù Patachos può anche superare i due metri e mezzo, mentre gli archi per la pesca superano di poco il metro. Le corde sono fatte con tre fili di cotone attorcigliati che vengono strofinati con foglie per farli diventare forti e lucidi. Un tipo di corda più sottile è fatto con una pianta che si chiama gravata e in questo caso la corda è strofinata con frutti freschi dell’araeira contenenti un succo nero protettivo contro l’umidità. Le tribù della regione del Maranhao si caratterizzano per avere un’arma più degli altri: una lancia che termina con una punta di legno duro.
Di particolare importanza le frecce si distinguono in almeno tre specie: le frecce da guerra, con punta di bambù concava, le frecce per la caccia di grandi animali, con punta concava ma fatta di legno e seghettata in modo che i serpenti non la espellano dopo la ferita; le frecce per la caccia agli animali più pericolosi, con punta schiacciata che termina in un tondino simile a un bottone e che produce una forte contusione. Un quarto tipo di freccia, migliore delle altre, termina con una punta liscia e si usa per la pesca. Il legno delle frecce è imbevuto di cera e poi passato varie volte nel fuoco per farlo indurire. Una volta attuato questo procedimento l’Indio inizia a intagliarlo e modellarlo. La lunghezza delle frecce è in genere di due metri, ma varia ovviamente secondo l’ampiezza dell’arco di cui si dispone. Le frecce sono sempre ornate con piume di animali tra le quali si preferiscono quelle dell’arara vermelha, della jacutinga, dello jacupemba o quelle della coda del mutum.
Le tribù del rio Napo, ad esempio, hanno lo stesso tipo di lancia descritta ma vi mettono una punta di un particolare bambù: il taquarassu ma, più solitamente le tribù che si dedicano in particolar modo alla pesca non usano fare la caccia collettiva e prendono soltanto alcuni uccelli con particolari cappi fatti con le liane o, occasionalmente, dei piccoli mammiferi, rispettando i tabù che vietano il consumo della carne di animali coperti di pelo. Le numerose e differenti tribù amazzoniche sono molto spesso in lotta tra loro e per questo la guerra è un evento fondamentale con funzioni economiche e sociali, a seconda che riguardi la difesa e l’allargamento del territorio, oppure la salvaguardia di un prestigio collettivo. I nemici non sono considerati tutti uguali, ma si differenziano in relazione al loro specifico codice guerriero che può essere giudicato di maggiore o di minore valore. Per questo motivo gli Indios del litorale non considerano avversari importanti quelli dell’interno che hanno tecniche di guerra assai inferiori alle loro, specializzati tra l’altro a combattere a bordo delle canoe e a far susseguire con ordine le varie fasi del combattimento.
Un combattente ferito deve essere capace di strapparsi la freccia dalla carne, spezzarla e morderne i pezzi e di continuare a muoversi e a battersi senza indietreggiare e senza voltarsi. Chi non è capace di fare questo è considerato un combattente di scarso valore e non rappresenta un gran merito il fatto di prenderlo prigioniero. Durante la prigionia i guerrieri hanno diritto di vivere in libertà dentro il territorio controllato dai vincitori fino a che giunge il momento del sacrificio che consiste nell’uccidere e mangiare il prigioniero ritenuto più coraggioso da parte del suo diretto vincitore. Tale sacrificio è seguito da una festa della durata di due giorni durante la quale si compiono complessi rituali, tutti volti a significare che le virtù del vinto sopravvivono nei vincitori. Conoscitori – come abbiamo avuto modo di apprendere – delle proprietà specifiche delle numerose piante medicinali, gli Indios sanno usare il curaro, potentissimo veleno naturale capace di bloccare la trasmissione neuro-muscolare e quindi provocare la morte istantanea, in modo strepitoso. Per questo hanno sempre impiegato il potente veleno per la caccia e a volte anche come arma da guerra, specializzandosi nella sua preparazione. Il curaro, noto come wourari o ourari, è estratto da alcune liane appartenenti a piante del genere “strychnos” e ha la caratteristica assai importante per un veleno da caccia, di agire solo se iniettato nella cute e non invece per via orale.
Usato per spalmare le frecce, ecco come ne è descritta la preparazione da un esploratore dei primi del ‘900: “… Un vecchio Indio stava estraendo il curaro da piante appena raccolte. Era l’alchimista della regione e aveva dei grandi vasi s’argilla in cui faceva bollire i succhi vegetali, dei vasi meno profondi in cui li faceva evaporare e delle foglie di banano arrotolate che servivano a filtrare i liquidi più o meno mescolati con fibre vegetali. Nella sua capanna regnava il più grande ordine e la più grande pulizia… la pianta utilizzatra era il bejuco de mavacure che si raccoglie abbondantemente lingo la riva sinistra dell’Orinoco e che si può usare sia fresca che essiccata badando al fatto che solo la corteccia e parte del midollo contengono il terribile veleno. La corteccia viene raschiata con un coltello e quindi ridotta in sottili filamenti triturandola sulla stessa pietra su cui si lavora la farina della manioca. Siccome il succo del veleno è giallo, tutta la massa assume quello stesso colore”.
Non esiste comunque un metodo unico per preparare il curaro, né un unico tipo di curaro e c’è chi li distingue a seconda dei recipienti dove sono conservati: canne di bambù, zucche, vasi di terracotta. In generale, e riassumendo le diverse osservazioni di numerosi ricercatori, il procedimento consiste nel far essiccare al fuoco la corteccia velenosa di una pianta, nel polverizzarla poi tra le mani attraverso un forte sfregamento, nel versarvi sopra acqua bollente e nell’usare direttamente sulle frecce il liquido così filtrato.
Leyenda sexta, (o del espíritu de la música). (9)
“Uakti (wah-ke-chee), una creatura enorme con tanti buchi sparsi sul corpo che ogni qualvolta attraversa la foresta, il vento che vi passa attraverso emette suoni meravigliosi e intriganti. La magia della musica amazzonica comincia da qui, da questa leggenda che vuole Uakti levarsi e mettersi a correre col vento che lo attraversa, portando scompiglio e gioia nel villaggio, tra gli Indios in attesa per la “festa del cauim”, che si svolge in occasione di particolari cerimonie come cerimonie religiose, di passaggio quali nascite, riti della pubertà, matrimoni, funerali, i cui preparativi hanno inizio alcuni giorni prima con l’approntamento del necessario affinché la “festa” riesca in ogni suo aspetto collettivo. E che va dalla preparazione delle paste che servono per dipingere il corpo (body-art), alla raccolta dei materiali per la fabbricazione delle maschere (nature-art), alla ricognizione dei materiali di ogni tipo, come noci, tuberi essiccati, tubi di canna, metallo, pietre, conchiglie, gomma, acqua, foglie, e di qualsiasi cosa produce suono, che permetta loro di fabbricare gli strumenti (music-art) davvero originali, che gli Indios utilizzano nel momento in cui Uakti fa risuonare la sua musica attraverso i fori che ha sul corpo”.
È scientificamente dimostrato, che la musica è in grado di scaturire emozioni simili in particolari gruppi di ascolto, sia che vivano in comunità, che in altre forme individuali. Va con sé che la musica e i canti degli aborigeni, presi ad esempio, e nati per una certa ritualità: una nascita, un matrimonio, un funerale, ecc. presentano caratteristiche e riescono a trasmettere emozioni diverse. Va detto inoltre che, l’emotività strumentale in cui una certa musica è suonata, e se vogliamo composta, è trasmissibile all’emotività attraverso i suoni che ne derivano, sia per le scelte tonali, sia per la lunghezza delle note, cantate o eseguite con uno strumento, pertanto, funziona da motore di sentimenti, un po’ come avviene per la maschera che si mette sul viso (o che ricopre il corpo di un danzatore), ha potere di trasformazione di una realtà che non è tale, capace di trasferire l’individuo in un “altro” (o in animale) e, in qualche modo, migliorarlo o peggiorarlo, a seconda dei casi, in qualcosa che lo “sublima”, rivestendolo di tutte le accezioni possibili, che vanno dall’idealizzazione, all’elevazione spirituale, all’esaltazione psicologica.
Ma è questa una storia che non è mai stata scritta e che qui ho cercato di raccontare (a mio modo) nell’ambito di un’esperienza di viaggio che ha lasciato un segno indelebile nel mio voler “viaggiatore sulle ali del tempo” che, tra clamorosi abbagli e straordinarie illuminazioni, cerca di scandagliare nei misteri che ci riserva questo nostro mondo, di misurarlo, utilizzarlo e comprenderlo nella sua nozione di infinito. Di ripercorrere, per così dire, le intuizioni e le follie che hanno costellato il cammino dell’uomo, cercando di svelare l’enigma della più importante delle sue invenzioni: quella “musica” che più lo accomuna con la natura cosmica del tutto. Quel “grande verde” in cui tutto, è affidato all’indicibile, a ciò che a noi riesce indescrivibile, inenarrabile e, in gran parte intraducibile, a causa delle lingue parlate dalle diverse etnie, sebbene il quechua (10), portato dagli Incas durante i loro falliti tentativi di conquista e, in un secondo tempo, dopo la scoperta dell’America, imposto e diffuso dai missionari cattolici per facilitarne l’evangelizzazione attraverso l’uso di un linguaggio comune, ha in certo qual modo, unificato molti dei linguaggi esistenti sul territorio. Lingue usanze e costumi di popolazioni che avremmo desiderato accompagnare nei misteri della loro stessa esistenza all’interno di quel paradiso terrestre che stiamo distruggendo con l’indifferenza e il silenzio.
Ecco, il nostro viaggio è giunto alla fine. E mentre ci scorrono davanti agli occhi ancora le immagini di un paradiso della natura che avremmo voluto incontaminato. Fermiamo tutto questo, prima che sia troppo tardi. Io mi fermo qui, prometto che torneremo ancora in Amazzonia, le tribù che la abitano sono numerose e di alcune non si conosce assolutamente nulla, neppure i loro nomi. Se bastassero le parole per dire ciò che vorrei, allora si aprirebbe un colloquio “disperato” sulla situazione: “una guerra di cui non si parla, non è neppure una guerra” dicono taluni giornalisti che fanno ben altro mestiere dal mio. Infatti siamo davanti a un ennesimo “genocidio” di cui nessuno parla. Dopo gli Indiani d’America, i Rom, i Berberi (tuareg), i numerosi “popoli” africani, gli Aborigeni australiani, dopo gli abitanti di Avatar, forse arriverà un giorno il nostro turno. Allora preferisco salutarvi con poche frasi intrise di sano profetismo tratte ancora una volta dal romanzo di Romano Battaglia (11) e che faccio mie:
“Il mistero della vita è nascosto nella foresta; camminando nell’imprevedibile conoscerai la saggezza dell’incertezza e capirai che cercare lontano significa scoprire verità ch’erano già dentro di te”.
Discografia:
Pubblicazioni in Italiano:
Ettore Biocca: “Viaggi tra gli Indi: Alto Rio Negro – Alto Orinoco” – CNR – Roma 1966
Diego Carpitella: “Yanoama: tecniche vocali e sciamanismo” (I Suoni – Su 2003) – Collana I Suoni – Cetra.
Harold Schultz e Vilma Chiara “Musica degli indiani del Brasile”, – Albatros – VPA 8452.
Vincentt Carelli, “Musica Indigena del Brasile”, SudNord Edit. – 1992. Centro de Trabalho Indigenista: Tribù Guaranì, Asurini, Walapì, Nambiquara, Aapanjèkra, Parakatejè, Bororo, Zuruaha.
Bibliografia essenziale:
Fritz Trupp, “The Last Indians: South America’s Culturall Heritage”, Perlinger Verlag -1981.
Peter Rivière “I popoli della terra: Amazzonia, Orinoco e Pampas” – Mondadori Milano 1973.
AA.VV. “La civiltà e i popoli dell’Amazzonia” – F.lli Melita Ed. – La Spezia 1992.
Note:
(1)Romano Battaglia, “Il dio della foresta” – Rizzoli Milano 1998.
(2-3-4) Franco Perlotto (fotografo) e Claudio Minoliti (reporter), articolo in “CapoHorn”, rivista specializzata in reportage di viaggio, di libri di avventura, di mare, di viaggi
e non solo...
(5) Giorgio Mancinelli, “Diario di viaggio”, (inedito), alcuni reportage utilizzati in diverse trasmissioni radiofoniche.
(6.7.8) AA.VV. “Miti e leggende degli Indios dell’Amazzonia” – Arcana Editrice – Milano 1987.
(9) Uakti (wah-ke-chee), il suo nome ripete quello del Tukano che ha dato luogo alla leggenda che porta lo stesso nome. Uakti appartiene al mito degli Indios che abitano le rive del Rio Negro. Il suo corpo è pieno di buchi in cui quando passa il vento, produce suoni che incantano le donne. Gli uomini della tribù cui Uakti si presenta, lo cacciano e lo uccidono e fanno del legno della palma che lo ha nascosto il legno per i flauti che portano lo stesso nome.
(10) Academia Peruana de la Lengua Kechwa (quechua) “Diccionario Castellano / Kechwa / Castellano” - Cuzco 1967.
(11) Romano Battaglia, op. Cit.
Cinema:
Tutti coloro che volessero farsi un’idea di quello che l’Amazzonia rappresenta in natura, può visionare i seguenti, oltre ad alcuni documentari della National Geografic specifici di alcune aree, i seguenti film d’autore che, oltre al successo riscosso per le tematiche trattate, permettono di vedere scorsi di ciò che di “meraviglioso” e di “pericoloso” l’Amazzonia rappresenta.
“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, un film di Rolf De Heer, dal capolavoro di Luis Sepulveda, interpretato da Richard Dreyfuss.
“Fitzcarraldo”, di Werner Herzog, con la musica dei Popol Vuh, interpretato da Klaus Kinski e Claudia Cardinale.
“Aguirre furore di Dio”, di Werner Herzog, musica dei Popol Vuh, interpreti Klaus Kinski e Helena Rojo del Negro.
“Mission”, un film di Roland Joffe, con le musiche di Ennio Morricone, interpreti Robert De Niro e Jeremy Irons.
“.jpg) - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusicologia 2: Amazzonia
“AMAZONAS: testimonianze di una cultura in via di estinzione”, di Giorgio Mancinelli. (prima parte)
(Da “Folkoncerto”, trasmissione radiofonica in due puntate messa in onda da RAI-Radio3, e “Il Canto della Terra” e “Itinerari Folkloristici”, reportage trasmesso dalla RSI; “Il canto del silbaco” articolo pubblicato in Audio-review n.28 – 1984.
È mia intenzione, ricordare qui, tutti quanti gli studiosi del folklore e quant’altri: etnologi, antropologi, sociologi, musicologi e scrittori di viaggi, che negli anni, in qualche modo, hanno contribuito alla mia formazione di ricercatore, e i tanti altri di cui ora mi sfuggono i nomi, che pure mi hanno insegnato, educato e meravigliato con le loro scoperte, con i loro scritti, i loro discorsi sull’importanza della musica popolare e, soprattutto, per l’aver dato corpo e voce, attraverso innumerevoli registrazioni fonografiche, a quella “letteratura orale” per lo più sconosciuta che, in qualche modo, riaffiora sempre in superficie nella cultura dei popoli “primitivi”, indubbiamente diversi da quelli “originari”, e che oggi, finalmente, è considerata parte del patrimonio universale. È infatti grazie all’operato di tanti ricercatori, etnologi, antropologi, musicologi che mi hanno preceduto, che si è reso possibile rilevare, finanche in modo particolareggiato, il sostrato comune di alcune popolazioni stanziali aborigene, tra quelle organizzate in comunità, fra cui quelle autoctone dell’Amazzonia, alle quali rivolgo questa mia investigazione, con l’intento di far conoscere e rivalutare un patrimonio etnomusicologico e culturale di forte impatto ambientale che, altrimenti, rischia di scomparire.
Nell’impossibilità di citarli tutti, fra discografici, produttori e tecnici del suono, che in passato hanno collaborato alle trasmissioni radiofoniche da me redatte, e agli editori, soprattutto quelli delle riviste di settore, che in passato hanno ospitato i numerosi articoli, consentendo la divulgazione delle mie “avventure musicali” in giro per il mondo. A tutti loro va il mio ringraziamento e la mia stima. Tuttavia è alla luce di quanto appena affermato nel titolo: “origini e tradizioni di una cultura in via di estinzione”, che m’incorre l’obbligo di trasmettere le mie conoscenze acquisite in anni di ricerca, in verità solo in parte svolta sul campo e che, in qualche modo, ha risvegliato in me il grande senso di responsabilità che mi porterei dietro, se lasciassi cadere nel dimenticatoio quanto ho appreso senza restituirlo alla sua universalità. Come appunto è detto nell’Antico Testamento: “Non sta a voi completare l’opera, ma non per ciò siete liberi di astenervene”. È dunque sulla scia di queste parole che più sento il dovere di trasmettere alle giovani generazioni il “messaggio” da me ricevuto, affinché non tutto infine vada perduto. Ma veniamo al dunque.
Prima di stabilire un qualsiasi itinerario ho la pessima abitudine di pormi alcune domande sulla ponderabilità della mia decisione e, ancor prima dei soliti interrogativi: come, dove e quando, mi chiedo sempre, perché? Perché ho scelto gli Indios dell’Amazzonia mi sembra di averlo spiegato ampliamente nell’introduzione, mentre invece non mi sono ancora soffermato sulla diversità del concetto riguardante la diversità che incorre tra “cultura originaria” e “cultura primitiva” alla base delle conoscenze e dei parametri sociologici che le contraddistingue, e che ovviamente fa la differenza. Nel linguaggio sociologico, la discrepanza fra le due è essenziale, e sta nella “proprietà prevalentemente “oggettiva/soggettiva” esclusivamente interiore dell’individuo, legata al processo di umanizzazione, all’acquisizione e allo sviluppo graduale delle facoltà intellettive, presente nella componente principale di un carattere sociale”, nell’una. E “nelle interazioni sociali trasmesse ed ereditate per la maggior parte dalle generazioni passate, e soltanto in minima parte prodotte originalmente e modificate dalle generazioni viventi” (1), nell’altra, se bene nel linguaggio antropologico entrambe le connotazioni non sono altro che due aspetti del medesimo fenomeno.
Nonché dalle dimensioni “tribali” (quantità delle persone che ne fanno parte), nella forma di coesione (sussistenza di diverse tribù che vivono nello stesso posto) e nell’efficacia delle diverse forme di comunicazione paritarie. Vi è infine un filone che potremmo definire psicologistico, il quale riconduce le origini della cultura, vista soprattutto nelle sue componenti universali, a certe condizioni proprie dell’esistenza dell’uomo in ogni tempo e società. Le opere più rappresentative in questo campo vengono dalla psicoanalisi (2), o sono da essa ispirate e che soprattutto, tendono a definizioni strutturali, sociologiche e dinamiche talvolta diverse (3). Nel caso specifico, attribuibili alle diverse etnie che vivono nella riserva equatoriale dello Xingu (4) e zone limitrofe del Mato Grosso in Brasile, e dell’Alto Orinoco (5) più a nord, lì dove la foresta amazzonica si espande ai corsi dei numerosi fiumi che s’intersecano sul territorio fino a lambire gli stati del Paraguai, Perù, Colombia, Venezuela, Guaiana caraibica.
In questi luoghi, il concetto di cultura elaborato dall’odierna scienza antropologica, intenta a riconoscere il valore delle forme di organizzazione sociale e dei costumi dei popoli, anche di quelli tradizionalmente definiti “primitivi”, coincide in larga misura con la forma “strutturale” (6) delle società aborigene di riferimento, quali appunto gli Indios dell’Amazzonia, di grande interesse etnologico, che possiedono un vasto materiale culturale straordinariamente complesso, accumulato nel corso dei secoli, e in parte ancora sconosciuto perché non sufficientemente studiato, e di cui oggi rivendicano il riconoscimento di un’autonomia (7), come conseguenza del “profondo legame umano” cui dovrebbe portare il complesso fenomeno che è la relazione tra una società avanzata e le popolazioni che, pur avendo una propria identità da mantenere e sviluppare, vengono inevitabilmente schiacciate. .
Incominciamo quindi, col solo ausilio del mezzo comunicativo universalmente dichiarato che è la musica che, al pari della voce umana nell’uso che se ne fa nel canto, a individuare le linee guida della tradizione aborigena sul suolo amazzonico, avulsi da preconcetti e stereotipi razziali d’ogni genere. Non un mezzo qualunque, casuale o discordante, altresì capace di evocare emozioni addirittura superiori, in molti casi, a quelle della parola scritta o delle arti visive, e che ci permette di riscoprire, pur nell’apparente arcaicità di un modo di vivere e pensare lontani dai nostri, un’impostazione sociale diversa, tuttavia autentica, che può senz’altro esserci d’aiuto nell’auspicata comprensione tra noi e loro.
Scrive Curt Sacks (8), che “La musica, immateriale e labile (almeno per quanto riguarda le origini) dà forma a un’esperienza che può essere e sarà in parte rivissuta dalle nuove generazioni nonostante i limiti posti dalla concezione primitiva, come la lotta titanica dell’uomo per stabilire saldamente le sue leggi nella natura e per darle forza ed efficacia tali da esprimere quanto gli uomini sentono: disperazione e gioia, amore, timore e speranza”. Cui fa eco Augusto Romano (9): “Da sempre la musica è considerata un ponte tra il mondo che noi abitiamo e il regno dell’invisibile, la cui realtà misteriosa e sfuggente è impossibile trascrivere nei termini del linguaggio discorsivo. È “l’albero che nell’orecchio sorge” (Rilke), le cui radici affondano nelle regioni oscure e caotiche della psiche e le cui chiome toccano i cieli intatti dello spirito”. Realtà questa, che mi permette ancora una volta di affermare un principio fondamentale che vado ripetendo da sempre e in cui davvero credo: “È nello scoprire il fascino profondo della musica che l’infinita ricerca di noi stessi si amplia di nuovi importanti capitoli che vanno ad aggiungersi a quella “storia universale” che noi tutti stiamo scrivendo”.
Quanto ci aspetta in seguito, è dunque un’avventura di viaggio alla ricerca di miti e leggende profondamente religiose, se per religiosità intendiamo un certo coinvolgimento di tipo animistico (10) legato al culto della natura, per lo più espresso nelle credenze e nelle tradizioni oralmente tramandate dai numerosi gruppi etnici presenti sul territorio, e riferite a un “tempo senza memoria” lontanissimo, o forse dimenticato. Una sorta di “nostalgia delle origini” maturata all’interno di un processo rituale assai variegato e una simbologia complessa, che dischiude a noi (esseri civilizzati e sempre più globalizzati), un mondo in parte sconosciuto che non si presta a essere raccontato con le parole. Semmai attraverso l’iniziazione sciamanica, o forse nell’uso arcaico delle danze, altresì narrato in musica, che qui assume il significato di voler recuperare quella “eccellenza di stile di vita” che noi, post-moderni disconosciamo, e che abbiamo definitivamente perduto.
Un mondo di suoni fonosimbolici, di vocaboli onomatopeici, imitativi dei versi degli animali che qui trovano il loro habitat naturale, considerati i dominatori assoluti della grande Foresta Amazzonica che da sempre li accoglie. Racconti e narrazioni quindi, appartenenti alle diverse etnie tribali idealmente riunite a formare un unico tipo antropologico che ho cercato di ridefinire dentro un determinato rapporto sociale che li accomuna. Così, come precedentemente da me svolto per i popoli di etnia Rom (11), e successivamente per i nomadi del Sahara (12), più che una ricerca, questa, vuole essere una ricognizione di quanto rimane di una cultura in via di estinzione, quella appunto degli Indios dell’Amazzonia. Non solo incentrata sul fatto musicale, bensì rappresentativa della fabbricazione di capanne e villaggi, di strumenti e utensili, di canoe e ceramiche, fino al tatuaggio (13) e alla body-art (14), con particolare riferimento all’utilizzo delle maschere rituali (15) destinate ad assicurare la sopravvivenza ad alti livelli trascendentali.
Ragione per cui gli Indios amazzonici sono portati a credere solo alle esperienze che possono fare attraverso i sensi, ciò che permette loro di trasferire il fantastico del sogno, nella dimensione reale, e a conferire alle metafore cui ogni sogno si affida, un significato concreto. Ecco allora che le forze mistiche da cui essi si sentono permeati da ogni parte vengono a inserirsi nella realtà individuale e sociale cui aderiscono fin dalla loro nascita. È così che nel loro fantasticare, il sogno di esseri soprannaturali, meglio ancora connaturati con tutto ciò che li circonda, il mondo del visibile e invisibile, si confondono, per assumere la forma della rappresentazione vissuta. È così che la musica e la danza, ancor più il travestimento o l’uso di una maschera, diventano un’assoluta concretezza. Tuttavia ciò non sarebbe così, e noi vivremmo ancora nell’ignoranza, se non fosse che l’importanza dei concetti di archetipo e di inconscio collettivo attraverso più approfondite ricerche umanistiche, non ci avessero illuminato la mente sulla concretezza dell’esperienza psicoanalitica, portata alla nostra conoscenza e posta all’origine delle cose e dei fatti.
Il termine, archetipo (o immagine primordiale), elaborato da C. Gustav Jung (16) è spesso identificato con certe immagini definite o precisi motivi mitologici, mentre, in realtà, non è altro che il frutto di rappresentazioni consce di uno stesso motivo che, pur nelle sue variazioni individuali, anche sensibili, continua a derivare dal medesimo modello fondamentale. Quindi, non derivato da un modello statico, altresì soggetto a fattori dinamici, che si manifestano sotto forma di impulsi altrettanto spontaneamente che gli istinti. Elementi non individuali e non ricavabili dall’esperienza personale, che Freud chiama “resti arcaici”, cioè forme mentali (collettive) “corrispondenti di modelli costituitisi molto prima che l’uomo sviluppasse una coscienza riflessiva, la cui presenza non può essere spiegata da alcun elemento della vita individuale (..) che si rivelano come dati primordiali, innati della mente umana”. E che Jung conferma “sarebbe assurdo pensare che tali rappresentazioni variabili siano ereditarie”, e tuttavia che “siano derivate da conseguenze dolorose di violenti conflitti emotivi”.
Che l’emotività individuale possa trasferirsi a livello collettivo è fuor di dubbio, esempi ve ne sono a iosa (guerre, pestilenze, terremoti), ma via via che gli antropologi culturali scavano nelle viscere del passato, scopriamo che non sono gli eventi del tempo storico ciò di cui impariamo a far tesoro, bensì i linguaggi e i diversi modi di esprimersi che ci comunicano le antiche credenze, i miti e i rituali di piccole entità tribali, quali sono quelle che vivono all’interno dell’Amazzonia, che non hanno conosciuto alcun mutamento in millenni, e tutt’ora esistenti ai margini della civiltà. Idiomi, lessici, stili e forme di vita, (al pari di codici spesso intraducibili e simboli arcaici impraticabili), riconosciuti a questi popoli che, secondo alcuni filologi e storici delle religioni non presentano alcun interesse di fronte alle complessità della vita del nostro tempo, sarebbero invece dimostrative di una primaria attività capace di trasformare, seppure inconsciamente, in simboli e forme di enorme importanza psicologica, espressi nella religione come nell’arte, inclusiva dei manufatti, dei costumi, come pure della decorazione del proprio corpo (travestimento, tatuaggio, maschere ecc.) entrato nell’uso quotidiano.
La storia del simbolismo (17) dimostra che qualsiasi cosa può assumere un significato simbolico: così gli oggetti naturali come pietre, piante, animali, montagne e vallate, il sole, la luna e le stelle, il vento, l’acqua e il fuoco, e tutte le cose che sono opera dell’uomo o le forme astratte e l’intero cosmo, assumono talvolta significati sacri che, tradotti in concetti intelligibili, sono rappresentativi delle manifestazioni della coscienza umana dei primordi. Tuttavia, particolari tipici dei costumi degli amazzonici, sono tutt’oggi considerati qualcosa di più di semplici riproduzioni naturalistiche. Sorge l’idea che certi segni tatuati (o dipinti) sui loro corpi costituiscono dei sortilegi per la caccia, del tipo di quelli praticati fin dall’antichità, nelle diverse parti del mondo in cui sono stati rinvenuti, al pari della totale identificazione fra l’essere vivente e l’immagine astratta della sua anima, qui rappresentata nella maschera indossata, dal potere soverchiante dell’impulso che alberga nella sua intimità. Di tale impulso l’uomo “primitivo” ha terrore e cerca di propiziarselo per il tramite di sacrifici tribali e di cerimonie rituali. Ciò significa che talune rappresentazioni sono vissute come realtà, in certa misura indipendentemente dal loro substrato, con un’autonomia in ogni caso relativa, poiché in natura “non c’è nessun dominio privo di rapporto con gli altri domini” – come suggerisce Durkheim.
Sembra ragionevole supporre una sorta di predisposizione inconscia nelle ripetitive esperienze dell’umanità, accumulate o associate tra simboli e significati, che entrano in gioco indipendentemente dall’esistenza individuale, che bensì diventa collettiva allorquando l’individuo vive all’interno di una realtà complessiva (tribale, etnica ecc.). La percezione è l’esplorazione diretta di una esigenza individuale (privata) che diventa di gruppo (collettiva), indirizzata a risolvere un determinato problema, o soddisfare le esigenze di uno scopo di tipo sociale, e che ha origine – scrive George Hausmann (18): “da un processo costituito da molteplici atti di formazione, mutuamente interconnessi, selettivi, astrattivi e persino creativi”.
La foresta Amazzonica, più che altre parti del globo, presenta all’etnologo una situazione che sfida qualunque tentativo di classificazione delle culture aborigene. In effetti, fin dall’inizio di ogni ricerca, si impone un taglio netto tra le grandi civiltà che la circondano, a cominciare da quelle andine del Perù e Colombia e le innumerevoli culture tribali, così diverse fra loro che hanno reso finora piuttosto sterili tutti i tentativi di classificazione secondo schemi storici, geografici o tipologici. Dal punto di vista economico, si possono sicuramente distinguere in modo sommario le popolazioni in cui predominano attività come la caccia (piccoli animali del sottobosco, pappagalli e scimmie), la pesca (pesci, bisce d’acqua ecc.), o la raccolta (frutti ed erbacee) ed altre in cui prevale l’agricoltura (manioca, tapioca, mais ecc.); ma sono presenti altresì tutti i sistemi economici di forma intermedia. Analogamente, le istituzioni sociali e le forme di vita religiosa variano col variare dei gruppi, a seconda che rientrino nell’una o nell’altra categoria, ma sarebbe vano, ad esempio, cercare di fissare una distinzione rigida tra le religioni delle tribù di cacciatori e quelle delle tribù di agricoltori.
Vari etnologi hanno evidenziato il fatto che un’analisi delle rappresentazioni mitiche, dei riti e delle cerimonie religiose delle tribù cosiddette aborigene dell’Amazzonia rivela spesso, se non sempre, l’esistenza di una concezione del mondo piuttosto tipica delle tribù dedite alla caccia e alla raccolta. Fenomeni che si potrebbero ritenere tipici di questa o quella zona non si limitano a questo ambito esclusivo e li si ritrovano a volte presso popolazioni i cui territori sono molto distanti tra loro, la cui lingua, il sistema economico e l’organizzazione sociale, sono sensibilmente diversi. Dato lo stadio attuale delle conoscenze, una presentazione sistematica o sintetica dei fatti incorre inevitabilmente in tutta una serie di limitazioni. In quanto ai vari lavori di sintesi disponibili, almeno quelli dovuti a A. Métreaux (19), F. Boas, A. Hultkranz e di R. Karsten, e tanti altri in lingua portoghese (alcuni mai tradotti), il loro principale scopo è quello di mostrare come si distribuiscono le idee, le credenze, le pratiche rituali tra certe tribù o certi “gruppi” tribali. Così, taluni fenomeni ritenuti per la loro frequenza tipici di una certa area, si possono presentare anche in altre regioni più interne.
Dall’inizio del XVI secolo, viaggiatori , avventurieri, missionari e studiosi hanno raccolto informazioni sulle religioni delle popolazioni indigene dell’Amazzonia, ma le loro testimonianze, in gran parte fortuite e accidentali, vanno usate con cautela. Pochissimi sistemi religiosi sono stati esaminati da etnologi competenti che abbiano avuto modo di condividere per un periodo abbastanza prolungato la vita di una popolazione indigena al punto di essere in grado di capirne realmente le profonde credenze e gli stessi rituali ad esse riferiti sono risultati scarni in relazione alle concezioni mitiche di riferimento.
Poiché è inevitabile che l’esposizione dei contenuti di questa ricerca operi una serie di scelte, cercherò, per quanto possibile, di mettere in evidenza i tratti ritenuti abbastanza generali e tipici di alcune aree culturali riferite ai fiumi Xingu, Rio delle Amazzoni e Rio Negro, Napo e Orinoco, senza dimenticare di richiamare i numerosi e risaputi limiti che si impongono, dato le lacune delle nostre conoscenze a disposizione, così precarie, per quanto concerne la maggior parte delle religioni indigene di quest’area equatoriale del continente. Per quanto nelle note al testo si faccia riferimento a una copiosa bibliografia, in realtà le fonti citate sono essenzialmente poche, rinvenute sparse in tomi che affrontano problematiche generiche, in parte non attinenti alla tesi prescelta, redatte in lingue non sempre accessibili.
Infatti, il discorso sulla musica, gli strumenti usati, le forme di canto e le rappresentazioni, per lo più, è trascurato dagli studiosi, vuoi perché si tratta di scienziati, biologi, etnografi, psicologi ecc. non inclini al fatto musicale in sé, sia perché dediti ad altro tipo di ricerca. Tuttavia vanno qui riconosciuti i miei personali debiti verso quegli autori le cui opere ho utilizzato nella stesura di questo mio libro, di gran lunga interessanti per quanto riguarda il concetto di etnia, le minoranze razziali, l’integrazione economico-sociale e le relazioni interraziali e, non in ultimo, la funzione sociale nei miti presenti nelle credenze popolari da essi descritte. Studi enciclopedici e monografici basati sulla ricerca, in gran parte rivolti all’osservazione diretta, si sono rivelati utili per la collocazione geografica, la classificazione culturale e linguistica, l’ispirazione e l’interpretazione teorica, nonché altrettanto fruttuosi per la rilevazione sociale e delle condizioni di vita della popolazione indigena brasiliana, qui presenti con il loro contributo di dati nella sezione: Bibliografia. Tra le fonti svolte per lo studio musicologico registrate “sul campo”, vanno segnalate particolarmente le pubblicazioni fonografiche presenti nella sezione: Discografia.
Moltissimi sarebbero gli autori di lingua madre da citare, tra i quali meritano senz’altro d’essere segnalati: Herbert Baldus, Florestan Fernandez, Eduardo Galvao, Curt Nimuendaju, Roberto Cardoso de Oliveira, Darcy Ribeiro, Vasconcelos alias Vicente de Paula Teixeira da Fonseca, le cui opere “in lingua”, per lo più mirate al collocamento delle realtà tribali, alle diversità dei linguaggi, ma anche all’acculturazione e la ricostruzione storica, come pure ai cambiamenti sociali, di trasfigurazione etnica e di emarginazione culturale, risultano inaccessibili o introvabili. Per quanto riguarda le fonti a cui mi sono ispirato per questa mia ricerca, ritengo doveroso citare almeno un libro “Amazzonia: mito e letteratura del mondo perduto” a cura di Silvano Peloso (20), che ha raccolto le testimonianze di numerosi scrittori brasiliani e non, e che ritengo prezioso per diverse ragioni, a cominciare dall’introduzione fino al corposo glossario, all’elencazione delle fonti bibliografiche, di grande utilità ai fini di questa ricerca. Tratto dall’Introduzione dell’autore, leggiamo:
“Racconta un’antica leggenda india che all’interno della foresta, lungo il Rio delle Amazzoni, abita da tempi immemorabili il Curupira, uno strano genio, nato un po’ deforme e con i piedi a rovescio, che è il nume tutelare dell’immenso universo verde e l’autore di strani sortilegi. Può capitare infatti che, inoltrandosi nella foresta, all’improvviso tutto si confonda nel labirinto della vegetazione: dovunque alberi, muraglie vegetali, fantasmi evocati dai riflessi della luce e il ricomporsi continuo di nuovi arabeschi nel regno della perenne metamorfosi. La maledizione del Curupira, a questo punto, non perdona..”.
La leggenda rappresenta evidentemente la proiezione simbolica di una lotta con l’ambiente, che si svolge in Amazzonia nel più grandioso scenario d’acque e di foreste che esista sulla terra: oltre sette milioni di chilometri quadrati che racchiudono i due terzi di tutte le foreste tropicali del globo; un fiume lungo più di seimila chilometri, che con i suoi 1.100 affluenti forma il più grande bacino idrografico del mondo e scarica nell’Atlantico il 20 per cento delle acque dolci di tutto il pianeta; decine di migliaia di specie animali e vegetali, molte ancora sconosciute, che rappresentano la testimonianza più concreta del nostro passato ancestrale. Ce n’è abbastanza per significare, con Euclides da Cunha (21), che l’Amazzonia rappresenta davvero “l’ultima pagina ancora da scrivere della Genesi”. Qui, infatti, la natura continua a sprigionare, con energia creativa continua, primordiali forme di vita che si accumulano caoticamente fino a rendere impossibile qualsiasi organizzazione e a dar vita a una realtà talmente “eccessiva”, da originare spontaneamente, nel corso del tempo, la scintilla della trasfigurazione mitica.
Così quando la pororoca, l’onda di marea alta alcuni metri, risale con il suo rombo assordante il fiume, gli indios parlano di Ipupiara e della Cobra Grande, gli spiriti del fiume che si agitano nella loro dimora acquatica; mentre geni e divinità diverse abitano l’interno della foresta, là dove, protetto dal folto della vegetazione, l’Uirapuru, un piccolo uccello della famiglia dei passeracei, il cui canto secondo una leggenda porta fortuna a chi ha il privilegio di ascoltarlo, eleva il suo melodioso canto alla felicità. “Ay ay Mama … ay ay Mama …”, è invece il canto assai prolungato, come un lamento triste, del Silbaco, tipo di uccello della foresta amazzonica le cui note disperate turbano l’ora del crepuscolo, ma ancor più straziano l’animo dell’Indio che in quelle grida ascolta un lugubre presagio di sangue, che sa di vendetta e di morte. La leggenda vuole che il Silbaco accolga l’anima vendicativa di Nihuana, una bellissima ragazza india alla quale i Karajana, questo il nome dato ai colonizzatori bianchi che un giorno uccisero il suo giovane amante: “… e l’anima di lei s’innalzò trasformandosi a poco a poco nell’allucinante forma di un uccello bizzarro, nero come una notte di uragano e di terrore”.
Alla leggenda del Silbaco (22), gli Indios collegano l’idea della vendetta ultima, definitiva, che li riscatterà da tanti soprusi subiti e dalla sottomissione forzata. La fatalistica certezza di essere un giorno vendicati ha portato alcune tribù di Indios alla passività remissiva che i Karajana hanno sfruttato per estendere il loro dominio in Amazzonia, con l’attuazione di un piano di confinamento di intere collettività nella riserva dello Xingu, il più grande Parco Nazionale del Brasile, in cui gli Indios sono costretti a vivere con mezzi assai ridotti. La storia narra della decimazione sistematica di intere tribù ritenute ostili, o ribelli, che ebbe inizio all’alba della Conquista ed è proseguita dagli imperi colonialisti, senza interruzione fino alle multinazionali che l’hanno sfruttata a proprio beneficio, fino al taglio della Transamazzonica (23), tutt’ora in piena attuazione, arbitrariamente voluta dalle leggi ufficiali.
Una stima recente, tuttavia molto approssimativa, rivela la presenza di esigui gruppi di Indios che vivono allo stato nomade all’interno della grande foresta e lungo l’Orinoco (Venezuela), che dagli avamposti di frontiera formati dalle cascate dell’Uguazù (Paraguay), e dello Yuruparì (Colombia), fino al grande cuore del Mato Grosso (Brasile) nel regno degli spiriti (24) e degli uomini giaguaro (25), la cui sopravvivenza sembra senza possibilità di appello. Con essi è però minacciata la continuità di un’intensa cultura, insieme di lingue, credenze, usanze e costumi di una tradizione orale che ha sfidato l’avanzamento tecnologico, mantenendosi per così lungo tempo all’interno di una sopravvivenza impermeabile e inattaccabile. Conoscitore del segreto potere della natura, l’Indio è partecipe dell’equilibrio cosmico nella misura in cui passato, presente e futuro si congiungono nella sfera dell’assoluto tutto, contro un avventuroso percorso tra selve, fiumi o costoni rocciosi, dove risuona il maestoso rito dei flauti di palma, la più intensa danza della memoria indigena.
La pratica rituale non è che una delle vie di accesso alla cosmogonia amazzonica, la cui conoscenza permette il divenire partecipi dei segreti che rendono palpabile il rapporto intimo che essi hanno instaurato con la natura che li circonda. Ancorché la cultura sciamanica, tramandata oralmente di padre in figlio, rappresentata a tutt’oggi tra le tribù, è la testimonianza di una naturale saggezza (la saggezza dei popoli) che supera ogni aspettativa. Infatti la conoscenza delle proprietà di certe piante tipiche della foresta pluviale e i medicamenti che se ne ricavano, restano un segreto non del tutto svelato. Così come l’uso di certi veleni come il curaro che essi impiegano per “avvelenare le frecce” con cui vanno a caccia, o l’utilizzo di alcune radici e bacche con cui preparano particolari droghe come la cocaina e l’epenà, di cui alcune non trovano riscontro nell’elencazione botanica di piante conosciute nel resto del mondo.
È qui che “l’uomo medicina”, com’è anche chiamato lo sciamano (26) della tribù, interviene col suo carico di foglie, funghi e cortecce che fa bollire sul fuoco, per debellare le febbri malariche, liberare dal morso di qualche serpente, o dalle punture degli insetti, come anche da alcune malattie di tipo virale, arrivate al seguito dei Karajana, cercatori d’oro e commercianti che da sempre vanno facendo scempio delle risorse naturali, appropriandosi d’ogni cosa. Intanto la foresta si va spopolando della fauna selvatica, degli uccelli piumati, delle farfalle variopinte, come dei tapiri, dei serpenti e anche delle rane il cui veleno è molto ricercato, che vengono trasferite altrove in piccole gabbie di bambù, con le canoe lungo il fiume. Ma a quanto pare gli Indios non possono farci niente, se non tramandare oralmente, di generazione in generazione, la saggezza appresa in migliaia di anni, di tutto ciò che essi conoscono sulle proprietà curative che la foresta pluviale fornisce loro e dei modi e gli “usi tribali” che essi ne fanno.
In tal senso, è di interessante la tecnica del “frullato” nel dialogo terapeutico tra due sciamani.
Come scrive (?) Baldus (27): “Lo sciamanesimo è una istituzione sociale, i cui rappresentanti, attraverso l’estasi ottenuta secondo metodi tribali, entrano in contatto col soprannaturale per difendere la comunità d’accordo con le rispettive ideologie religiose, sia attraverso viaggi nel mondo dell’al di là, sia attraverso la possessione da parte degli spiriti”. Ciò a conferma che esiste uno sciamanismo collettivo raggiunto da tutti, o quasi, attraverso l’uso dosato e prolungato di alcaloidi allucinogeni, come, ad esempio, l’epenà, che permette agli adulti iniziati di volare verso il sole, di chiamare gli spiriti della natura, di trasformare se stessi negli spiriti di questo o quell’animale. Ciò che non avviene per le donne o ai bambini, i quali, solo dopo che è passata l’età puberale, vengono iniziati al mondo degli spiriti e all’uso degli allucinogeni, e dopo un lunghissimo periodo di isolamento e di digiuno, durante il quale il giovane viene continuamente sottoposto all’inalazione dell’epenà.
Emaciato, stanco, intossicato, lentamente il giovane comincia ad avere contatto con il mondo degli spiriti (Hekurà) che dai monti scendono per venire nel suo corpo. Scrive Helena Valero (28), che ha avuto modo di presenziare a questo rito: “Dapprima il giovane impara a invocare Hekurà di tucano, e quello del pappagallo, poi quelli più difficili di grande armadillo, di giaguaro, ecc. … In questo difficile lavoro che dura giorni, ogni richiamo sessuale va allontanato. Col dominio sugli spiriti ausiliari, il giovane riesce attraverso gli allucinogeni a divenire egli stesso Hekurà”. Con la parola Hekurà gli Indios (Yanoàma), indicano gli spiriti della natura e gli uomini che riescono a possederli, ma solo ad alcuni vengono riconosciute più potenti capacità di sciamano.
Canto dello sciamano:
“Gli Hekurà mi trovarono: ero solo in un giorno di silenzio. La figlia di Hekurà veniva danzando verso di me, quando è arrivata vicino mi ha spinto e sono caduto. Ha aperto il mio petto, la mia gola, ha pulito tutto il mio sangue; ha strappato la mia lingua e ha messo al suo posto penne di Hekurà. Ero morto disteso, ma sentivo quello che la figlia di Hekurà cantava. Era bella, non esiste donna bella come quella. Dopo che è venuta la figlia di Hekurà, adesso s’ che canto bene. Una nuova lingua hanno messo nella mia bocca, per questo conosco e canto i canti degli Hekurà …”. (trad. H. Valero).
Impressionante è il significato religioso degli Hekurà nei momenti più drammatici, quando si avvicina la morte. “Per celebrare i morti, infatti, gli Yanoàma organizzano grandi feste (reaho) che durano giorni. In queste occasioni si riuniscono raggruppamenti che vivono anche molto lontani tra loro. I canti notturni sono canti corali responsoriali. Sono prima le donne a cantare, e poiché queste feste collettive si svolgono in genere nelle notti di plenilunio, esse cantano fin quando la luna ha percorso quasi metà del suo cammino. Dopo, fino alle prime luci dell’alba, continuano i canti degli uomini. L’ingestione delle ceneri dei defunti avverrà la mattina seguente da parte dei parenti e delle persone care, mentre gli altri assisteranno e parteciperanno al dolore. La cerimonia dell’endocannibalismo chiude la serie delle feste celebrative. È così che, ad esempio, solo gli uomini possono mangiare le ceneri di un uomo ucciso con una freccia dai nemici. Essi credono che, se le donne le mangiano, i guerrieri che andranno a vendicare il morto saranno visti da lontano dalle donne dei nemici, le quali li avviseranno e così essi non riusciranno a vendicarsi. Tutte le volte che decidono di far guerra ai nemici, per vendicare il morto, fanno feste e prendono un poco di quelle ceneri, per combattere meglio. Conservano però un po’ di ossa finché i figli saranno grandi e potranno venire anched loro a vendicare” (29).
Sarebbe troppo facile qui, aggiungere qualche nota riferita a quella superstizione o alla sete di vendetta che noi occidentali abbiamo debellato come una malattia di cui dovevamo sbarazzarci, ma che non rientra nell’esercizio mentale dell’animismo di cui si è già parlato, e che invece andrebbe affrontato sotto una luce di più ampio respiro, quale emanazione di una religiosità arcaica, per cui gli aborigeni demandano ogni singolo risvolto spirituale a un ascetismo sincretico, di più ampia rilevanza. Per cui nella loro semplicità tutto è emanazione delle forze impositive della natura, nella quale trovano risposta e che partecipano alla danza cosmica del creato. E perché no, in quella forma di autosuggestione che, in qualche modo, deve aver suggerito a Romano Battaglia (30) questo racconto celeste che trovo molto significativo, e inserito nel suo romanzo:
“Lo sai che cos’è la foresta? È un frusciare di sogni verdi legati alla voce delle stelle. Nell’attraversarla può avverarsi un desiderio recondito come l’accendersi di un frammento di altri mondi, caduto per sopravvivere. La foresta è la coscienza del mondo, ma anche la nostra coscienza buia ed intricata nella quale ci nascondiamo quando siamo stanchi e avviliti. Io ti guiderò verso la luce, ma il risultato del viaggio dipenderà da te”.
Si è già parlato dell’utilizzo della meloterapia e della etnopsichiatria nelle pagine introduttive all’Etnomusicologia, mon in specifico della medicina. È il caso di farlo qui, a proposito del rapporto inviolato che le tribù Indios dell’Amazzonia mantengono con la “medicina naturale”, o come la si vuole chiamare oggi “omeopatica”, e che tende ad assecondare la natura che li circonda. Ma di quale natura stiamo parlando? Non certo, spero, quella dei rifiuti o delle scorie, o dei derivati chimici. Per il momento diciamo che non ci riguarda. Ciò che ci interessa capire di essa è senz’altro lo “scopo rituale” che gli Indios, verosimilmente, devono aver “inventato” per giungere alla risoluzione di problemi pratici, necessari a far fronte alle emergenze non rare, di esseri colpiti da frecce e giavellotti, o fratturati per cadute varie. Così come già veniva raffigurato nelle caverne preistoriche spagnole e francesi, nello specifico gli Indios da sempre hanno combattuto contro le febbri malariche che spesso li decimavano prima dell’arrivo con gli occidentali del chinino, sintesi di piante che addirittura nascevano spontanee nella foresta. Così come l’animale ferito si lecca la parte offesa e l’uomo porta la mano sulla parte dolente, residuo di comportamenti istintivi, forse iscritti nel patrimonio genetico di molte specie animali, ancora rintracciabili nella loro e nostra vita quotidiana.
Dal gesto protettivo al concetto di cura il passa è davvero breve; più difficile invece è arrivare a identificare le sostanze medicamentose. Mirella Rostaing (31) l’ha fatto per noi, sullo sfondo dell’attuale problema riferito alla progressiva distruzione dell’Amazzonia. Nel suo bel libro “Iguazù, gli Stregoni del profondo Verde” ci parla, con grande sensibilità ecologica, di questa natura misteriosa, dai magici poteri, analizzando piante “sacre e magiche” di cui ci rivela ricette segrete e formule miracolose, con particolare riferimento alle differenziazioni climatologiche, con apporti positivi e davvero sorprendenti sui costumi tribali che accompagnano certi riti iniziatici, accompagnati da nenie, canti e litanie, da una certa musica strumentale e, in qualche caso, da particolari danze di tipo evocativo ed espiatorio. La capacità di intervenire con successo nelle cure di diverse malattie è confermato dalla riscoperta della fornita farmacopea che le popolazioni “primitive” attuali possiedono, e sulla quale il mondo scientifico sta da diversi anni intensificando le ricerche. Non è un caso che già dal 1979 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un documento in favore di un ritorno all’impiego di piante medicinali e rimedi tradizionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, auspicando una maggiore attenzione alla “ricca eredità dell’esperienza ancestrale”.
Per capire quanto potrebbe essere utile una maggiore attenzione verso la medicina primitiva basterebbe ricordare che essa nacque da conoscenze accumulate nel corso dei millenni e molto spesso le tracce di questo faticoso cammino sono ancora oggi rintracciabili sia pure sotto aspetti molto diversi. Proprio in molte parti dell’America, infatti, e in special modo in Amazzonia, troviamo testimonianze autentiche che lasciano intravedere come si comportavano e si comportano ancora gli Indios davanti a una ferita; come arrestare una emorragia mediante la cauterizzazione con minuscole piume d’aquila e polvere raschiata dalle pelli appena conciate. Come, ad esempio, nei casi di feriste più vaste, essi cucivano i lembi con fili di tendini animali e aghi d’osso; così come usavano salsapariglia e ginepro come diuretici; cascara, scialappa e podofillina come purganti; infuso di caprifoglio (potente stimolatore di vomito) come emetico; decotto di corteccia di salice (aspirina) per combattere gli stati febbrili; come anche, un tatuaggio sulla’epidermide, o una pittura vegetale aveva ed ha presso gli indigeni una funzione simbolica e magica, tautologica, capace di suggestioni curative. Non deve stupire se affermo che l’uso delle droghe, prima di divenire un fenomeno tutto moderno, è roba vecchia. L’uomo ne faceva ricorso fin dall’epoca delle caverne. È anzi probabile che la conoscenza delle sostanze stupefacenti fosse molto più estesa in epoca preistorica che oggi, si pensi all’abilità che i “primitivi” dovevano avere, per motivi di sopravvivenza, nel riconoscere le varie specie vegetali.
E qui torniamo all’operato degli sciamani, i cosiddetti “uomini medicina” di cui abbiamo già investigato. Anche lo sciamanismo è strettamente legato alla danza. Di particolare interesse invece, sono tutti i suoni sciamanici che si presentano in numerose formalizzazioni, da grida semplici e articolate, ai rantoli, ululati, succhiamenti, soffi, sibili, versi d’imitazione animale, etc.; estremamente precise, modulari e liturgiche. Grida e canti accompagnano spesso le danze guerriere, eseguite in concomitanza, presso gli Yanoàma durante i giorni del “reaho”. Si tratta per lo più di danze che celebrano la partenza o il ritorno da spedizioni di caccia o altre evenienze importanti della vita collettiva. Scrive Biocca (32) che: “I danzatori isolati o in gruppi agitano elegantemente rami di palme in forma festosa, o col corpo totalmente o parzialmente dipinto di nero, mostrano minacciosamente le loro armi percorrendo tutto il perimetro interno dello “sciapuno” (casa comune) con grida e canti di animali. Quando tutti i singoli danzatori , dopo aver compiuto giri di danza nello “sciapuno”, si riuniscono per entrare in fila, tutte le grida degli animali della foresta si fondono in un complesso straordinario, nel quale è ancora possibile riconoscere un ritmo”.
Esempio di meloterapia sciamanica per una donna malata: (reg. Biocca, trad. Valeri):
“Hekurà stanno venendo, Figlia di Hekurà con lunghe ciglia, guarda verso di noi … / Piume bianche sono intorno alla testa di tutti gli Hekurà. / Là c’è il monte dei falchi: è grande, nel mezzo è nero, in alto è bianco. / Koetotto è il grande monte … / Le stelle rosse come sangue stanno cadendo con sangue! / Che visione meravigliosa! / Fanciulle con ornamenti di foglie nelle orecchie. / Hukosike è un monte alto con palme. / È nero; le sue rocce hanno graffi come serpenti. / La corona degli Hekurà è graffiata con sangue a strisce di serpente … / Ho avuto terrore! / È passato un lampo avanti ai miei occhi. / I nostri Hekurà hanno intorno alla testa una corona di pure stelle! / Ho strappato dalla donna pelle di yaì! (spirito del male). / È questa pelle che fa ruotare il mio sguardo. / Vedo strisce di fuoco in terra come serpenti … / Ho paura … all’orecchio degli Hekurà, padre mio, c’è appesa una stella di sangue! ..”.
L’elemento che più ci coglie è indubbiamente il sangue, il rosso cosmico delle stelle, il rosso del fuoco che tinge di paura ogni aspetto dell’evento sciamanico la cui azione termina con l’affidare la donna alle cure di alcune donne affinché la portino a braccia tra canti e danze nella foresta, pensate, per ritrovare “l’ombra”, cioè la sua “anima” smarrita. Ma già i suoni si fanno più forti e più aspri, in questo brano che vi propongo.
Esempio di meloterapia sciamanica per una capo Wawanaweteri reduce da una spedizione contro gli Hereweteri, (reg. Biocca, trad. Valeri):
“Soffia negli occhi degli Hekurà (nemici) / Molti ne stanno arrivando col vento. / Cerchi di fuoco di Hekurà girano tutto intorno! / Ora ho colpito un Hekurà nell’occhio! / Gli Hekurà lanciano fiamme verso di lui (il malato) / L’ho colpito e ha gridato – Io sono Yawari / Sono Yawari, Hekurà di Yawari … / Il fuoco degli Hekurà si avvicina! / Sciamariwe, vieni, diminuisci il suo dolore; / tapiro vieni con la tua bocca aperta / per togliere il dolore dal collo … / Un osso di Yaì sta nel suo collo. / Sciamariwe, trattieni la sua ombra, / perché (il malato) non muoia … / Tam, tam, tam , dei, dei, dei / Hekurà di tapiro strappa col tuo dente il dolore. / È sangue di Titiri (la notte scura) che scorre nel suo collo. / Titiri grida; ma non è morto e non vuole uscire dal collo! / Occhio di Yaì, rosso come puro fuoco, guarda verso di noi! / Figlio mio, che non salti su te … / Titiri è uscito dal collo; / Mi sta vicino, apre e chiude le unghie / tutto circondato da fuoco”.
È ancora il rosso del sangue, il rossore del fuoco, il sangue che fluisce scuro dalla ferita, il buio della notte come la morte che scorre in questo canto accompagnato da grida luttuose e una mimica drammatica, da corse e salti in direzione dei monti e del cielo. gli sciamani che prendono parte al rito succhiano con le loro bocche la ferita nel collo del malato, finché incomincia a sgorgare nuovo sangue “rosso”. La scena narrata è di una violenza e di una drammaticità impressionanti, la danza che l’accompagna furiosa.
Presso i Camayurà – ad esempio – l’uso cerimoniale “urua” prevede il lento avanzare, a piccoli passi cadenzati, dei suonatori-danzatori su un tracciato circolare e antiorario che si snoda attraverso le capanne del villaggio. Ricavato da sezioni di canna di bambù tenute insieme da legamenti di liane, il flauto urua è uno strumento dal suono originalissimo, simile al basso, e presente presso molte tribù amazzoniche, seppure di fattezze e dimensioni diverse. In alcuni casi esso è presente nella versione doppia e può raggiungere i dieci metri di lunghezza, per cui a suonarlo sono chiamati gli uomini più vigorosi della tribù, per scacciare, essi dicono, il mama’e, lo spirito ancestrale riposto in ogni essere e in ogni cosa della natura, nella chiusa stagione “dell’aurora” che va da agosto a settembre.
Presso un’altra tribù amazzonica, gli Yawalpiti, troviamo lo yakui, un flauto ritenuto tabù (33) per le donne. Si tratta di una flauto di canna di bambù dalle dimensioni ridotte, rispetto al precedente, tuttavia sempre esagerate rispetto a un flauto normale a becco. Questo è fornito di quattro fori e d è suonato, non senza fatica, da danzatori musicisti che s’immedesimano nel mama’e dello strumento, il cui suono serve ad evocare Yakhi il più temuto “spirito dell’acqua”. Una leggenda raccolta presso gli Indios dello Xingu, detta “del agua y del fuego” (34), è narrato:
“All’origine dei tempi, il mondo fu distrutto dal fuoco, un cataclisma spaventoso, tutta la foresta era infuocata… iri… iri… iri... Tutto bruciò e nel mondo rimase solo cenere. Cercando disperatamente di salvarsi, alcuni runas (gli uomini) si trasformarono in cervi, in armadilli, in lombrichi, in vacche della selva. L’armadillo-runa si nascose sotto terra, mail suo guscio fu lambito dal fuoco; ed è per questo che oggi il dorso degli armadilli è nero e durissimo… iri… iri… iri... Chundaruku, il cervo-runa, vedendo avanzare la linea del fuoco che distruggeva tutto, si arrampicò svelto su una palma impregnata d’acqua più delle altre e che per questo non sarebbe bruciata facilmente. Pertanto la tagliò e la usò come barriera contro il fuoco, riuscendo così, a lasciarsi il fuoco alle spalle, ma le sue zampe non furono risparmiate e sono tutt’ora nere… iri… iri… iri... Altri runas si trasformarono in lombrichi, molti di essi riuscirono a salvarsi, ma la maggior parte di loro perì. Solo dopo questo grande cataclisma Yaya creò altri uomini e fece loro dono del fuoco. Dal niente lo trasse, e il prezioso dono scaturì dal suo pensiero e dalla sua forza nella pietra focaia… iri… iri… iri...”.
La leggenda qui di seguito riportata, dai contenuti fantastici, ci presenta l’Indio come il detentore del messaggio ancestrale della natura, di cui gran parte è andato perduto o forse solo dimenticato nel corso dei millenni, la cui scomparsa, almeno di quel poco che ne rimane, è costantemente minacciata:
“Quando si tralascia la conoscenza di ciò ch’è stato, quello che rimane è solo un grande vuoto e un senso d’infinita tristezza” – recita un canto di anonimo tribale, che Horacio ci riporta, lasciandoci intendere che è raccolto nella saggezza dei semplici il senso di questa come di altre fiabe che ci aiutano a penetrare la mentalità genuina quasi primordiale degli Indios, così lontana dalla nostra. E che forse, proprio per questo, più vicina a quelle verità fondamentali che solo uno studio approfondito (e comparato) può restituire alla conoscenza, che ci permette di capire dove l’uomo moderno, ha sbagliato in passato e continua a sbagliare oggi, nell’ignorare un tale patrimonio ambientale e culturale, senza aver compreso che ne vale la sua stessa sopravvivenza (35).
In un'altra ancora è detto, che:
“Molto tempo dopo Yaya pensò di fare un fiume e lo progettò in maniera che da una parte l’acqua fluisse verso il basso e dall’altra verso l’alto. Nel mezzo vi sarebbe stato un vortice. Così, senza alcuno sforzo, i runas avrebbero potuto viaggiare verso l’alto o verso il basso, a seconda del lato che sceglievano. Però il piano non riuscì come essi volevano: sopra, infatti, vi era la sorgente del fiume e da lì tutte le acque fluivano verso il basso” (36).
Il racconto di questa breve “fola” spiega, molto semplicemente, difficoltoso in altro modo che non sia un linguaggio infantile, la combinazione della “creazione” di due fiumi che, scaturiti da una stessa sorgente, si dirigono su due versanti diversi, e con la quale si vuole qui significare la possibilità di scegliere la via più consona al proprio destino. Un modo poetico di interpretare quelle che sono le “vie” possibili e infinite del cielo, cui le “grandi via d’acqua” per corrispondenza con la mentalità indigena, da sempre segnano una “via” da seguire, un inizio ma non la fine. Infatti, quando uno dei danzatori fa la sua apparizione nel villaggio, anzi, ancor prima che egli faccia il suo ingresso, le donne avvertite dal suono grave dello strumento, corrono a nascondersi, poiché Uakti (wah-ke-chee), una creatura enorme con tanti buchi sparsi sul corpo che ogni qualvolta attraversa la foresta, il vento che vi passa attraverso emette suoni meravigliosi e intriganti, è ritenuto così terribile che se una donna lo guarda, anche involontariamente, i danzatori posseduti dal suo spirito lo le infliggerebbero torture fino a lasciarla morire. Tale è il supporto animista che lo conforma, che il culto di Uakti è pressoché totemico (37) presso gli indios Yawalpiti, i quali ritengono che il suono dello yakui vada ben oltre il significato di fare musica, bensì, riguarda più da vicino, l’intimo segreto dello spirito evocato: cioè, l’acqua, con i suoi nessi che comporta nell’intimo femminile.
Altri strumenti musicali tuttavia, vengono usati per questo scopo, ma anche per segnare ritmicamente un momento del canto collettivo o nelle pratiche sciamaniche. Lo sciamano fa uso del chocalho, un guscio di frutta secco contenente pietruzze e semi che agitati producono il suono caratteristico delle maracas. Esempi di queste forme musicali formano il contenuto di un album sonoro di grande interesse etnologico: “Bresil- Musique du haut Xingu” (38). Per quanto riguarda le tecniche vocali, i dialoghi cerimoniali, come anche per i canti responsoriali e la meloterapia sciamanica rimando al noto lavoro di Ettore Biocca (39) “Viaggi tra gli Indi: Alto Rio Negro – Alto Orinoco”, (un’opera monumentale di 3 volumi e 15 dischi 17cm. edito dal CNR 1966, che può considerarsi un classico di consultazione per il ricercatore della quale Diego Carpitella ha pubblicato una scelta musicale nelle collana I Suoni, dedicata agli Indios: “Yanohama” (40), che da il titolo all’album.
Gli Yanohama sono un grande gruppo indigeno ritenuto tra i più bellicosi, che vive nel vasto territorio che oggi divide l’attuale Venezuela e il Brasile, situato nel cuore della foresta equatoriale. Scrive Diego Carpitella: “Tra gli Yanohama è considerata musica solo quella vocale, mentre gli strumenti sono considerati semplici giocattoli. Dal punto di vista musicale, ci troviamo dinanzi a materiali “elementari”, pure ritenuti essenziali nello studio delle interazioni succedutesi. In quanto allo Sciamano, va detto, che si manifesta in senso sociale, avendo lo scopo di formalizzare l’esorcismo magico, psichico e fisioterapico, soprattutto sotto l’effetto dell’epenà, la droga allucinogena utilizzata nelle forme di enfasi collettiva, come feste particolari, riti a carattere magico”.
In “Musica degli indiani del Brasile” (41), Harold Schultz e Vilma Chiara hanno raccolto testi originali relativi alle tribù Karaja, Javahè, Kraho, Tukuna, Juruna, Suyà, Trumai, Shukarramae, tutte ancora esistenti in Amazzonia, delle quali alcune in via di estinzione a causa dell’impossibilità di trovare sufficientemente selvaggina e per le malattie cui gli Indios sono soggetti. I canti raccolti in questo album di raro reperimento, sono di carattere iniziatico, e vengono eseguiti prima delle battute di caccia o della raccolta della manioca, e in occasione di guerre o festività religiose. Vengono eseguiti canti solistici, ninne nanne e lamentazioni funebri. Nelle forme di coro misto (donne e uomini), a-responsorio, in cui il canto è trasformato in elemento dialogante tra vari gruppi tribali, mentre, gli strumenti musicali interloquiscono direttamente con gli spiriti.
Sono questi poco più che esempi, esemplificazioni per il ricercatore meno preparato, di una più vasta cultura orale di cui si è preso in considerazione l’aspetto eclatante della musica, per il ruolo accattivante, che questa è chiamata a sostenere, in ambito specificamente antropologico dell’Amazzonia. Dacché la leggenda del Silbaco, come un guizzo violento nell’affresco “selvaggio e armonioso” dell’insieme della natura, non è che una delle numerose credenze che si incontrano in Amazzonia. Quella stessa che i Karajana hanno solo sfiorato (forse) senza capirla, e che la civiltà tecnologica non è riuscita a dominare. A chi si domandasse quale sorta spetta all’Indio?, questa “mite creatura della natura”, avrà certamente in risposta un altro interrogativo, spaventoso e allo stesso tempo ossessivo, come un accordo di flauto ripetuto all’infinito, che risponde al canto dolente e assai prolungato del Silbaco: “Ay ay Mama … ay ay Mama …”, la cui indignazione non è puramente formale.
Discografia e altro:
In Italia:
Ettore Biocca: “Viaggi tra gli Indi: Alto Rio Negro – Alto Orinoco” – CNR – Roma 1966
Diego Carpitella: “Yanoama: tecniche vocali e sciamanismo” (I Suoni – Su 2003) – Collana I Suoni – Cetra.
Harold Schultz e Vilma Chiara “Musica degli indiani del Brasile”, – Albatros – VPA 8452.
Ethnic Folkways in Anthology of Brasilian Indian Music:
“Music of Peru: tribes Aymara, Quechua, Mestizos”– (FE4311)
“Music from Mato Grosso: tribes Camayura,Chavante, Iwalapeti, Kayabi” (FE4446)
“Indian Music of Upper Amazon: tribes Cocòma, Campa, Shipido, Conibo” (P458)
Musée de l’Homme:
“Upper Orinoco: tribes Guarahibo, Maquiritare, Piaroa, and Puinave” (E1-5)
“Upper Amazone: tribes Iawa, Bora ” (L.D. 3)
“Yayuro tribes (Southern Venezuela)” (L.D. 1)
“Musique des Indiens du Rio Xingu et des Kaingang de Santa Catarina” (L.D. 15)
“Brésil: Musiques du Haut Xingu” (Ocora 558517)
“Brésil: tribes Gorotire, Kubenkranhen, Kwikuru, Yaulapiti, Kamayura, Kayapo, Kaingang”
(Chant du Monde MC 20.13)
“Brasile: Mùsica Indìgena” (Centro de Trabalho Indigenista 1992)
“Venezuela: tribes Puinabe, Maquiritare, Guaharibo, Kalina, Yayuro, Piaroa” (American
Columbia SL.212)
Note:
(1) Enciclopedia Einaudi Vol.4 – Edmund Leach: “Cultura/Culture” – Torino 1978. E in L. Gallino, “Dizionario di Sociologia” – UTET – Torino 2006; e in Umberto Galimberti, “Psicologia” – Garzanti Milano 1999. AA.VV. “Il concetto di cultura” a cura di P. Rossi – Einaudi Torino 1970.
(2) S. Freud, per il quale “la parola “civiltà” designa la somma delle realizzazioni e degli ordinamenti che differenziano la nostra vita da quella dei nostri progenitori animali e che servono a due scopi: a proteggere l’umanità dalla natura e a regolare le relazioni deghli uomini tra loro”.
(3) C. G. Jung, diversamente invece “le espressioni culturali sono manifestazioni dell’originaria capacità simbolica dell’uomo che trascende l’impianto pulsionale (di Freud), quanto al suo senso e al suo significato”.
(4) Patrick Mengent, “Brésil, Musique du Haut Xingu” - Université de Paris X – Nanterre – Musée dell’Homme.
(5) Ettore Biocca: “Viaggi tra gli Indi: Alto Rio Negro – Alto Orinoco” – CNR – Roma 1966; e in
J. Grelier, “Gli Indiani dell’Orinoco” – Rusconi – Milano 1977.
(6) C. Lévi-Strauss, “Antropologia strutturale” e in “Il pensiero selvaggio” – Il Saggiatore, Milano 1976. In cui, attraverso un sorprendente itinerario etnologico che analizza miti, riti, credenze e altri fatti di cultura, l’autore accantona radicalmente ogni idea di “esotismo” e ritrova la genesi dei nostri attuali schemi logici in una specie di “ricerca del pensiero perduto”.
(7) Darcy Ribeiro, “In difesa delle civiltà Indios” – Jaca Book – Milano 1973; in cui è messo a fuoco il destino delle popolazioni indigene brasiliane colpite nella loro storia e nella loro stessa esistenza, dallo choc dell’urto con quella che l’occidente chiama civiltà.
(8) Curt Sacks “La musica del mondo antico” – Sansoni Ed. Firenze 1981.
(9) Augusto Romano “Musica e psiche” – Bollati Boringhieri – Torino 1999.
(10) animismo: Il termine è usato in antropologia per classificare le tipologie di religioni o pratiche di culto nelle quali vengono attribuite qualità divine o soprannaturali a cose, luoghi o esseri materiali. Queste religioni cioè non identificano le divinità come esseri puramente trascendenti, bensì attribuiscono proprietà spirituali a determinate realtà materiali. Questo tipo di credenze è così chiamato perché si basa sull'idea di un certo grado di identificazione tra principio spirituale divino (anima) e aspetti “materiali” di esseri e realtà (anche "demoni" e altri enti). La posizione filosofica corrispondente all'animismo viene di solito chiamata panpsichismo.
(11) G. Mancinelli “Musica Zingara: testimonianze etniche della cultura europea” – MEF – Firenze Atheneum 2006.
(12) G. Mancinelli “Miti di sabbia: racconti perduti del Sahara” - ilmiolibro.it 2010 – Terra Incognita – Rivista on-line 2011.
(13) Victoria Ebin, “Body decorated” – Thames and Hudson Ed. – London 1979. Il principale mezzo espressivo usato per questo genere artistico è il corpo umano. Il corpo è usato per allestire eventi estemporanei con movimenti corporei accompagnati da musica, elementi scenografici, danze, sequenze di azioni e gesti. La body art rende il corpo protagonista assoluto considerandolo soggetto e oggetto dell'espressione artistica ed esibendolo come opera. Vi è la volontà di provocare, di scuotere le convinzioni in fatto di arte. All'uso del corpo come linguaggio, ricorrono sempre più artisti contemporanei di differenti tecniche e tematiche.
(14) Lea Vergine, “Dall' informale alla body Art”: In questo libro l’autrice parla di alcuni caratteri che fanno da comune denominatore a questa maniera di fare arte: "la perdita di identità; il rifiuto del prevalere del senso della realtà sulla sfera emozionale; la romantica ribellione alla dipendenza da qualcuno o da qualcosa; la tenerezza come meta mancata e quindi frustrante; l'assenza (e l'angoscia che ne deriva) di una forma adulta, altruistica, d' amore". In queste azioni spesso gli autori sono ossessionati dalla necessità di agire in funzione dell' altro. Vi è la necessità di mostrarsi per poter essere. Il performer non sceneggia la storia di un personaggio, ma è egli stesso storia e personaggio. Si volge così verso la ricerca di un'umanità non schiacciata dal funzionalismo della società, che sfugge al concetto di profitto. "l' importante non è sapere, ma sapere che si sa. È uno stato in cui la cultura non serve più a niente". E continua: "Sbloccate le forze produttive dell' inconscio, si scatenano - in un continuo drammatizzare isterico - conflitti tra desiderio e difesa, tra licenza e divieto, tra contenuto latente e contenuto manifesto, tra pulsioni di vita e pulsioni di morte, tra voyeurismo ed esibizionismo, tra tendenze sadiche e piacere masochistico, tra fantasie distruttive e catartiche". Nelle azioni della Body Art la riproduzione meccanica (video, fotografia, film) assolve ad una duplice funzione: documentativa e di indagine penetrante.
(15) G. Mancinelli “Maschere Rituali”, trasmissione radiofonica messa in onda da Radio Rai3.
(16) C.G. Jung “Gli archetipi e l’inconscio collettivo” – Bollati Boringhieri 1997.
(17) Il simbolismo è un movimento artistico sviluppatosi in Francia nel XIX secolo che si manifestò nella letteratura, nelle arti figurative e di riflesso nella musica come fenomeno di un'arte sempre più sottratta al condizionamento della realtà: le suggestioni esercitate dai componimenti di Richard Wagner ne sono la dimostrazione. La sua nuova musica è contraddistinta da una morbida e dissimulata sensualità che sembra cogliere le remote radici dell'essere. Al posto degli elementi del melodramma classico viene adoperato il canto declamato (che in una certa misura ricorda l'antico recitativo secco), svincolato dalle forme fisse della tradizione.
(18) George Hausmann, in Curt Sacks “La musica del mondo antico” op. cit.
(19) A. Metreaux “Religioni e riti magici indiani nell’America Meridionale” – Il Saggiatore – Milano 1971.
(20) Silvano Peloso, “Amazzonia: mito e letteratura del mondo perduto” – Editori Riuniti . Roma 1988.
(21) Euclides da Cunha, in S. Peloso op. cit.
(22) J. Meunier – A. M. Savarin “Il canto del Silbaco” – Bolla Edit. – Torino 1970.
(23) Transamazzonica. Per secoli la foresta amazzonica ha respinto qualsiasi contatto con il resto del mondo. Le particolari condizioni ambientali, le comunicazioni difficili, possibili solo per via fluviale, hanno permesso alle tribù di Indios di vivere nella foresta senza alcun contatto con la storia; l'Amazzonia è rimasta una delle regioni piè incontaminate e disabitate della Terra. A partire dagli anni Cinquanta però, quando il Brasile ha avviato il processo di sviluppo e di industrializzazione, è iniziato lo sfruttamento dell'Amazzonia. La regione è infatti ricca di materie prime ed è anche una gigantesca riserva forestale; da alcune ricerche e sondaggi inoltre è apparsa la possibilità che esistano giacimenti petroliferi. Sono stati investiti capitali brasiliani e stranieri, statunitensi, europei, giapponesi, in una serie di iniziative non sempre pianificate.
È apparso allora necessario aprire delle vie di comunicazione nella foresta e costruire una rete stradale là dove si era sempre proceduto a colpi di machete. La costruzione di una strada Transamazzonica, lunga 4500 chilometri, che dal Brasile raggiunge il territorio peruviano e boliviano, ha però incontrato notevoli difficoltà ambientali e climatiche. Agli ostacoli si è reagito con distruzioni violente e indiscriminate della foresta con mezzi meccanici che non hanno rispettato né l'ambiente né l'uomo: migliaia di ettari sono stati disboscati e le popolazioni amazzoniche sono state direttamente e indirettamente le vittime dell'aggressione all'habitat naturale. Alla fine degli anni Sessanta è stato scoperto il più ricco giacimento di ferro del mondo (una riserva per centinaia di anni valutata in 18 miliardi di tonnellate di minerale) e inoltre ricchi giacimenti di bauxite, nichel, magnesite, stagno e oro. Per sfruttare queste risorse è stata costruita la Grande Perimetrale Norte, grande strada perimetrale del nord: si tratta di quindicimila chilometri di strade che percorrono il margine settentrionale del bacino amazzonico. La presenza dell'oro ha attirato a ondate successive migliaia di "garimpeiros" che hanno invaso la foresta e i fiumi dell'Amazzonia. Sono contadini poveri ed ex braccianti, provenienti in gran parte del Nordest brasiliano, che cercano di fuggire la miseria e la siccità della loro terra e invadono le terre degli indios seminando spesso morte e distruzione. Per precipitare l'oro utilizzano il mercurio, che poi scaricano nei fiumi contaminando in modo irreparabile i pesci e tutte le forme di vita acquatiche. Il governo brasiliano ha favorito la lottizzazione delle terre che fiancheggiano la Transamazzonica e le altre strade, nonché la creazione di grandi aziende agricole che praticano, dopo aver distrutto la foresta, l'allevamento brado del bestiame. Si tratta sovente di proprietà vaste quanto la Valle d'Aosta o la Liguria appartenenti a multinazionali straniere come la Volkswagen, la Nestlè, la Goodyear e l'italiana ENI. Il terreno così drammaticamente privato della copertura forestale si impoverisce nel giro di pochi anni poiché la capacità di autoregolazione della foresta cessa e si ha la trasformazione in savana erbacea. Ci si ritrova allora con un suolo sterile e soprattutto incapace di assorbire le acque, soggetto a forti fenomeni di erosione. Si pensi che mentre le piogge normalmente dilavano 1kg di terreno per ogni ettaro di foresta, delle zone diboscate ne dilavano più di 30kg. Considerando che la foresta amazzonica produce il 50% dell'ossigeno atmosferico si comprende come le conseguenze saranno pesanti per tutta l'umanità se questo polmone verde verrà distrutto.
(24) C. Levi-Strauss, “Tristi Tropici” – Il Saggiatore Milano 1982, dal Mato Grosso all’Amazzonia, è questo soprattutto un libro di viaggio, il racconto delle sue esplorazioni presso le società indigene del Brasile, tra le più “primitive” della terra. Come è noto, per l’autore, i “selvaggi” sono assai più vicino a noi di quanto si voglia credere, e il nostro pensiero, preso in certe sue manifestazioni, è sempre “selvaggio”.
(25) Joe Kane, “Lo spirito del giaguaro” – Sperling & Kupfler Milano 1998, in cui è descritta la lotta di una tribù dell’Amazzonia per la sopravvivenza, con una visione del mondo saggia e illuminante.
(26) sciamano: “uomo di medicina e di religione”, figura rinvenibile originariamente presso le culture dei cacciatori-raccoglitori scarsamente strutturate, tecnologicamente poco evolute e omogenee. Il nome è un calco dalla lingua tunguso della Siberia, una delle zone in cui è stata identificata la forma classica di sciamanesimo. Lo sciamanesimo è diffuso non soltanto presso le culture orali dell'Asia centrale, dell'America settentrionale e dell'Oceania, ma anche, pur esprimendo riserve, presso culture e religioni più strutturate, come la religione cinese e lo scintoismo giapponese. Lo sciamano, generalmente di sesso maschile, è essenzialmente un medium, un portavoce degli spiriti nel cui mondo entra al momento dell'iniziazione, durante il quale egli affronta numerose prove che dovrebbero indurre sogni e visioni. Questo primo, duplice riconoscimento – degli spiriti e della comunità – si completa con la formazione da parte di sciamani esperti. I principali compiti religiosi dello sciamano sono la guarigione e la divinazione, ottenute mediante la possessione spiritica o il trasferimento dell'anima dello sciamano fino al cielo o agli inferi. Esistono resoconti di resurrezioni miracolose operate da sciamani che, recandosi fino alla terra dei morti, ne riportano lo spirito del defunto. Inoltre, lo sciamano officia i riti di passaggio: propizia la stagione della caccia e svolge funzione di psicopompo guidando nell'aldilà le anime dei morti. Gli sciamani occupano una posizione sociale ed economica elevata, specialmente se diventano famosi come guaritori. Numerosi sono i tentativi di spiegare il fenomeno degli sciamani e delle loro cure. Alcuni studiosi hanno istituito un parallelismo tra la guarigione sciamanica e la terapia psicoanalitica osservando che in entrambi i casi si producono simboli efficaci e terapeutici, che recano sollievo psicologico e fisiologico. Parecchi antropologi, rifiutando la teoria secondo cui gli sciamani sarebbero essenzialmente nevrotici e psicotici, hanno avanzato l'ipotesi che gli sciamani siano dotati di capacità cognitive superiori al resto della comunità. “Lo sciamanesimo è stato da altri interpretato semplicemente come anticipazione di un sistema religioso più organizzato o come tecnica per il raggiungimento dell'estasi. Lo sciamanesimo è la forma di spiritualità più antica del mondo. Non ha né leggi né templi: poggia le sue fondamenta solo sull'incontro diretto con gli Spiriti, con il Viaggio dentro la Realtà Altra, una sapienza atavica in cui medicina, magia e mistica sono inestricabilmente intrecciate. Per gli sciamani malattia e sofferenza sono solo sentieri nella foresta, dove ci accade di smarrirci ma da cui è anche possibile tornare indietro - e il compito degli sciamani è quello dei cercatori di anime smarrite.I loro metodi sono così primordiali e assoluti da essere del tutto simili in ogni parte del mondo, in popolazioni mai venute in contatto tra loro, come gli indios del rio delle Amazzoni e gli aborigeni australiani (info@sciamanesimo.com).
(*) Danilo Manera, “Yuruparì: i flauti dell’anaconda celeste” – Feltrinelli – Milano 1999. Un avventuroso percorso tra gli sciamani-giaguari e il loro affascinante universo dell’anaconda ancestrale da cui discendono i popoli “tucani”. Contiene, in appendice, la “Leggenda di Yuruparì” raccolta da Ermanno Stradelli all’inizio del 1900.
(27) (?) Baldus, in “Yanohama: tecniche vocali e sciamanismo” – I Suoni (vedi discografia).
(28) Helena Valero, ibidem, rapita dagli Yanoàma nell’Alto Orinoco da bambina e vissuta con loro per oltre 20 anni, ha tradotto questo canto (e altri), che ha poi affidato a Padre Cocco.
(29) Ettore Biocca, op. cit.
(30) Romano Battaglia, “Il dio della foresta” – Rizzoli Milano 1998. Vale qui la pena di citare un brevissimo “romanzo di viaggio”, nel quale l’autore afferma un concetto interessante per la sua propulsione spirituale.
(31) Mirella Rostaing, “Iguazù: gli stregoni del profondo verde”, - Mondadori Arcana – Milano 1989.
(32) Ettore Biocca, op. cit.
(33) tabù: in una società umana un tabù è una forte proibizione (o interdizione), relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata "sacra e proibita". Infrangere un tabù è solitamente considerata cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. Il termine è derivato dalla lingua di Tonga ed è presente in numerose culture polinesiane. In queste culture un tabù (o tapu, kapu) ha anche significati religiosi. Il termine tabù (tapu) appartiene allo stesso ambiente culturale che ci ha fornito il termine mana. Quando una certa azione o abitudine è classificata come tabù, essa viene proibita, vengono istituite proibizioni e interdizioni riguardanti la sfera di attività che la riguardano. Alcune di esse sono sanzionate dalla legge con pene severe, altre provocano imbarazzo, vergogna e sono oggetto di insulti. Non esistono tabù universali, cioè presenti in tutte le società, ma alcuni (come il tabù dell'incesto) si ritrovano nella maggior parte di esse. I tabù possono avere varie funzioni e spesso accade che essi rimangano in effetto anche quando i motivi originali che li avevano ispirati non sussistono più. Per questo motivo alcuni sostengono che i tabù aiutano a scoprire la storia di una società quando non ci sono altri documenti a testimoniarla. I tabù a volte sono talmente forti da coprire anche le stesse discussioni che li riguardano, col risultato che, a volte, in queste discussioni, invece di nominarli esplicitamente, si ricorre a termini edulcorati (eufemismi) oppure alla semplice sostituzione del termine con altro più o meno equivalente. Marvin Harris, esponente di spicco del materialismo culturale, si è sforzato di spiegare la genesi dei tabù come diretta conseguenza delle condizioni ambientali ed economiche delle società nel cui ambito essi si sviluppano. Anche Sigmund Freud ha dato un contributo all'analisi dell'influenza dei tabù sul comportamento umano, mettendo l'accento sulla forte componente motivazionale inconscia che porta a considerare necessaria una certa proibizione. In questa sua visione, descritta nella collezione di saggi Totem e Tabù, Freud ipotizza un nesso fra i comportamenti "proibiti" e la "santificazione" di oggetti e simboli appartenenti a determinati gruppi di soggetti fra di loro affini.
(34) Patrick Mengent, op. cit.
(35) “Miti e leggende degli Indios dell’Amazzonia” – Arcana Editrice – Milano 1987.
(36) Ibidem.
(37) totem: In antropologia, un totem è un'entità naturale o soprannaturale, che ha un significato simbolico particolare per una singola persona o clan o tribù, e al quale ci si sente legati per tutta la vita. In alcune correnti pagane, si usa "evocare" all'occorrenza dentro di sé il Totem di un animale (per es.: in una situazione pericolosa si evoca l'animale Totem del Lupo) al fine di incorporare le caratteristiche più istintuali e utili alla situazione che sono proprie di quell'animale. In alcuni culti sciamanici, il totemismo si avvicina al concetto di "possessione volontaria" poiché i praticanti di queste discipline antiche e primitive entrano in un contatto così profondo con lo "spirito" dell'animale Totem da esserne "soggiogate", prendendone persino alcuni atteggiamenti ed abitudini oltre che, come si suppone, le loro abilità.
(38) Patrick Mengent, op. cit. (vedi discografia)
(39) Ettore Biocca, op. cit.(vedi discografia)
(40) Diego Carpitella, Nota musicologica in “Yanohama” - I Suoni, (vedi discografia).
(41) Harold Schultz e Vilma Chiara, “Musica degli indiani del Brasile”, Museo di Stato di San Paolo, Brasile. _ Albatros VPA 8452  - Musica
- Musica
Etnomusicologia 2 - Il paesaggio sonoro
“Il PAESAGGIO SONORO” di Giorgio Mancinelli (*).
Del “World Soundscape Project” – (Progetto Mondiale per l’Ambiente Sonoro), ideato e condotto negli anni Settanta alla Simon Fraser University di Vancouver (Canada), da Raymond Murray Schafer (1), per promuovere una nuova ecologia del suono che fosse sensibile ai crescenti problemi dell'inquinamento acustico, non si sente parlare molto, e i suoi libri più tradotti “The Soundscape” (1977), e “The Tuning of the World” - in italiano “Il paesaggio sonoro” (1980), sono pressoché irreperibili. Tuttavia l’importanza di detto Progetto, si riferisce innanzitutto al riconoscimento dell’ambiente acustico naturale consistente nei suoni delle forze della natura e degli animali, include gli esseri umani:
Possiamo quindi parlare di vero e proprio paesaggio sonoro, riferito all’habitat musicale che distingue le diverse entità etniche che abitano la terra, quel vasto territorio emerso che ci circonda, così come è stato definito, seppure con proprietà fondamentalmente diverse dal paesaggio geografico vero e proprio, evidentemente soggetto a modificazioni, e che si avvale della presenza umana come mezzo “comparativo” per ristabilire l’equilibrio “ecologico” in gran parte andato perduto nel tempo. Acciò voglio introdurre qui un aspetto inusitato e forse azzardato, che si rifà specificamente all’idea dell’“imprinting” (2), che straordinariamente mi sento di applicare alla morfologia del territorio, per quel tanto che le antiche tradizioni (miti, leggende, religioni) attribuiscono a luoghi della terra con una forte connotazione sonora e in qualche modo musicale. “Si tratta di una disciplina – scrive ancora Schafer (3) – che ci permette (..) di sollecitare altri studi e ricerche in molte regioni del mondo (..) per cui, dopo aver raccolto un’ampia e rigorosa documentazione sui paesaggi sonori di un determinato ambiente e stabilito confronti tra il passato e il presente, potremo fare raccomandazioni intelligenti – è questo il punto che più ci interessa – per un migliore avvenire”.
Il metodo utilizzato è apparentemente semplice: “Poiché non possiamo piazzare nessun apparecchio per registrare i rumori (suoni) del passato, non ci rimane che registrare e analizzare i paesaggi sonori attuali e far parlare le persone che vi vivono per stabilire sui loro ricordi qualche confronto. La storia però può anche ricostruirsi con la geografia, andando a studiare, per esempio, le solitudini di un qualche paesaggio, ambiente naturale o regione isolata che forse ancora esiste. Indubbiamente i paesaggi sonori di una regione ancora allo stato di natura, sono meno rumorosi di quelli delle città moderne ma, ciò, non deriva dal fatto che vi sia un silenzio assoluto; sembra piuttosto che i suoni siano soggetti a cicli di pause, come se coloro che li producono conoscano il momento preciso in cui conviene interromperli. Si scopre così che le diverse specie di insetti, di quadrupedi o di uccelli hanno dei ritmi sonori quotidiani o stagionali complementari” (4).
Gli esempi sono forniti dallo stesso Schafer e per lo più riferiti alle sue osservazioni nella Colombia Britannica (Canada) luogo della sua provenienza: “Durante il mese di giugno, le rane cessano di gracidare all’alba, nel momento preciso in cui comincia il canto degli uccelli; e si fanno sentire di nuovo quando l’ultimo canto svanisce nel crepuscolo. Nell’Ontario, le oche si sentono soltanto qualche giorno dell’anno, in maggio, quando filano verso il nord, ed in ottobre quando tornano al sud. Ciascuna emissione sonora pare attenda il suo momento per farsi meglio ascoltare, la pausa di altri suoni in cui inserirsi, come in una conversazione ben diretta o in un’orchestrazione musicale ben riuscita”. Questi esempi per dire che mentre in un centro abitato si cerca di raggiungere una specie di indifferenza acustica per essere disturbati il meno possibile dai rumori, in campagna si tende l’orecchio per percepire minimi rumori, come il latrato di un cane della fattoria vicina che forse vuole significare qualcosa, magari un visitatore indesiderato, o lo scricchiolio di un ramoscello che può essere l’avvertimento di un pericolo.
Fatto curioso, la medesima dipendenza nei riguardi dell’udito si riscontra nelle foreste e nelle immense distese senza alberi, come per esempio nei deserti, dove poggiando l’orecchio al suolo si percepiscono le vibrazioni prodotte dal passo di un animale lontano, lo sgretolarsi delle rocce, lo spostarsi dei granelli di sabbia, lo scorrere delle acque sotterranee. Ciò che ha permesso al ricercatore di compilare un grande catalogo sulla morfologia dei paesaggi sonori e di scoprire se le relative reazioni degli esseri umani sono cambiate in funzione dei rumori emessi: “Sono state fatte classificazioni per epoche, per siti e per “oggetti” sonori descritti; vi si è associato un programma computerizzato che permette confronti statistici sulla comparsa e scomparsa dei diversi suoni (..) che, dopo accurate analisi, hanno lasciato dedurre una reazione diversa degli esseri umani al rumore o alla sua assenza, cioè al silenzio” (5). Diverso è l’aspetto che viene attribuito al silenzio dalle differenti generazioni, un tempo decisamente positivo, ora strepitosamente negativo. Contrariamente a quanto si pensa gli intervistati appartenenti all’ultima generazione, lo definiscono: “solenne, opprimente, di morte, torpido, strano, angosciante, deprimente, eterno, doloroso, solitario, pesante, disperante, assoluto, allarmante”, mentre solo poche volte gi attribuiscono una connotazione positiva: “In realtà, pare che non sentano il valore della meditazione compiuta durante una silenziosa passeggiata in campagna e, nemmeno quel silenzio assorto che si stabilisce in una sala prima dell’inizio di un concerto, che quasi si potrebbe dire che il fascino del silenzio sia svanito” (6).
Ci si chiede, e il ricercatore lo fa con grande enfasi: “..se ci si dovrà rassegnare alla scomparsa di certe qualità della vita come, ad esempio: la tranquillità? O piuttosto dobbiamo rivedere il nostro atteggiamento nei loro riguardi?”. Meglio rendersi conto di quanto noi stessi abbiamo perduto e andiamo perdendo, e identificarne come responsabili quei suoni forti e persistenti dovuti alla tecnologia che rallentano la nostra facoltà di pensare e spezzano il ritmo naturale della nostra vita, senza che neppure ce ne accorgiamo. “Se vogliamo restituire eleganza ed equilibrio al nostro ambiente interiore, dobbiamo dominare la tracotanza di queste macchine dominatrici del nostro ambiente esterno” – avverte ancora Schafer – è nel cercare di migliorarle, studiandone la ricaduta negativa che hanno sul paesaggio sonoro e gli effetti collaterali che riversano sulla natura umana.
Molto spesso succede di paragonare il paesaggio sonoro a un’immensa composizione musicale nella quale potremmo essere immersi in permanenza con grande delizia dei nostri sensi, se fosse migliorata l’orchestrazione. Sembrerà impossibile che un comune paesaggio sonoro possa anche lontanamente assomigliare ad una musica, eppure dovrebbe essere così, come “forse” era all’origine dei tempi. Ma che cosa è una musica se non un equilibrio, un’armonia tra i suoni? E l’uomo, durante il suo faticoso progresso nei secoli, non è partito da suoni emessi a caso da un qualsiasi strumento per giungere infine alle raffinate melodie che ci è dato sentire? “Solo se sapremo ricomporre l’ambiente sonoro del mondo, così come per la musica, unita alla scienza e all’arte, che potremo dire un giorno di aver reso un grande servizio alla società e a tutta l’umanità” – dice il nostro mentore Schafer, auspicando che solo il giorno in cui impareremo a padroneggiare i suoni violenti e aggressivi, e cominceremo a creare artifici sonori per scopi che non saranno né il profitto, né il potere, solo allora ritroveremo l’equilibrio di “pause e alternanze” necessarie a ricostruire la nostra calma interiore.
Anche se è appurato che una carta dei paesaggi sonori è molto difficile da realizzare se non si prende a fondamento della ricerca un pezzo di territorio relativamente piccolo e lo si studia a fondo da tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Tuttavia, se confrontata con quanto ci è voluto per disegnare la mappa geografica del globo, ciò risulterà fattibile. Piuttosto cerchiamo di mettere a punto i metodi appropriati per compilare una buona carta sonografica, che servirà a farci scoprire un mondo trascurato e sottovalutato eppure collegato all’uomo (essere umano) da molteplici legami mai venuti meno, che sono di grande importanza. Tutto sta nel partire con il piede giusto, in questo caso con un approccio giusto, e la ricerca si avvierà da sé. Per esempio, se nel corso di una passeggiata in campagna, vi capita di registrare dei suoni e ne annotate per iscritto le impressioni ricevute, ecco che state redigendo una specie di panorama acustico che, riletto e riascoltato più volte, potrebbe risvegliare i più piacevoli ricordi, come sfogliare un album di fotografie o di appunti di viaggio.
Il suggerimento ci è dato da due autorevoli studiosi di Sociologia Acustica di fama internazionale, Irmgard Bontinck (7) e Desmond Mark (8), rispettivamente autori di studi sull’ambiente acustico ed i paesaggi sonori contemporanei, nonché dell’articolo “Il recupero dei suoni perduti” da cui traggo quanto segue: “Gli effetti di suoni super amplificati cui siamo costantemente esposti, provocano nel sistema metabolico chimico del nostro organismo una maggiore produzione di adrenalina che, ricerche recentissime, volte a indagare l’azione diretta del rumore sul sistema nervoso, ha osservato la provenienza di un danno alla materia cerebrale. Uno choc acustico può avere come risultato di cancellare gli engrammi, quelle fragili vie che, nel cervello, registrano gli effetti degli stimoli e creano la memoria. Ebbene, la perdita della memoria potrebbe essere l’aspetto più preoccupante di una vita trascorsa in un ambiente rumoroso e super amplificato”. A questo proposito è doverosa una citazione scientifica riferita ancora una volta da Oliver Sachs (9) che riconosce quanto palesemente – “..traspare già nella prima infanzia, fondamentale in tutte le culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie. Può essere sviluppata o plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui. Ciò nondimeno, è così profondamente radicata nella nostra natura che siamo tentati di considerarla innata”.
Non per caso si è parlato di “imprinting”, che sta a significare: prendere forma, e per estensione educazione, formazione originaria, e per estensione “trasmissione”, che può avere diversi utilizzi. In etologia e psicologia è la forma di apprendimento di base, che si verifica in un periodo della vita detto periodo critico quando si è predisposti biologicamente a quel tipo di apprendimento. I primi studi sull'imprinting vennero fatti da Konrad Lorenz (10) su delle oche e ne rilevò come esse subito dopo la nascita identificano la propria madre nel primo oggetto o persona in movimento che vedono. Vi domanderete cosa centra con la nostra ricerca. Come sempre l’indagine su ciò che a noi sembra essere anomalo, più spesso getta luce su fenomeni di segno opposto. Per comprendere ciò dobbiamo però incamminarci su un'altra strada affatto facile e che riguarda la genetica comportamentale, almeno per riuscire a individuare in qual modo e forma l’imprinting trova applicazione in Etnomusicologia. Tuttavia non è la sola scienza ad essere coinvolta nella risposta che possiamo dare alla nostra domanda. Le problematiche affrontate dalla Etnopsichiatria (11) ad esempio, hanno rivelato che alcune turbe della psiche esistono anche presso le società primitive e le loro manifestazioni sono modificate secondo l’impronta culturale dell’ambiente patogeno. Infatti alcune patologie come ad esempio la malattia mentale non esiste in sé stessa, ma tiene conto della nozione ambientale, come una “realtà” creata unicamente da certe strutture sociali, per esempio alienanti la libertà, o condizionanti l’indipendenza dell’individuo.
In altro campo scientifico, spetta alla linguistica, più d’ogni altra disciplina, il primato di aver consentito di esaminare il processo di formazione del linguaggio verbale fondamentale nella trasmissione d’una cultura specificamente orale e comune a un popolo che l’ha tramandato da una generazione all’altra e da un gruppo all’altro, e che ha permesso di stabilire come ogni forma verbale è comprensibile della cultura che l’ha generata entro un determinato ambiente. Se si considera “ambiente” l’insieme del territorio in cui un gruppo etnico si trova a “vivere”, allora è possibile affermare quanto segue: “..che ogni cultura, per quanto “primitiva” possa essere, possiede una propria concezione del paesaggio sonoro che l’ha verosimilmente formata e che non può essere maggioritaria o minoritaria rispetto ad altre, perché anche quella in apparenza più umile, la meno conosciuta, può essere portatrice di verità necessarie a tutte le altre” (12). Se trasferito all’esperienza etnica della musica tradizionale, si rivela altrettanto utile nello studio della genetica comportamentale quando è riferita al comportamento di individui che trovano una rispondenza esistenziale di notevole interesse relativamente all'evoluzione di un comportamento musicale geneticamente determinato. Qui entra di proposito la genetica comportamentale che, infatti, studia l'influenza della genetica sul comportamento degli individui. Pertanto, alcuni individui umani e soprattutto gli animali nati in ambienti diversi hanno maturato sensibilità diverse e conoscenze diverse, che i nascituri accolgono in sé dal primo momento in cui si affacciano alla vita.
Il progresso tecnico e le conseguenti modifiche dell’ordine ambientale e di conseguenza sociale può dirci oggi qualcosa di più in proposito alla genetica delle popolazioni, altra branca della stessa disciplina che va sotto il nome di genetica generale, e fa seguito alla realizzazione delle “mappe geniche” elaborate da Luigi Sforza-Cavalli (13) , e del suo prestigioso team, che ha messo in evidenza la possibilità di sovrapporre agli alberi genealogici delle popolazioni umane, le lingue da esse parlate: “Le mappe dei geni della Terra rivelano realtà stupefacenti: che da un solo idioma parlato all’incirca centomila anni fa, derivano tutte le famiglie linguistiche, cioè le migliaia di lingue parlate attualmente nel mondo”; a cui si va ad aggiungere la storia delle rispettive lingue a dar forma a “una sorta di spina dorsale degli studi sulle origini”. Ciò avvalora ancor più quanto ipotizzato a sua volta da Charles Darwin (14), il quale, anticipando di molto i tempi, aveva altresì immaginato quanto segue: “Se possedessimo un perfetto pedigree dell’umanità, una sistemazione genealogica delle razze umane, fornirebbe la migliore classificazione delle diverse lingue oggi parlate; e se venissero incluse tutte le lingue estinte, e tutti i dialetti intermedi, allora una tale sistemazione sarebbe l’unica possibile”.
La genetica delle popolazioni analizza infatti le caratteristiche genetiche delle genti nel loro insieme mediante metodi matematici, ed in particolare afferenti alla teoria delle probabilità e alla statistica. La disciplina studia, in particolare, le distribuzioni e le variazioni nelle frequenze alleliche (15) dei geni sotto l'influsso delle quattro forze che regolano l'evoluzione: la selezione naturale, la deriva genetica, le mutazioni e le migrazioni. Questa branca, che consta di ulteriori sotto-discipline, è in grado di spiegare fenomeni come l'adattamento e la speciazione di molte forme di imprinting epigenetico (16), ivi inclusa la genetica quantitativa, ovvero la selezione in base ad informazioni sul fenotipo (17) e le relazioni tra gli individui, nonché la genetica ecologica più focalizzata sui temi ecologici e che studia prevalentemente le dinamiche delle popolazioni aborigene o così dette “selvatiche”. Dacché si è arrivati alla trattazione di un intero gruppo sociale che riconosce nel proprio repertorio organizzativo una specie di consiglio teologico (psicoterapia di gruppo) che opera in un’atmosfera di collaborazione e di rispetto reciproco, tale da essere presa a “modello di ricerca”, sebbene nel rispetto delle differenze “folkloristiche” dovute, anche se procedono differentemente l’una dall’altra nel cammino della stessa prospettiva. In questa prospettiva il valore del gruppo è sempre più importante, a tal punto che si parla di “super-ego collettivo” quando si tratta di società allo stato tribale. Non è dunque anormale che le cerimonie rituali presso le popolazioni aborigene, con le emozioni che esse procurano, con la tolleranza che manifestano, con il calore umano che sprigionano e con le regressioni e riorganizzazioni che suppongono, abbiano come conseguenza il reinserimento del soggetto nel proprio gruppo, nella propria tribù, nella propria società, e più generalmente nel proprio habitat naturale. I legami sociali, il cui valore protettivo per l’individuo è ben conosciuto, sono così rinforzati dalla rappresentazione collettiva del mondo in cui il magico e il reale non conoscono divisione.
Molti sono gli aspetti che confluiscono in una realtà etnica e che portano il ricercatore a determinarne la “tipologia” sociale. Una di queste può essere proprio la musicologia comparata, cioè la comparazione tra “stili” e “tipologie” diverse, tra “società” e “mondi” quello occidentale e orientale, diversi mettendoli a confronto. Ma ci arriviamo iniziandone a parlare con l’aiuto di un grande studioso Curt Sachs (18), la cui cultura artistico - letteraria ha superato di gran lunga il secolo appena terminato. Autore di numerosi libri dedicati allo studio della musica, degli strumenti musicali e della danza, e tutt’ora insuperati, considerati pietre miliari per chiunque voglia avvicinarsi allo studio della musica in senso assoluto: “Non si è avuto nessun serio lavoro di ricerca, nel campo della musica primitiva, prima della fine del XIX secolo, donde il primo compito degli studi musicologici a riguardo, per cui tutte le influenze estranee, ivi compresa quella europea, debbono essere eliminate prima di ogni altra cosa” – questo l’incipit del capitolo che – a mio parere – la dice lunga su come improntare il futuro lavoro di ricerca per il musicologo.
Da cui il consiglio dello specialista: “..il nostro senso critico non dev’essere mai guidato né da una speciosa somiglianza, né da altre pregiudiziali con altre musiche, tantomeno paragonata con quella dell’occidente europeo. Nonché, che il ricercatore deve mettere da parte non solo la propria musica, ma se stesso con tutte le sue tradizioni e con i suoi pregiudizi. Perché se anche le nostre orecchie registrano meccanicamente e pertanto obiettivamente, il nostro cervello capta ed interpreta in modo totalmente soggettivo”. A voler dire che ogni ricercatore, per forza di cose o, piuttosto inconsciamente, ridimensiona ogni altra musica sui pochi modelli ritmici della musica a cui è avvezzo. “Per ovviare a questo inconveniente, abbiamo bisogno di un controllo obiettivo ed incorruttibile sia delle altrui trascrizioni, sia del nostro proprio tentativo di capire e rendere la musica “comprensibile” dapprima ai nostri orecchi, per poi passare alla sua elencazione e definizione” – ribadisce ancora il nostro autore.
Con il nome tedesco, Vergleichende Musikwissenschaft (19), tradotto in quello di “musicologia comparata” e, in questa forma, diffuso nei paesi anglosassoni, la materia di studio ha aggiunto una nuova possibilità al complesso delle discipline musicali, ponendosi come un must della ricerca, per cui nessuna scienza può prescindere dai metodi comparativi. La cosiddetta musicologia comparata, infatti, condotta nei diversi continenti e gli arcipelaghi ha accumulato una tale quantità di materiale da renderci partecipi di una gigantesca evoluzione che va dai rudimenti embrionali del canto primitivo all’espressione complicata e ricercata dell’arte orientale. Tale visione d’insieme ha permesso, inoltre, di superare la fase del puro confronto, per far confluire la musica primitiva e quella orientale, un tempo lontane e tenute fuori della considerazione generale, nella branca iniziale della storia della musica: in quell’antro della coscienza del profondo, che rinfranca il “rapporto armonioso” che da sempre la musica ha con noi stessi e con il nostro passato. In tal senso, trova ispirazione anche l’incipit al capitolo III, in cui l’autore fa sfoggio della sua eloquenza, fornendoci un esempio di comparazione in musica con l’uniformità della vita dei primitivi: “..nonostante tutte le differenze di temperamento, di carattere, di intelligenza, ogni atto, sia esso pratico o artistico nella vita dei primitivi, viene intese dai membri della tribù come l’atto di un animale è inteso dai suoi simili. E la musica primitiva non rappresenta il linguaggio personale, l’espressione individuale di singoli maestri. Esprime bensì quanto ognuno è in grado di esprimere; canta la vita dell’intera tribù; la sua aspirazione è l’aspirazione di un sentimento collettivo. (..) I testi, in se stessi, sono senza pretesa alla portata di ogni membro della tribù. Sarebbe vano attendersi una relazione diretta fra un testo e l’occasione in cui viene cantato” (20), ancor meno se ne ricava un’esecuzione strumentale.
Quando non segua una monotona scansione fondata su una nota sola, il canto delle civiltà primitive non ha un’esistenza propria, indipendente dalle parole, per quanto insignificanti possano essere, né può aversi poesia senza canto. La poesia, in senso lato, porta la melodia e insieme le parole lontano dal discorso parlato. I poeti alterano e livellano gli accenti logici necessari al raggiungimento della comprensione che consenta loro il dialogo. Cioè, sostituiscono il libero ritmo espressivo della frase parlata con modelli pressoché fissi, in luogo del naturale fluire del discorso pongono artificiose combinazioni di parole che spesso vengono meno alle regole grammaticali e della sintassi, per dire che sostituiscono le parole consuete con altre insolite che non userebbero nel parlare abituale. L’arte si sa, altera l’ordine naturale delle cose per porle su un piano più elevato o comunque diverso, e gli esecutori del canto non sono da meno, di proposito, evitano le intonazioni vaghe e irrazionali dell’eloquio. Per quanto possiamo riportarci indietro, la melodia del linguaggio, così libera e fluente nell’atto del parlare, nel canto è risolta in una serie di intervalli uniformi, e di silenzi (pause) che lasciano sbalorditi per la loro profondità.
Del resto, come abbiamo avuto modo di apprendere, la memoria non ci è di alcun aiuto. Quando va molto indietro nel tempo, essa tende a idealizzare e a isolare i suoni, questo spiega il perché un suono del passato registrato oggi, ci sembra a volte molto diverso dal suono che ricordavamo. Pur tuttavia esso ci procura una sorta di “nostalgia” perché lo associamo all’idea che di esso avevamo e rimpiangiamo il silenzio, quella deliziosa pausa tra i suoni, che c’era servita a percepire meglio, a riflettere, a fissarlo nella memoria. Ma è questo un aspetto per così dire “emozionale” che apre un’altra parentesi di ricerca che spero di poter approfondire in seguito.
Discografia e altro:
La musica elettronica ha fatto in più occasioni ha attinto alla cultura etnica elaborando brani che hanno poi ottenuto il plauso dei discografici e del pubblico, per lo più relativi a sonorizzazioni, colonne sonore per documentari e film, di carattere ambientale anche detta 'soundscape composition', pari ad una composizione musicale elettroacustica che crea un ritratto sonoro di un particolare ambiente sonoro. Tra i compositori che hanno formalizzato 'paesaggi sonori', spiccano senz'altro i due pionieri della sintesi granulare in tempo reale: Barry Truax e Luc Ferrari, la cui “Presque rien, numéro 1” (1970) è sicuramente una delle prime 'bande sonore'di riferimento. Mentre Riccardo Piacentini, è invece ideatore della foto-musica con foto-suoni per sonorizzazioni ambientali, dove i paesaggi sonori sono spesso utilizzati in performance musicali.
Per i ricercatori più attenti e gli amanti della natura, evidenzio una serie di tre album fotografici editi dalla Emi-Brigaders di Johannesburg che raccolgono le voci degli animali, dall’insetto all’elefante, raccolte dalla nota antropologa Sue Hart, reperibili sul mercato d’importazione. Le scelte effettuate da molti artisti non a caso conduce alla rinnovata ottica in cui va vista l'Etnomusicologia e “l’arte di fabbricar suoni,” nei termini più realistici della comparazione tra le varie esperienze dell’evoluzione in musica.
Molti sono i titoli cui fare riferimento: “Spheres” di Keith Jarrett – “The Forest” di David Byrne – “Desert” e “Ocean” di Stephen Micus – “Ambient”, “Uakti: aguas da amazonas” e “Anima Mundi” di Phil Glass per uno splendido documentario sulla natura di Godfrey Reggio e, senz'altro dubbio, “Dune” di Klaus Schulze – nonché “Caverna Magica” di Andreas Vollenweider anche se con qualche riserva (da parte mia).
Un nome in assoluto è quello di Vangelis Papatanassiou che ha composto le colonne sonore di molti documentari sulla natura di Frederic Rossif e le cui musiche risultano di una tale aderenza all’immagini che quasi è possibile credere che l’ispirazione ha in qualche modo superato la realtà: “L’Apocalypse des Animaux” (Polydor) – “Soil festivities” (Polydor) – “Opera sauvage” (Polydor) – “Antarctica” (Polydor). Un brano tra gli altri, che più rivela la rivisitazione etnica è, ad esempio, incluso in “Spiral” (RCA-Victor), dal titolo “Dervish D” ripreso appunto dalla tradizione Dervishia, legata alla religione dell’Islam; e “Ignacio” (EMI) colonna sonora del film di F. Reichenbach, in cui il compositore utilizza una melodia greca eseguita al santuri.
Altri esempi tra la musica avanzata e colta vedono Iannis Xenakis, Jon Cage, Luciano Berio, Cick Corea, Shotakovick, Schoemberg, Isao Tomita, Stomu Yamashta’s, Kitaro, Anouar Brahim, Kronos Quartet, Peter Gabriel, Ennio Morricone, insieme a tantissimi altri, non in ultimo la cantante “punk” Patti Smith che ha inserito nell’album “Ester” (Emi-Arista) una danza degli spettri “Gost Dance” ripresa dal folklore pellerossa di grande effetto emotivo.
Bibliografia:
“Five village soundscapes (Music of the environment series) “- A.R.C. Publications, 1977.
“Handbook for Acoustic Ecology” - Barry Truax 1978.
“Acoustic Communication : Second Edition” - Barry Truax & World Soundscape Project - 1985.
“Wild Soundscapes: Discovering the Voice of the Natural World” - Bernard L. Krause - book & CD ,2002.
“The Auditory Culture Reader (Sensory Formations) 2004” - Michael Bull, 2004.
“Ecologia della Musica - Saggi sul paesaggio sonoro” - a cura di Antonello Colimberti - Donzelli 2007.
“Creare paesaggi sonori “- Luigi Agostini – Ed. Lulu 2007.
Note:
(1) R. Murray Schafer, op. cit.
(2) Imprinting: l'imprinting genomico (o epigenetico) è un processo che lascia nel nascituro un'impronta di diverso tipo nei geni trasmessi dal genitore di sesso maschile ed in quelli trasmessi dal genitore di sesso femminile, ed è indispensabile per un corretto sviluppo embrionale.
(3-4-5-6) R. Murray Schafer, op. cit.
(7) Irmgard Bontinck, in “Il Corriere” UNESCO, Anno XXIX n.11; ha diretto lo studio di Ricerche dell’Istituto Internazionale di Musica, Danza e Teatro nei mezzi audiovisivi, fondato a Vienna dall’UNESCO, e chiamato Mediacult. È autrice di uno studio critico sulla Cultura del Sistema preparato per l’UNESCO. Ha diretto la pubblicazione di “New Patterns of Musical Behaviour of the Young Generation in Industrial Societies” Vienna 1974.
(8) Desmond Mark, in “Il Corriere” UNESCO, Anno XXIX n.11; studioso di Sociologia Acustica presso l’Istituto di Sociologia della Musica a Vienna, ha pubblicato parecchi studi sull’ambiente acustico e i “paesaggi sonori” contemporanei; ha contribuito alla pubblicazione di una serie di studi sul Comportamento musicale della gioventù” – Vienna 1976.
(9) Oliver Sachs, op. cit.
(10) Konrad Lorenz:
(11) Etnopsichiatria:
(12) in “Il Corriere” UNESCO, anno XI n.6, articolo “Unesco e Musica” che evidenzia l’importanza che questa importante Organizzazione mondiale da alla musica etnica di tutti i popoli del mondo, con la produzione di raccolte preziosissime per lo studio e la ricerca in Etnomusicologia, con riferimento ai suoi impegni futuri.
(13) Luigi Sforza-Cavalli, “Imprinting” (articolo in Il Messaggero – Roma, 14 maggio 2000.
(14) Charles Darwin: “L’origine della specie”, Bollati Boringhieri, Torino 1967.
(15) frequenze alleliche
(16) epigenetico:
(17) fenotipo:
(18) Curt Sachs “La musica nel mondo antico” – Sansoni Editore, Firenze 1981. Musicologo, studioso dell’arte, storico e ricercatore, nonché scrittore, è professore all’Università di Berlino. In passato ha insegnato all’Università di New York e in seguito alla Columbia University. Alla base dei suoi studi orientati all’investigazione della storia degli strumenti musicali su un terreno fino ad allora inesplorato, ove gli strumenti sono considerati come simboli della cultura umana attraverso il tempo. È inoltre autore di studi musicologici sull’indagine sistematica e storia degli impulsi motori e sensori in relazione alla musica, uno studio di carattere estetico e psicologico, dal titolo “Rhythm and Tempo”. Opere apparse in Italia oltre quella sopra citata: “Storia degli strumenti musicali”, “Storia della danza”.
(19) Vergleichende Musikwissenschaft - “musicologia comparata:
(20) Curt Sachs, op. cit.  - Musica
- Musica
Quaderni di Etnomusicologia 1: Patagonia
“PATAGONIA: terra di armonie selvagge”, di Giorgio Mancinelli.
(Da “Il canto della terra”, trasmissione radiofonica in due puntate messa in onda da RSI –Radio della Svizzera Italiana).
Il primo itinerario proposto da questa ricerca etnomusicologica prende avvio da Buenos Aires, tappa necessaria quanto obbligatoria, per proseguire verso la Patagonia e l’estrema punta della Terra del Fuoco: “un ammasso accidentato di sterili rocce, di alte colline e inutili foreste, il tutto avvolto in nebbie ed eterne tempeste” – come ci rivela Paul Theroux (1) lo scrittore che visitò la Patagonia negli anni ’80, e che annotò molte osservazioni utili per la conoscenza di questa terra e dei popoli che la abitavano, ancora oggi fonte di scientifica curiosità. “Sapevo che era la parte più vuota dell’America e una delle meno conosciute – e quindi una serra di leggende, mezze verità e cattiva informazione” - aggiunge. Degli antichi abitatori di queste regioni, più conosciuti col nome di indios Fuegini, non rimangono che pochissimi manufatti d’uso quotidiano, il ricordo di alcune usanze arcaiche entrate nella quotidianità, e alcuni nomi riferiti ad abitanti aborigeni. Eppure: “Non appena gli scienziati, come Darwin, grattarono il terreno, trovarono che era un cimitero d’ossa di mammiferi preistorici, alcuni dei quali si pensò fossero ancora viventi. E inoltre: foreste pietrificate, laghi effervescenti e colate di ghiaccio azzurro che si addentravano in foreste di faggi”. Come ci rivela Bruce Chatwin (2) il viaggiatore che ha fatto della Patagonia un affascinante ed erudito racconto di viaggio.
Sembra che gli aborigeni fossero divisi in almeno due gruppi distinti: il primo includeva i Selk’nam, i Tehuelches e gli Haush che abitavano gli umidi pascoli della Patagonia Orientale; il secondo gruppo, comprendeva gli Yamana, i Chono, e forse gli Ona originari dell’Arcipelago Fuegino che si estende dall’isola di Chiloe a nord, all’isola Navarino a sud, dove cresce una vegetazione di cespugli spinosi e piove per due terzi dell’anno. Diretti discendenti di quelle popolazioni amerindie che verosimilmente vi si stabilirono in tempi molto lontani, vanno certamente menzionati gli Aymara, sparsi nelle provincie montuose di Tarapaca e Antofagasta nell’odierno Chile; i Mapuche conosciuti come il “popolo della terra”, circostanziati nell’area rurale detta Araucania, e per questo anche chiamati Araucani; e i Qawashqar, considerati i più antichi abitanti della Terra del Fuoco, che vivevano “ai piedi del mondo”, nella regione più a sud del pianeta, e di cui si è quasi perduta memoria. Ma, mentre si conosce gran parte della cultura degli Aymara, rimasti isolati dalle influenze della civiltà occidentale per lunghissimo tempo, fatto che gli ha permesso di continuare a condurre il loro modo di vita tradizionale; quasi nulla rimane della cultura dei Qawashqar, chiamati anche Alakaluf (ma probabilmente trattasi di una diversa etnia tribale di nomadi navigatori), molto attaccati al proprio territorio, malgrado dovessero costantemente lottare contro l’asprezza dell’ambiente naturale.
Thomas Falkner (3), che visitò la Patagonia nel 1774, riguardo agli aborigeni, annota che: “Sono un popolo innocente e mite (..) si nutrono principalmente di pesce, che si procurano o tuffandosi in acqua o infilzandolo con le fiocine (..) sono lesti di piede e catturano guanachi e struzzi lanciando le loro bocce (bolas)”. Charles Darwin (4) ancora nel 1832 parlando dei “patagoni” racconta: “Quando sbarcammo, manifestarono un certo allarme , ma continuarono a parlare e a gesticolare con grande rapidità. Era senz’altro lo spettacolo più curioso e interessante cui avessi mai assistito: non avrei mai creduto che tanto grande fosse la differenza fra l’uomo civile e quello selvaggio; è maggiore di quella fra un animale selvatico e uno domestico, poiché nell’uomo vi è una maggiore capacità di miglioramento. (..) un giorno, mentre ci dirigevamo verso la spiaggia vicina all’isola Wollaston, passammo a fianco di una canoa con sei fuegini. Erano le creature più abiette e miserevoli che avessi mai visto”.
Le ragioni della quasi totale estinzione di questi gruppi sono strettamente collegate con l’arrivo degli occidentali sul continente che, a loro volta per sottometterli alla schiavitù, organizzarono il massacro di grandi gruppi di indios, e successivamente, li ridussero alla condizione di miserabili dai trafficanti contrabbandieri per ragioni esclusivamente economiche. Al resto pensò la predisposizione degli indios alle malattie portate dalla civilizzazione e, infine, i violenti tentativi di imporre a questa gente una cultura a loro completamente estranea. Va aggiunto che in questa vasta estensione territoriale, oggi divisa fra gli stati del Chile e dell’Argentina, le risorse naturali non offrivano possibilità allo sviluppo dell’agricoltura o alla lavorazione di terraglie, così come la scarsa vegetazione non ne offriva alla tessitura, pertanto gli autoctoni si dedicavano soprattutto alla caccia e alla pesca in quel grande deposito che le rocce delle coste e le spiagge delle insenature offrivano loro, di elefanti marini, lontre, pinguini, e balene che tiravano a secca nei canali dell’isola.
Visitata nel tempo da navigatori quali Ferdinando Magellano e Alessandro Malaspina, da ricercatori come Charles Darwin e Fitz Roy, descritta da Saint-Exupéry e Joshua Slocum, esaltata da J. Luis Borges e Luis Sepulveda, che oltre ad averne rivelato l’affascinante attrattiva dei luoghi, l’hanno anche straordinariamente definita la terra “al di là dei confini del mondo”, consegnandola definitivamente all’immaginazione e alla leggenda, che spinge oggi il ricercatore e lo scienziato, così come il turista o il visitatore, a un costante viaggiare nei luoghi “patagonici”: quasi a voler indicare qualcosa di infinito e d’immenso e anche di totalmente esotico e pericolosamente attraente. La definizione è di Hermann Melville (5) che, nel suo romanzo “Moby Dick”, l’aggettiva così: “Poi, i mari selvaggi e remoti dov’egli (la balena) voltolava la sua massa simile a un’isola, i pericoli, indescrivibili e senza nome, della caccia: queste cose, con tutte le concomitanti meraviglie di un migliaio di parvenze e suoni patagonici s’aggiungevano a spingermi al mio desiderio” e – aggiungerei – ad andare oltre. Non ci rimane, quindi, che avventurarci in questa irrealtà di parvenze e suoni al pari di quei “viaggiatori letterari”, come amava definirsi Bruce Chatwin, e cercare di comprendere ciò che resta dell’antica cultura musicale, (poiché questo è il nostro scopo di ricerca), degli strumenti e dei canti originari della Terra del Fuoco tanto lontana quanto mostruosamente straordinaria: “il punto oltre il quale non è dato andare”.
La componente forse più resistente della cultura Qawashqar (6), dei quali ci occuperemo in questa ricerca, è senza dubbio il linguaggio, che sopravvive ancora, seppure in parte, minacciato dall’introduzione di una scolarizzazione in cui si parla solo spagnolo. Probabilmente lo stesso che Darwin ascoltò incontrando gli aborigeni “dal linguaggio sottile”, e li trovò così “abietti” da dubitare, che appartenessero alla sua stessa specie. Secondo lo studioso Augusto Raùl Cortazar (7), le aree più interessanti per la ricerca etnologica sono almeno quattro, in ordine: regioni andine della Sierra de Calalaste, Pampa del Chaco, Patagonia, Terra del Fuoco, da cui prendono il nome le relative quattro regioni. Ricerche effettuate sul campo in Patagonia, hanno portato a conoscenza di una comune cultura andina dedita al “nomadismo ciclico”: seminano i campi di grano, quinoa, patate, aglio, pepe chili e fagioli sull’altopiano. Parliamo quindi di un popolo di raccoglitori e consumatori di piante e frutta selvatiche, le cui scorie, essiccate, venivano conservate e costituivano una buona scorta per accendere il fuoco.
Questo, era “fondamentale” alla loro stessa sopravvivenza e, una volta acceso, prendevano tutte le precauzioni per non farlo spegnere, poiché riaccenderlo, nel clima freddo e umido dell’arcipelago, non era impresa da poco e significava grande dispendio di legna secca da bruciare. Praticavano un artigianato poverissimo che la famiglia poteva scambiare con altre, oltre al smercio delle prede di caccia e pesca con gli acquirenti locali. Quando il gruppo familiare viaggiava, e solitamente si spostava a bordo di piccole canoe ottenute dal tronco degli alberi, portava il fuoco con sé nella canoa, insieme a un piccolo numero di utensili per lo più attinenti la caccia, come fiocine, trappole, ecc., finché non lo si poteva mettere nella nuova capanna. Loro unica forma di organizzazione sociale era il piccolo gruppo familiare, le decisioni venivano prese dal capofamiglia, e non c’erano capi o autorità al di fuori del gruppo familiare che veramente contassero. Malgrado ciò la loro condizione economica ne faceva un popolo praticamente nomade ed ogni anno con l’avvicinarsi dell’inverno, i Qawashqar si trovavano a lasciare le capanne e i campi per i burroni e le gole della Cordigliera della Ande, prima che le pastura per le greggi diventino secchi e gelino. Queste erano formate in prevalenza da alpaca e lama e talvolta anche da pecore e capre, tenute in recinti costruiti in pietra dove veniva accumulato lo sterco che sarebbe servito a concimare i campi per il successivo pascolo.
I campi, che nel frattempo, avevano raccolto le piogge, assai numerose, permettevano al bestiame di pascolare sui terreni da pascolo, detti bofadales in primavera, mentre le terre sull’altopiano, così concimate e irrigate, sarebbero state pronte per la semina, quando i gruppi avrebbero fatto ritorno nei villaggi per mietere il raccolto alla fine dell’estate. Una delle principali funzioni della comunità tribale era l’organizzazione e l’allestimento delle feste che si basavano sull’esistenza di forze e spiriti presenti nella natura, e che l’uomo spesso, secondo una concezione animista, doveva onorare e placare, con offerte e olocausti. Si narra che fu proprio il grande navigatore a dare a questa estrema landa il nome di Terra del Fuoco, dopo aver avvistato numerosi falò accesi giorno e notte lungo le coste dello stretto che oggi porta il suo nome, e scambiò per le “anime dei morti che bruciavano all’inferno”. Una delle feste più importanti, che ritroviamo nelle diverse regioni, è chiamata del floreo, che si tiene nel corso dei mesi estivi, in cui gli animali del gregge vengono agghindati con ornamenti coloratissimi. Floreo deriva dalla parola “flor” che significa fiore, e poiché non ci sono fiori sull’altipiano, gli ornamenti sono fatti con lana multicolore. La festa è una gioiosa celebrazione delle greggi, in cui le diverse tribù trovano l’occasione per fare musica insieme e cantare, soprattutto, per tramandare la narrazione dei “miti” tribali che alcune leggende fanno risalire all’origine del tempo.
La “narrazione di un mito” è il contenuto di una registrazione eseguita sul campo durante le riprese di un documentario sulle tribù della Patagonia, riferita proprio ai Qawashqar, dal titolo: “Atqashap” (8), linguisticamente parlando il "topo", allo stesso tempo identificato con la gente della tribù che l’ha tramandata seguendo il peculiare concetto secondo cui essi chiamano “canzone” quella che per noi sarebbe una “narrazione”. La storia consiste in un numero di episodi che si riferiscono a Atqashap, per mezzo dei quali sono messe in risalto le sue virtù: “Uomo come me, ma topo. / Sono i primi uomini..”. In essa si riflettono le origini della vita e della storia della gente Qawashqar. Il narratore parla in un ritmo speciale adattato al contenuto semantico di cosa si sta dicendo, e adopera un linguaggio pieno di arcaismi, la maggior parte dei quali è incomprensibile per la presente generazione. Questo linguaggio costituisce un’improvvisata manifestazione rituale, forse la sola ancora conservata oggi. L’idea centrale del mito è la lotta fra Atqashap e Silum “il male”, che è situato geograficamente al Nord. Questa potrebbe essere allusiva degli invasori che arrivavano sempre da quella direzione. Nel corso degli altri episodi astuzia, velocità e coraggio sono messi in rilievo come virtù fondamentali fra le altre: “Silum viene dal Nord per uccidere Atqashap, ma quest’ultimo imbroglia il suo nemico travestendosi, e poi nascondendosi in una testa di delfino, cosicché Silum lo colpisce alla testa credendo di averlo ucciso”. In un altro episodio: “Silum solleva il suo bastone per ucciderlo, ma Atqashap, essendo un topo, corre sulla cima del bastone salvandosi (la dinamica della velocità è imitata nella narrazione)”. Ciò è confermato nell’episodio in cui: “Atqashap ha dell’acqua nascosta in un piccolo pozzo, e deve berla velocemente per poi nasconderla di nuovo, in modo che Silum non la trovi” (9).
Molta parte del linguaggio usato nelle canzoni, ad esempio, consiste in parole senza senso usate in forma onomatopeica in cui, la ripetizione di una stessa frase o parola, emette un suono, si combina in ordine con le altre, se scandita crea ritmo, se cantilenante crea consonanza. Un esempio è dato da una canzone molto in voga, di cui esistono molte versioni e conosciuta anche al di fuori del contesto regionale, dal titolo “Chichili” (10) che, nel ricordo della gente è una canzone d’amore che parla di qualcuno che si sta innamorando, anche se nessuno ricorda il preciso significato delle parole. Nella versione più complessa di questa canzone, Chichili sta a significare “desiderio di tenere, di mantenere”: “yapashquna goles warlay yetenaq achal” corrisponde a “l’amante abbraccia una donna”. Si è cercato, in fase comparativa, di avvicinarla al chequa, lingua tipica parlata lungo tutta la Cordigliera delle Ande, ma inutilmente. E non solo, risulta diverso anche il modo di cantare, come diversi sono gli strumenti arcaici, dal suono molto singolare: il pinqalyo o pinkullu, è una sorta di flauto di canna con 4 o 5 fori rintracciato sull’altipiano andino, suonato trasversalmente durante la pastorizia. Un noto canto entrato nella tradizione e solitamente accompagnato dal pinkullu ha un titolo intraducibile “Sumirumansanisa” (12); si tratta di una canzone laudatoria di contenuto agreste, le cui parole di lode sono rivolte alle montagne sacre “raffigurazioni di mitiche divinità”. In essa un pastore invoca la “mamala” (madre natura), anche detta “pacha-mama” (nelle regioni andine), affinché protegga il suo gregge di lama dal correre troppo velocemente, sì da fargli temere di perdersi nella nuvola di polvere che solleva e di finire in qualche dirupo.
Dalle regioni più interne, sorvolando l’immensa distesa che il sole, incendia fin dalle prime ore dell’alba: “in una di quelle albe che dopo la tempesta, appaiono come la rinascita del mondo”, si nota chiaramente la parziale utilizzazione a culture agrarie sparse sul tessuto umido e fertile della Pampa, una terra apparentemente senza confini, mentre la gran parte di essa è deserta, rotta solo da rari ciuffi d’alberi stravolti dal vento, percorsa da branchi di bestiame, per lo più bovidi in masse caracollanti di groppe a migliaia in cerca delle distese d’erba utilizzata per i pascoli assai numerosi. Piccoli centri abitati e fattorie segnano una ragnatela di civiltà che, con il maggiore sviluppo dell’agricoltura, la stanno cambiando in parte l’aspetto selvaggio che la distingueva. Attorno alle estancia, le fattorie, si vedono molte oasi verdi dette cascos, rigogliose di eucalipti, pioppi e alberi del paradiso, piantati dalla mano dell’uomo. Alcuni talmente isolati, da sembrare verdi isole sperdute nella vasta pianura; altri, formati da un solo grande albero: l’ombù, tipico di questa regione, entrato nella leggenda e nelle canzoni popolari, punto di riferimento e di ritrovo per uomini e animali che vi trovano riparo dal sole cocente del giorno e dall’umido pungente della notte.
Ben presto si è immersi nella Pampa più selvaggia, piana e asciutta, senza punti di rilievo, continuamente spazzata dai venti che raggiungono sovente la violenza dell’uragano, quando non è la bonaccia a farla implodere sotto il sole infuocato. È questa la terra detta “del silenzio” che si estende dalle Ande, al Chàco, al Paranà, fino all’Atlantico e la Patagonia, terra leggendaria di gaucho errabondi che vanno alla ricerca delle distese di verde per le loro mandrie. Infatti, all’indirizzo dei gaucho assetati d’ombra e di riposo, sono indirizzati i racconti di gesta leggendarie, come anche degli eroi che un tempo hanno soggiornato e attraversato la Pampa, ed entrati nella letteratura ufficiale. Uomini come “Martin Fierro”, eroe dell’omonimo poema di Josè Hernàndez (12) che la solitudine della Pampa ne ha fatto un uomo altero e poetico, il cui personaggio romanticissimo, alimenta ancora oggi la fantasia sudamericana sulla figura del gaucho, di cui leggiamo un passo:
“Aquì me pongo a cantar, / al compàs de la viguela / que al hombre que lo desvela / una pena extraordinaria, / como el ave solitaria / con el cantar se consuela”.
"E qui mi metto a cantare, / al compàs della viguela / che all'uomo che lo svela / una pena straordinaria, / come l'uccello solitario / col cantare si consola".
Al mitico gaucho è dedicata più di una canzone, come ad esempio quella qui riportata:
“Quando mia sarà la terra, seminerò parole / che mio padre, Martin Fierro, diede al vento.. / Quando mia sarà la terra, io ti giuro semente / che la vita sarà un dolce grappolo / e nel mare dell’uva il nostro vino. / Quando mia sarà la terra, darò alle stelle / astronauti di messi, la luna nuova.. / Quando mia sarà la terra, formerò con i grilli / un’orchestra, dove possano cantare / quelli che pensano” (13).
Il gaucho, figura mitica della pampa, rispecchia quell’ideale di libertà incontrastata che è sempre presente nel popolo argentino. “E il popolo, vi è presente come problema aperto – scrive J. Luis Borges (14) – che non basta l’esistenza del gaucho e della pampa a spiegare la letteratura gauchesca, che si è formata quando uomini di cultura urbana si sono avvicinati a quel mondo, attraverso l’esperienza dell’indipendenza argentina e le guerre civili”. È il caso di citare almeno un altro personaggio famoso della letteratura: “Santos Vega” (15), “al cui amore nessuna donna avrebbe resistito e nessun uomo ha mai vinto in duello”. Narra la leggenda che un giorno, accettata la sfida lanciata da un misterioso cavaliere, rivelatosi poi il diavolo in persona, egli fu vinto e morì in seguito al combattimento. E aggiunge che, nelle notti di luna la sua ombra torna errabonda ad attraversare la pampa:
“Tu alma puebla los desiertos, / y del Sud en la campaña / al lado de una cabaña / se eleva fúnebre cruz; / esa cruz, bajo de un tala / solitario, abandonado,/ es un simbolo / venerado / en los campos del Tuyú”.
La tua anima popola i deserti, / e del Sud nella campagna / di fianco ad una capanna / si alza funebre croce; / quella croce, sotto di un bosco / solitario e abbandonato, / è un simbolo venerato / nei campi del Tuyú".
Bartolomé Mitre fu il primo che fissò per iscritto il motivo di “Sacra Pianura”, ispirato nella tradizione orale dello stesso. Il poema "A Sacra Pianura, payador argentino" fu scritto nel 1938 e raccolto in libro di Rime nel 1954. Questo poema sottolinea la tradizione orale della poesia e la permanenza dei versi di “Sacra Pianura” nel paese e nella natura, oltre il passo del tempo. Qui si sente riferito il posto dove Sacra Pianura sarebbe stato sepolta: sotto un bosco, nei campi del Tuyú. Ma non è solo per questi poemi maggiori della letteratura gauchesca che il fenomeno è importante, in tutto il Sudamerica i proverbi e le canzoni legate alla figura del gaucho, tra cui spicca una ballata popolare conosciuta come: “Milonga del solitario”, il lamento triste di un gaucho rimasto solo che il poeta e narratore Atahualpa Yupanqui (16), ritenuto “l’anima stessa dell’Argentina”, ha raccolto e fatto conoscere al mondo intero:
“Toda la noche ho cantado / con el alma estremecida. / Que el canto es la abierta herida / de un sentimiento sagrado. / A naides tengo a mi lado / porque no busco piedad. / Desprecio la caridad / por la verguenza que encierra. / Soy como el leon de mi sierra: / vivo y muero en soledad”.
“Tutta la notte ho cantato / con l'anima scossa. / Che il canto è l'aperta ferita / di un sentimento sacro. / Nessuno tengo al mio fianco / perché non cerco pietà. / Disprezzo la carità / per la vergogna che rinchiude. / Sono come il leone della mia catena montuosa: / vivo e muoio in solitudine”.
La figura del gaucho arrivata fino a noi è impastata di popolare saggezza, di esperienze complesse anche importanti, che hanno fatto di lui un essere completo. E questo significa non solo che egli continuerà a vivere fin tanto che continuerà ad esistere la pampa, il mondo che condiziona e determina la sua esistenza, ma significa, anche che egli continuerà ad essere idealizzato e continuerà a suggestionare l’uomo moderno proprio sulla scia della tradizione poetica, narrativa e spirituale della Pampa, la “tierra del silencio”, com’è anche chiamata dalle numerose voci popolari, e descritta in questa canzone di gusto gauchesco, di Atahualpa Yupanqui: “Vidala del silencio” (17):
“Cierta vez en la manana de un pais de montanas azules, / miraba yo esas nubes pequenas, que suelen quedar como / prendidas de las piedras en la mitad del cerro. / El aire, ausente. mas arriba, un cielo azul, abajo,la tierra dura, y calida. / Alguien me dijo unas raras palabras refiriendose a esas / nubecitas blancas, quiza lejanas ya, que embellecian el paisaje... / Eso que usted està mirando, no son nubes, amigo. / Yo creo que son vidalas olvidadas, son melodias, esperando que alguien / comprenda su silencio, entienda su palabra, intuya su canciòn. / Poco tiempo después de ese momento que no se puede / traducir cabalmente, porque esta màs allà de nuestro /
entendimiento, asì poco tiempo despues / naciò la vidala del silencio”.
“Una certa volta nella mattina di un paese di montani azzurri, / io guardavo quelle nuvole piccole / che normalmente rimangono come / agganciate delle pietre nella metà del dorso. / L'aria, assente. ma sopra, un cielo azzurro, abbasso, / la terra dura, e calda. / Qualcuno mi disse alcune rare parole riferendosi a quelle / piccole nuvole bianche, chissà lontane già che abbellivano il paesaggio... / Quello che lei sta guardando, non sono nuvole, amico. / Io credo che siano vidalas dimenticate / son melodie / sperando che qualcuno / comprenda il suo silenzio, capisca la sua parola, / intuisca il suo cantare. / Poco tempo dopo quello momento che non si può / tradurre perfettamente, perché va al di là del nostro / intendimento, è così che poco tempo dopo / nacque questa vidala del silenzio”.
Un tempo le terre della Pampa erano abitate esclusivamente da tribù indios autoctone che popolavano la grande pianura anch’esse chiamate “pampa”, da cui il nome dato in seguito alla terra che le ospitava. Tra queste vi erano i Queranoi e i Puelches che vivevano a grande distanza le une dalle altre e che di tanto in tanto si riunivano per lo scambio di merci e manufatti, oltre che per combattere, e forse – ma questo non è stato appurato – per festeggiare insieme particolari riti e cerimonie di fratellanza. Festività nelle quali gli indios s’intrattenevano con canti e danze facendo uso di particolari strumenti ancora oggi in uso fra le popolazioni autoctone delle Ande. Tuttavia, il ceppo più antico, sembra fosse lo stesso per entrambe le popolazioni, delle quali, pur con tutte le riserve del caso, si conoscono solo pochi e dubbi esempi di musica strumentale diversamente distribuiti nelle varie regioni. Ognuna di esse possiede ritmi, e qualche volta anche strumenti diversi, nonostante la chitarra spagnola si ritrovi dappertutto. La musica del sud, che include Buenos Aires e la Pampa, riflette fedelmente le melodie, spesso malinconiche e talvolta appassionate, tipiche della cultura “gauchesca”, suonate alla chitarra, a differenza delle regioni del nord dove si usa il charango, una sorta di mandolino ricavato dal guscio dell’armadillo. Così come nella regione del nord-est, in prossimità del Paraguai, l’armonica rimpiazza la fisarmonica.
Tutte le regioni dell’ovest, o Cuyana, confinanti con il Chile risentono di una reciproca influenza, per cui sono molto simili per l’uso costante degli stessi strumenti, dal charango, ai differenti tipi di flauti. Ma è senz’altro nelle regioni del centro che la musica non rassomiglia a quella di nessun altro paese sudamericano, ed è qui che si scoprono i ritmi argentini più originali e gli strumenti più conosciuti, come: il bandoneon, alcuni tipi di violini, il piano e il contrabbasso. Inutile ricordare che esistono una grande varietà di danze popolari, come la zamba e la chacarera, il tango e il carnavalito; e diversi tipi di melodia e di canto, come la tonada, la milonga, la coplas, la vidala; nonché modi diversi di narrare, come l’homenaje, la nostalgia, la baguala.
Un altro strumento tipico denominato o-thara, è ricavato dall’arbusto di una pianta originaria dell’altipiano andino, di cui non si conosce l’eguale, ad esso si affida il “popolo della terra” così detto dei Mapuche, conosciuto come il più grande gruppo indigeno ancora oggi esistente in Sudamerica, che vive nella regione confinante detta “la frontiera” o Araucania prossima al Chile, di cui pure è conosciuta la cultura musicale, ricca di numerosi canti infantili e d’amore. Sempre ai Mapuche si deve il trutruka, uno strumento non bene identificato, ricavato dal seme di una pianta assai rara, o forse anche dal nocciolo di un frutto essiccato, nel quale si soffia all’interno attraverso una stretta fessura praticata in orizzontale che emette un effetto acustico particolare, così che all’ascolto fa pensare a un suono arcaico, quasi “mistico”, come può esserlo un suono emesso dalla medesima natura del luogo.
Dalla Pampa all’estrema punta della Terra del Fuoco c’è un lungo cammino da intraprendere e il viaggio non è certo dei più facili. A renderlo impervio, a meno che non si raggiunga Ushuaia in aereo, è il vento che giunge da tutte le parti e che talvolta spira a forte velocità, ora sferzante e gelido, ora più tiepido quasi graffiante, che ulula nelle orecchie e lascia frastornati. Ushuaia è il punto di partenza della nostra spedizione via mare verso la penisola di Valdés, ed anche della nostra ricerca etnologica dei suoni della natura e delle voci degli animali che la abitano. È una piccola città costruita i primi del ‘900 dai coloni, per lo più inglesi e tedeschi che vi si stabilirono all’inizio del secolo per ragioni di studio. In minoranza vi si incontrano francesi e italiani accomunati da una stessa scelta di vita, per lo più pescatori o cacciatori, qui giunti, insieme ai tagliaboschi e agli estancieros, una sorta di guardie forestali governative, a popolare questi territori ricchi di fauna e di altre ricchezze naturali. E che, dopo la scomparsa degli indios Tehuelche (tribù originaria della Terra del Fuoco) che un tempo stanziavano sul territorio, popolano ormai questa terra affascinante quanto inospitale.
La vita sociale a Ushuaia rispecchia quella di una qualunque città di mare dove la gente parla più o meno delle stesse cose riferite alla pesca, all’andare per mare, alle imbarcazioni, ai motori, forse con meno entusiasmo per la rigidità del clima. Per lo più si lasciano cadere i discorsi e gustare lunghi sorsi di malto d’importazione, o ascoltare la radio che trasmette di tanto in tanto, interrompendo il programma di musica moderna, il bollettino del mare. Il resto del tempo lo si passa a osservare il moto dell’Oceano. Qui si ha la netta sensazione di essere proprio giunti alla fine della strada, poiché la tempesta non cessa mai di urlare e le onde, si abbattono rabbiose contro le coste. Ma basta una giornata meno burrascosa del solito che tutto, per così dire, si rianima. L’intero paesaggio muta d’aspetto. si può anche fare una passeggiata per le stradine del centro commerciale e fare piccoli acquisti di souvenir da portare agli amici increduli e le necessarie calzature di pelo di foca per ripararsi i piedi dal gelo. Tanto da somigliare a quei patagones che Magellano, il grande navigatore portoghese, incontrò durante il suo primo viaggio proprio qui, e che avevano in uso di indossare attorno ai piedi pelli di guanaco, da sembrare autentiche zampe di animale, da cui il nome spagnolo pata-gones.
Ovviamente, di quelli che un tempo furono gli autoctoni, neppure l’ombra, e forse, le rare fotografie di inizio secolo e i disegni che li ritraggono, insieme a piccoli utensili per la caccia e la pesca in mostra nel piccolo e interessante museo di Ushuaia, appartengono a un tempo davvero molto lontano che nessuno ricorda più. Le notizie che li riguardano, raccolte dalle diverse spedizioni succedutesi a partire dalla seconda metà del ‘700, sono per lo più riportate nei diari di bordo dei navigatori spagnoli e inglesi che vi presero parte, e dalle rilevazioni geografiche dei missionari salesiani di cui padre Alberto Maria De Agostini (18) esploratore, fotografo e presbitero italiano, famoso per le esplorazioni della Patagonia e della Terra del Fuoco, fu uno dei fautori. Ordinato sacerdote salesiano, padre De Agostini scelse di diventare missionario nelle zone meridionali dell'Argentina e del Cile, dove i salesiani fin dal 1875 operavano la loro missione a favore degli indios delle etnie Alakaluf, Ona e Yamana dei quali descrisse la vita e le tradizioni. Tra il 1912 e il 1945 affiancò alla propria attività pastorale una nutrita serie di viaggi esplorativi avendo come base logistica Punta Arenas, sulla costa settentrionale dello Stretto di Magellano. Realizzò un'accurata cartografia della Patagonia meridionale e della Terra del Fuoco colmando così varie lacune presenti nelle carte del tempo. Da ricordare il suo contributo alle scienze naturali e all’antropologia: raccolse minerali e fossili, contribuì alla classificazione di numerose specie vegetali, approfondì le conoscenze sulla morfologia glaciale delle zone esplorate. Nei suoi libri, infatti, si trovano riferimenti oltre che agli usi e i costumi, notizia dei diversi idiomi usati e dei caratteri somatici degli aborigeni che li diversificavano dagli europei.
Dalla “Cronaca di Bordo” della spedizione guidata dal navigatore Alessandro Malaspina (19) del 1789, apprendiamo che: “Il giorno 3 di dicembre, avendo saputo dal comandante Pena di varie tribù che erano state avvisate del nostro arrivo, si fecero trovare vicino alla spiaggia. Immediatamente che scendemmo a terra, si presentò sull’alto di un monte poco distante dalla spiaggia, un patagone capo di tribù, e con segni di amicizia che gli facemmo, si avvicinò, senza avanzare però troppo; assicurato poco dopo, per mezzo di altri segni amichevoli, sulle nostre intenzioni pacifiche, si avvicinò comandando un indio che lo seguiva a grande distanza, che lo accompagnasse, e ciascuno presentò al nostro comandante un guanaco, alla cui dimostrazione corrispose con un abbraccio e vari regali di valore. Soddisfatto, il capo chiamò tutta la sua tribù e vennero in numero di 60 persone, 20 erano uomini e gli altri giovani, donne e bambini. Tutti si presentarono a cavallo con più di 40 cani, e dopo essere scesi a terra ci fecero segni di sedersi sopra l’erba, ciò che essi fecero immediatamente. Seguirono poi i regali fatti a ciascuno indio senza escludere le donne e i bambini che apprezzarono in particolare i relicari (reliquari) con nastro di seta rossa, che si misero al collo, e su tutto manifestavano la loro approvazione”.
La “Cronaca” ci relaziona inoltre sui caratteri somatici del tipo indio e del suo modo di vivere: “..i lineamenti generalmente rotondi e con denti proporzionati e larghi, narici ben fatte, poche sopracciglia e capelli neri, molta robustezza nei vecchi, si ungono il corpo con olio, nessun segno di ferite, né altra arma che le bolas per la caccia, fabbricano i loro costumi, i cappelli, e una specie di stivaletti di pelle di guanaco, ballano e cantano in diverse occasioni rituali” (20). Nulla ci dice degli strumenti musicali usati, se ve ne fossero stati di particolari e sulla qualità della musica prodotta, solo “cantano e ballano”, nessun’altra notizia a riguardo, ad esempio, su come cantassero e quali fossero i ritmi e i passi delle loro danze. Tuttavia siamo portati a pensare che la musica presente in questa regione non sia del tutto avulsa da una stretta concomitanza con la natura che l’ha prodotta e che in qualche aspetto conservi ancora aspetti dei suoi caratteri originali, in questo caso specificamente tribali, residuali della tradizione più arcaica. Non è affatto impossibile che caratteri della musica tribale di queste regioni siano perpetrati, in qualche modo, nelle espressioni della musica prodotta oggigiorno, e proprio per la ineluttabile possibilità che, seppure cambiano gli strumenti e le tecnologie, in fondo è di per sé lo stesso l’uomo a governarne il suono, a liberarlo e farlo vivere nel cosmo delle vibrazioni, con i suoi modi e i limiti della sua creatività.
Gli esempi rintracciabili nell’odierna discografia sono molteplici ed eclatanti, a incominciare dal noto sassofonista jazz argentino Gato Barbieri (21) anche detto “el pampero” e ai suoi recuperi etnici, in qualche modo legati alla sua terra di provenienza, l’Argentina, se non altro per la scansione rallentata del tempo, per il raggruppamento onomatopeico delle varianti allungate delle sue sonorità, come ad esempio nella sua “Vidala triste”, un “canto d’amore alla vita” appartenente al folklore sudamericano, in cui vengono espressi i desideri contrastanti dell’anima del gaucho. Ma è forse nell’andamento malinconico, dolente di inespressi ricordi che trovano luogo nell’estrema e sconvolta eredità degli avi, che meglio si riesce a ravvisare lo spirito arcaico dell’indio. La comparazione musicologica ci porta a un altro esempio, un poema sul mistero dell’esistenza narrato da Atahualpa Yupanqui (22): “A quel llaman distancia”, con quello ancora più antico dal titolo “Atqashp”, ovvero la narrazione di un mito in cui – ricordate – si faceva riferimento alle lontane origini tribali dei Qawashqar, entrambi musicalmente contenuti sulla stessa cadenza ritmica, tipica della narrazione andina. L’equivalenza è evidente, Athaualpa di fatto scandisce con il canto la propria narrazione, mentre l’anonimo narratore qawashqarigno adatta il contenuto semantico del racconto, al ritmo che l’accompagna o che si vuole creare, e che è forse il solo, conservatosi, all’interno di queste culture d’altura.
La differenza fonetica della "vidala" è sostanziale, anche se all’orecchio dell’ascoltatore disabituato ciò non arriva, entrambe sembrano due narrazioni dalla stessa identica assonanza, corrispondente di una diversità naturale dei due dicitori. Non è così, più semplicemente si chiama effetto di sostituzione, riguardante il trasferimento di un fatto emotivo personalissimo, all’interno di una sonorità della voce che finisce per contraddistinguere entrambi gli esecutori che si trovano a improvvisare su una sorta di rituale che solo loro conoscono, e mai codificato. Fatto esclusivamente fonografico riguarda la nota composizione della più nota “Misa Criolla” di Ariel Ramirez (23), espressione di un sentimento religioso che riguarda il Sudamerica tutto. Tale è l’intraprendenza dell’animo indio che l’autore ha sentito di impostare la Misa sull’andamento cadenzato e processionale della vidala nel Kyrie di apertura per poi lasciar esplodere l’emozione mistica che essa tramanda al ritmo del carnavalito tipico della tradizione andina. Per restare ai nostri giorni potremmo porre uno di fronte all’altro due esempi di una danza popolare: la "milonga", che ha conosciuto numerosissime esecuzioni e interazioni non solo di genere musicale, quanto di stili di epoche diverse, e che rappresenta una vera e propria tipologia di canto.
Originariamente conosciuta come ballo di strada già nei primi anni del XIX secolo, la milonga possiede elementi della musica africana nella sua struttura ritmica e influenze di danze creole ed europee importate dai colonizzatori spagnoli, a imitazione del portamento e l’andamento nel camminare, nonché nell’atteggiamento macho degli uomini che ostentavano il potere, e subito accalappiato al lazo dal gaucho la cui figura ormai mitica, ne faceva uno stereotipo di rudezza e di grande fascinazione. L'origine della "milonga" è incerta e molto discussa. Si sa, tuttavia, che arrivò nella regione di Buenos Aires attraverso vie diverse, come fenomeno popolare detto “de ida y vuelta” per via che i generi viaggiavano dall'America all'Europa e viceversa acquisendo trasformazioni e adattamenti in ogni regione specifica. Ha somiglianza con altri ritmi come la chamarrita, il choro, il candomblé e la habanera definitisi in altre aree geografiche. Si presume che la "milonga" abbia apportato elementi al tango, che più tardi prese la forma originale della stessa come sottogenere.
L’esempio non è casuale e riguarda una stessa musica suonata dalle migliori orchestre del mondo e cantata dalle voci più efficaci della comunicazione musicale e canora, divenuta patrimonio dell’umanità. Poniamo due esecuzioni a confronto: un tango argentino eseguito da Astor Piazzolla (24) e la sua reinterpretazione dei Gotan Project (25). La differenza sembrerebbe abissale, mentre invece quasi non esiste, sebbene le due versioni siano davvero molto distanti tra loro e coprano uno spazio temporale non indifferente: vuoi per la grande modernità dell’interpretazione dell’uno, vuoi per il recupero a effetto del nuovo gruppo che ripropone, attraverso tutte le interazioni accettate nel tempo, le sonorità di una "milonga" snaturata nei suoni e tuttavia riconoscibile, apprezzabile nella sua nuova veste musicale, tale da rinnovarne il successo popolare, esteso a un pubblico sempre più ampio, vasto quanto l’universo mediale.
Accompagnati dal suono cadenzato della "vidala" che non ci solleva dalle preoccupazioni di carattere meteorologico, ci imbarchiamo al porto di Ushuaia e affrontiamo la traversata del canale detto di Beagle, dal nome del famoso brigantino che un tempo condusse Charles Darwin e Robert FitzRoy (26) nelle loro prime spedizioni al Polo Sud. Il paesaggio alquanto aspro è qua e là coperto di foreste di lenga, un albero tipico di questa regione la cui crescita lentissima è misurabile con lo scorrere del tempo che passa e di cui non ci si accorge, se non per il continuo passaggio instancabile delle nuvole. Da qui, circumnavighiamo per un tratto la costa, per poi immetterci nel Parque Nacional de Hornos, una manciata di piccole isole che segnano il punto cruciale di Capo Horn. L’impressione è quella di andare incontro all’ignoto, oltre l’imperativo vincolante della mente di voler tornare indietro, a sostegno degli appunti di viaggio di C. Darwin che nel 1832 in proposito, così scriveva: “Navigando sullo stretto (di Magellano) avevamo l’impressione che i lontani canali conducessero al di là dei confini del mondo”.
Solo una volta superato lo stupore iniziale ci si rende conto quanto quelle parole fossero, e ancora oggi lo sono, piuttosto veritiere, considerato che le nostre preoccupazioni iniziali si rivelarono all’improvviso, nelle forme di una tempesta di enormi dimensioni, che ci costrinse a stare al chiuso dell’imbarcazione per tutto il tempo, con onde che sembrano impossibili da superare, e che dal Pacifico sembravano volerci scaraventare nell’Atlantico. Non saprei dire a riguardo se fossi giunto alla fine o all’inizio del mondo, solo che lo spettacolo era impressionante, quasi mostruoso. La violenza degli oceani che s’incontravano superiore ad ogni aspettativa, i sentimenti contrastanti di voler vedere e conoscere che mi avevano spinto fin lì e che in qualche modo ancora mi sostenevano, erano costantemente affrancati dalla paura di non farcela a tornare indietro, malgrado le rassicurazioni dei marinai che dicevano di aver visto di peggio. Paul Theroux (27) sembra abbia subito la stessa fascinazione e un identico timore: “A Boston nevicava, quando partii: la Patagonia prometteva un clima diverso, un cambiamento di umore e la possibilità di girovagare in tutta libertà. È lo stato d’animo migliore per iniziare un viaggio. Ero pieno di slancio; solo più tardi, nei viaggi , si capisce che le distanze più grandi ispirano le più grandi illusioni, e che il viaggio solitario è un piacere che spesso si paga”. Ma se quello non era il peggio, allora il meglio dov’era? – mi chiesi. Avrei dovuto saperlo, l’avevo portato con me fin dall’inizio del viaggio, e improvvisamente l’avevo perduto di vista, racchiuso nello spirito d’avventura e di conoscenza che da sempre spingono l’uomo a cercarsi, forse a cercare Dio. “La Patagonia – ci ragguaglia ancora Theroux – era quindi la promessa di un paesaggio sconosciuto, l’esperienza della libertà, la parte più a sud del mio paese, la destinazione perfetta (..) e quando finalmente vi arrivai, ebbi la sensazione di essere approdato al nulla, a un non-luogo. Il paesaggio aveva un aspetto desolato, eppure dovevo ammettere che i suoi tratti erano leggibili e che io esistevo in esso. Questa era una scoperta: il suo aspetto, pensai, in fondo, un non-luogo è un luogo” (28).
Al ritorno, Ushuaia ci accoglie tremanti e spossati per una breve sosta al riparo e per rifocillarci con una tazza di caffè bollente. Quindi si riparte in aereo per Rio Gallegos e di lì in auto attraverso Esperanza fino a El Calafate, dal nome del bellissimo fiore giallo che vi nasce spontaneo, comprensivo della natura che circonda la “meravigliosa” vista del Lago Argentino, con i suoi 1800 chilometri quadrati di acque gelide, solcate da erranti iceberg e popolato da trote e salmoni. El Calafate è punto di riferimento per numerosi scienziati ed ecologisti, fotografi e cineoperatori che qui giungono in ogni stagione da ogni parte del mondo. Indubbiamente la più grande attrattiva di questo straordinario scenario naturale sono i ghiacciai del Perito Moreno, inclusivo del Cerro Torre (3128 mt) e del Fitz Roy (3441 mt), che più d’ogni altro dominano per la loro imponenza, l’unico al mondo in continuo avanzamento verso la barriera dei ghiacciai, la cui pressione provoca la caduta di enormi blocchi di ghiaccio che, con fragore e alti spruzzi, s’immergono nelle acque gelide, per riemergere poi, quasi fossero ripresi al rallentatore, in forma di iceberg e avviarsi nel loro lento peregrinare verso i bracci lacustri. È questo uno spettacolo straordinario, davvero irrinunciabile, che da solo ripaga del viaggio intrapreso.
Lasciata la terra dei ghiacciai ci spingiamo a Puerto San Juliàn e di lì in aereo fino a Puerto Madryn nel Golfo Nuevo. La vista del mare aperto e le belle giornate assolate mi rinfrancano, prima di riprendere il viaggio di circumnavigazione della penisola di Valdès, dove incontriamo Puerto Piramides, una baia di bianche piramidi naturali a picco sul mare, uno spettacolo per gli occhi, tale da sembrare uscita quasi dalla fantasia di un artista, da cui il suo nome. Numerosa la fauna le cui diverse specie trovano in questi luoghi un habitat naturale a loro confacente. A venirci incontro per primi – in senso figurato – sono i pinguini, che tanto somigliano a quei signori in tight che un tempo affollavano le stazioni termali. Qui a Punta Tambo, nel periodo che va da novembre a gennaio, se ne possono trovare fino a 800 mila esemplari tra maschi e femmine. I primi ad arrivare sono i maschi, riconoscibili per le bande scure sul collo e sul petto. Monogami e fedeli, i pinguini si dirigono verso il luogo designato fin dalla nascita, e attendono l’arrivo della compagna, la quale sopraggiunge esattamente dieci giorni dopo, per l’accoppiamento. Numerose sono le foche, ma è forse l’elefante marino l’attrazione esclusiva del luogo. Così detto per la massa carnosa che i maschi accumulano sul naso, rigonfia come una proboscide di elefante, è considerato il più grande dei pinnipedi e può raggiunge i sei metri di lunghezza e pesare fino a quattro tonnellate, mentre le femmine, di solito stese attorno alla loro massa ingombrante, non superano la tonnellata. Questi, letteralmente spalmato sulle rocce della costa dove s’addormenta al tepore dei raggi del sole, si lascia ammirare come qualsiasi grasso signore disteso sulla spiaggia in una domenica d’agosto.
Meta ultima del nostro viaggio è il rifugio delle balene australi che qui, nella Baia di Valdès si possono osservare, insieme ai pinguini, alle foche e ai leoni marini. Si può restare sbalorditi di fronte allo spettacolo offerto da questi enormi cetacei, lunghi fino a 16 metri e del peso di 50 tonnellate, che s’inabissano e riemergano con gravida mollezza in un gioco di spruzzi. Osservare le balene australi, i delfini e le focene è probabilmente la più entusiasmante fra le esperienze naturalistiche, del resto sono animali esclusivi che trascorrono la maggior parte della vita sott’acqua o in zone remote al largo, cosicché osservarli o studiarli può essere molto difficile. La conoscenza della loro distribuzione geografica, del loro comportamento e di altri aspetti della vita di questi animali è in perenne evoluzione. Non si sa nemmeno quante specie esistano poiché ne vengono scoperte sempre di nuove e vi è un costante dibattito sull’opportunità di ripartirne alcune su due o più generi. Mark Carwardine (29) che insieme a Martin Camm, ha curato una “Guida illustrata ai cetacei di tutto il mondo”, ci informa sul whale watching: “È attualmente una delle attività in maggiore espansione in tutto il mondo e coinvolge più di settanta paesi attirando ogni anno più di 4milioni di persone”, che hanno soppiantato pescatori e cacciatori che un tempo operavano in queste acque con scopi strettamente economici.
Egli scrive: “L’eccezionale incontro con una balena, un delfino o una focena, è ancora più straordinario perché, nonostante i molti secoli di persecuzione da parte degli esseri umani, esse ci accettano prontamente come amici. Le balene grigie in particolare sono così aperte e curiose da rendere talora difficile capire che è l’osservatore e chi l’osservato. (..) Questo tipo di esperienza può cambiare la vita di una persona; andare in canoa – ad esempio – è un metodo meraviglioso per osservare i cetacei, anche se è molto importante non spaventarli avvicinandosi troppo silenziosamente. Può essere pericoloso, ma i cetacei stessi sembrano essere consci della loro forza e delle loro dimensioni e, se vengono trattati con le dovute cautele, sono in genere attenti a non causare danni”.
Trovo davvero incredibile come un animale di così enormi dimensioni conosca una simile “delicatezza” quasi da farci sentire goffi. Noi, che della delicatezza abbiamo fatto una virtù estetica, non riusciremmo a essere delicati quanto loro. Eppure è così che ci si è resi conto del loro “cantare”, seppure la parola “canto” è qui usata per descrivere il campione dei suoni prevedibili e ripetibili prodotti da determinate specie di balene o megattere (specialmente la Megaptera novaeangliae) in un modo che ai cetologi ricorda il canto umano.
E se i viaggiatori, gli scrittori in genere ci hanno fin qui impressionato e, al tempo stesso, affascinato con i loro racconti, ancor più noi dovremmo essere conquistati dalla “poesia” che proviene dal “canto delle balene” durante la stagione dell’accoppiamento, facendo supporre che lo scopo dei canti sia aiutare la selezione naturale. Trovo straordinario sapere che le “canzoni delle balene” siano un comportamento competitivo tra maschi che seguono uno stesso potenziale partner, un sistema per definire il territorio o una tecnica di corteggiamento da maschio a femmina e che le balene che occupano le stesse regioni geografiche tendono a cantare canzoni simili, solo con leggere variazioni. Sembra che le balene che vivono in regioni che non si sovrappongono cantano collezioni di unità completamente differenti, e che, man mano che la canzone si evolve alcuni vecchi motivi non vengano rivisitati. Il biologo marino Philip Clapham (30) descrive il canto delle balene "probabilmente il più complesso nel regno animale". In proposito va qui ricordato che una analisi di 19 anni di canzoni di balena ha trovato che, nonostante si potessero ritrovare dei motivi generali nella canzone, le stesse combinazioni non ricorrevano mai.
Così come trovo affascinante che nel ripetersi costante del creato la bellezza trovi pur sempre il posto che gli spetta, anche se noi (esseri umani) ce la mettiamo tutta per distruggere ciò che ne rimane. Anche se un giorno, è accaduto, il Voyager Golden Record (31) ha portato il canto delle balene nello spazio, assieme ad altri suoni che rappresentano il pianeta Terra. Ed è qui, nella penisola di Valdès, che padre Oceano sembra levare il suo profondo respiro e sussultare di soddisfazione quando, con straordinaria destrezza, alcune delle balene che stiamo osservando, per una volta ancora, si lasciano ammirare nel silenzio del profondo mare che le accarezza e in qualche modo le protegge dal caparbio dominio dell’uomo, per trovare la loro salvezza nella sopravvivenza. Ecco, il nostro itinerario s’interrompe qui, con le immagini viventi del creato, mentre in alto, nel cielo solo talvolta terso, la fantasmagoria delle nuvole, che tutto avvolge, muta a ogni mutare del vento, e dà a questo viaggio, un ché di surreale, come fosse sospeso nel tempo. Ed anche se ormai nel mondo rimangono pochi luoghi inesplorati, l’aver dato il nostro contributo alla scoperta di questo continente ci deve rendere molto orgogliosi. In fondo: “La voce umana non potrà mai raggiungere la distanza coperta dalla sottile voce della coscienza (Mahatma Ghandi).
Bibliografia e testi di consultazione:
“Quawashqar: Una investigaciòn etnolinguistica en el Pacifico”, di Christos Clair-Vasiliadis – in Rivista de Estudios del Pacifico, 5 – Valparaiso, 1972.
“Fuegians Songs ”, di E. M. von Hornbostel – in American Anthropologist, 3 1936.
“The Music of the Fuegians”, di E. M. von Hornbostel – in Ethnos, XIII 1948.
Meridiani: “Argentina” Anno XI, n.73, Milano 1998 – e “Patagonia – Terra del Fuoco” Anno XVIII n.143, Editoriale Domus - Milano 2005.
“Balene e Delfini: Guida illustrata ai cetacei di tutto il mondo”, Mark Carwardine e Martin Camm – Dorling Kindersley Handbooks – RCS Libri – Milano 2001.
Bruce Chatwin: “In Patagonia” – Biblioteca Adelphi, Milano 1982.
Bruce Chatwin – Paul Theroux: “Ritorno in Patagonia” - Adelphi, Milano 1991.
Discografia:
Unesco Collection - Philips “Musical Souces: Amerindian Ceremonial Music from Chile”, Berlin/Venice 1975. Emi-Odeon “Musical Atlas: Chile” – commentary by Manuel Dannemann- editor Alain Daniélou –- Berlin/Venice 1976.
“Antologia de la Cancion Folklorica Chilena”, Gaston Soublette, Odeon-Chile 1975.
“Musica Andina e della Terra del Fuoco”, a cura di ClairVasiliadis, Medina, Salas, Stratigopoulou – Registrazioni sonore raccolte sul campo edite dal Centro di Lenguas Indigenaz di Valpàraiso -Albatros VPA 8225 – 1979.
Atahualpa Yupanchi: “A que le llaman distancia” – Odeon-Iempsa 1423 – Perù. E in: “Cancion para Pablo Neruda” – Le Chant du Monde LDX 74540 – 1974 ; “Vidala del Silencio” – Le Chant du Monde LDX 74697 – 1979. Cantautore, poeta, ricercatore, musicista argentino.
Ariel Ramirez: “Misa Criolla” di– Philips SBL 7684 – 1965, compositore e musicista argentino.
Gato Barbieri, “Vidala triste” in “Bolivia” - BMG –jazz – 1973. Ed in: “El Parana”, “Under Fire” e “Carnavalito” in “Fenix”, – Philips 1973. Inoltre:“Hasta Siempre”, in “Chapter Two” e “Milonga Triste”, in “Chapter Three” – Impulse 1974. Jazzman argentino.
Astor Piazzolla, musicista di bandoneon, compositore di Tango argentino: "Concierto para bandoneon - Tres Tangos" - con Lalo Schifrin.Elektra 1988. "Astor Piazzolla e Quintetto di Tango" - RSI 1983.
Gotan Project, gruppo di nuova formazione ispiratosi alla cultura del Tango: "Lunàtico" - Iya Basta! - Records 2006. "La revancha del Tango" - Iya Basta! Records - 2001. "Gotan Project Tango 3.0" - Iya Basta Records - 2010.
Voyager Golden Record, è un disco per grammofono inserito nelle due sonde spaziali del Programma Voyager, lanciato nel 1977, contenente suoni e immagini selezionate al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra. È concepito per qualunque forma di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro che lo possa trovare. La sonda Voyager impiegherà 40.000 anni per arrivare nelle vicinanze di un'altra stella. Le probabilità che venga trovato da qualcuno sono estremamente remote in rapporto alla vastità dello spazio interstellare. Un suo possibile ritrovamento ad opera di una forma di vita aliena potrà avvenire soltanto in un futuro molto lontano. Il suo lancio è infatti visto più che altro come qualcosa di simbolico che non un tentativo reale di comunicare con forme di vita extraterrestri. Attualmente, nel 2010, le sonde Voyager sono due dei quatto artefatti prodotti dall'umanità usciti dal Sistema solare. Gli altri due sono le sonde Pioneer 10 e Pioneer 11, appartenenti al omonimo Programma Pioneer, e lanciate rispettivamente nel 1972 e nel 1973. Ogni sonda Pioneer possiede una placca metallica che identifica il loro luogo e il loro tempo d'origine, per beneficiare altri viaggiatori spaziali che potranno ritrovare le placche in un lontano futuro. « Questo è un regalo di un piccolo e distante pianeta, un frammento dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere ai nostri tempi, ma potremmo farlo nei vostri. » (Jimmy Carter, Presidente degli Stati Uniti d'America).
Note:
(1) Paul Theroux , “Ritorno in Patagonia”, con Bruce Chatwin – Adelphi 1991.
(2) Bruce Chatwin , “Patagonia”, “Ritorno in Patagonia” - Adelphi 1989.
(3) Thomas Falkner, “A description of patagonia” – Hereford 1974.
(4) Charles Darwin , “Journal of researches into the Natural History and Geology of the Countries Visited during the Voyage round the World of H.M.S. Beagle” – London 1902.
(5) Hermann Melville “Moby Dick” – Meridiani Mondadori 1987..
(6) “Qawashqar”, in A. Raùl Cortazar, in “Musica Andina e della Terra del Fuoco”, a cura di ClairVasiliadis, Medina, Salas, Stratigopoulou – Registrazioni sonore raccolte sul campo edite dal Centro di Lenguas Indigenaz di Valpàraiso -Albatros VPA 8225 – 1979.
(7) A. Raùl Cortazar, académico argentino. Abogado y doctor en Letras, uno de los folklorólogos más reconocidos de su país, se dedicó a la docencia y a la investigación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, Folklore General y Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Jefe del Departamento de Folklore del Museo Etnográfico y Director de la Biblioteca Central de la Universidad. Creó el Seminario de Folklore y la Carrera de Licenciatura en Folklore. Libros: “El folklore argentino y los estudios folklóricos : reseña esquemática de su formación y desarrollo”. Buenos Aires, El Ateneo, 1965. “Ciencia folklórica aplicada: reseña teórica y experiencia argentina”. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1976.
(8) “Atqashap” (vedi discografia Atahualpa Yupanqui)
(9) Ibidem
(10) “Chichilli” (vedi discografia“Musica Andina e della Terra del Fuoco”, a cura di ClairVasiliadis, Medina, Salas, Stratigopoulou).
(11) “Sumirunmansanisa” (vedi discografia Unesco Collection - Emi-Odeon “Musical Atlas: Chile” – commentary by Manuel Dannemann).
(12) José Hernández, scrittore, giornalista e poeta argentino. La sua opera più famosa è il “Martín Fierro”, poema epico su un gaucho della pampa, un poema epico argentino scritto da nel XIX secolo. Il poema fu pubblicato nel 1872 con il titolo El gaucho Martín Fierro ed è considerato un capolavoro del genere gauchesco in Argentina e Uruguay. Una prosecuzione dell’opera, intitolata “La vuelta de Martín Fierro” (Il ritorno di Martín Fierro) fu pubblicata da Hernández nel 1879.
(13) Ibidem
(14) J. Luis Borges, Narratore, poeta e saggista, è famoso sia per i suoi racconti fantastici, in cui ha saputo coniugare idee filosofiche e metafisiche con i classici temi del fantastico (quali: il doppio, le realtà parallele del sogno, i libri misteriosi e magici, gli slittamenti temporali), sia per la sua più ampia produzione poetica, dove, come afferma Claudio Magris, si manifesta "l'incanto di un attimo in cui le cose sembra stiano per dirci il loro segreto".
(15) Bartolomé Mitre fu il primo che fissò per iscritto il motivo di “Sacra Pianura”, ispirato nella tradizione orale del gaucho Santos Vega. Il poema "A Sacra Pianura, payador argentino" fu scritto nel 1938 e raccolto in libro di Rime nel 1954.
(16) Atahualpa Yupanchi (vedi discografia)
(17) Ibidem
(18) Alberto Maria De Agostini esploratore, fotografo e presbitero italiano, famoso per le proprie esplorazioni della Patagonia e della Terra del Fuoco. Realizzò un'accurata cartografia della Patagonia meridionale e della Terra del Fuoco colmando così varie lacune presenti nelle carte del tempo. Da ricordare il suo contributo alle scienze naturali e all’antropologia: raccolse minerali e fossili, contribuì alla classificazione di numerose specie vegetali, approfondì le conoscenze sulla morfologia glaciale delle zone esplorate e descrisse la vita e le tradizioni degli ultimi indigeni della Patagonia e della Terra del Fuoco. Il Cile gli ha dedicato un grande parco nazionale nella Terra del Fuoco e il nome di un fiordo lungo 35 km. Opere: I miei viaggi nella Terra del Fuoco, Paravia, Torino, 1928 . Opere: Ande Patagoniche - viaggi di esplorazione nella Cordigliera Patagonica australe , Milano, Soc. Geografica G. De Agostini, 1949. Trenta anni nella Terra del Fuoco, SEI, Torino, 1955. Sfingi di ghiaccio, Ilte, Torino, 1958. Padre De Agostini produsse anche una grande quantità di articoli, pubblicati su varie riviste specializzate. Una scelta della sua vastissima produzione fotografica è stata raccolta su alcuni numeri dei Cahier Museomontagna, editi dal Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino: Ai limiti del mondo. Alberto M. De Agostini in Patagonia e Terra del Fuoco - 1999 La naturaleza en la América austral. Alberto M. De Agostini – 2000.
(19) Alessandro Malaspina, esploratore e navigatore italiano a servizio della Spagna. Dopo aver attraversato l'Atlantico in soli 52 giorni, le corvette si trovarono in rada a Montevideo il 20 settembre, dove vennero stabiliti protocolli per i rilievi astronomici, geografici e cartografici, per l'esecuzione delle raccolte naturalistiche e le riparazioni necessarie alle navi e fu rilevato l'estuario del Río de la Plata prima di iniziare la navigazione verso la Terra del Fuoco dove incontrò le popolazioni della Patagonia a Puerto Deseado, nello Stretto di Magellano.
(20) Ibidem
(21) Gato Barbieri, (vedi discografia)
(22) Athaualpa Yupanchi, (vedi discografia)
(23) Ariel Ramirez, (vedi discografia)
(24) Astor Piazzolla, (vedi discografia)
(25) Gotan Project, (vedi discografia)
(26) Robert FitzRoy, navigatore britannico, celebre per aver condotto in qualità di capitano il brigantino Beagle nel viaggio in Patagonia e nello stretto di Magellano, trasportando come passeggero il naturalista Charles Darwin la cui esperienza fu la scintilla che innescò le sue teorie sull'origine della specie. Durante il viaggio sul brigantino Beagle tiene un diario di bordo sul quale annota le proprie esperienze, proprio come Darwin. Fitzroy è anche considerato uno dei pionieri della meteorologia, egli infatti diede vita alle prime previsioni del tempo.
(27) Bruce Chatwin e Paul Theroux op. cit.
(28) Ibidem.
(29) Mark Carwardine e Martin Camm, “Balene e Delfini: Guida illustrata ai cetacei di tutto il mondo”, Dorling Kindersley Handbooks – RCS Libri – Milano 2001.
(30) Philip Clapham, biologo, in “Lone whale's song remains a mystery”, New Scientist, numero 2477, 11 dicembre 2004: “L'incremento del rumore ambientale nel mondo oceanico causato dalla navigazione è alla base delle lamentele degli ambientalisti sul fatto che gli umani stiano distruggendo questa importante caratteristica dell'habitat marino. Due gruppi di balene, le Megattere e le sottospecie di balenottera azzurra trovate nell'oceano indiano, sono note per la produzione dei suoni ripetitivi in varie frequenze conosciuti come canto delle balene”.
(31) Voyager Golden Record, (vedi discografia).  - Musica
- Musica
Etnomusicologia 1- Musicologia per capire i popoli
“MUSICOLOGIA PER CAPIRE I POPOLI”, di Giorgio Mancinelli (*).
(Studi e ricerche effettuati per “Folkoncerto”, un programma di Etnomusicologia trasmesso da RAI – Radio Tre, e apparsi in numerosi articoli sulle riviste: Big, Super Sound, Musica & Dischi, Nuova Scienza, L’Annuario Discografico, Hi-FI, Audio Review).
Se la musica ha il privilegio di parlare un linguaggio universale, così come è stato ribadito da più parti, ancor più dobbiamo riconoscere ad essa la peculiarità di efficace veicolo di comprensione tra i popoli e, a buon diritto, di far parte delle discipline di studio specifiche che sono fonte primaria di conoscenza, alla quale, pure contribuiscono tutti i popoli della terra indistintamente, nessuno escluso, riconosciuti all’interno del fenomeno di acculturazione. Per cui, in prospettiva della “nuova realtà musicale” quale si è andata delineando in questa nostra epoca di repentini cambiamenti, studiare l’Etnomusicologia assume significato di riappropriazione delle testimonianze più rappresentative della cultura musicale. Pur con le sue accezioni peculiari, vuoi musicali (strumentali), vuoi orali (poetico letterarie), inerenti agli usi e i costumi dei popoli che l’hanno determinata, nel loro effettivo stanziamento geografico. Volutamente rivisitate in quanto “espressioni originali” autentiche, e in grado di restituire, in taluni casi accertati, identità etniche - culturali ben definite, che ci permettono di riequilibrare lo stacco tra passato e presente che ha reso discontinuo il suo percorso millenario.
Non un forzato “ritorno alle origini” dunque, di cui pure si è fomentato negli anni passati dal 50 al 70 del secolo scorso, bensì, voler restituire alla Etnomusica in genere, l’importanza che gli spetta, all’interno del conformarsi della cultura dei popoli, per lo più ignorata dalle varie Enciclopedia della Musica (1) o le diverse pubblicazioni di Storia della Musica (2) che, spesso sottovalutano o appena sorvolano, quelle che sono le componenti “originali” scaturite dalla cognizione musicale dell’uomo primitivo. Cognizioni primarie che pure, in qualche modo, sono giunte fino ai nostri giorni, attraverso la tradizione (memoria del passato), la trasmissione psico-fisiologica (del pensiero), unita al gesto (mimico), al canto onomatopeico (imitativo) e alla danza (riflesso ritmico), cui venivano attribuite determinate peculiarità rituali e particolari scopi specifici all’interno delle tradizioni. Come di provocare stati di estasi (riti iniziatici, esaltazione e trance), che avvicinavano l’uomo al mondo soprannaturale (riti magici), a quello di guarire malattie (musicoterapia, etnopsichiatria, olismo), o in grado di provocare la pioggia (tecnica di suggestione, ipnoterapia, scienza di confine), come pure la possibilità di comunicare messaggi a esseri lontani (viventi), o sollecitare “incontri” con l’al di là (con i defunti, l’avvicinarsi alla divinità, ecc.), oggi studiati in altre discipline specifiche inerenti all’etnologia (studio delle popolazioni), all’antropologia (studio delle differenze culturali tra gruppi umani), alla psicologia (studio del comportamento degli individui e i loro processi mentali), e la fisica (studio dell’acustica e la tecnica del suono).
La musica in primo luogo – essenza fondamentale della nostra ricerca antropologica – va qui considerata un fenomeno in continua evoluzione, intesa come creazione di una comunità che si esprime tramite una costante sintesi di equilibri e soluzioni che si prospettano all’interno di essa. Più in generale, sostanza significativa di possibile rivalutazione e riutilizzazione delle diverse sfere di percezione da parte dei nostri sensi e delle nostre emozioni che, altresì, se la si osserva attraverso l’obiettivo della scienza musicologica, non possiamo che riscontrarne l’esistenza già in quelli che in natura sono oggi considerati i “paesaggi sonori” del nostro quotidiano, quali: il fruscio delle foreste, lo sgretolarsi delle rocce, il sollevarsi della sabbia, lo scorrere delle acque, l’infuriare del vento, la combustione del fuoco, i versi o il “canto” di alcune specie animali e, non in ultima, la meraviglia della voce umana. Ecco quindi, e proprio partendo da queste prime forme naturali, imperniate sulla evidenziazione di una realtà esistente, che lo studio dell’Etnomusicologia assume carattere di “fondamento” sul quale imperniare ogni ricerca sulla musica, vuoi per andare “alla ricerca dei suoni perduti”, che per sviluppare una qualsiasi teoria sulla musica futura, o anche sul futuro della musica, la cui conoscenza, sostenuta dalle attuali apparecchiature foniche e acustiche decisamente avanzate di cui disponiamo, e grazie a una maggiore sensibilità uditiva, ci permette una migliore conoscenza del mondo che ci circonda.
Etnomusicologia dunque, non solo come ricordo del tempo, o come magia e incanto perduto, piuttosto, come mondo da riscoprire, in cui le diverse categorie di suoni percepiti vengono studiate come veicolo di comunicazione e di scambio per la comprensione tra i popoli. Come ha evidenziato in passato Alain Danielou (3): “L’uomo impiega, al pari degli animali, dei suoni per comunicare, e spesso è difficile distinguere gli elementi articolati, che noi chiamiamo linguaggio, da quelle emissioni di voce contraddistinte all’altezza del tono e dalla durata, che sono alla base della musica. Non a caso esistono, infatti, lingue tonali, recitazioni cantate e strutture musicali proprie del linguaggio parlato (..) che nel tempo hanno sviluppato forme musicali libere da qualsiasi funzione sociale, le quali, proprio perché svincolate da presupposti rituali, hanno progredito rapidamente sulla via del perfezionamento tecnico e del raffinamento del gusto”. In breve, non si conoscono popoli, fin da quelli primitivi ad oggi, che non abbiano conosciuto o che non conoscano una qualche forma musicale, sia che rientri nella propria cultura etnica (ritualità tribale) o faccia parte del proprio habitat naturale (rocce parlanti, vulcani tonanti, alberi suonanti, animali canterini), da cui l’uomo ha appreso la “formula” talvolta impregnata di magia, della musica esistente nel creato.
Quindi, prima di parlare d’altro, è bene sapere che l’apporto della fisica relativo ai fenomeni acustici, contrassegna il primo passo nello studio scientifico in Etnomusicologia. Invero ogni suono della natura è un evento fisico relativamente complesso in quanto consiste nella trasmissione attraverso aeriforme, liquide o solide, delle vibrazioni provenienti da un corpo (materia) entrato in movimento, che può essere considerato in funzione del tempo, cioè dall’inizio alla fine delle vibrazioni, oltre che in funzione della forma esatta dell’onda delle frequenze e dell’intensità delle componenti vibratorie. Forma che può differire negli ascoltatori, in relazione al grado di attenzione e alle loro aspettative. Secondo Peter F. Ostwald (4): “Allorché le vibrazioni raggiungono quei recettori sensibili che sono le orecchie, sollecitano una grande varietà di percezioni, che diversi gruppi di specialisti hanno contraddistinto in: rumore, suono e linguaggio. Così, sappiamo che il rumore per lo più viene classificato nella categoria dei suoni con effetto importuno o molesto, spesso causa di tensione, irritabilità, molestia o dolore effettivo, in grado, se improvviso, di far trasalire”. Un argomento quest’ultimo di difficile argomentazione, e tuttavia ampiamente trattato dal noto neurologo e psichiatra Oliver Sachs (5) nella sua teoria sulla musicofilia.
Ciò per dire che lo studio fisico delle onde sonore, sebbene sia oggi sostenuto da più sofisticate tecnologie, può definire le qualità dei suoni e la quantità dei rumori suscettibili di ferire l’orecchio o il resto del corpo, ma non può definire esattamente cos’è il suono, come neppure cosa sia il rumore, poiché in entrambi i casi, i fattori umani (età, capacità uditive dell’individuo, gusti e maniere di sentire variabili nel tempo ecc.), vi sostengono un ruolo preponderante. Non per questo si pretende che ogni rumore debba essere eliminato, bensì controllato e fatto oggetto di studio per meglio conoscere quali sono le problematiche causate dai rumori cui gli individui (ma anche gli animali) si vanno adattando e con quali invece riescono a convivere, e come intervenire per risolverle. È questo uno dei grandi meriti riconosciuto al “World Soundscape Project”, qualificato come progetto per l’ambiente sonoro, lanciato negli anni ’80 dal compositore canadese R. Murray Schafer (6) e dai suoi colleghi di Vancouver (di cui si tratterà in altro capitolo). Ai fini della nostra ricerca è importante almeno conoscere quelle che sono le peculiarità fisiche del nostro corpo, o almeno dei nostri sensi, a cominciare da quello uditivo, ahimè transitorio, in ragione del fatto che tutto ciò che è suono, è recepito per lo più, una sola volta, nel preciso istante in cui esso avviene.
Perché il fenomeno vibratorio produca nell’uomo la sensazione sonora, le frequenze delle vibrazioni non devono essere inferiori a 16 HZ, al di sotto della quale si hanno i cosiddetti infrasuoni mentre, al di sopra dei 12.000 Hz, si hanno gli ultrasuoni, entrambi non specificamente rilevabili dall’orecchio umano. Le onde elastiche di frequenza inferiore, o maggiore di detta soglia, pur giungendo al nostro orecchio, non sono in grado di provocare alcuna sensazione uditiva. Solo nel caso di una tensione uditiva in cui le nostre orecchie divengono ricettive al massimo, si registrano e riconoscono rumori che, in generale, non sentiremmo. I fisiologi a un certo punto della ricerca sulle possibilità uditive, hanno optato per la teoria che ogni orecchio si crea una “soglia” fissa e che un suono non può essere percepito finché non raggiunge una certa intensità idonea a superare suddetta soglia. Adesso noi sappiamo che questa è una semplice teoria che può essere vera per un piccolo gruppo di suoni relativamente puri, emessi in laboratorio in condizioni controllate, ma che non è applicabile alla maggioranza dei rumori. In breve, chi (tra gli studiosi), infine, volesse giungere a una definizione oggettiva del singolo fenomeno, deve ripiegare su una definizione soggettiva (e filosofica): il “suono” è senz’altro una sensazione particolarmente piacevole, mentre il “rumore” pur essendo un suono, è ancorché indesiderabile.
Scrive Alessandro Bertirotti (7): “I suoni usati nella pratica musicale classica (escludendo quindi i casi riguardanti la musica elettronica) sono prodotti da vibrazioni variamente complesse e proprio dalla complessa composizione di un suono dipende fondamentalmente il suo timbro. È interessante ricordare come, già nella metà dell’Ottocento, il fisico tedesco Helmholtz riuscì col semplice utilizzo di opportuni risonatori a scoprire importanti caratteristiche della voce umana, portando in evidenza proprio la complessa composizione dei singoli suoni. (..) Inoltre, egli riuscì anche a compiere, almeno in via approssimativa, l’operazione opposta all’analisi, cioè la sintesi dei suoni: combinando, con le intensità convenienti, i suoni di vari diapason, riuscì a riprodurre sensibilmente le vocali. Questo ormai non fa più effetto oggi, che siamo abituati a sentire macchine che parlano con voci umane ma, se si pensa che i suoi lavori risalgono alla metà dell’Ottocento, è possibile apprezzare in pieno il valore dell’intuizione e della sua capacità sperimentale”.
Lasciamo dunque agli studiosi di acustica e sonorizzazione di illuminarci sui rapporti che esistono tra la fisica e la musica in riferimento agli eventi che determinano la percezione del suono, così come ai musicologi di scrivere la storia, date e luoghi degli avvenimenti sociali che hanno determinato le diverse teorie sulla musica, ed inoltriamoci, non privi di interesse ed entusiasmo, negli antri della natura che ci circonda alla scoperta dei “suoni originari” che ne sono parte: “I suoni della natura che l’uomo ha recepito sin dalle più lontane origini - scrive ancora A. Bertirotti (8) – entrano a far parte del repertorio cognitivo umano e si selezionano come memoria della specie. Da questo “serbatoio” l’uomo trae gli strumenti atti ad elaborare musica e a fruirne. Anche il “problema della notazione musicale” diviene essenziale per una ricerca sulle origini e gli sviluppi dell’oggetto-soggetto sonoro. Il suono che diventa musica si configura come una delle espressioni privilegiate nelle quali gli uomini possono riconoscersi e rappresentare le proprie emozioni. Poiché la musica esiste quando è eseguita, la notazione musicale raccoglie in sé la memoria delle pratiche sociali dalle quali deriva: traduce in simboli le condotte sonore di chi la produce, di chi la esegue e di chi ne fruisce. La notazione scritta (delle culture alfabetizzate) consente la riproduzione esatta di un messaggio complesso come un brano musicale. Nelle culture orali invece, la trasmissione della musica è soggetta a variazioni e la musica viene ricreata da capo ad ogni nuova esecuzione, ed è ciò che noi chiamiamo improvvisazione. In questo contesto, è importante la fenomenologia culturale per la creazione dell’opera d’arte e per la sua fruizione. Se si pensa che a partire dalla Bibbia ogni forma di creazione è sempre collegata ad un suono, la relazione circolare suono – uomo – suono si configura come punto di inizio e motore fondamentale dello sviluppo della specie”.
In qualche modo va detto che il recente interesse riservato all’Etnomusicologia come disciplina di studio all’interno delle Università, comporta una formazione di base più evoluta di quanto si creda, che trova fondamento nella “ricerca” ai fini della conoscenza antropologica dell’individuo che è l’uomo, e che va oltre quindi, lo studio di quelle che sono le fonti, per così dire, “archeologiche” della disciplina, per inoltrarsi nella memoria dei popoli di ieri come in quelli di oggi che, incredibile a dirsi, non mancano di esempi eclatanti, pur senza trascurare il contesto culturale in cui la musica popolare si è formata e continua a diffondersi. Circostanza questa rivelatrice della costante contaminazione che essa opera all’interno dei diversi stili conosciuti e delle rispettive tendenze: dalla beat generation, al punk, a quella così detta wave, new-age o ethnic ecc., fino alle più recenti iterazioni e rivisitazioni legate ai fenomeni musicali più evoluti. Non escluso il rock che pure, malgrado le sopravvenute trasmigrazioni, tuttavia non si è mai posto in contrasto con essa. Ed è proprio al pop - rock che, va riconosciuto l’aver esteso l’obiettivo della musica popolare nel suo intento di “riconoscimento” e di “approvazione” delle nuove generazioni, e che infine l’ha trainata fino alle soglie della street-music così detta, dai rapper o che dir si voglia, dai breakers di strada, con l’aggiunta di assonanze ritmiche e melodiche nuove e talvolta inusitate, di cui non si avvale la musica più avanzata, elettronica e minimalista, definita ora house, techno, minimal, ora trance, dub-step, dance, vintage, e che, grazie alle sue capacità, è in grado di trasportare l’ascoltatore in luoghi e tempi fuori della sua dimensione abitudinaria.
Tantomeno dobbiamo disconoscere che, nell’arduo cammino che ha attraversato, la musica etnica così detta, o anche quella folk - popolar tipica d’oltre oceano, da sempre, trova nella musica colta (acustica, sinfonica e operistica) lo scrigno della propria sopravvivenza, condividendo con essa, almeno in parte, quell’alone di indiscussa notorietà che questa ha saputo diffondere nel mondo. Circostanza questa, che ha salvato molta musica etnica dalla dimenticanza cui altrimenti era destinata, ancorché spogliata delle scorie del passato, trova oggi, ampia diffusione nella rivisitazione discografica, non solo come risposta “documentaristica” confacente agli scopi della ricerca musicologica. In tal senso, più appropriata alla sua funzione socio - culturale che continua a svolgere una volta superata la barriera dell’incomprensione linguistica e dell’ibridismo di alcune sonorità stridenti che, guarda caso, almeno in alcuni casi eclatanti, pure ne amplia la sua effettiva dimensione di messaggio, fino a divenire sollecitazione e stimolazione dei sensi e della percezione, uno dei tanti aspetti vitali di cui si pensa fosse composta la musica delle origini.
L’ibridismo innocuo di cui la musica di nuova generazione spesso si compone può anche essere vantaggioso poiché trae da una cultura affine elementi che funzionano da catalizzatori e arricchiscono la tradizione stessa partecipe di una determinata cultura. Tuttavia diventa nocivo quando tenta di applicare strumenti e stili diversi inerenti di una tradizione ad un’altra assolutamente incompatibile. Cioè, invece di prendere in prestito elementi costruttivi capaci d’imprimere nuovo vigore alle tradizioni musicali di un certo paese, prende in prestito elementi incompatibili con i principi fondamentali della musica di quel paese, il che ne determina un ibridismo talvolta inaccettabile. Esempi eclatanti di ibridismo musicale si rilevano in alcune regioni dell’Asia e in Africa che, secondo il parere di Tran Van Khé (9): “..impoverisce e talvolta distrugge addirittura il carattere nazionale delle tradizioni in questione è ciò che avviene nella maggior parte dei casi, allorché la musica dell’Oriente o dell’Africa viene a contatto con la musica occidentale. E quando i musicisti orientali o africani di oggi accompagnano i canti basati sulle loro particolarità sonore con un pianoforte accordato su una scala ugualmente temperata, o peggio ancora usano clarinetti, sassofoni e finanche chitarre elettriche per eseguire la musica tradizionale, punteggiando le frasi di essa con gli accordi e gli arpeggi ordinari, cioè con quelli della scala diatonica occidentale”..
Un argomento questo davvero interessante che però ha scatenato qualche polemica nel mondo dei compositori e fruitori della musica come Dimitri Shostakovich (10): “Considerando ogni cultura di pari valore e di pari interesse, è il caso di domandarci in quale misura e in quali modi i mezzi di espressione musicale, elaborati da un popolo nel corso di lunghi secoli, possano essere recepiti da un altro popolo e sottoposti a norme artistiche diverse. Contrariamente a quanti hanno sollevato la questione, per me tutt’altro che chiara, dell’incompatibilità dei sistemi modali ed armonici e nella nocevolezza che questi recano all’eredità culturale dei paesi orientali o africani i mezzi polifonici o armonici della musica europea, o ancora del beneficio che recano, al contrario, gli elementi musicali di paesi culturalmente affini”. Qui l’autore sembra porsi in polemica con Tran Van Khé, il quale, basandosi sulla specifica dell’ibridismo in musica, parla di incompatibilità tra i diversi sistemi musicali. “Per me – ribadisce Shostakovich – non si tratta di sapere se vi è incompatibilità e compatibilità tra diversi sistemi musicali, perché mi sembra che il problema delle interazioni musicali tra popoli etnicamente diversi e geograficamente lontani può essere risolto unicamente dalla sensibilità artistica e dal talento di compositori, esecutori, insegnanti e musicologi, come anche dalla loro sincerità e onestà”.
Certo, si può incorrere nel pericolo di approcci sconsiderati o, peggio ancora, basati su interessi commerciali; e si può essere indotti a trascurare per negligenza o superficialità una tradizione musicale che può rappresentare un grande apporto al patrimonio culturale dell’umanità. “Un atteggiamento irriflessivo – scrive ancora Shostakovich – può produrre un’esecrabile standardizzazione e far smarrire irrimediabilmente le proprie ricchezze nazionali. Ma d’altra parte, non si deve impedire all’arte (musicale) di un popolo di beneficiare di contatti con le manifestazioni artistiche di un altro popolo, né opporsi a prestiti di elementi da un sistema di linguaggio musicale ad un altro. Tra i motivi naturali e legittimi che spingono una tradizione musicale sulla via del continuo progresso, non solo dobbiamo annoverare il contatto diretto con la realtà mutevole, cioè con il rinnovarsi perenne delle condizioni ambientali e la conseguente presa di coscienza di nuove istanze e nuove concezioni di pensiero, ma dobbiamo includere altresì la capacità di assimilare la produzione di altri paesi”. Che è poi quanto in realtà accade quando ci avviciniamo alle culture più evolute, diversamente quando ci addentriamo in quelle che per qualche ragione sono rimaste alla primitiva concezione di base, e cioè allo stato genetico del loro sviluppo.
Riprendiamo invece a parlare della “musica delle origini” che, ahimè dobbiamo ammetterlo, non siamo in grado di recuperare perché connessa con il fattore tempo che ci allontana da essa ormai, e che nessuna persona vivente è più in grado di ricordare. Tuttavia alcuni suoni del passato li possiamo recuperare perché connessi con fenomeni geologici o meteorologici che possiamo chiamare eterni o anche (secondo la nota teoria junghiana) “archetipici”, come lo scoppio del tuono o il frangersi delle onde sugli scogli ecc. pur tuttavia riproducibili. Mentre di altri, appartenenti ai tempi della preistoria acustica, come ad esempio i rumori di alcune attività umane che, sia pure limitatamente, sussistono ancora, possiamo formulare congetture rimettendo insieme gli elementi in gioco, quali possono essere alcune testimonianze ancora valide dell’antica vita sociale e della sua organizzazione dello spazio, ma che non ci aiuta molto a ricostruire, quanto è andato perduto dello spazio-tempo. Per il fatto che la musica di per sé corrisponde a un effimero inalienabile, nel senso che ogni rumore o suono che è possibile captare ad un dato momento, risale solo a pochi istanti prima, e che quindi non è mai antico.
Ne sono un esempio utile i segnali provenienti dalle stelle che hanno certamente impiegato molti anni luce per raggiungere la terra, ma non si può dire che essi abbiano molta importanza nel nostro ambiente acustico. Mentre la rapida estinzione dell’energia sonora (oggigiorno captabile), unita alla nostra limitata capacità di udire, fa sì che anche il più forte rumore, pochi istanti dopo la sua emissione, non sia più afferrabile. Concludendo, per noi recuperare i suoni del passato è infinitamente più difficile che ricostruire l’immagine visiva di un “paesaggio” verosimilmente esistito. Mentre, tranne uno scarsissimo repertorio, registrato in massima parte in laboratori (elettronica) o studi di registrazione (effetti acustici e sonorizzazioni), non rimane alcuna traccia di quanto risuonò un giorno intorno all’uomo, delle antichissime cosmogonie precedenti la creazione e che Marius Schneider (11) definisce “Quella realtà spesso descritta come un’oscurità sonora in cui nulla è ancora solido e tutto è vibrazione musicale, e la creazione stessa come l’atto sonoro originario, come un paesaggio graduale a oggetti sempre più solidi e silenziosi”. Di cui la musica è senza dubbio la più antica allegoria possibile che si riconduce alla sua essenza, spiega le connessioni tra musica e magia, il rapporto tra parola e suono, la funzione simbolica dei suoni vocali e strumentali, la struttura linguistica di ritmo-melodia e armonia.
Apprendiamo così che, l’insieme della cultura musicale e tutto ciò che ad essa ruota attorno, si rivela uno dispositivo fondamentale “per la conoscenza di chi siamo”. È questa un’osservazione talmente ovvia da non sembrare necessario soffermarvisi e riflettere sul suo significato. Eppure, anche quando con i primi studi antropologici, ci si è accorti che l’essere consapevoli della propria esistenza, non è dato scontato per tutti allo stesso modo, non ci si è preoccupati – almeno non a livello educativo e scolastico – di supportare una campagna a sostegno della ricerca Etnomusicologica fondamentale di quella “cultura primaria” che associata, a una necessaria e quanto mai dovuta “presa di coscienza”, è in grado di restituirci la consapevolezza dell’immenso “dono” che ci è dato, determinata dal fatto che la musica, alla stregua delle altre arti, va considerata patrimonio di tutta l’umanità. Mi piace qui sottolineare un’intrigante intuizione di Marcel Mauss (12) che, con il triplice obbligo di dare, ricevere e ricambiare, il dono costituisce un “fenomeno sociale totale” a cui fare riferimento, all’interno di una sorta di prerogativa universale, e che va visto come un corpus unico e irripetibile del passato della cultura di un popolo, pur con le sue diversificazioni e interazioni, le sue eredità peculiari e speculari, che per la tipologia umana che autenticamente lo ha corrisposto. Fatto, questo che ha permesso allo stesso Mauss di affermare: “che tutte le società arcaiche, siano esse considerate “selvagge” o “primitive”, o “senza stato”, pensano se stesse e pensano il loro universo e perfino il cosmo, nel linguaggio del dono”, di cui la musica – aggiungo – figura tra i beni materiali di cui ogni giorno usufruiamo.
Naturalmente, pur con evidente riserva, credo che una tale affermazione teorica non possa essere dimostrata induttivamente mediante accumulazione di esempi, ma soltanto possa valere finché confutata sul piano psicologico o forse olistico (religioso) al di fuori di ogni possibile ricerca, malgrado si abbia la sensazione che si stia parlando di un puro miraggio, che quindi avrebbe comunque un’esistenza soltanto ideologica. Donde il problema che si pone a tutti e a nessuno del perché popoliamo questa terra, perché si sono formate le comunità umane, perché della nostra stessa esistenza, ecc. Non a caso il tema del dono (ricevuto) è qui messo in maggiore risalto sulle altre preposizioni della ricerca, allo scopo di suffragare l’ampio materiale etnomusicologico che abbiamo a disposizione. Se esso sia sufficiente e abbastanza eloquente da risultare infine dimostrativo, è un fatto che va oltre il campo di investigazione, poiché il materiale di osservazione, qui di seguito riportato, per quanto con proposito letterario, è al dunque esclusivamente di natura cartacea, e richiede di essere sostenuto da altrettanto materiale sonoro corrispettivo come quello da me ascoltato e annotato, e riportato nell’ampia sezione discografica inclusa al termine del capitolo.
Alcuni studiosi affermano – e non sempre a torto – che l’ascolto di un disco di folklore esclude da una partecipazione attiva e pertanto non raggiunge lo scopo “creativo” proprio della musica popolare. In breve, tutto ciò che è inciso, presentato, illustrato è artefatto ma, se è vero che il manufatto discografico non permette di trovare una unità di sintesi, quale invece si riscontra nella partecipazione al “fatto” musicale, poiché è annullata la distinzione tra artista e pubblico di una rappresentazione, che invece vive ogni insita “espressione” con tutto il corpo in una sorta di comunicazione totale. Tuttavia, quello che qui importa annotare, è che il “modello” che ha caratterizzato finora la cultura orale nel senso più ampio del termine, in quanto basato sulla ripetizione ciclica di eventi secolarizzati, non è diverso da quello annotato dai primi studi antropologici o etnologici effettuati dai ricercatori nell’800 e ancor prima. Oggi, seppure con metodi diversi, quello stesso modello si rende indispensabile alla continuità della vita di gruppo di molti popoli di tradizione, così come pure, definisce la specifica estrazione sociale che lo caratterizza, sia che si tratti degli Aborigeni australiani, degli Indios amazzonici, degli Zingari di cultura Rom, dei Peul o dei Bantu africani, dei Tuareg o di altre popolazioni nomadi Sahariane, ecc. (solo per citarne alcune).
Tanto per fare un esempio piuttosto banale prendo a caso l’espressione entrata nell’uso comune che viene spesso attribuita a certa musica, dal gusto “pittoresco” o quanto meno “folkloristico”, detta con l’inflessione della lingua anglosassone con la quale spesso la si usa etichettare e che, in qualche modo, pure la contraddistingue, conferendogli una definita identità. Testimonianza questa, che ci consente di riconoscere una dignità culturale specifica, distintiva di molti popoli più o meno conosciuti in seno alla sempre più evoluta popolazione delle nazioni, per cui andare alla ricerca delle loro “origini” linguistiche, o tracciare le linee di un modello culturale che possano aver perseguito, come pure evidenziare i caratteri originali di cui si compone la loro tradizione musicale, assume significato di andare alla ricerca della “memoria del tempo” e di quanto ci permette di ripercorrere l’intero arco ciclico socio-musicale dell’umanità. È quanto più rientra nel lavoro dell’Etnomusicologo, il cui impegno dev’essere meta e linea di partenza di un percorso ancora tutto da scrivere. Etnomusicologia dunque, come acquisizione di un maggiore bagaglio culturale, per un sempre maggiore impegno sociale nella conoscenza di popoli e paesi “altri” dal nostro, che si aprono a noi e ci svelano i loro segreti e le loro gemme musicali, i loro riti, le usanze e i costumi. Rendendoci partecipi del loro mondo fantasmagorico, di colori, di note, di suoni, di strumenti, di canti e di balli che hanno conosciuto la notte dei tempi, molti dei quali, mantengono ancora oggi tutto il fascino del loro mistero. Ma è bene che lo scopriate da voi stessi.
Bibliografia, discografia e altro:
Il ricercatore e lo studioso, o chiunque voglia essere introdotto all’Etnomusicologia, possono fare oggi affidamento su moltissimo materiale di consultazione, edizioni librarie e discografiche, documentari e registrazioni d’epoca, speciali allestimenti di mostre e simposi su diversi argomenti inerenti ai differenti argomenti di ricerca, indetti da Centri Culturali, Musei di Antropologia e delle Trazioni Popolari. Inoltre, molte Librerie hanno allestito al loro interno un reparto specialistico in cui è possibile trovare oppure ordinare molti testi un tempo introvabili, grazie a ristampe e quant’altro riferite a E. De Martino, Pitré, G. Nataletti, D. Carpitella, R. Leydi, Lombardi-Satriani, C. Tullio Altan, Pinzauti, Di Nola, Mircea Eliade, A. Danielou, J. G. Frazer, Metreàux, Malraux, E. Burnett-Tylor, B. Nettl, M. Freedman, Levi-Strauss, A. Lomax, Renè-Guenon, C. Sachs, M. Schneider, Leroi-Gourhan, Alexei A. Léontiev e tantissimi altri. Ed anche ristampe nozionistiche sul folklore meso-americano, le religioni indiane, e del lontano Oriente, nonché la ricerca archeologia degli strumenti musicali, i riti e le usanze sessuali degli aborigeni, gli ultimi popoli “primitivi” della terra, ecc.
In discoteca, sono rilevanti le produzioni discografiche riguardanti questa o quella popolazione, curate da famosi musicologi, etnologi e studiosi del folklore. In Inghilterra, la Oxford University Press, in collaborazione con la His Master ‘s Voice, ha pubblicato un’importante collana dal titolo: “The Music in Sound” che va dalla musica dei primordi fino alla musica moderna attraverso le sue fasi evolutive. Giunta alla sua X ristampa, si compone di 25 LP, accompagnati da piccoli volumi esplicativi che ne illustrano l’intero contenuto. Relativa all’Organizzazione Internazionale UNESCO, sottopongo all’attenzione di quanti operano nel settore della cultura le collane musicali: “Antologia della Musica Africana” (14 vol.), “Antologia Musicale dell’Oriente” (26 vol.), “Antologia della Musica Classica dell’India del Nord” (4 vol.), dirette dal noto studioso Alain Danielou per conto della Musicaphon-Barenreiter (Germania), oltre a quelle prodotte in Italia “Musical Atlas” alle quali ho prestato la mia collaborazione. Si tratta di un vero e proprio Atlante geografico della Musica, un insieme di documenti sonori (36 LP) che raccolgono le testimonianze linguistiche e musicali d’ogni gente e paese, accompagnati da testi esplicativi in italiano, francese e inglese, che ne facilitano la comprensione. Riuscendo a ricreare, pur nel limitato spazio di una registrazione sonora, una visione esemplificata delle caratteristiche e delle componenti tradizionali dell’arte musicale di ogni popolo.
Altro importante contributo alla ricerca Etnomusicologica è quello prodotto dall’Editoriale Sciascia, la cui produzione nelle due collane pubblicate: “Albatros” e “Zodiaco” hanno assunto raggiunto una fisionomia piuttosto unica nel settore discografico, riscuotendo notevole successo tra il pubblico più giovane. Un encomio particolare va alla collana “Albatros” per le note di copertina sempre ricche di nozioni, affidate a veri ricercatori della materia; con registrazioni “sul campo” curate da Leydi, Carpitella, Lomax e moltissimi altri. Notevole anche la produzione della Argo-Decca: “The Living Tradition”, risultato di quindici anni di ricerche che l’esperto di etnologia Deben Bhattacharya ha registrato “dal vivo” (75 vol.); autore, inoltre, di molti articoli e libri sull’Etnomusica, nonché arrangiatore delle colonne sonore dei suoi molteplici documentare filmati in giro per il mondo.
Per gli amanti dell’attualità, segnalo per la Decca i due album dedicati alla Cina: “Chants Traditionnels de Chine” e “Musique Traditionnels de Chine”, entrambi contenuti in una veste grafica splendida. Registrati “dal vivo” da Pierre d’Ursel i due album raccolgono i canti e le musiche tradizionali del Tibet, Gansu, Shansi, Taiwan, Quingai, in cui sono raccolte cerimonie religiose e altri riti cerimoniali cinesi proposti dall’Opera di Pechino.
Note:
(*) Giorgio Mancinelli, giornalista free-lance, ricercatore e studioso di antropologia, saggista, programmatore radiofonico per la RAI “Folkoncerto”, “Maschere rituali”; RSI - Radio della Svizzera Italiana “Itinerari Folkloristici”, “Il canto della terra”; Radio Vaticana “Il Cantico di Natale”, “Pasqua di resurrezione”. Ha collaborato col Prof. Alain Danielou alla collana di Etnomusicologia “Musical Atlas” per l’UNESCO-EMI, e la pubblicazione di articoli e reportage su diversi quotidiani e riviste di settore. Libri: “Anno Domini: Usanze e costumi della tradizione natalizia” - Grafica & Arte Editore 1992. “Gli Zingari: Usi e costumi di un popolo nomade” – Lato/Side Editore 1994. “Arpaderba: una fiaba ecologica” – illustrata da Mariaelisa Leboroni – Perugia 1998; “Musica Zingara: Testimonianze etniche della cultura europea” - Firenze Atheneum 2006, vincitore del Premio per la Saggistica Italiana “L’Autore” 2006. Attualmente collabora con alcuni siti web ed ha all’attivo inediti tra romanzi e short stories.
(1) “The New Oxford History Of Music” vol.1 – Oxford Press – London - per l’Italia Garzanti-Feltrinelli – Milano 1991.
“Enciclopedia della Musica” – Garzanti, Milano 1996.
“The Larousse Encyclopedia of Music” – The Hamlyn Publishing Group – London 1978.
“The world of music”, Journal of the International Institute for Comparative Music Studies – Berlin in association with The International Music Council (UNESCO). Chairman of the Board: Alain Danielou.
(2) “Breve storia della Musica”, Massimo Mila – Einaudi, Torino 1963.
“La Musica Primitiva”, Marius Schneider – Adelphi, Milano 1992.
(3) Alain Danielou - Editoriale in Il Corriere Unesco (Anno XXVI – Giugno 1973.
Saggista e filosofo, oltre a essere il curatore delle collane sopra riportate, è stato consigliere emerito presso il Consiglio Internazionale della Musica Africana e Asiatica, ha diretto l’Istituto di Studi Comparativi della Musica – Venezia Fondazione Cini. Ha scritto saggi sulla filosofia indiana, traduzioni dal sanscrito (la sua collezione di manoscritti sanscriti sulla musica è una delle più importanti al mondo); ed opere come “The Ragas of Northern India Music” (2 vol.) – Londra 1953. “Le Politheisme Hindou” – Parigi 1960. “Situation de la Musique et des Musiciens dans les pays d’Orient” – Firenze 1971, e “Traité de Musicologie Comparée ” – Unesco Collection e in “Trattato di Musicologia Comparata” Lerici – Cosenza 1977.
(4) Peter F. Ostwald: “Psicologia del rumore” in Il Corriere Unesco (Anno XXVI – Giugno 1973.
Psichiatra e pedagogo è un’autorità in materia acustica e di linguistica applicata ai problemi della sanità mentale e della malattia. Professore di psichiatrica alla Scuola di medicina, Università di California, San Francisco U.S.A. Sua opera più importante: “Communication and Human Interaction” – New York 1977.
(5) Oliver Sacks: “Musicofilia” - Adelphi, Milano 2009.
Medico e scrittore, vive a New York dove insegna neurologia e psichiatria alla Columbia University Artist. È autore di molti libri, fra i quali “Risvegli”, da cui è tratto il film che 1990 ebbe tre nomination agli Oscar. “Ogni storia cui l’autore dà voce illumina uno dei molti modi in cui musica, emozione, memoria e identità s’intrecciano, e si definiscono. Forse la musicofilia è una forma di biofilia, giacché noi percepiamo la musica quasi come una creatura viva” (dalle note di copertina).
(6) R. Murray Schafer: compositore, fondatore e direttore del World Soundscape Project, Progetto Mondiale dell’Ambiente Sonoro da lui ideato per promuovere una nuova ecologia del suono, sensibile ai crescenti problemi dell'inquinamento acustico, con il testo “The Tuning of the World” (1977), tradotto in Italiano con il titolo “Il paesaggio sonoro” 1980. Ha studiato al Royal Conservatory di Londra e all'Università di Toronto e per molti anni ha insegnato alla Simon Fraser University di Vancouver. Una personalità eclettica tra le più interessanti della musica contemporanea nordamericana, e nel 1987 è stato insignito del premio Glenn Gould e nel 2005 del Walter Carsen Prize, attribuitogli dal Canada Council for the Arts.
(7) Alessandro Bertirotti: in “Etnomusicologia e antropologia della musica” – Seminario tenuto all’interno del Corso di Etnologia (dispense a. a. 2001-2002), Università degli Studi di Firenze. È scrittore, ricercatore, docente universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. L'unico docente italiano che si occupa di Antropologia della Mente presso la facoltà di pedagogia di Firenze, dove è docente di Antropologia culturale e della mente. È direttore scientifico della collana antropologia e scienze cognitive della Bonanno Editore, membro della direzione scientifica della rivista on-line piscolab, e inoltre membro del comitato scientifico del Centro Studi Internazionale Arkegos e direttore dell'area Antropologica Umanistica; ricercatore nel campo della biomusicologia presso i laboratori di antropologia dell'università di Firenze. Tra la sua copiosa produzione, vanno ricordati: “Antropologia culturale nella musica: quale utilità didattica?” in - E.P.T.A. News, Roma 1994,. “L'uomo, il suono e la musica” - Firenze University Press, Firenze2003. Con Larosa A. “Umanità abissale. Elementi di Antropologia secondo una prospettiva evolutiva e globo centrica” - Bonanno Editore, Roma-Catania 2005. “L'anima cerebrale”, Bonanno Editore Acireale-Roma 2009. “Ragionevolmente divini”, prefazione al testo di M. Chiappini, David Lazzaretti. “La mente ama. Per capire ciò che siamo con gli affetti e la nostra storia” - Il Pozzo di Micene Edizioni, Firenze 2011.
(8) A. Bertirotti, op. cit.
(9) Tran Van Khé: in “Musica addio” in Il Corriere Unesco (Anno XI – Giugno 1973.
Direttore del Centro Studi di Musica Orientale presso l’Istituto di Musicologia dell’Università di Parigi e membro del Consiglio Internazionale della Musica. Specialista delle musiche asiatiche, ha compiuto numerosi studi sulla musica tradizionale del Vietnam , sulla musica di Asia ed Europa. Sua opera più importante: “Musique et Societé” . Rivista Internazionale “Cultures” – UNESCO 1978.
(10) Dimitri Shostakovich: una delle più importanti figure della musica moderna russa, ricevette diversi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Autore prolifico di musica per tutti i generi, dalla canzone alla musica per balletto, alle colonne sonore per film, alcune opere e sei concerti e pagine per pianoforte. Risalgono infatti al 1915 (aveva 9 anni) le prime testimonianze di composizione. Šostakovič entrò nel 1919 al Conservatorio di San Pietroburgo, dove continuò a studiare il pianoforte con Leonid Nikolaev e composizione con Maximilien Steinberg: si diplomò nel 1923 in pianoforte e nel 1925 in composizione. Nel 1927 il governo gli chiese una seconda sinfonia in commemorazione dell’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. In quello stesso anno ottenne un diploma onorifico al concorso Chopin di Varsavia. Iniziò contemporaneamente a lavorare all'opera satirica "Il Naso" ispirata all'omonimo racconto di Gogol'. Il suo linguaggio si rifà alla tradizione e alla cultura russa, mischiandole in una propria e originalissima visione della forma e del contenuto. Dopo un primo periodo di avanguardia, Šostakovič si riallacciò alla musica romantica, ispirandosi a Gustav Mahler. La sua musica spesso comprende acuti contrasti e elementi grotteschi. Le quindici sinfonie e i quindici quartetti per archi sono generalmente considerati le sue composizioni di principale importanza.
(11) Marius Schneider, “Il significato della musica” – Rusconi, Milano 1979. Filologo, musicista, ricercatore, è stato Direttore dell’Istituto Espanol de Musicologìa di Barcellona. Si è dedicato allo studio dell’origine delle tradizioni popolari, alla ricostruzione delle antiche cosmogonie. Titolare della Cattedra di Musicologia all’Università di Colonia. Sue opere principali in italiano: “La Musica Primitiva”, Marius Schneider – Adelphi, Milano 1992 e quella sopra citata.
(12) Marcel Mauss: "Saggio sul dono: Forma e motivo dello scambio nelle società acaiche" – Einaudi, Torino 1965. Antropologo, sociologo e storico delle religioni francese, massimo esponente della scuola di Durkheim. Collaboratore della rivista Annéè Sociologique, fondata nel 1898 da Emile Durkheim. Fra le sue opere fondamentali vi è il “Saggio sull'origine del sacrificio”, scritto a quattro mani con Henri Hubert. Il libro non tratta strettamente dell'origine del sacrificio, ma scavalca questa tematica per andare a indagare la dinamica e le strutture di questo rito. Mauss parte dal concetto originario di sacrificio, nella sua accezione più etimologica: il sacrificio come sacrum facere, rendere sacro, come atto religioso che comporta la rinuncia di un bene a favore di un essere sovrumano. Molto conosciuta e importante per la storia dell'antropologia, la sua teoria, espressa nel celebre "Saggio sul dono", nasce dalla comparazione di varie ricerche etnografiche, tra le quali lo studio del rituale potlach di Franz Boas e del Kula di Bronislaw Malinowski.